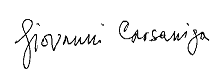Giovanni Carsaniga
Ricordando
Ferdinando e Mariuccia Visco-Gilardi
| Il mio primo
ricordo dello zio Nando risale all’estate del 1937, quando avevo poco
più di tre anni, e abitavo in un’area di Milano allora abbastanza
periferica non lontano dalla sede della Fiera Campionaria. Mio zio,
arrivato con una nuova bicicletta, mi portò appollaiato sulla canna a
fare un giretto intorno al Viale Giulio Cesare. A questo ricordo se ne
mescola un altro: lo sfondo musicale del Bolero di Ravel diffuso
nella zona da un furgone con altoparlanti della Voce del padrone.
Perché il Bolero non saprei dire. Ravel era allora gravemente
malato, a pochi mesi dalla morte nel dicembre del ’37, e le case
discografiche si preparavano a celebrarlo registrando le sue opere più
note. Ho ancora davanti agli occhi l’immagine dei due piatti del
giradischi, necessari per non interrompere la continuità della musica,
come invece avveniva coll’unico piatto del grammofono di casa dove un
disco come quelli di allora a 78 giri non durava più di tre
minuti. Certo fui portato dallo zio a vedere questo furgone radiofonico. Il ricordo successivo, più maturo, risale al 1940, quando mio padre mi portò con sé al Sinodo di Intra. Passai così alcuni giorni a Milano dagli zii Nando e Mariuccia, giocando con Leonardo, di poco più giovane. |
Durante uno
di questi giochi lo legai strettamente con delle cinghie. Contemplando il
mio lavoro dissi, quasi per provare una per me inusitata espressione: “Mi
sembri un delinquente!”. La zia, che udì, mi sgridò acerbamente. Ho della
zia Mariuccia un ricordo meno preciso, come di un misto di severità e
dolcezza, di amore e fermezza, di emotività e riserbo: e ora rimpiango di
non averla conosciuta abbastanza. Ci fu in quei giorni una visita alla Fiera
Campionaria dove mi fu comprata una bicicletta rossa che mi servì
felicemente per alcuni anni, finché le sue dimensioni rimasero compatibili
con le mie.
Fu lo zio, senza dubbio, a spiegarmi perché i giornali del tempo
pubblicavano l’immagine di un fondista finlandese, Pekka Nijemi, che si era
particolarmente distinto in un episodio della recente guerra
russo-finlandese, quando i soldati, come mostravano altre fotografie,
rivestivano tute bianche per meglio confondersi con la neve. Ho la vaga
impressione che lo zio simpatizzasse più coi finlandesi che coi russi.
Ritagliai la fotografia e per qualche tempo Pekka Njiemi signoreggiò nel mio
Olimpo privato di eroi.
Le vicende della guerra interruppero i rapporti per alcuni anni e i due
incontri successivi avvennero a Bolzano: uno, se ben ricordo, poco dopo la
nascita di Aldo e un altro quando Ettore aveva cinque o sei anni, e Sisa,
distribuendo le cose da fare fra i fratelli maggiori, si riservava il
compito (che a me pareva il meno oneroso) di accompagnarlo a fare il bagno
nelle glaciali acque del torrente Tàlvera. Ma i miei rapporti con lo zio
acquistarono maggior significato quando diventai sufficientemente maturo per
apprezzarne le qualità intellettuali. Non saprei bene quando avvennero i
successivi incontri, alcuni durante i miei anni di università, quando lo zio
visitava i miei genitori alla Spezia o a Intra, altri quando rientravo in
Italia da una delle mie permanenze all’estero, passando per Sesto. Ricordo
il senso di assoluta sicurezza e protezione che mi dava la sua presenza,
quando arrivavo stanco da un lungo viaggio in treno o in auto (un senso che
provo anche quando sono ospite dei miei cugini), e il piacere di poter
leggere o almeno consultare le ultime novità della cultura italiana che si
accumulavano negli scaffali del suo appartamento; e di ripartire con due o
tre di quei libri di cui si sarebbe poi nutrita la mia attività didattica
fuori d’Italia.
Dalle nostre conversazioni ho ritratto due principi che mi hanno poi sempre
accompagnato. Uno è che qualsiasi oggetto, naturale o metafisico, materiale
o culturale, è suscettibile di un esame e di una discussione razionale; e
che non esistono due forme di conoscenza diverse, una rigorosa e scientifica
per i fenomeni del mondo materiale, e un’altra, vaga, impressionistica e
polivalente, per quei fenomeni immateriali che vanno sotto il nome di “mondo
dello spirito”. L’altro principio è che un argomento non va mai dispiegato
con tanta forza da lasciare poco o nessuno spazio all’oppositore. Se da un
lato, adottandoli, ho subito l’influenza didattica di mio zio, dall’altro
questa influenza non è stata diretta. Vivendo in un mondo in cui il maggior
filosofo laico dichiarava l’impossibilità di non dirsi cristiano, l’unità
della conoscenza ha portato mio zio a non separare il suo marxismo dalla sua
religione, ambedue portatori di un messaggio di protesta e di rinnovamento.
Per me, invece, l’unificazione mediante gli stessi strumenti gnoseologici
del mondo della materia e di quello dello spirito ha reso la religione
superflua come espressione della mia esperienza spirituale. Per quanto
riguarda lo spazio del dialogo, ascoltando mio zio avevo talvolta la
sensazione che, se non fossi stato tendenzialmente d’accordo con lui, la sua
impeccabile razionalità mi sarebbe potuta apparire soverchiante.
Guardando indietro viene la tentazione di pensare che Ferdinando
Visco-Gilardi avrebbe dovuto avere titoli di studio, cariche e uffici, onori
e influenza all’altezza della sua vasta cultura, del suo acume politico e
della sua integrità morale e intellettuale. Quante persone cosiddette di
spicco nella vita pubblica e culturale italiana valgono infinitamente di
meno. Eppure, consideriamo l’effetto sui destinatari della sua voluminosa
corrispondenza ricca di intuizioni e spunti, l’estensione della sua attività
politica in tutte le sue forme, la sua esperienza culturale di cui la
biblioteca che ha lasciato è solo un simbolo, la multiforme testimonianza
resa e continuata in tanti campi dai suoi figli e nipoti.
Il valore delle vite che oggi celebriamo, di due consorti che si amarono e
lavorarono insieme e separatamente per gli stessi fini, è incalcolabile, al
di là di qualsiasi riconoscimento ufficiale, e porta frutto anche nel mondo
di oggi. Questo è il significato profondo della nostra commemorazione, a cui
mi unisco con fervore.