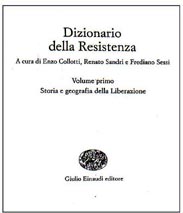Estratto da:
Dizionario della Resistenza
A cura di Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano
Sessi
Volume primo
Storia e geografia della Liberazione
CARLO ROMEO - LEOPOLD
STEURER Bolzano e Alto Adige
I venti mesi della Zona d'operazione delle Prealpi (Zop). Le
ordinanze del commissario supremo (reintroduzione del tedesco nella
toponomastica e nell'amministrazione, riaggregazione alla provincia di
Bolzano dei comuni di Livinallongo e Ampezzo e di quelli della Bassa
Atesina, proibizione della ricostituzione del Partito nazionale fascista (Pnf),
severa regolamentazione nella Zop della mobilità di persone in entrata e in
uscita, chiusura e sequestro della stampa cattolica di lingua tedesca,
limitazione nella circolazione della stampa italiana, ecc.) interrompono nei
fatti qualunque contatto con il resto d'Italia, pur con l'alibi delle
necessità militari. Nasce un movimento fascista clandestino che tiene
contatti con Salò (Ufficio zone alpine, retto dal conte Casalini e poi da
Antonio Bonino) con questi obiettivi: informare Mussolini degli effetti
annessionistici che avevano le ordinanze di Hofer; sollecitare dichiarazioni
ufficiali sull'italianità della Zop; costituire una brigata Alpina, formata
dalle leve italiane della provincia ed evitarne cosi l'arruolamento nelle
forze armate germaniche. In realtà anche sulla stampa di Salò cadde un velo
di silenzio sulle due zone di operazioni.
Nella gestione del suo "regno" Hofer fa ricorso di volta in volta al
consenso o al terrore. In Alto Adige per la popolazione sudtirolese la
restituzione dello spazio (negato dal fascismo) alla cultura popolare e alle
sue organizzazioni (dalle bande musicali, agli Schützen, alle associazioni
giovanili ecc.) viene vista da molti come una forma di rinata autonomia
culturale. Tali spazi sono ovviamente strumentalizzati ai fini della guerra
e della propaganda. E dove a nulla può il compenso ideale, Hofer cerca il
consenso con vantaggi materiali. Con un'ordinanza del dicembre r943 i salari
dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi pubblici e del
ramo bancario vengono aumentati del trenta per cento. Ciò tende soprattutto
a evitare malcontenti nella zona più "calda" della provincia, ovvero tra i
lavoratori della neonata zona industriale di Bolzano, importante per la
produzione bellica, in cui sono diffuse "cellule" fortemente politicizzate.
L'effettivo esercizio del potere, nonostante la facciata "bilingue", passa
in ordine gerarchico ai Kreisleiter, i sindaci commissariali che
sostituivano i podestà fascisti, e al loro apparato burocratico (ricalcato
sulla struttura del partito nazionalsocialista). Nei vari campi
dell'economia vennero insediati dei Kommissarische Leiter (gerenti), nelle
cui mani stava il destino delle ditte e imprese commerciali, industriali,
bancarie e artigiane.
L'istituzione della Zop non risparmiò l'esperienza degli aspetti più brutali
dell'occupazione nazista. Circa trenta appartenenti alla comunità ebraica di
Merano, rimasti ancora in provincia dopo l'emanazione delle leggi sulla
razza del 1938, sono i primi ebrei deportati dall'Italia (12 settembre),
anche in virtù dell'attiva collaborazione di elementi locali, peraltro mai
processati nel dopoguerra. Di loro tornerà solo una donna dai campi di
sterminio.
Nel luglio 1944, dopo la chiusura di quello di Fossoli, viene installato
alla periferia di Bolzano (via Resia) un Durchgangsiager (campo di
transito), gestito dalle SS, che funzionò sino alla fine dell'aprile 1945.
Vi passarono. almeno undicimila prigionieri (partigiani, ostaggi, ebrei,
zingari) destinati alla deportazione in Germania e si verifìcarono molti
episodi di sevizie ed esecuzioni sommarie. E da ricordare poi l'attività del
Tribunale speciale (Sondergericht) di Bolzano, che dal novembre 1943 alla
fine della guerra decreta più di trenta condanne a morte per partigiani
italiani e renitenti e disertori sudtirolesi. Nel gennaio del 1944 il
commissario supremo emana l'ordinanza di arruolamento di tutti gli uomini
abili delle classi 1894-1926. Nel caso dei Dableiber (cittadini italiani)
ciò avviene in contrasto col diritto internazionale. Per i casi di obiezione
di coscienza e la diserzione è previsto l'arresto dei familiari (Sippenhaft).
Ciononostante in Alto Adige saranno più di trecento i disertori sudtirolesi.
Vengono costituiti i reggimenti di polizia Bozen (dicembre '43),
Alpenvorland (settembre '44), Schlanders (novembre), Brixen (ottobre),
impiegati soprattutto nella lotta antipartigiana nel Bellunese e nel
Feltrino. Furono trentadue soldati dell'XI compagnia del 3° battaglione del
Bozen, in addestramento a Roma, a cadere nell'attentato di via Rasella.
Nonostante la provincia non sia direttamente interessata da operazioni
belliche, nei venti mesi della Zop le sofferenze delle popolazioni civili si
fanno sempre più pesanti. Oltre alle prestazioni di guerra e alle
requisizioni (per i contadini bestiame e viveri), pesanti conseguenze hanno
i tredici grandi bombardamenti aerei su Bolzano, miranti a colpire la linea
ferroviaria del Brennero, di vitale importanza per i rifornimenti alle
truppe d'occupazione in Italia e che causano più di duecento morti e la
distruzione o il danneggiamento di un terzo degli edifici.
Il Cln dell'Alto Adige. L'attività del Cln altoatesino comincia
all'inizio del 1944. Espressione della Bolzano dirigenziale e impiegatizia,
stenta a imporre inizialmente il proprio ruolo di guida sulle cellule
autonome delle fabbriche. Proprio il "canale delle fabbriche", e cioè i
trasporti quasi quotidiani tra le case madri milanesi e torinesi e gli
stabilimenti bolzanini, risulta importantissimo per i collegamenti con il
Cln Alta Italia Clnai (materiale di propaganda, denaro, entrate e uscite
clandestine). Guidato da Manlio Longon (Pda), don Daniele Longhi (Dc),
Andrea Mascagni, Enrico Pedrotti e Rinaldo Dal Fabbro (Pci), il Cln
altoatesino cerca non solo di rappresentare i partiti democratici italiani,
ma di coinvolgere antinazisti sudtirolesi attraverso contatti con
l'imprenditore Erich Amonn (che sarà nel dopoguerra fondatore e primo
presidente della Südtiroler Volkspartei). Vista l'impossibilità di
organizzare formazioni armate per la mancanza di un retroterra favorevole,
l'organizzazione è attiva specie nell'azione di propaganda clandestina,
soprattutto nei contatti con la Resistenza trentina, veneta e lombarda e,
dal luglio 1944 in poi, nell'assistenza agli internati del lager di Bolzano.
I Cln di Milano e di Padova inviano
ripetutamente (tramite Enrico Serra) denaro e materiale per l'assistenza e
l'organizzazione di fughe, opera in cui si distingue Ferdinando Visco
Gilardi.
I tentativi di azioni belliche da parte
del Cln bolzanino, in particolare il reperimento di esplosivo; hanno
tuttavia esito sfortunato. Il gruppo di sette operai guidati da Walter
Masetti viene arrestato e morirà a Mauthausen. Nel dicembre 1944 l'intero
gruppo dirigente del Cln di Bolzano viene individuato dalla Gestapo. Durante
i duri interrogatori del maggiore del
sd August Schiffer (condannato a morte dagli alleati nel 1947) muore
per sevizie lo stesso Longon. Qualche mese prima dal terzo piano del IV
corpo d'armata, sede degli interrogatori, si era gettato il conte
Giannantonio Manci, animatore della resistenza trentina.
La liberazione. Ogni attività clandestina cessa, o quasi, fino
all'arrivo, agli inizi dell'aprile 1945, di Bruno De Angelis,
inviato dal Clnai (esattamente dalle Fiamme verdi) per organizzare il
passaggio dei poteri in vista della resa tedesca. De Angelis ricostituisce
il Cln provinciale (con Luciano Bonvicini responsabile politico e Libero
Montesi, «capitano Franco», come responsabile militare), recluta e inquadra
militarmente ogni forza disponibile. Si tratta soprattutto di operai della
zona industriale di Bolzano e di appartenenti a una formazione giovanile
autonoma definitasi «apolitica», di tendenza nazionalista, la brigata
Giovane Italia, che ha avuto contatti con la X Mas (da cui aveva ricevuto un
carico d'armi).
Le trattative di De Angelis con i comandi germanici (generale Heinrich von
Vietinghoff, comandante del Gruppo armate sud-ovest) si intrecciano con
quelle che il generale Karl VVolff (comandante in capo delle SS e
plenipotenziario della VVehrmacht - Forze armate tedesche - in Italia) da
tempo sta svolgendo coi servizi segreti degli alleati in Svizzera. Tra
diverse altre missioni dell'Office of Strategic Services, un ruolo
particolare nelle trattative altoatesine ha la missione Norma (del capitano
Cristoforo De Hartungen), che permette qualche contatto con il generale
Clark. Il Gauleiter Hofer, deluso nella sua richiesta di poter costituire un
Tirolo indipendente sotto la sua autorità, denuncia le trattative in corso a
Kesselring. Ma ormai è troppo tardi. Il 29 aprile 1945 a Caserta viene
firmato l'armistizio, che dovrebbe entrare in vigore il 2 maggio. Nel
frattempo De Angelis insiste per il passaggio dei poteri militari e civili
nella provincia al Cln. Vietinghoff preferirebbe attendere l'arrivo degli
alleati, accogliendo le richieste di Erich Amonn e del prefetto Karl Tinzl.
Quest'ultimo, proprio in quei giorni, è stato contattato dal capitano Henri
Clairval, un ufficiale dei servizi segreti francesi in missione a Bolzano,
che assicura la buona disposizione da parte della Francia riguardo a un
ritorno della provincia all'Austria (Clairval verrà in seguito allontanato
dagli americani).
La situazione precipita col verificarsi di scontri sanguinosi. A Merano il
30 aprile, dopo un vano tentativo di occupazione del municipio, un corteo di
italiani che festeggia la notizia delle insurrezioni nelle città del Nord
Italia viene disperso a fucilate, col bilancio di nove morti e una decina di
feriti. A Lasa il 2 maggio sono fucilati nove operai italiani della Todt. A
Bolzano, secondo un accordo temporaneo concluso la sera del 2, il
pattugliamento di depositi, caserme, strade dovrebbe essere misto, cioè di
partigiani e militari tedeschi. In quel momento l'organigramma delle forze
partigiane, quale risulta dai documenti disponibili, dalle testimonianze e
dalla memorialistica, è alquanto confuso. Oltre alle tre formazioni Bari,
Livorno e Pasubiana che, sotto la guida di Libero Montesi, costituiscono la
divisione Alto Adige, vi sono infatti la già menzionata brigata Giovane
Italia (Gino Beccaro) e numerose formazioni nate dalle cellule autonome
della zona industriale. Proprio nella "zona" hanno inizio gli incidenti che
insanguinano la mattina del 3 maggio. Le cause sono da ascriversi in primo
luogo alla confusione nei comandi delle truppe della VVehrmacht in caotica,
ritirata verso il Brennero (sparatorie lungo la strada statale e vicino alla
ferrovia); in secondo luogo, alla mancanza di coordinamento all'interno
delle varie formazioni partigiane (tentativo di disarmo delle sentinelle
tedesche nella zona industriale); infine, a vera e propria rappresaglia da
parte germanica (presso lo stabilimento Lancia). Il numero dei morti assomma
a venticinque partigiani e venti civili. Mentre ancora in città si spara
VVolff e Vietinghoff firmano il documento in base al quale Bruno De Angelis
assume l'amministrazione della provincia in nome del governo italiano. Si
compie cosi un primo significativo passo verso il mantenimento del Brennero
da parte dell'Italia.
La resistenza tedesca. Quando, dopo 1'8 settembre 1943, i principali
esponenti dei Dableiber sono costretti a fuggire (come il canonico Michael
Gamper) o sono addirittura deportati (come Friedl Volgger), le redini
dell'organizzazione Andreas Hofer Bund
(ahb) vengono prese in mano dal giornalista Hans Egarter. Questi si
preoccupa dell'organizzazione dell'ahb
nel difficile contesto locale, dell'assistenza ai perseguitati e dei
contatti con gli alleati. Attraverso la Val Venosta riceve e manda
informazioni ai servizi segreti alleati in Svizzera (McCaffery) tramite
corrieri. Nel marzo del 1945 si preparano in Val Venosta le basi di appoggio
per un progettato lancio di paracadutisti francesi, nell'evenienza che i
tedeschi si trincerino nel cosiddetto «ridotto alpino». Gli avvenimenti
successivi vanificano tale progetto.
Dopo l'ordinanza di arruolamento del gennaio 1944, cresce il fenomeno della
diserzione e dell'obiezione di coscienza. Un caso particolare è quello della
Val Passiria, in cui un consistente gruppo di disertori armati (la
cosiddetta banda Gufler), in contatto con Egarter, costringe a una posizione
difensiva i nazisti e la sod
locale, vendicando con furti, incendi e omicidi gli arresti e le
persecuzioni ai danni delle famiglie dei disertori. Nel dopoguerra alcuni di
questi giovani saranno processati e assolti in un primo tempo (Bolzano,
1949), in seguito condannati in appello (Trento, 1951) da una sentenza che
negherà loro la qualifica di partigiani (come nel caso di Johann Pircher).
Generalmente la matrice cristiana dell'opposizione sudtirolese al nazismo è
evidente non solo nella diretta partecipazione del clero, ma nel significato
di "testimonianza" che hanno numerosi episodi. Tra questi spicca quello di
Josef Mayr Nusser, presidente diocesano della Gioventù cattolica di Bolzano,
anima del movimento dei Dableiber e fondatore dell'ahb nel 1939. Arruolato a forza nelle SS nel 1944, rifiuta di
prestare il giuramento al Führer, per motivi religiosi. Nella deportazione a
Dachau, muore di fame in un vagone blindato. Altro episodio degno di
menzione è quello del reggimento Brixen. Composto di numerosi Dableiber,
durante la cerimonia del giuramento (febbraio 1945), di fronte al Gauleiter
Hofer, tace compatto al momento di pronunciare la formula. Viene disarmato e
inviato per punizione sul fronte orientale, in Slesia.
Legata in qualche modo all'attività dell'ahb
è la pressione esercitata, tramite Erich Amonn, sul prefetto Karl Tinzl e
sui comandi della VVehrmacht per la liberazione di centotrentasei ostaggi
internazionali (politici, religiosi, familiari di uomini di stato) inviati
da Himmler in Val Pusteria sotto la sorveglianza di un reparto di SS. Gli
ostaggi vengono liberati e consegnati agli alleati. Il crudo bilancio finale
delle vittime della resistenza sudtirolese è il seguente: ventiquattro
fucilati, centosessantasei deportati nei campi di concentramento,
centoquaranta imprigionati.
La Resistenza nel dopoguerra. Dal maggio fino al 31 dicembre 1945
prefetto dell'Alto Adige, subordinato al governo militare alleato, è Bruno
De Angelis. Oltre ai problemi di ordine pubblico vi sono numerose questioni
che provocano tensione tra i gruppi linguistici e che troveranno soluzione
diplomatica solo con l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Vi è
anzitutto la richiesta di autodeterminazione portata avanti dalla Südtiroler
Volkspartei (svp), nata come partito di raccolta etnico, ma legittimato agli
occhi dell'alleato proprio dalla presenza degli antinazisti sudtirolesi (Amonn,
Egarter, Volgger ecc.). Per questo motivo l'svp non prende parte ai lavori
del Cin provinciale, e per lo stesso motivo trecento appartenenti all'AHB
rifiutano il «brevetto Alexander», in quanto la sua formulazione in italiano
sarebbe pregiudiziale. In questi mesi l'operato di De Angelis viene
variamente interpretato. Da parte sudtirolese è considerato il principale
oppositore, in sede locale, dell'istanza di autodecisione. Da parte italiana
gli si addebitano una condotta troppo conciliante e un dialogo "diretto" con
la Svp che esclude il Cln locale.
Neppure l'epurazione, affidata a un comitato composto da elementi di
entrambi i gruppi linguistici, avrà significativi effetti. Mentre altrove
sarà la guerra .fredda ad accelerare il processo di rimozione collettiva, in
Alto Adige la contrapposizione etnica eviterà un ripensamento all'interno di
entrambi i gruppi linguistici. Paradossalmente l'Alto Adige è uno dei pochi
casi in cui un certo nazismo potrà presentarsi come "antifascista" e un
certo fascismo come "antinazista". Nel gruppo italiano la continuità nel
dopoguerra di non pochi elementi (in campo amministrativo, giornalistico,
culturale, giudiziario) del ventennio fascista sarà garantita dall'esigenza
di difesa nazionale. Nel gruppo tedesco l'appello all'unità della minoranza
porterà a una visione distorta e alla "rimozione" del recente passato nonché
al reinserimento nella vita pubblica e di partito di elementi compromessi
col regime nazista. Tutto ciò, oltre al contenzioso sull'assetto
autonomistico della provincia, rimanderà di molti decenni l'avvio del
processo di convivenza e collaborazione democratica.
Nota
bibliografica:
AA.VV.,
Tedeschi, partigiani, popolazioni nell'Alpenvorland, Marsilio, Venezia
1984; AA.VV., Option Heimat opzioni, Tiroler Gcschichtsverein,
Bolzano 1989; AA.VV., Italien und Südtirol. Italia e Alto Adige.1943-45,
in «Geschichte und Region / Storia e Regione», III (1994), Folio, Bolzano;
U. Corsini e R. Lili, Alto Adige. 1918-1946, Athesia, Bolzano 1988;
R. De Felice, Il problema dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi
dall'AnschIuss alla fine della seconda guerra mondiale. II Mulino,
Bologna 1973; C. Gatterer, In lotta contro Roma (1968), Praxis 3,
Bolzano 1995; L. Happacher, II lager dì Bolzano, Saturnia, Trento
1979; G. Lazagna, Il caso del partigiano Pircher, La Pietra, Milano
1975; C. Romeo, Sulle tracce di KarI Gufler il bandito, Raetia,
Bolzano 1993; F. Steinhaus, Ebrei/Juden. Gli ebrei dell'Alto Adige negli
anni Trenta e Quaranta, La Giuntina, Firenze 1994; L. Steurer, La
deportazione dall'Italia. Bolzano, in AA.VV., Spostamenti di
popolazione e deportazione in Europa. 1939-45, a cura di R. Falcioni,
Cappelli, Bologna 1987; L. Steurer, M. Verdorfer e W. Pichler, Verfolgt,
verfemt, vergessen, Sturzflüge, Bolzano 1993; K. Stuhlpfarrer, Le
zone d'operazione Prealpi e Litorale Adriatico. 1943-1945 (1969),
Libreria Adami, Gorizia 1979; C. Villani, Ebrei fra leggi razziste e
deportazioni nelle provincie di Bolzano,Trento e Belluno, Società Studi
Trentini, Trento 1996.