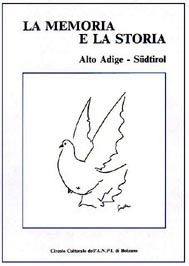Estratto da
LA MEMORIA E LA STORIA
Alto Adige – Südtirol
Circolo Culturale dell’A.N.P.I. di Bolzano
LA CITTÀ INVISIBILE
Dietro la
quotidianità:
testimonianze
di lotta e di libertà
Il campo
di concentramento di Bolzano
«Polizeiliches Durchgangslager Bozen»
Al concorso indetto
dall'A.N.P.I. di Bolzano, intitolato «LA MEMORIA E LA STORIA» abbiamo
pensato di aderire con questo lavoro. Le direttive che ci hanno guidati in
questo impegno sono:
1) Raccolta di testimonianze orali, o reperite, di chi, avendo vissuto di
persona l'esperienza della Seconda Guerra mondiale è o è stato in grado di
attingere dalla memoria; utilizzazioni di vecchie testimonianze.
2) Selezione del materiale acquisito. In tale fase ci ha guidati un
criterio di particolare attenzione nei confronti delle esperienze vissute da
coloro i quali sono stati internati per periodi più o meno lunghi nel campo
di concentramento di via Resia, a Bolzano.
3) Organizzazione del lavoro in modo da dare parte predominante alle
vicende personali di chi ha vissuto tale esperienza direttamente, e ne porta
tuttora i segni, oltre che nel corpo, soprattutto nella mente. In questa
ricerca di microstoria, molto importante per noi l'aver conosciuto in
maniera così viva un passato che, letto nei testi scolastici, assume una
luce tanto diversa.
Se in principio lo stimolo che ci ha mosso a tale lavoro era semplice
curiosità, oggi ci sentiamo di poter affermare, insieme a coloro che ci
hanno seguiti ed aiutati con i loro racconti, che lo scopo di questa
ricerca, dev'essere quello di non lasciare che la memoria di un passato così
denso di insegnamenti preziosi vada smarrita.
Bolzano, 11 Febbraio 1991
David Piccoli Chiara Poznanski
Classe 5a A
Liceo Scientifico «Torricelli» Bolzano
Alla periferia di Bolzano,
ai margini del rione popolare delle semirurali denominato di «S. Giovanni
Bosco», sorgeva il «Durchgangslager», cioè «Campo di Concentramento di
transito».
La sua attività iniziò alla fine del luglio 1944 con l'arrivo di prigionieri
evacuati dal campo di Fossoli, vicino a Modena. Per la sua costruzione
vennero utilizzati degli hangars per automezzi appartenenti al Genio
militare dell'esercito italiano: questi vennero divisi in grandi vani con
alcune tramezze e diedero così luogo ai cosiddetti blocchi. Furono allestite
anche una cucina ed una tettoia per i servizi igienici. In un tempo
successivo furono costruite una vera e propria prigione ed altre baracche.
Gli internati venivano contraddistinti, oltre che con il numero di
matricola, con un triangolo di stoffa colorato: rosso per i politici, verde
per gli ostaggi, rosa per i rastrellati. Gli ebrei dovevano invece portare
cucita sulla divisa una stella gialla.
Una ricerca di Laura
Conti, medico di Milano partigiana internata, tuttora vivente, individua tra
gli internati la seguente composizione:
A) BAMBINI: ebrei, zingari gitani o slavi, in un blocco, con le madri;
B) DONNE: erano mogli, madri o parenti di partigiani o di ricercati
politici, politiche o partigiane esse stesse, ebree di ogni nazionalità,
zingare, ed anche prostitute o ladre. Il gruppo delle donne fu sempre più
unito di quello degli uomini.
C) UOMINI: costituivano il gruppo più numeroso e, a causa della divisione in
blocchi e delle continue deportazioni, meno unito. Erano partigiani,
disertori, rastrellati, politici, ebrei, ufficiali italiani leali al re,
agenti segreti alleati ed anche zingari, ladri o contrabbandieri.
In generale il campo di Bolzano fu di smistamento, tappa intermedia ai
massacri di Auschwitz, Mauthausen, Dachau, vi passarono almeno 12.000
persone, stimate per difetto, per il fatto che uno stesso numero di
matricola veniva assegnato successivamente a più di un prigioniero nel
susseguirsi degli arrivi e delle partenze. Altre stime fanno ammontare a
circa 30.000 il numero di coloro che furono internati nel Lager di Bolzano.
L'amministrazione del Lager era affidata a due comandanti delle «SS»,
tenente Tito e maresciallo Haage, alle cui dipendenze era un gruppo di
militari, anche SS, tedeschi, sudtirolesi, ucraini.
Essi tendevano a demandare parte delle questioni organizzative agli stessi
detenuti, che ogni giorno dovevano relazionare sulla situazione. Le «SS» si
proponevano in tal modo di fomentare tra gli internati sospetti e
diffidenze, ma l'organizzazione clandestina interna valse a contrastare
decisamente questo loro proposito. L'organizzazione interna priva di
contatti con l'esterno, era nata ad opera di detenuti operanti nel campo di
Fossoli prima dell'estate '44. Uno degli obiettivi che questi temerari si
erano proposti consisteva nel fare un censimento della popolazione del campo
e di tenerlo costantemente aggiornato. Inoltre essi soccorrevano i detenuti
più provati.
Tra gli appartenenti a tale gruppo ricordiamo: le dottoresse Buffulini,
Laura Conti, il dott. Bartellini e Armando Sacchetta. Va ricordato che le
provincie di Bolzano, Trento, Belluno vennero di fatto annesse al Reich dopo
1'8 settembre 1943 e costituirono una delle due «zone d'operazioni»,
assoggettate all'autorità tedesca. La prima, che comprendeva le tre
provincie di Bolzano, Trento e Belluno venne denominata Operationszone
Alpenvorland Zona d'Operazione delle Prealpi; la seconda fu la
Operationszone Adriatisches Kustenland Zona di operazione del Litorale
Adriatico. Scrive a questo proposito Happacher (L. Happacher, II Lager di
Bolzano. Trento 1979)' «A differenza di quanto avvenne nel resto dell'Italia
occupata, dove, almeno formalmente, la Repubblica Sociale Italiana poteva
esercitare una sua autorità, il regime di occupazione tedesco cancellò ogni
forma di autorità centrale italiana nelle due zone di Operazione, stabilendo
di fatto, se non di diritto, l'annessione di questi territori al Reich e
provocando reazioni da parte della R.S.I.
Preoccupazione del Gauleiter del Tirolo, Franz Hofer, fu subito quella di
alzare una cortina protettiva a difesa dei confini dell'Alpenvorland da
intromissioni della R.S.I. Né persone, né informazioni potevano entrare
nell'Alpenvorland, neppure se fasciste, senza l'autorizzazione delle
autorità locali. L'Alpenvorland veniva progressivamente a configurarsi come
un'isola sotto il diretto e totale controllo del Commissario Supremo; l'Adriatisches
Kunstenland, seppure in misura minore, subiva la stessa sorte. Non casuale
sembra quindi la presenza dei due maggiori campi di concentramento in Italia
nelle rispettive «capitali» delle Zone di Operazioni: Bolzano e Trieste. La
sede migliore, cioè, per un campo di concentramento, era quella che
permetteva ai nazisti di contare non solo sul diretto controllo del campo,
come avvenne a Fossoli, ma anche sulla garanzia che dava loro il possesso
del territorio circostante».
Enrico Pedrotti (trentino residente a Bolzano, fu uno dei promotori della
Resistenza in Alto Adige. Catturato dalla Gestapo nel dicembre 1944, venne
internato nel campo di concentramento, nelle celle dei pericolosi, e
sottoposto a torture) in un suo scritto pubblicato molti anni addietro
dice in proposito che in effetti il Lager fu creato in una situazione
ideale, dato che «un Lager in Italia non avrebbe certamente avuto vita
facile, malgrado le S.S.».
Il Lager di Bolzano, l'inizio delle cui attività è da fissarsi secondo Ada
Buffulini (medico di Milano, internata al Lager di Bolzano, scomparsa nel
luglio 1991) alla fine luglio del 1944, fece, secondo Pedrotti,
«pienamente onore» ai suoi ideatori nazisti. Riuscì infatti a convogliare,
dal '43 al '45, secondo certe stime, intorno ai 30.000 italiani, dei quali
il 90%, avviati via via ai campi di sterminio specializzati di Dachau e
Mauthausen, non fece più ritorno.
Nell'articolo sopra citato Pedrotti ricorda che la «consegna» dei detenuti
veniva fatta alle S.S. del Lager in gran parte dai camerati fascisti della
vicina Repubblica di Salò: «Li abbiamo visti coi nostri occhi, i fascisti,
portare nel Lager gruppi di compatrioti, di partigiani laceri e feriti e
darli in mano alle S.S. naziste, che come prima accoglienza li cacciavano a
pedate con la faccia rivolta contro il muro d'ingresso per fare l'appello».
I capitoli centrali dell'opera di Happacher riguardano la popolazione del
campo, nelle sue suddivisioni, secondo le motivazioni determinanti
l'arresto, la deportazione e l'internamento, e 1' organizzazione del campo,
sia quella ufficiale che quella clandestina.
L'ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO
Dopo la chiusura del Campo
di Fossoli, con la brutale strage, i primi internati del campo di Bolzano
furono, per l'appunto gli internati di Fossoli, tra i quali anche alcuni
fascisti «di fronda»: non si è appurato, a quanto finora risulta, per quale
ragione essi fossero internati, se per reati comuni o se come essi
sostenevano, perché una posizione politica «frondista» li rendesse infidi ai
nazisti o a qualche formazione fascista.
Il campo continuò poi a funzionare come luogo di raccolta e di smistamento
dei prigionieri partigiani e politici provenienti dalle carceri dell'Italia
occupata dai nazisti: gli internati provenivano principalmente dalla
Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Friuli, dall'Emilia.
I convogli si susseguirono, in treno e in camions militari, fino al marzo
del '45, con un ritmo, all'incirca mensile o bimensile. Il convoglio di
marzo diretto ai campi di concentramento in Germania ritornò indietro per
l'impraticabilità della ferrovia. Da quell'epoca per i continui arrivi a
Bolzano di nuovi prigionieri il campo si trovò'ad ospitare molte più persone
di quante ne potesse contenere.
Nei blocchi ricavati dagli ampi capannoni con lunghe fila di «castelli» (una
specie di giacigli sovrapposti), venivano ammassati i detenuti:
un tavolato, un sacco di trucioli, un paio di coperte. Quando andava bene vi
era disponibile l'intero pagliericcio. In condizioni normali il Lager di
Bolzano poteva accogliere qualche centinaio di detenuti. Ebbene, i nazisti
riuscirono a farcene stare oltre 3.500, nei periodi precedenti alle
deportazioni in Germania. Ammassati in tre, in quattro per tavolaccio in
condizioni inenarrabili. Nel blocco delle celle, che poteva contenere al
massimo 80 persone, ne vennero ammassate fino a 150 circa.
LA RESISTENZA INTERNA
Secondo Laura Conti, nella
citata ricerca, «... resistenza interna e resistenza esterna furono
strettamente collegate: l'una non avrebbe potuto far nulla, o quasi nulla,
se non fosse esistita l'altra. La resistenza esterna fu organizzata da un
gruppo di persone residenti a Bolzano, che decisero di aiutare gli
internati.
La resistenza interna aveva la sua base in un'organizzazione clandestina
piuttosto rigida, che si richiamava ai criteri organizzativi dei Comitati di
Liberazione Nazionale, sulla base della cooperazione tra i diversi partiti.
La vita clandestina del Lager era difatti guidata da un comitato; ad esso
facevano capo i rappresentanti di ogni baracca; l'organizzazione andò
perfezionandosi, anche formalmente, a tal punto che vennero distribuite
anche tessere d'iscrizione ai partiti e salvacondotti del C.L.N.. A coloro
che al momento dello scioglimento del campo avrebbero assunto responsabilità
direttive vennero distribuiti bracciali e distintivi, al fine di facilitare
il servizio.
Di preciso si sa anche che vennero preparate numerose evasioni con diversi
sistemi: particolarmente fughe dai luoghi di lavoro, o dai vagoni ferroviari
dei convogli in partenza per la Germania.
L'insieme di queste attività ebbe, secondo Laura Conti, non solo «il
significato di una lotta per la sopravvivenza, ma il significato integrale
di ogni lotta della Resistenza». Il comando SS riuscì a scoprire alcuni dei
segreti di Bolzano: di conseguenza numerosi i catturati. Riportiamo alcuni
passi della «testimonianza» di Enrico Pedrotti pubblicata nel 1964:
«Tra il 15 e il 20 dicembre 1943 l'organizzazione del C.L.N. clandestino di
Bolzano venne catturata quasi al completo, inizialmente Manlio Longon e don
Daniele Longhi, quindi Rinaldo Dal Fabbro e molti altri. Lo sapemmo subito e
sarebbe stato facile non farci prendere a nostra volta. Eravamo già
avvertiti dalle nostre staffette che ci avevano cercati. L'attesa non durò
molto; li sentii salire per le scale. I nazisti avevano un passo
inconfondibile; suonarono alla porta... Mi portarono al Corpo D'Armata ...
poi giù, fino ad una grossa porta sprangata, poi giù ancora, attraversando
un lungo corridoio con i grossi tubi delle caldaie. A sinistra un passaggio
con quattro porte di ferro, quattro celle tristemente famose. Mi aveva
trattenuto il timore per la famiglia. Mi rinchiusero nell'ultima... Mi
sedetti e attesi in perfetto silenzio ... Eppure avvertivo delle voci, come
da lontano: ascoltai meglio, non riuscivo a seguire le parole. Mi buttai per
terra con l'orecchio il più vicino possibile alla fessura sotto la porta ...
Ero teso come una corda, quella voce la conoscevo: era «Angelo», Manlio
Longon (Manlio Longon, presidente del C.L.N. di Bolzano, uno dei maggiori
organizzatori della Resistenza in Alto Adige, in collegamento con il C.L.N.
Alta Italia di Milano. Catturato nel dicembre 1944, fu lungamente torturato,
quindi ucciso. Medaglia d'oro al valor militare.)... Mi rimaneva poco tempo,
ormai, e chiamai forte: «Angelo, sono Marco» ... Riuscimmo a stabilire un
dialogo serrato ... Presto sarebbero venuti a prendermi ... Dovevo «sapere»
il più possibile .... Seppi così tutto quello che conoscevano di noi e
quando gli stivali rimbombarono sul cemento armato fino alla mia cella,
Angelo ebbe ancora il tempo di gridarmi «coraggio Marco!» ... Qualche giorno
dopo, la vigilia di Capodanno, Angelo venne portato al Corpo d'Armata ... Lo
uccisero sotto interrogatorio, simulando la beffa di un suicidio. Tutti noi
del blocco celle avemmo la triste percezione di ciò che era accaduto la
stessa notte dell'assassinio. «Angelo» non rispose più ai nostri richiami,
mai più avrebbe risposto. La mattina di Capodanno 1945 l'SS Mann Otto (Otto
e Misha, due spietati guardiani, ventenni, erano SS ucraini di origine
tedesca, «promossi» alle loro indicibili gesta dalla reclusione in un
riformatorio per giovani delinquenti) cantava a squarciagola: Cantava
sempre Otto, quando morivano quelli delle celle».
La rete dell'organizzazione interna, riferisce Laura Conti, non venne invece
mai scoperta, ma si tenne miracolosamente in piedi fino all'ultimo. Laura
Conti cita il nome di coloro che a Bolzano si prodigarono nell'opera di
collegamento con il Lager e particolarmente a favore di quelli che
riuscivano ad evadere: Mariuccia
Visco-Gilardi
e Maria Pedrotti, i cui mariti erano rinchiusi nel
blocco-celle, Franca Turra, Margherita Bonvicini, Fiorenza e Vito Liberto,
Luigi Rocco Biamino ed i dirigenti di allora delle fabbriche Acciaierie,
Magnesio e Lancia, tutti di Bolzano.
FERDINANDO VISCO GILARDI E
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA
Con la morte di Longon, il C.L.N. bolzanino riceveva un duro
colpo e doveva rinunciare alle azioni di guerriglia e di sabotaggio, anche
per la impossibilità di sostegno da parte della popolazione locale.
Continuava, invece l'opera di salvataggio ed assistenza degli internati del
campo di concentramento. Tra coloro che si prodigarono in questa attività
Ferdinando Visco Gilardi. Gianni Bianco in una rievocazione di anni addietro
così ne delinea la figura: «Gilardi, milanese di nascita, s'era stabilito
dal 1940 a Bolzano, ma aveva mantenuto amicizie e contatti nel capoluogo
lombardo.
La sua maturazione politica e spirituale (Gobetti era stato il faro più
luminoso per la sua giovinezza) aveva formato in lui il terreno adatto
perché germinasse il seme della Resistenza: la Resisenza venne a lui per il
canale milanese che gli fornì indicazioni e mezzi per organizzare la
assistenza e le fughe di reclusi nel Lager di Bolzano.»
Vengono poi descritti i contatti tra Gilardi e la «centrale» milanese, dato
che, per ragioni di sicurezza, era opportuno avere scarsi rapporti con i
gruppi locali: «I contatti tra Gilardi e la centrale milanese,
principalmente con Lelio Basso, vennero stabiliti attraverso i viaggi di due
donne, Virginia Scalarmi e Gemma Bartellini. Furono esse a rifornire Gilardi
di generi alimentari e capi di vestiario, per gli internati, materiale
spedito in casse a Bolzano con la collaborazione dell'allora direttore delle
Acciaierie, ing. Ventafridda, che mise a disposizione i trasporti per conto
della fabbrica bolzanina da Milano: sui camions, in mezzo alla mercé legale,
c'era anche quella destinata al Lager ...
La via dei pacchi divenne dunque anche la via dei messaggi clandestini in
entrate ed in uscita, che consentirono di preparare le fughe dei detenuti:
in quest'opera furono validi collaboratori di Gilardi due idraulici che
avevano ogni tanto accesso al campo per eseguirvi lavori, Degasperi e
Brunelli, nonché le internate, come già ricordato, dottoresse Ada Buffulini,
medico consultore al campo, Laura Conti, ambedue milanesi. Le fughe potevano
essere organizzate o favorite. Nel secondo caso si trattava di fornire
subito ai fuggiaschi documenti falsi, vestiario, denaro, cibo e ospitalità
per i primi giorni. Il danaro arrivava in sufficiente quantità da Milano,
assieme a carte d'identità in bianco, che poi Gilardi riempiva con
generalità false e le foto dei fuggiaschi. Inoltre venne trovato un certo
numero di famiglie italiane di Bolzano che si prestavano spesso più in uno
slancio di umanità e solidarietà, che per impegno politico, ad ospitare i
clandestini. Infine venivano organizzati i trasporti per Milano. Per le
evasioni preparate dall'esterno questa fase doveva essere preceduta da altre
più rischiose:
si dovevano stabilire l'ora e le modalità della sortita, far trovare al
fuggiasco un mezzo di trasporto, in genere una bicicletta, nei pressi del
Lager e quindi indicargli il primo rifugio utile. Numerose furono le fughe
di questo tipo organizzate da Gilardi prima del suo arresto. Gilardi cadde
nelle mani dei nazisti il 19 dicembre 1944. È perfettamente nota la sua
sorte: il trasferimento al Corpo d'Armata, l'interrogatorio da parte del
maggiore Schiffer. Fin dalle prime battute Gilardi si rese conto che
Schiffer sapeva ben poco di lui e quel poco favoriva la sua posizione, nel
senso che egli appariva, anziché un resistente, un filantropo, che si era
dedicato ad aiutare gli internati. Gilardi lo assecondò in questa
sensazione... Si costruì pertanto una serie di ammissioni da rilasciare,
tali da confermare quanto era probabile che i nazisti già sapessero sulla
sua attività, senza peraltro compromettere altre persone reali, integrandole
con una serie di fatti del tutto inventati, ma molto verosimili. Il tutto da
riferire poco a poco, sotto forma di confessione strappata e non volontaria.
Nonostante ciò non gli fu risparmiata la tortura, le cui fasi sono descritte
negli stessi verbali d'interrogatorio che tra maggio e giugno del 1945
vennero resi in Bolzano da Christa Roy, segretaria ed amante del «boia di
Bolzano», il citato maggiore delle «SS» Schiffer, il quale aveva trasformato
i sotterranei del Corpo d'Armata in uno dei più spaventosi luoghi di
sofferenza.
Gilardi stesso ricorderà le atrocità subite, dalla tortura allo «spiedo»
(legato all'asta di ferro, il suo corpo veniva fatto ruotare e percosso a
nerbate che gli strappavano la pelle) fino alla tortura degli elettrodi
(alle tempie gli venivano applicati due elettrodi e lo stesso maggiore
azionava la corrente elettrica, onde renderla progressivamente più intensa).
Dopo alcuni giorni Schiffer si convinse e prese per buone le ammissioni
fasulle o comunque innocue che Gilardi aveva fatto sotto tortura;
gliele fece mettere per iscritto e lo inviò al Lager, in cella di
segregazione. Nel campo Gilardi potè constatare che la sua organizzazione
funzionava ancora. E fu in grado così di continuare il lavoro. Attraverso la
«bocca del lupo» della cella Gilardi poté mettersi in comunicazione con gli
altri ed avvertirli di quanto lui aveva detto alle «SS», perché non lo
contraddicessero e perché non si lasciassero a loro volta mettere in
trappola. Riuscì persino a far avere una lettera a sua moglie, fornendole
tra l'altro indicazioni sull'assistenza agli evasi dal campo che si
trovavano ancora in città ed una all'ingegnere Ventafridda, direttore delle
«Acciaierie», perché avvisasse gli amici di Milano della situazione e della
sua cattura. Pur restando segregato, potè allacciare contatti con Laura
Conti, con Nella Mascagni, con il professor Leoni, Dal Fabbro e Pedrotti,
detenuti al pari di lui.
Vi rimase per quattro mesi, testimone dei quotidiani misfatti delle «SS», la
cui ferocia pareva accrescersi, paradossalmente, di fronte all'imminenza,
che tutti percepivano, della disfatta.
La sera del 28 aprile si diffuse nel campo la notizia che erano in corso
trattative tra la Croce Rossa Internazionale e il Comando del Campo per la
liberazione degli internati. La sera stessa si tenne una riunione del CLN
clandestino del campo e fu scartata la possibilità che era stata ventilata
tempo prima, di una rivolta degli internati disarmati contro le SS che li
custodivano.
Gli internati ricevettero un regolare Entlassungsschein, firmato dal
comandante del campo e con questo furono rilasciati. Il 30 aprile, dopo
gravi peripezie degli ultimi giorni, che fecero temere a tutti il pericolo
di una imminente fine, la Croce Rossa Internazionale, entrata dalla
Svizzera, trovò modo, pur tra incessanti difficoltà, di sbloccare la
situazione.
Testimonianze dal «Campo»
(Continua la ricerca Piccoli-Poznanski)
Orali:
hanno il grande valore dell'immediatezza, del provenirci direttamente da chi
ha vissuto certe esperienze in prima persona. Questa, oltre ad essere la
caratteristica che le rende così preziose ed interessanti, ne rappresenta
pur il limite maggiore. Innanzitutto per l'inevitabile soggettività di chi
testimonia e porta su di sé i segni fisici e psicologici di un passato
seppur così lontano. Poi per quella che è un 'inevitabile censura che la
memoria applica ad ogni dato che in lei risiede ed in particolare su
avvenimenti così dolorosi e traumatici, incidendo talvolta anche
considerevolmente, a livello inconscio, sulla realtà. Così avvenimenti
possono essere rimossi o «arricchiti» di particolari. In questo genere di
analisi ci si scontra poi spesso con quella che pare essere una strana
tendenza, insolitamente diffusa tra le persone che hanno vissuto la seconda
guerra mondiale: quella di voler insabbiare e dimenticare fatti tanto
dolorosi. Fattore questo che potrebbe forse portare a reticenze più o meno
volontarie.
Scritte:
potenzialmente potrebbero essere le più valide tra tutte. Si tratta di
lettere, cartoline, biglietti scritti in quel tempo, che avrebbero il solo
limite della inevitabile parzialità (limite, questo, che se riconosciuto con
un'attenta analisi, potrebbe in realtà fornire oggi ulteriori, preziose
informazioni). Purtroppo, però, le lettere da noi raccolte di internati del
campo di concentramento di Bolzano hanno rivelato un certo scrupolo, un
timore a parlare troppo realisticamente di ciò che in esso accadeva; una
rigida censura vagliava ogni messaggio e, oltre a cestinare quelli giudicati
illeciti, provocava dure punizioni verso chi trasgrediva alle regole. Per
quanto riguarda poi i biglietti usciti illecitamente, vi si trovano solo
vaghi accenni alle reali e crudeli vicende di vita nel Lager, in quanto i
prigionieri cercavano più che altro di fare elenchi di cose di cui
abbisognavano e di tranquillizzare le famiglie, evitando loro i particolari
più degradanti della loro condizione.
Testimonianza di LUIGI GATTI di Bolzano
Luigi Gatti, detto «Cianci», persona molto nota a Bolzano, è nato a Innsbruck nel 1920, da madre svizzera e padre italiano. È stato per numerosi anni insegnante di lingua italiana nelle scuole medie di lingua tedesca. Ha svolto e tuttora in parte svolge attività nel campo dello spettacolo e dell'intrattenimento
.
Quando è stato arrestato e perché?
Fui catturato i primi di gennaio a Bolzano. Mi avvicinarono due persone in
borghese, che poi si rivelarono per due SS. Mi condussero al loro ufficio di
Gries e da lì al Corpo d'Armata. Mi arrestarono perché ero disertore della
Repubblica di Salò. I repubblichini invece di mandarci al fronte contro
l'avanzata Anglo-americana, avevano deciso di impiegarci in rastrellamenti
contro i partigiani: compito ignobile che io non potevo sopportare. Ma i
nazisti ritennero di aver preso una staffetta o un emmissario del C.L.N. Per
tre giorni al Corpo d'Armata mi sottoposero a sevizie. Cercarono di
estorcermi confessioni, ma io non ero in grado rispondere anche se avessi
ceduto, perché in realtà non sapevo niente. Ogni tanto svenivo. Le sevizie
consistevano nell'attorcigliare fili elettrici dietro le orecchie e far
passare la scossa più forte dopo ogni domanda. Durarono tre giorni le
torture e le bastonature. Non ottenendo, ovviamente, nessun risultato, mi
inviarono nel carcere di Via Dante. Da lì al Lager di Bolzano, dove fui
assegnato al blocco K. Ricordo solo che quelli del blocco degli ostaggi
erano trattati meglio. Potevano comunicare con l'esterno, ricevere pacchi,
portati da qualcuno in portineria.
Come erano trattati gli ebrei?
Non potrei dirlo, penso che venissero trattati come tutti gli altri. La
domenica quando c'era un'ora o due di passeggiata si potevano vedere. Certo
per loro il destino era più oscuro perché destinati ai Lager in Germania.
Analoga sorte toccava ai politici. Anch'io dovevo seguire quella sorte, ma
grazie ai continui bombardamenti sulla linea del Brennero il mio convoglio
non partì. Rimanemmo fermi nel carro merci cinque o sei giorni logicamente
senza mangiare. Eravamo in 50 dentro un vagone. In campo parlavamo fra di
noi molto raramente:
non avevamo nulla da dirci. Il servizio sanitario era controllato dalle
guardie. Le persone che uscivano per andare a lavorare avevano modo di
comunicare con l'esterno. Certe volte portavano dentro sigarette, biglietti,
qualche cosa da mangiare.
Vorremmo sapere della sua giornata, a che ora si alzava, cosa le
portavano da mangiare, se lavorava?
La mattina molto presto dovevamo saltare già dal giaciglio a castello che
arrivava anche a tré piani. Questi letti erano di legno e sprovvisti anche
del pagliericcio. Seguiva l'adunata, se la memoria mi aiuta; con precisione
ricordo che l'adunata si faceva anche la sera prima di rientrare nei
blocchi. Dal campo uscivano le squadre che andavano al lavoro, gli altri
rimanevano dentro. Verso mezzogiorno ci portavano la minestra di cavoli e
qualche volta un pezzo di patata. Non vi era colazione. Forse qualcuno stava
meglio, questo dipendeva dalla guardia più o meno ligia. Una sera, spinti
dalla fame, i miei compagni arrivarono a farsi la minestra con la segatura,
che serviva per il riscaldamento della cella. Una famiglia a me molto cara,
i Nulli (La famiglia Nulli, di Iseo, era legata di stretta amicizia a
Rino Gatti, pure di Iseo, padre di «Cianci». I Nulli erano stati arrestati
per aver favorito partigiani della Val Camonica), mi fece avere
attraverso il capo campo, delle polpette che io poi divisi con i miei
compagni. I Nulli, che appartenevano al blocco ostaggi, avevano una radio
clandestina con la quale potevano ricevere radio Londra. Secondo una notizia
che mi venne riferita, il blocco degli ebrei era il più litigioso. Alla
sera, all'appello, bisognava uscire in fila ben inquadrati. C'era il comando
«Cappelli giù». Possedevamo infatti chi uno straccetto, chi un berretto, chi
un passamontagna. Eravamo rapati a zero, ma per distinguerci dagli altri,
noi politici avevamo una striscia di capelli in mezzo alla testa che ci
rinnovavano ogni due o tré giorni. Un mio compagno che non aveva obbedito
all'ordine «cappelli giù» fu picchiato a sangue da un certo Cologna (Cologna
era un sudtirolese, guardiano del campo, appartenente alla «Gendarmerie»)
Ancor oggi suscita in me una certa impressione il ricordo dei pidocchi. Ve
ne erano a manciate e non eravamo in grado di liberarcene in nessun modo. Ci
furono tentativi di fuga riusciti. Sarei potuto scappare anch'io, ma sapevo
che avrebbero preso i miei genitori come ostaggi. L'aviazione alleata cercò
di colpire con una bomba il campo per farci fuggire ma il suo tentativo
fallì.
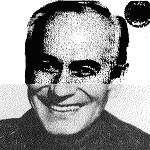
Testimonianza di NELLA MASCAGNI
Fu arrestata nel novembre
del '44 a Cavalese e trasferita alle carceri di Trento, dove rimase fino a
pochi giorni prima del Natale '44. La lasciarono libera nella speranza che
qualche compagno di lotta prendesse contatto con lei: i nazisti avrebbero
avuto modo di arrestare altri partigiani. Questo, per fortuna, non si
verificò. Fu nuovamente arrestata nel febbraio del '45 e internata nel campo
di concentramento di via Resia, a Bolzano, dove rimase fino alla
liberazione, che avvenne alla fine dell'aprile dello stesso anno.
La signora Mascagni era staffetta di una formazione partigiana che operava
in vai di Flemme; quando la formazione dovette sciogliersi, a seguito di un
rastrellamento compiuto dalle «SS», i superstiti si trasferirono in vai di
Non e si unirono ad altre forze partigiane, operanti in quella zona, dove
agiva anche una missione radio alleata, la «VITAL» che con la trasmittente
si era installata in una grotta sopra il lago di Molveno. La
rice-trasmittente era fatta funzionare dall'R.T. Brunetti, paracadutato
assieme alla radio, affiancato in questo suo compito dai partigiani,
anzitutto da Enrico Pedrotti e Andrea Mascagni.
Il compito di una staffetta era quello di portare ordini, di tenere i
contatti tra le varie formazioni in montagna e il comando del C.L.N. che
operava clandestinamente a Trento e a Bolzano. Aveva anche il compito di
trasportare armi, munizioni, viveri ed informazioni.
Tra giugno e dicembre del
'44 tutti i dirigenti della resistenza trentina e bolzanina furono
catturati, a Trento per delazione di un traditore, a Bolzano per una
spietata sorveglianza nazista alla quale il CLN e i suoi collaboratori non
riuscirono a sottrarsi.
Il campo si presentava diviso in due grossi blocchi che un tempo ospitavano
gli automezzi del Genio Militare. Al centro, fra i due blocchi, i nazisti
avevano costruito una serie di baracche adibite ad infermeria, cucina,
lavanderia e docce. Trasversalmente a questa serie di costruzioni,
parallelamente al muro di cinta del campo, fu costruito il «Blocco-Celle»
che ospitava intorno a 150 prigionieri, i quali, non essendo stati ancora
processati, erano a disposizione delle «SS». In questo Blocco Celle visse
per tutto il periodo dell'internamento la signora Mascagni. Nei blocchi
vivevano partigiani e prigionieri politici provenienti da altre carceri
italiane o dal campo di concentramento di Fossoli, che fu smobilitato
all'avvicinarsi delle truppe alleate alla Linea Gotica. I due comandanti del
campo di Fossoli divennero così comandanti del campo di Bolzano.
Della vita che si svolgeva nel campo la signora Mascagni poté sapere ben
poco, perché, come tutti gli internati delle celle, visse un lungo periodo
di segregazione in una cella da cui usciva solo per essere portata agli
interrogatori, su un furgoncino nero senza finestrini, al Corpo d'Armata,
dove era il comando della Gestapo. Se gli interrogatori non erano troppo
cruenti l'internato tornava al campo, mentre se veniva torturato e seviziato
rimaneva alcuni giorni nelle celle dei sotterranei del Corpo d'Armata.
I prigionieri del Blocco-Celle, e con loro la signora Mascagni, potevano
uscire ogni giorno all'aria per 20 minuti, ma non avendo alcun diritto al
lavoro dovevano trascorrere il resto del giorno nella loro cella (m. 2,50x1,
50), quasi impossibilitati a muoversi perché la maggior parte della cella
era occupata dal letto a castello. Il blocco celle ospitava quasi
esclusivamente prigionieri politici, partigiani e ostaggi.
C'era, anche un piccolo blocco di ebrei, sempre poco popolato perché essi
venivano mandati regolarmente, dopo una breve permanenza a Bolzano, in
Germania, nei campi di sterminio. I prigionie! dei blocchi, sia uomini che
donne, lavoravano all'esterno del campo stesso. Uscivano la mattina all'alba
in piccole squadre, con la divisa a righe degli internati, per essere
portati nei vari luoghi di lavoro: le donne lavoravano nella galleria del
Virgolo, dove era sfollata la ditta «I.M.I.» di Ferrara che costruiva
cuscinetti a sfere, oppure erano destinate alla pulizia delle caserme, delle
abitazioni dei vari ufficiali nazisti, o ancora venivano impiegate nella
sartoria del campo. Gli uomini erano addetti alla falegnameria del campo,
alla rimozione delle macerie dopo i bombardamenti, e al pericoloso
disinnescamento delle bombe inesplose. I lavoratori esterni erano i più
fortunati, perché dalla popolazione italiana delle Semirurali ricevevano
aiuti per il loro sostentamento. Gli internati dei blocchi vivevano però
sempre con l'incubo delle «chiamate», che per loro rappresentavano la
deportazione in Germania.
La vita nelle celle d'altronde era un inferno per la tensione continua, la
mancanza di movimento, l'incubo degli interrogatori e il terrore continuo
delle «morti notturne»; naturalmente anche i bisogni corporali venivano
soddisfatti nella cella, dove i detenuti avevano a disposizione un
recipiente di latta, detto «bugliolo». Nelle celle si conosceva anche la
fame più nera, perché, diversamente da quanto accadeva a coloro che
lavoravano all'esterno del campo, i detenuti delle celle non potevano
ricevere alcun aiuto dalla popolazione, e perciò erano costretti a subire il
più duro razionamento di cibo.
La generosità di tante persone libere non si limitava solo all'aiuto
alimentare. Accadeva spesso che si facessero tramite fra i detenuti e i loro
parenti, fornendo notizie e facendo pervenire lettere. Preziosa fu l'opera
dei ragazzini di 13-14 anni, che riuscivano ad intrufolarsi tra le squadre
di lavoro per «recapitare» biglietti, messaggi, lettere od altro. La
giornata nel campo per gli internati nei blocchi cominciava assai presto con
il famoso «appello» per controllare eventuali evasioni. Volutamente gli
internati erano lasciati a lungo in piedi con il ghiacciò, la neve, la
pioggia; poi venivano fatti rientrare e ricevevano una tazza «di liquido
nero». Il loro cibo consisteva in una minestra di rape o verze ed un pezzo
di pane nero sia a pranzo che a cena. Per gli internati delle celle il cibo
era più scarso, in quanto essi, secondo i carcerieri, «non producevano», e
consisteva in una tazza di liquido nero senza zucchero all'alba, in un
mestolo di piselli o ceci lessati senza sale a pranzo. Sulla superficie
della «minestra» navigavano strani vermiciattoli. Verso le sedici veniva
distribuita una pagnottella piuttosto piccola di pane spesso raffermo od
ammuffito, e il pasto serale ricalcava quello del mezzogiorno.
Verso i primi di aprile, anche per gli internati delle celle cominciarono ad
arrivare i primi pacchi del comitato di assistenza al campo (per la verità
molto pochi anche perché trattenuti dai «padroni» del campo) e quelli dei
familiari. L'assistenza al campo era stata
organizzata nel 1944, per la precisione nella tarda estate del '44 su
iniziativa di Lelio Basso alto esponente politico di Milano e, a Bolzano, da
Ferdinando Visco-Gilardi, che riuscì a coinvolgere un considerevole numero
di patrioti locali.
Un compito fondamentale della Resistenza a Bolzano fu quello di aiutare ed
assistere gli internati del campo non solo con viveri e vestiario, ma anche
organizzando le fughe. Tutte le fughe sono state infatti possibili grazie a
quel meraviglioso gruppo di partigiani che si sono prodigati fino al limite
delle loro forze, alcuni dei quali hanno sacrificato la loro vita ed altri
sono finiti nello stesso lager di Bolzano:
Manlio Longon, ucciso al Corpo d'armata, Visco-Gilardi e Dal Fabbro,
torturati e seviziati. Ed ancora Franca Turra, i coniugi Liberio ed altri
ancora. La
dottoressa Laura Conti di Milano, internata nel Lager, teneva il
collegamento con la signora Turra, la famosa «Anita», facente parte del
comitato di assistenza al campo per organizzare fughe di personaggi politici
che sarebbero sicuramente stati destinati alla deportazione, e quindi a
morte sicura. Le fughe avvenivano con difficoltà ma sempre con la preziosa
collaborazione degli abitanti delle Semirurali, veramente degni di
ammirazione nel rischiare le rappresaglie dei nazisti, ospitando anche per
più giorni i prigionieri evasi. Questi venivano poi prelevati dai compagni
delle cellule partigiane della «Lancia» e, per mezzo di camion che da
Bolzano tornavano a Torino, raggiungevano le formazioni partigiane del
Piemonte.
Nella Mascagni sottolinea ancora una volta come questa «resistenza senza
armi» sia stata fondamentale per la vita e la sopravvivenza degli internati:
molti di questi eroici operai delle fabbriche hanno pagato con la vita la
libertà altrui: infatti Beretta, Degasperi, Ferrari, Frattini, Masetti,
Meneghini e Trevisan furono catturati, inviati nel campo di Mauthausen, da
dove non sono più tornati. Di Degasperi rimane un biglietto alla moglie,
biglietto fatto passare attraverso lo spioncino del vagone merci del treno
che lo portava in Germania. Il centro di raccolta degli aiuti che giungevano
a Bolzano dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia di Milano era la
chiesa di Cristo Re. Qui i responsabili dell'assistenza al campo con l'aiuto
di civili antifascisti e degli stessi padri Domenicani confezionavano i
pacchi per gli internati. In verità al blocco celle ne pervennero molto
pochi, perché gli internati di questo blocco solo raramente potevano avere
contatti con gli altri internati, essendo sempre guardati a vista, durante
il passeggio, da «SS» armate.
Nella Mascagni precisa che
il primo pacco ricevuto, contenente pane, mele e polvere antisettica veniva
dal Vescovo di Belluno. Per quanto riguarda i suoi contatti con la famiglia,
fu aiutata da un suo ex scolaro della polizia trentina che a volte entrava
per servizio nel Lager. Tre o quattro volte riuscì a dargli un biglietto da
consegnare ai genitori. C'era anche una via regolare per scrivere ai
familiari, che imponeva lettere chiaramente false sulla realtà che gli
internati stavano vivendo; lettere che venivano regolarmente censurate.
Durante la sua permanenza al campo la Signora Mascagni ricorda di una
tentata fuga di due detenuti, non riuscita e della conseguente punizione: un
pestaggio tale da causare la morte dei due internati. Oltre che di episodi
agghiaccianti di sofferenze e soprusi, la signora parla pure di esempi di
grande solidarietà tra gli internati, i quali, uniti dallo stesso ideale, si
scoprivano più vicini che mai nel dolore, nell'angoscia e nel bisogno.
Molte volte le donne si sono rivelate dotate di grande coraggio. A questo
proposito è emblematico l'episodio di Tea Palman, staffetta di una
formazione partigiana nel Bellunese, già processata e condannata, che, per
aver fatto pervenire un biglietto compromettente fuori del campo, caduto in
mano alla Gestapo, fu portata al Corpo d'Armata, sede della Gestapo,
picchiata selvaggiamente per giorni e notti. Venne ricondotta in cella in
uno stato pietoso. Alla signora Mascagni, che chiese ai guardiani un po'
d'acqua per alleviare le sofferenze della compagna, fu risposto che l'acqua
non c'era, ma c'era sempre l'orina. Gli ultimi quindici giorni di prigionia
Nella Mascagni fu incaricata del compito di «scopina» delle celle, cosa che
le procurò il grande vantaggio di non essere chiusa a chiave. Essa ricorda
con una certa gratitudine un vecchio sergente alsaziano che le permetteva di
cuocere durante la notte qualche patata da dare ai compagni più provati; a
turno, qualche volta, li faceva nascostamente uscire dalle celle per farli
passeggiare un po'. Era vergognosa consuetudine che i guardiani nazisti si
appropriassero spesso dei pacchi che i familiari inviavano agli internati.
Il 21 e 22 aprile, mentre l'Italia settentrionale si preparava
all'insurrezione, i nazisti decisero di tinteggiare le celle e i detenuti
furono costretti a trascorrere la notte all'aperto, in attesa che il colore
asciugasse.
Il 28 e 29 aprile '45, tutti gli internati furono radunati al centro del
campo forse destinati alla sorte di quelli dei campi di sterminio nazisti.
Fu un momento drammatico per tutti. Improvvisamente si senti un suono di
claxon all'ingresso del Lager. Il cancello fu aperto ed entrò un automezzo
della Croce Rossa Internazionale da cui scesero il Dott. Zanoni, che insieme
ad altri medici aveva operato attivamente al centro di resistenza
dell'Ospedale, il Dott. Bonvicini, che fu il primo sindaco politico di
Bolzano dopo la liberazione, ed un ufficiale inglese.
I tre parlarono con il comandante del campo e dopo breve trattativa furono
messi al muro. Fu un momento di grande angoscia per tutti. Gli internati
vennero rimandati nelle loro baracche. La signora Mascagni ed il cuoco
ebreo, vinta la paura, rimasero a guardare, ma scoperti da una guardia delle
«SS» furono picchiati. Per fortuna l'intraprendenza del Dott. Zanoni e la
presenza dell'ufficiale inglese (giunto a Bolzano dalla Svizzera) ebbero il
sopravvento sull'ottusità dei comandanti nazisti (l'Italia era già tutta
liberata e gli Americani erano già alle porte di Bolzano). Dopo poche ore
iniziava l'evacuazione del campo.
Nella Mascagni
Lettera di Nella Mascagni
6-4-45
Miei cari, spero che quest'oggi venga
quel mio scolaro e di potervi fare avere così questo mio biglietto. Ho
passato una Pasqua tragica ma adesso tutto va bene. Per quanto il
campo sia zeppo non si parla più di partenze per la Germania. Non ho più la
febbre. Il prof. Meneghetti mi ha fatto pervenire in cella attraverso la Ada
delle aspirine, e la febbre è passata quasi del tutto. Le due guardie delle
nostre celle sono più feroci che mai, anche due notti fa hanno ucciso uno
che era appena arrivato. Passiamo notti da incubo. Mamma cara, domenica
attraverso un foro del legno che copre il finestrino della cella ti ho visto
vicino a Don Piola. Non venire più mammina, mi fa soffrire troppo vederti e
non poterti parlare. Se potete mandatemi sigarette. Il maestro Mascagni sta
un po' meglio. Io sono serena. Aspetto di essere libera e di volare da voi.
Vi bacia tanto la vostra Nella
Prima lettera alla famiglia
Cara mamma e caro papa,
sono nel campo di concentramento di Bolzano, non so se rimango qui o se ci
mandano in Germania, state tranquilli e non preoccupatevi per me. Vi mando
questo biglietto attraverso un mio ex-scolaro che ora è nella polizia
trentina, se potete, attraverso di lui, mandate un qualche cosa da mangiare
e qualche sigaretta. Soldi ne ho abbastanza. Qui con me ci sono tanti
compagni, ho visto Pedrotti, se vedete la moglie ditele che sta bene (abita
in via Padre Giuliani al numero 1).
Vi bacio tanto tanto. State tranquilli. Io sono forte.
la vostra Nella