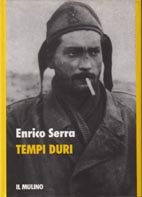Estratto da:
Enrico Serra
TEMPI
DURI
Guerra e Resistenza
Società editrice il Mulino
|
Enrico Serra (1914), dopo essersi laureato in Giurisprudenza con una tesi di Diritto internazionale (1937), ha lavorato all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi). Nel 1940-42 ha combattuto in Africa, sul fronte libico, e in seguito ha preso parte alla Resistenza. È decorato di medaglia d'argento sul campo, di una Croce di guerra al valor militare e di quattro Croci al merito di guerra. Dopo il conflitto mondiale è stato ancora all'Ispi, ha lavorato al giornale «Italia libera» e in seguito all'ÀNSA di Londra e di Parigi. Dal 1961 ha insegnato Relazioni internazionali nell'Università di Bologna. Dal 1972 al 1992 è stato capo del Servizio storico e documentazione e dell'Ufficio studi del ministero degli Esteri. Nel 1986 è stato eletto socio corrispondente dell'Institut de France. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di storia della politica estera e della diplomazia italiana, tra le quali vanno ricordate: Alberto Pisani Dossi diplomatico (1987); La diplomazia in Italia (1988); L’Italia e le grandi alleanze nel tempo dell'imperialismo. 1870-1915 (1990). È inoltre autore del Manuale di-storia delle relazioni internazionali e diplomazia, giunto all'ottava edizione. |
Il
campo di concentramento di Bolzano
Nella primavera del 1944 l'attenzione di chi si occupava dell'assistenza e
dell'evasione dei prigionieri politici si spostò dal campo di concentramento
di Fossoli, alle porte di Carpi (Modena), a quello di Bolzano, dove venivano
raccolti i patrioti, prima del loro arrivo ai campi della Germania.
Fu anche per questo che «Maurizio» mi chiamò e mi incaricò di recarmi a
Bolzano per un sopralluogo. Aveva avuto notizia che in quel campo di
concentramento si trovavano molti compagni di Giustizia e Libertà, tra cui
Roberto Lepetit e il figlio di un consigliere delegato dell'Edison, Bobbio.
C'erano anche due miei cari amici della cellula creata, insieme a Sandro
Migliazza e Mario Giuliano, nella università Statale di Milano allora in via
del Conservatorio; e precisamente Piero Ziccardi e il giovane assistente
Armando Sacchetta, che morì di cancrena nel campo di concentramento, in
seguito all'amputazione di una gamba per ferita d'arma da fuoco.
Mi recai come al solito ad un nostro recapito segreto, ch'era, come già
scrissi, l'Ufficio studi della Banca Commerciale Italiana in piazza della
Scala di Milano, diretto dall'intrepido La Colla. .Ivi mi incontrai con
Giannantonio Manci, che mi diede i primi ragguagli sulla situazione
altoatesina e con l'intrepido avvocato Mario Jacchia.
Uscimmo e ci fermammo a chiacchierare sulla piazza, all'angolo con via
Manzoni. C'era un sole abbastanza caldo: passò, bellissima, una giovane
studentessa delle Belle Arti, che conoscevo e con la quale mi fermai a
discorrere un poco. Era l'Anna Mella di Sant'Elia che più tardi doveva
sposare il valoroso comandante partigiano Edgardo Sogno. Il ricordo mi è
rimasto indelebile perché legato al contrasto tra la giovinezza con tutte le
sue promesse, ed i due che non molto dopo dovevano incontrare la stessa
tragica fine.
Bolzano era, come è noto, territorio sotto diretto controllo della Germania
nazista, che non vi aveva permesso neppure la ricostituzione del Partito
fascista. Vi si poteva accedere solo con uno speciale permesso delle
autorità tedesche, che si doveva esibire ad ogni occasione. Non averlo,
com'era il caso mio e di altri compagni, significava disporre del più
sicuro... passaporto per le carceri e peggio. In compenso l'oppressione
tedesca (anche di una parte della popolazione allogena) aveva rafforzato
l'unità degli italiani: gli stessi fascisti avevano chiesto di poter
partecipare alla lotta di liberazione.
A Bolzano si arrivava a bordo di autocarri che facevano la spola tra Milano
e quella zona industriale, soprattutto delle «Acciaierie». Si sceglieva
ovviamente di viaggiare di notte. Quando si arrivava nei pressi di Riva del
Garda, dove c'era un posto di blocco tedesco che eseguiva i controlli, ci si
infilava sotto il tendone dell'autocarro rannicchiandosi in mezzo alle casse
e ai carichi. E così si faceva a Salorno, ed ogni qualvolta il conducente
segnalasse dei raggruppamenti sospetti di militari tedeschi.
Il punto di riferimento che mi era stato dato si rivelò eccezionale sotto
tutti gli aspetti, quasi a significare quell'inesauribile fonte di liete
sorprese che rimane, con tutti i suoi difetti, il nostro Paese.
Si
chiamava Ferdinando Visco Gilardi, alias «Giacomo». Credo di averlo
conosciuto meglio di molti altri, perché nelle lunghe notti in cui eravamo
costretti a starcene nascosti, si apriva con me, riandando il suo fortunoso
passato. Ebbi quindi modo di stringere con lui e con la sua indimenticabile
moglie (passata a miglior vita in ancor giovane età) affettuosi legami di
stima e di amicizia, sempre continuati nonostante qualche successiva
diversità di opinione politica, e nonostante la lunga lontananza.
A Bolzano si occupava di affari, vendeva ossigeno; ma non era difficile
scoprire in lui l'uomo di studio, di origine crociana con il quale era
piacevole e fruttuoso conversare di temi politici e culturali. Ricordo
ancora, nella prima delle mie quattro o cinque missioni, alcune simpatiche
riunioni nella sua casa ospitale, la moglie sempre sorridente, dolce, di
un'innata religiosità (erano entrambi protestanti) tra una vera nidiata di
figlioli, tutti belli e sorridenti, cui non avevano esitato ad aggiungere un
altro bambino, di lontana parentela, che allevavano amorosamente come gli
altri.
La maggior parte della sua vita, Gilardi l'aveva trascorsa tra i libri.
Aveva fatto l'editore di opere di alta cultura, destinate ovviamente ad un
pubblico ristretto sotto un regime che professava l'anticultura. Aveva
diretto una «Collana delle idee» con opere di Buonaiuti e di Rensi. Nel 1934
pubblicò un libro di saggi di filosofia politica dovuto alla penna di
Benedetto Croce, dal titolo Orientamenti, che raggiunse presto la
terza edizione. In uno di quegli scritti, dedicato alla dottrina dello
Spengler esaltante la superiorità della razza germanica su «i popoli di
colore» - tra cui lo Spengler annoverava «gli abitanti della Russia e di una
parte dell'Europa meridionale ed orientale-meridionale», cioè spagnoli,
italiani, balcanici - Croce non gli risparmiava i suoi strali più feroci e
definiva l'autore un «imbecille-disperato». Si capisce come la casa editrice
Gilardi e Noto non potesse avere vita lunga...
Il buon Ferdinando aveva lasciato la sua cara Milano senza smarrirsi
d'animo, senza perdere quella fiducia nel vero è nel buono, ch'era la sua
qualità più bella. Era giunto a Bolzano, come amava ripetermi, per puro
caso, rispondendo ad una inserzione di giornale. E si era subito fatto, nel
giro di solo quattro anni, una invidiabile posizione personale, una rete di
amicizie sicure e fidate. Venute le ore buie per l'Italia, era entrato nella
Resistenza in modo del tutto naturale, aderendo alle formazioni Giustizia e
Libertà, un'adesione in realtà che aveva già dato molto prima sul piano
culturale.
Conservo ancora preziosamente il libro di Gaetano Salvemini Dal Patto di
Londra alla Pace di Roma, nella rara edizione di Piero Gobetti, 1925,
ch'egli volle allora donarmi conoscendo l'inclinazione dei miei studi. Sul
libro, con la data 1° agosto 1947, lo stesso Salvemini, appena rientrato in
Italia, volle apporre la dedica: «ricordo di buona amicizia».
Guidato da «Giacomo» potei fare una prima ricognizione del campo di
concentramento. Rimasi sorpreso della relativa libertà di cui godevano quei
prigionieri, che venivano portati fuori dal campo a coltivare degli orti nei
pressi del cosiddetto «villaggio italiano». La scorta era formata da soldati
anziani, palesemente richiamati e ritenuti inabili per il fronte.
Dalla finestra del primo piano di una di queste minuscole casette intorno a
via Piacenza, un'anziana signora parlava, talvolta in tedesco e talvolta in
francese, con una internata, una figliolona assai spigliata, che mi dissero
essere, la moglie austriaca di Indro Montanelli. Scambiai anch'io qualche
rapida e circospetta parola con due o tre prigionieri.
Nel primo pomeriggio, la colonna degli internati, accompagnata dalla modesta
scorta di territoriali, rientrava al campo di concentramento, donde usciva
in analoghe circostanze la mattina dopo. Mi sorprendeva il fatto che in
queste condizioni propizie, ben diverse da quelle del campo di Fossoli, le
fughe fossero poche ed occasionali. Poi mi resi conto dai biglietti che
riuscii a scambiare con alcuni prigionieri, tra cui Ziccardi e Lepetit, che
la maggior parte degli internati era caduta in una specie di apatia,
alimentata in parie dalla convinzione della fine imminente della guerra, in
pane dalla paura delle rappresaglie verso i congiunti. Nessuno del resto
poteva immaginare gli orrori inumani, più spesso la fine straziante, che
sarebbero toccati a coloro che venivano avviati ai campi di sterminio della
Germania.
Fu quindi relativamente facile far pervenire ai prigionieri denaro, viveri,
e... «seghetti». Solo dopo le prime, consistenti fughe, il servizio di
sorveglianza si fece più rigoroso; furono proibite le uscite dal campo, dove
fu instaurato un regime di terrore.
«Maurizio» fu sempre largo di consigli e di aiuti. Poco a poco riuscii a
portare a Bolzano tutto l'occorrente per falsificare carte di identità e
lasciapassare.
Con «Giacomo» avevamo costituito una cellula piccola, ma molto attiva. Ne
facevano parte Marcello Caminiti, Manlio Longon, Enrico Pedrotti (Marco),
Luciano Bonvicini. un farmacista con il figliolo adolescente, un carabiniere
dei servizi segreti e pochi altri.
Purtroppo
l'abitudine che avevamo presa di voler sapere solo l'indispensabile, per
evitare di parlare sotto la tortura, e di non tenere note scritte, mi
impediscono ora di mettere in giusta luce altre collaborazioni. Soltanto nel
giugno del 1945, dopo la Liberazione, quando «Maurizio» mi inviò in Alto
Adige per una missione conoscitiva della situazione, presi degli appunti-in
cui ritrovo, per Bolzano, dove si accentuavano le critiche al neo-prefetto
Bruno De Angelis,
che aveva Ferdinando Gilardi come vice prefetto,
i nomi di Nazari, Nolet, Piccinini, Pasa, Leardini, Policaro, Bacci, Amato,
Di Stefano, Beccara, Dal Fabbro, Bonvicini, Zanoni, Don Longhi, Facchin,
Benedetti, ecc.
Tra i collaboratori, di cui ho dimenticato il nome, vorrei citare un giovane
operaio comunista, «Frigo», che serviva di collegamento con il campo. Caduto
come molti altri nelle mani delle SS. dovette promettere sotto tortura di
tarmi arrestare. Fu così portato a Milano, dove in effetti mi vide mentre
sceglievo dei libri da una bancarella in piazza Fontana; naturalmente passò
oltre, con il suo seguito di SS, senza... riconoscermi. Un altro
collaboratore assai utile fu un commissario meridionale della Questura.
Su tutti spiccava e di gran lunga la personalità di Manlio Longon, padovano,
direttore amministrativo della «Magnesio», uomo di grande cultura e
patriottismo. Lo vidi per la prima volta nel suo ufficio presso la
«Magnesio», e mi offrì la sua piena disponibilità per la lotta di
liberazione. Si professava allievo del professor Meneghetti dell'università
patavina.
L'ultima volta che lo vidi fu a Milano, nell'autunno, in un ristoro di Porta
Venezia dove mi aveva invitato. Mi espresse tra l'altro le sue
preoccupazioni perché si sapeva controllato dalla polizia tedesca,
che aveva già fatto una prima visita nel suo ufficio. Lo scongiurai di non
rientrare a Bolzano, mi rispose che doveva farlo, anche perché aveva
lasciato là la moglie e quattro figlie.
Venne poi arrestato dalle SS e torturato per alcuni giorni.
«Giacomo», ossia Gilardi, che si trovava in una cella vicina alla sua, lo
sentiva urlare per il dolore, quando lo riconducevano dopo l'interrogatorio.
Una notte sentì i passi delle SS, che riportavano in cella il corpo del
Longon e lo gettavano sul giaciglio. «Giacomo» si rese conto dal silenzio
che doveva essere già morto.
Fu decorato di medaglia d'argento alla memoria, una ricompensa
inferiore ai suoi meriti.
Insieme a «Giacomo» approntammo due distinti piani di fuga.
Uno, che
doveva servire per Bobbio, era molto semplice. Si trattava di lasciare una
bicicletta, con una giacca sul .manubrio appoggiata al muro di una delle
casette del villaggio italiano, dove i prigionieri venivano accompagnati a
lavorare. Bobbio avrebbe dovuto .inforcarla, indossare la giacca ed
allontanarsi: all'angolo della strada uno dei nostri lo avrebbe affiancato
ed accompagnato ad un rifugio sicuro.
Bobbio non poté o piuttosto non volle farlo. Ne approfittò invece Luigi
Cinelli; un comunista il quale fu così lesto, che quando arrivai sul posto
all'ora convenuta, era già scappato. Dovemmo tenerlo nascosto circa una
settimana prima di trovare il modo di spedirlo a Milano. Si prestò al
trasporto il proprietario di un camioncino, che fu giocoforza raggiungere a
mezzanotte, in pieno coprifuoco alla periferia di Bolzano. Cinelli arrivò a
Milano sano e salvo.
L'altro sistema studiato per Lepetit, era più complicato ma altrettanto
sicuro. Lepetit avrebbe dovuto accusare dolori appendicolari/per cui era
previsto il ricovero all'ospedale civile di Bolzano. Di là sarebbe stato
fatto fuggire, lungo un passaggio poco noto che comunicava con la chiesa
dell'ospedale. Tutti i medici e gli infermieri da noi contattati si erano
dichiarati disponibili ad aiutarci. Al resto avremmo pensato noi.
Purtroppo Lepetit, che lavorava nell'infermeria del campo cui aveva fatto
arrivare grossi quantitativi di medicinali, aveva ricevuto assicurazioni dal
tenente medico tedesco che non sarebbe stato inviato in Germania. E così non
volle o non poté tentare la fuga. Il risultato fu che Lepetit, Bobbio e
tanti altri cari amici finirono nei campi di sterminio tedeschi da cui non
sono più tornati. Da Mauthausen ritornò invece Piero Ziccardi, allo stremo
delle forze.
Il. piano «Lepetit» servì ugualmente ma per un altro: l'avvocato Luciano
Elmo di Milano. Servendosi dei seghetti da noi forniti, molti prigionieri
assiepati nei carri bestiame dei convogli ferroviari diretti in Germania
riuscirono a segare le sbarre dei finestrini e a gettarsi dai treni in
corsa. Alcuni rimasero feriti nella caduta, e tra questi appunto l'avvocato
Luciano Elmo di Milano, che riportò la frattura di un braccio, un vistoso
taglio sul viso da orecchio a orecchio e altre ferite varie. Raccolto
semisvenuto da contadini, venne avviato all'ospedale.
Il giovane figlio del farmacista di Bolzano, Bonvicini, venne ad avvertirmi
che se non avessimo subito prelevato l'avvocato Elmo dall'ospedale, sarebbe
stato sicuramente arrestato, avendo dovuto il piantone di servizio segnalare
alla Questura il suo ricovero per ferite. Accompagnato dal giovane mi recai
all'ospedale civile con due biciclette, di cui una da donna, e mi appostai
davanti alla porta della chiesa: contemporaneamente feci avvertire i medici.
Poco dopo l'avvocato Elmo, accompagnato da un infermiere uscì: aveva il
volto vistosamente bendato ed un braccio ingessato. Dovemmo aiutarlo per
farlo salire sulla bicicletta. Lo guidai, spesso sospingendolo tra lo
stupore dei passanti a casa di Caminiti, dove purtroppo non c'era nessuno.
Non mi rimase che condurlo, passando di nuovo davanti al comando tedesco con
tanto di sentinelle, alla «Magnesio» dove Longon lo fece nascondere
temporaneamente in una cantina. Scesa la notte, potemmo trasferirlo in un
ricovero più sicuro, mandargli un medico e quindi avviarlo a Milano.
In quei giorni ci trovammo a dover nascondere oltre una ventina di evasi: il
che voleva dire nutrirli, vestirli, fornirli di documenti ed avviarli verso
Milano. Tra questi c'era anche il notaio Neri, un repubblicano romagnolo,
ferito alla testa e febbricitante, che aveva trovato rifugio nel garage di
un fascista. Il quale però non denunciò né lui né me, né il medico che si
recò a curarlo. Altri evasi, rimasti più o meno indenni nel salto dal treno,
preferirono evitare Bolzano e dirigersi subito all'avventura verso-sud.
Questo fu il caso dello studente olandese Walter De Hoog coraggiosissimo,
ch'era un diretto collaboratore di Parri e di Alberto Cosattini.
Durante la mia permanenza a Bolzano, ricevevo di tanto in tanto da parte di
«Maurizio» e di «Somma» (alias: Fermo Solari, poi senatore socialista)
l'invito ad occuparmi di altri problemi. Compii una missione in Cadore e due
a Trento, in momenti in cui l'organizzazione della Resistenza incontrava
delle difficoltà specie. dopo l'eroico suicidio Manci che torturato per non
parlare si era gettato da una finestra del comando. Mio compito era quello
di informarmi della situazione. Fissarmi tutto nella memoria e poi riferire
a Milano.
A Trento incontrai comandanti partigiani, esponenti del
pda, tra cui Ivo Perini, ed un paio di ufficiali effettivi
datisi alla macchia.
Fu
così possibile rimettere in funzione, anche con il prezioso aiuto di
«Giacomo», una struttura organizzativa paramilitare.
Ho sempre sperato che Gilardi scrivesse il resoconto dettagliato di quest'attività,
come mi aveva promesso. Purtroppo egli venne arrestato nei rastrellamenti
che ebbero luogo dall'autunno in poi. Finito in campo di concentramento,
durante la prigionia lasciò il pda
per entrare in quello comunista, da cui ricevette nuovi e
diversi compiti: fu il primo vice prefetto di Bolzano. Quando finalmente
poteva dedicarsi ai ricordi, fu colto da improvvisa morte nel 1970. Forse
tra le sue carte si potrebbero ancora trovare indicazioni preziose.
Spionaggio a Bolzano
Bolzano, ed in parte anche Trento, erano di estremo interesse per
l'intensa attività politica e spionistica che vi si svolgeva, in previsione
della fine della guerra.
Assai attivi erano in questo senso gli esponenti della popolazione di lingua
tedesca tra cui la potente famiglia Amonn, proprietari terrieri e
commercianti di frutta, che avevano optato per l'Italia. Ebbi alcuni
colloqui segreti con il più giovane dei due fratelli Amonn, Erich, di
sentimenti filocattolici ed antinazisti, per cercare di trovare quantomeno
degli elementi per un programma comune immediato: oltre tutto si trattava di
salvare il salvabile delle centrali elettriche, delle attrezzature
industriali di Bolzano e di quanto i comandi tedeschi stavano accumulando
nel «ridotto» alpino. Presaghi della fine, gli ufficiali tedeschi vivevano
in modo orgiastico - le notti piene di canti, di festini, di baccanali e...
peggio - che:non lasciavano prevedere nulla di buono..
Il ricordo di Erich Amonn è quello di un interlocutore educato, cortese, ma
irremovibile: nessuna intesa fu possibile. Da molte parti del resto
raccoglievo informazioni che gruppi di allogeni stavano organizzandosi, in
vista di una secessione dall'Italia al momento della Liberazione. Facevano
eccezione le cellule comuniste di lingua tedesca, combattive ma assai
limitate di numero. Il basso clero era in parte austriacante.
Oltre alla propaganda in favore del «Südtiroler Volkspartei», venivano
distribuiti degli «Ausweis» del « Südtiroler Widerstands bewegung Andreas
Hofer», che aveva come emblema l'aquila del Tirolo austriaco; venivano anche
distribuite bandiere tirolesi-austriache.
Nella regione pullulavano agenti segreti di vari paesi, soprattutto inglesi
ed americani, individuabili perché frequentavano gli stessi nostri ambienti.
Attivi erano quelli francesi della missione «Clairval», che aveva riesumato
nientemeno che il programma del generale Foch di creare uno Stato cattolico,
con funzioni di cuscinetto, unendo la Baviera con il Tirolo austriaco e con
quello italiano. Raccolsi tessere e documenti di questa iniziativa
che-qualche anno dopo consegnai a Salvemini. Si diceva allora che il
progetto francese avesse raccolto l'adesione, probabilmente strumentale, del
prefetto Tinzl e di alcuni maggiorenti allogeni.
Era molto difficile raccapezzarsi in una tale situazione nonché vagliare le
molte informazioni che affluivano in continuazione. A dare un tocco di
diverso carattere a questo scenario, venni a sapere che da mesi
giungevano regolarmente a Bolzano autocarri carichi di quadri, arazzi,
tappeti, statue ed altri tesori artistici. asportati dai tedeschi in varie
località italiane (Siena e Genova soprattutto). Venivano stipati nel palazzo
Reale dove furono sistemate anche una ventina di casse del tesoro
numismatico di Vittorio Emanuele III. Il mio bravo informatore mi fece
sapere che tra i quadri c'erano alcuni «Tintorello» (!?).
Che cosa si poteva fare? Quello che preoccupava maggiormente gli italiani
che prestavano servizio nel castello Reale, dove alloggiava il Generale
Wolff con la famiglia, era il comportamento dei militari tedeschi, tra cui
il capitano Spengler ed il sergente maggiore Haase. Il palazzo era pieno
zeppo di cibi prelibati, di vini e di liquori delle migliori marche,
razziati un poco dovunque. Ogni sera era baldoria, una specie di sagra che
ricordava da vicino certi paradigmi del romanticismo tedesco. La
preoccupazione che alla fine avrebbero incendiato il palazzo e distrutto i
tesori d'arte ivi accumulati - solo una parte era stata inviata in Germania
o a Campo Tures - fu assai grande. Per fortuna prevalse il lato luculliano:
quando verso la metà di maggio del 1945 arrivarono le truppe alleate, il
generale Wolff ed i suoi collaboratori stavano per celebrare con un gran
pranzo una delle tante ricorrenze ad hoc.
Fu per me un distacco doloroso dall'Alto Adige. Ma mi confortava la
convinzione di aver lasciato colà un gruppo di persone di grande
patriottismo, coraggiose e di assoluta integrità morale.
L'autunno del 1944 fu assai duro per la Resistenza, in Alto Adige e
dovunque: l'ultimo colpo di coda del serpente nazista.
A Milano, a causa delle infiltrazioni di spie, le retate di patrioti si
susseguirono alle retate, colpendo gravemente il movimento azionista. Venne
preso anche «Maurizio», e la sua assenza ebbe conseguenze gravissime
sull'organizzazione del pda,
alla vigilia della Liberazione.
Con Leo Valiani, Mario Paggi, Giuliano Pischel, Fermo Solari, Vittorio Foa,
Mario Dal Pra, Bepi Signorelli, Alberto Cosattini ed altri dovemmo dedicarci
a riannodare le fila in Lombardia e in Emilia.