UNA
‘ANTOLOGIA’ DI TESTI RACCOLTI DA
FERDINANDO VISCO GILARDI
Autunno 1969
“Molto
belle e dotte pagine sparse,
dovute a diversi eccellentissimi autori,
in cui si ragiona di cose riguardanti la vita degli uomini,
la natura e l'arte,
trascelte da un amante dei retti pensieri e dei sentimenti gentili
in codesto incipiente autunno,
per il diletto e l'ammaestramento dei diletti Amici.”
f.v.g.
INDICE
1 - Della superstizione (Francesco
Bacone)
2 - Dei giardini (Francesco
Bacone)
3
– Offerta (F.D.E. Schleiermacher)
4 – Sondaggio (F.D.E.
Schleiermacher)
5 - Filosofia della natura (J.
W. von Goethe)
6 - Frammento sulla natura (J.
W. von Goethe)
7 - Canto degli spiriti sopra l'acqua (J. W. von Goethe)
8 - Canzone di maggio (J. W.
von Goethe)
9 - Dal contrasto fra emozione e passione (Immanuel Kant)
10 – Frammento (Novalis)
11 - Dignità dell'uomo (G.
Pico della Mirandola)
12 - Alcune parole sulla universalità e l'amore nell'arte (W.
H. Wickenroder)
13 - Della vera libertà del Sapiente (C. Bovillus)
14 - Mischie di pioggia e di venti (Leonardo da Vinci)
15 – Facezia (Leonardo da
Vinci)
16 - Il negromante (Benvenuto
Cellini)
17 - Della virtù nell'arte medica (Paracelso)
18 - Della differenza esistente fra gli uomini (M.
G. de Montaigne)
19 - Dell’incostanza e delle nostre azioni (M. G. de Montaigne)
20 - Quanto sia ingiusto il risentimento verso quelli che mancano di
riconoscenza (P. Nicole)
21 - Osservazioni su parecchi difetti delle giovinette (F.
Fenelon)
22 - Uomo di fondo, uomo assennato (Baltasar Gracian)
23 - Sui cenni con l'occhio (Ibn
Hazm)
24 - Sulla corrispondenza epistolare (Ibn Hazm)
25 - Ascesi ed erotismo (Rosa
Mayreder)
26 - Un diario (Enrico
Federico Amiel)
27 - Cultura estetica e ascetismo (Edoardo Tagliatatela)
28 - Erotica ed estetica (Otto
Weininger)
29 - Una lettera e alcune altre (M. von Kleist)
30 - Lettere d’amore di una monaca portoghese (1665-1667 - ?) (Mariana
Alcoforado)
31 - Una lettera di Kant (1792) (Immanuel Kant)
32 - Qualche lettera di Flaubert a Louise Colet (Gustave
Flaubert)
33 - Beethoven, Bettina Arnim-Brentano e Goethe
34 - Ancora dal “giornale intimo” di Amiel (a proposito di Goethe) (Enrico
Federico Amiel)
35
– Mignon (J. W. von Goethe)
36 - I sacrifici che valgono (Giovanni
Ferreri (l884- ?)
37 – L’Evangelo della ragione (Gotthold Ephraim Lessing)
38 - La vittoria sulla caducità (V. Solovev)
39 – Pestalozzi (Giovanni
Niederer)
40 – Fondamenti per prolungare la vita (Giovanni Amos Comenius)
41 - Il fenomeno puro (J.
W. von Goethe)
42 - Materia ed etere (Günther
Wachsmuth)
43 - Il pensiero al servizio della comprensione del Mondo (Rudolf
Steiner)
44 - L'idea della libertà (Rudolf
Steiner)
45
- Goethe e Hegel (Rudolf Steiner)
46 - Friedrich Nietzsche e la psicopatologia (Rudolf Steiner)
47 – Le concezioni radicali del mondo (Rudolf Steiner)
48 - Scienze naturali e vita dello spirito (Rudolf Steiner)
49 - Premesse ad una “Conoscenza soprasensibile del mondo e
dell’uomo” (Rudolf Steiner)
50 – Introduzione al tema: “Pensiero umano e pensiero cosmico” (Rudolf
Steiner)
51 - Della questione sociale (1919) (Rudolf Steiner)
52 - Brano de “La mia vita” di Rudolf Steiner (Rudolf
Steiner)
53 - Altro stralcio da un’”Autobiografia” (Collingwood)
54 – Del “Manifesto” (Antonio
Labriola)
55 - Del materialismo storico (Antonio Labriola)
56 - Dai “Principi del comunismo” (1847 ?) (Friedrich Engels)
57 - Per la storia della “Lega dei Comunisti” (Friedrich
Engels)
58 - Una lettera di Antonio Labriola a Friedrich Engels (Antonio
Labriola)
59 - Una seconda lettera di Labriola a Engels (Antonio
Labriola)
60 - Sull’alienazione: 1. Sulla produzione della coscienza (Karl
Marx, Friedrich Engels)
61 – Sull’alienazione: 2. Il lavoro estraniato (Karl
Marx, Friedrich Engels)
62 - Della guerra di indipendenza in Italia (Karl Marx)
63 - Da “Rivoluzione e controrivoluzione in Germania” (Karl
Marx)
64 - Una lettera della moglie di Carlo Marx (Jenny Marx)
65 - Sulla tomba di Marx (Friedrich
Engels)
66 – I destini storici della dottrina di Carlo Marx (Nicolaj
Lenin)
67 - Rappresentazione borghese volgare della dittatura e come Marx
concepiva quest’ultima (Nicolaj
Lenin)
68 - Il crollo della seconda Internazionale (Zinoviev e Lenin)
69 - L'epoca rivoluzionaria (Lev
Trotzky)
70 – L’Esercito rosso (Lev
Trotzky)
71 – Come organizzare l’emulazione? (Nicolaj Lenin)
72 - La IIIª Internazionale e il suo posto nella storia (Nicolaj
Lenin)
73 - Lenin è morto (Iosif
Stalin)
74 - Da “I principi del leninismo” (Iosif Stalin)
75 - Deviazioni nel campo della questione nazionale (Iosif
Stalin)
76 – L’ideologia dell'imperialismo (1910) (Rudolf Hilferding)
77 – La funzione principale dello Stato (Paul M. Sweezy)
78 - L’imperialismo (Maurice
Dobb)
79 - Violenza e legalità (1902) (Rosa Luxemburg)
80 - Formazione dell’”armata di riserva” (1909) (Rosa
Luxemburg)
81 - Le tendenze dell’economia capitalistica (1909) (Rosa
Luxemburg)
82 - Il partito socialista italiano (1911) (Rosa Luxemburg)
83 - Alla redazione del “Labour Leader” di Londra (Rosa
Luxemburg)
84 - Ai proletari di tutti i
Paesi (1918) (Rosa Luxemburg)
85 - La controrivoluzione (Antonio
Gramsci)
86 - L’Internazionale comunista (Antonio Gramsci)
87 - Primo: rinnovare il partito (Antonio Gramsci)
88 - Lo Stato italiano (Antonio
Gramsci)
89 - Partito e frazione (Palmiro
Togliatti)
90 - Contro il pessimismo (Antonio
Gramsci)
91 - Sulla contraddizione (Mao
Tse Dun)
92 - Il movimento (cinese) del 4 Maggio 1919 (Mao Tse Dun)
93 - Contro il “liberalismo (Mao
Tse Dun)
94 - Il volto del nazifascismo (1941) (Palmiro Togliatti)
95 - La classe operaia e la partecipazione al governo (giugno 1944) (Palmiro
Togliatti)
1
- Della superstizione (Francesco Bacone)
Meglio sarebbe non avere affatto
alcuna opinione di Dio che averne una indegna di lui; ché l'una cosa è la
miscredenza, l'altra è la contumelia: e certo la superstizione è un
vilipendere la Divinità. Ben dice Plutarco a questo riguardo: "Sicuramente
avrei più caro che molti uomini dicessero che non ci fu mai un uomo chiamato
Plutarco, anzi che dicessero che ci fu un tale Plutarco che soleva mangiare i
suoi figli appena nati; come i poeti narrano di Saturno. E, come la contumelia
è maggiore verso Iddio, così maggiore è il pericolo per gli uomini. L'ateismo
non preclude l'uomo dal buon senso, dalla filosofia, dalla pietà naturale,
dalle leggi, dalla reputazione: tutte cose che posson guidare a una virtù
morale esterna, anche senz’esserci religione; ma la superstizione le abbatte
tutte, ed instaura una monarchia assoluta nella mente degli uomini. Per cui
l'ateismo mai non produsse perturbazione negli Stati; perché esso rende gli
uomini attenti a se stessi, dato che non guardan più in là; e noi vediamo che
i tempi proclivi all'ateismo (come l'epoca di Augusto) furon tempi civili;
laddove la superstizione è stata la confusione di molti Stati, e introduce un
nuovo “primum mobile” che priva tutte le sfere di governo. Maestro della
superstizione è il popolo; e in ogni superstizione i saggi seguon gli stolti; e
gli argomenti sono adattati alla pratica in ordine inverso. A ragione fu detto
da uno dei prelati del Concilio di Trento, in cui predominava la dottrina degli
scolastici, "che gli scolastici erano come astronomi che fingono
eccentriche ed epicicli, e congegni di orbi per preservare i fenomeni, pur
sapendo che tali cose non esistono affatto”; e, del pari, gli scolastici
avevano creato un certo numero d'assiomi e di teoremi sottili e intricati, per
preservare il culto della Chiesa. Son cause di superstizione riti e cerimonie
gradevoli e sensuali; eccesso di santità esterna e farisea; eccessiva reverenza
per tradizioni che non possono che gravare sulla Chiesa; gli stratagemmi dei
prelati per la loro ambizione e il loro guadagno; il favorir troppo le buone
intenzioni, il che apre la via a disegni e novità; l’alludere a cose divine
per interessi terreni, che non può che produrre contaminazione d'immagini; e
infine barbarie di tempi, specialmente se s'accompagna con calamità e disastri.
La superstizione senza velo è cosa deforme; poiché come aggiunge deformità
alla scimmia l'esser tanto simile a un uomo, così la somiglianza della superstizione alla religione non fa che renderla più deforme; e a
quel modo che la carne sana, si corrompe in piccoli vermi così buone forme e
ordinamenti si corrompono in una quantità di pratiche meschine. V'è una
superstizione che consiste nello schivare la superstizione, quando gli uomini
pensano che il miglior modo d'agire sia d'allontanarsi il più possibile dalla
superstizione che prima avevano accolta; sicché si dovrebbe porre ogni cura
acciocché (come avviene con tutte le purghe) il buono non venga tolto via col
marcio, il che comunemente capita.
Francesco Bacone (da Verulamio, e Visconte di Sant'Albano - 1561-1626)
2
- Dei giardini (Francesco Bacone)
E poiché l'effluvio dei fiori
è assai più soave nell'aria (dove va e viene come il gorgheggio della musica)
che nella mano, perciò nulla più si conviene a tale diletto che sapere quali
sono i fiori e le piante che meglio profumano l'aria. Le rose, damaschine e
rosse, trattengono tenacemente il loro profumo, sicché potreste camminare lungo
tutta una siepe di esse, senza sentirne la soavità, neanche quando v'è la
rugiada mattutina. Parimenti, gli allori non lasciano trapelare profumo alcuno
ove crescono. Poco il rosmarino e la maggiorana; il fiore che sopra tutti gli
altri effonde il più dolce profumo nell'aria è la viola, specialmente la viola
bianca doppia, che vien due volte l'anno, verso la metà d’aprile e circa il
giorno di San Bartolomeo (24 agosto). Poi la rosa muscosa; poi le foglie di
fragola morenti, con un eccellentissimo odore cordiale; poi il fiore della vite,
un pulviscolo come quel dell'agrostide, che cresce sul grappolo in sul primo
spuntare; poi la rosa canina, poi le violacciocche, che son deliziose se le
collochi sotto la finestra d'un salotto o camera a, pianterreno; poi garofani e
garofanini, specie il garofano a mazzetti, e il garofano da chiodo; poi i fiori
del tiglio; poi il caprifoglio, purché siano a qualche distanza. Non parlo dei
fiori di pisello poiché son fiori da campo; ma quelli che più dolcemente
profuman l'aria, non al passare, come gli altri, ma calpestandoli e
schiacciandoli, sono la pimpinella, il timo selvatico, il mentastro, sicché
dovete piantare d'essi interi viali, per gustarne il piacere mentre passeggiate.
Francesco Bacone (da Verulamio, e Visconte di Sant'Albano - 1561-1626)
3
– Offerta
(F.D.E. Schleiermacher)
Nessun regalo più prezioso può
offrire un uomo ad un altro uomo se non l’intima conversazione del suo spirito
con sé stesso: perché esso gli apporta il dono maggiore che esista, una
visione chiara e diretta dell'intimo di un libero essere. Nessun dono è più
duraturo: perché nulla può distruggere il godimento che una volta tale visione
ti ha concesso; e la sua intrinseca verità le assicura il tuo amore in modo che
tu volentieri ritorni a contemplarla. Nessun altro dono tu preservi con maggior
sicurezza dalla voglia e dalla malizia altrui: perché esso non è avvolto in
alcun ornamento accessorio che, per caso possa guidare ad altro uso o abuso, o
possa allettare i desideri sensibili. Se qualcuno sta in disparte e guarda di
sbieco questo gioiello, attribuendogli falsamente forme ridicole che il tuo
sguardo diretto non vi scopre, fa che questo vano motteggio non ti privi della
tua gioia, così come esso non mi farà pentire di aver condiviso con te ciò
che avevo.
Vieni, prendi il dono, tu che puoi comprendere il pensiero del mio spirito!
Possa la chiara musica dei miei sentimenti essere un accompagnamento al canto
che tu intoni dentro di te, e la scossa che penetra in te al contatto della mia
anima possa diventare anche per la tua vita un impulso vivificatore.
Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher(1768‑1834)
4 – Sondaggio (F.D.E. Schleiermacher)
Gli uomini rifuggono dal
guardare in se stessi e molti tremano servilmente quando alla fine non possono
più a lungo evitare la questione: che cosa ho fatto che cosa son diventato? chi
sono realmente? Questa ricerca li spaventa; essi non sanno cosa ne verrà fuori.
Credono che un uomo possa più facilmente giudicare gli altri che se stesso, e
sono convinti di agire con lodevole modestia se, dopo l'esame, più rigoroso di
se stessi, si riservano ancora il diritto di avere sbagliato nel calcolo. E
tuttavia è la sua caparbietà che nasconde un uomo a se stesso; il suo giudizio
non può errare, purché egli volga realmente il suo sguardo su se stesso. Ma
questo appunto i più né possono né vogliono fare. Il fascino della vita e del
mondo li tiene interamente legati a sé, e, decisi a non distrarre lo sguardo da
tale spettacolo per non percepire null'altro, tutto quello che essi vi scoprono
di sé non è se non un vago e ingannevole riflesso. Senza dubbio io posso
giudicare un altro uomo soltanto dai suoi atti, perché non vedo mai la sua
intima disposizione. Io non posso mai conoscere immediatamente qual era
precisamente la sua intenzione; io confronto semplicemente i suoi atti gli uni
con gli altri e ne deduco, non senza incertezza, lo scopo della sua azione e lo
spirito che lo animava. Ma quale vergogna che uno guardi se stesso come un
estraneo guarda un altro estraneo! che uno rimanga ignaro della sua vita
interiore, e perfino si pavoneggi della sua supposta acutezza se riesce a
cogliere solo l'ultima di una serie di decisioni che misero capo ad un atto
esterno, insieme col sentimento che la accompagnava e con l'idea che la
precedette immediatamente! Come mai costui potrà conoscere se stesso e gli
altri? Che cosa lo può guidare nelle sue incerte congetture dell'interno
dall'esterno, se non fonda il suo giudizio su un'esperienza decisiva di qualcosa
d'immediatamente certo? L'inevitabile presentimento dell'errore lo rende
pauroso, l'oscuro sospetto che egli stesso ne sia colpevole gli opprime il
cuore, e i suoi pensieri vacillano incerti, per paura, dinanzi a quella piccola
parte di autocoscienza che gli uomini portano ancora con sé, degradata
all'ufficio di duro censore, e che spesso sono costretti ad ascoltare, pur
contro voglia.
In verità gli uomini hanno ragione di preoccuparsi, quando hanno esaminato
sinceramente gl’intimi motivi della loro vita, di non sapervi spesso
riconoscere ciò che è veramente umano (la ragione) e di vedervi gravemente
offesa la conoscenza morale che è la consapevolezza della vera umanità.
Chiunque, infatti, non ha esaminato la sua condotta precedente, non può neanche
dar la garanzia che nel futuro si ricorderà di far parte dell’umanità e che
si dimostrerà degno di appartenervi. Se egli ha spezzato una volta il filo
dell'autocoscienza, se anche una sola volta, si è abbandonato alle impressioni
e ai sentimenti che ha in comune con gli animali, come mai può sapere se non è
precisamente nella più grossolana animalità? Contemplare dentro di noi
l'umanità e non distoglierne mai lo sguardo, una volta che l'abbiamo trovata,
è l'unico mezzo sicuro per non allontanarci dal suo sacro recinto. Questa
visione è l'intimo e necessario legame tra l'azione e la contemplazione, legame
che solo a uomini stolti o di ottusa sensibilità appare inintelligibile e
misterioso. Una maniera veramente umana d'agire produce la chiara consapevolezza
di ciò che c'è di veramente umano in me, e questa consapevolezza, alla sua
volta, non permette alcun'altra condotta se non quella che è degna dell'umanità.
Chi non si sa elevare a questa chiara visione é sempre spinto qua e là
vanamente da oscuri e istintivi presentimenti; invano si tenta di educarlo e di
abituarlo; invano egli inventa mille espedienti e prende mille audaci
risoluzioni per rientrare a viva forza nella cerchia dell'umanità: le sacre
porte non si aprono, ed egli rimane fuori, su un terreno non consacrato, e non
può sfuggire alle persecuzioni dell’offesa divinità, né al vergognoso
sentimento di essere esiliato dalla sua vera patria. È sempre pura follia è
vana impresa dare regole e fare esperimenti nel regno della libertà. Per essere
uomo, si richiede un'unica libera decisione: chi una volta l'ha presa, rimarrà
sempre un uomo; chi cessa di esserlo non lo è mai stato.
Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher(1768‑1834)
5
- Filosofia della natura (J. W. von Goethe)
Un passo della introduzione di d'Alembert alla
grande enciclopedia francese, che non è il luogo qui di riprodurre, è stato
per noi di grande importanza; comincia alla pagina X dell’edizione in quarto
con le parole: “A l’égard des sciences mathématiques” e termina alla
pagina XI: “étendu son domaine". La fine, che si ricollega con l'inizio,
contiene questa grande verità: Che nelle scienze tutto si basa sul contenuto,
sulla validità di un principio stabilito all'inizio e sulla purezza delle
intenzioni. Anche noi siamo convinti che questa grande esigenza deve farsi
valere non soltanto nel caso della matematica ma in tutte le scienze, le arti,
come anche nella vita.
Non si ripeterà mai abbastanza: il poeta, come l'artista figurativo, deve
innanzi tutto preoccuparsi se l'argomento che prende a trattare è tale che da
esso si possa sviluppare un'opera multiforme, completa, sufficiente. Se si
trascura questo, ogni altro sforzo è completamente inutile: il piede e la rima,
la pennellata e il colpo di scalpello sono sprecati inutilmente; e anche se una
esecuzione magistrale può affascinare il pubblico intelligente per qualche
momento, tuttavia esso sentirà immediatamente la mancanza di spirito che
inficia tutto ciò che è falso.
Così nel campo artistico, così in quello scientifico, e anche in quello
matematico, tutto dipende dalla verità fondamentale, il cui sviluppo si mostra
nella speculazione non così facilmente come nella pratica; giacché questa è
la pietra di paragone di ciò che lo spirito ha concepito, di ciò che è stato
ritenuto vero dal senso interno. Quando l'uomo, convinto del contenuto dei suoi
propositi, si rivolge all'esterno e pretende dal mondo non soltanto che esso sia
d'accordo con le sue idee ma che si adatti a lui, obbedisca a quelle idee e le
realizzi, allora soltanto si ha per lui l'importante esperienza che gli
permetterà di stabilire se si è sbagliato nella sua impresa, o se la sua epoca
non è in grado di capire la verità.
Tuttavia vi è un segno distintivo fondamentale per cui la verità si può
distinguere pel modo più sicuro dall'illusione: la verità agisce sempre in
modo fecondo e favorisce chi la possiede e la alimenta: l'errore invece rimane lì,
morto e sterile, anzi è da considerare come una necrosi nella quale la parte
che perisce impedisce a quella viva di risanarsi.
J.
Wolfgang von Goethe (1749-1832)
6 - Frammento sulla natura (J. W. von Goethe)
Natura!
Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più
addentro in lei. Non richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice
della sua danza e ci trascina seco, finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle
sue braccia.
Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu non
ritorna - tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le
siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo
segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei nessun potere.
Sembra aver puntato tutto sull'individualità, ma non sa che farsene degli
individui. Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile.
Vive tutta nei suoi figli; ma la madre dov'è? Unica vera artista, essa va dalla
più semplice materia ai contrasti più grandi e, apparentemente senza sforzo,
alla perfezione assoluta - alla determinatezza più precisa, eppure delicata.
Ognuna delle sue opere ha la sua propria essenza, ognuna delle sue
manifestazioni il concetto più isolato; eppure formano un Tutto unico.
Recita uno spettacolo; se lei stessa lo vede, non sappiamo; eppure lo recita per
noi, spettatori seduti in un angolo. C'è in lei una vita eterna, un eterno
divenire, un moto perenne; eppure non fa un passo avanti. Si trasforma di
continuo, non conosce un attimo di quiete, ignora l'immobilità; colpisce di
maledizione l'indugiare. È salda. Il suo passo è misurato, rare le sue
eccezioni, invariabili le sue leggi.
Ha pensato e non cessa mai di pensare; non come l’uomo, tuttavia, ma come
natura. Si è riservata un'intelligenza propria, che abbraccia ogni cosa e di
cui nessuno può carpirle il segreto.
Gli uomini sono tutti in lei, e lei in tutti. Gioca d’amica, con ciascuno di
noi, tanto più soddisfatta quanto più la vinciamo. Con molti il suo giuoco è
tanto segreto, che finisce prima ch’essi se ne accorgano.
Anche la cosa più innaturale è natura. Chi non la vede dappertutto, non la
riconosce in nessun luogo.
Ama sé stessa e tiene fissi su di sé innumerevoli occhi e innumerevoli cuori.
Si è moltiplicata per godere di sé. Crea sempre nuovi goditori, mai sazia di
offrirsi. Si compiace d'illudere. Punisce come la più severa tiranna chi
distrugge l'illusione in sé o negli altri; stringe al cuore come un figlio chi
le si abbandona con fiducia.
Innumerevoli sono i suoi figli. Avara, propriamente, non è con nessuno, ma ha i
suoi beniamini, cui prodiga molto e molto sacrifica. Ha preso sotto la sua
protezione ciò che è grande.
Suscita dal nulla le sue creature, e non dice loro né da dove vengono né dove
vanno. Devono soltanto correre. La strada la conosce lei.
Ha pochi congegni, ma sempre operanti, mai inerti, sempre multiformi. Il dramma
ch’essa recita é sempre nuovo, perché crea spettatori sempre nuovi. La vita
è la sua più bella scoperta; la morte il suo stratagemma per ottenere molta
vita.
Avvolge l'uomo nella tenebra e lo sprona continuamente alla luce. Lo inchioda,
torpido e greve, alla terra; ma lo scrolla sempre a nuove imprese. Suscita
bisogni perché ama il moto; il miracolo è che ne ottenga tanto con mezzi così
limitati.
Ogni bisogno è un beneficio; presto appagato, presto risorgente. Se ne
elargisce uno di più, è una nuova fonte di piacere; ma, ben presto,
ristabilisce l'equilibrio. Ad ogni momento spicca il balzo verso la meta più
lontana; ad ogni momento è alla meta.
la vanità in persona; ma non per
noi, agli occhi dei quali si è fatta la cosa più importante. Permette ad ogni
bambino di baloccarsi con lei, ad ogni pazzo di giudicarla, a migliaia e
migliaia d’inciampare in essa e non vedere nulla; ma trae piacere da tutti,
trova il suo tornaconto in ciascuno.
Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora con lei
anche quando si pretende di lavorarle contro. Trasforma in beneficio tutto ciò
che dà, perché lo rende a priori indispensabile. Indugia per farsi desiderare;
fugge via perché non se ne diventi mai sazi.
Non ha linguaggio né discorso, ma crea lingue e cuori attraverso i quali parla
e sente.
La sua corona è l'amore. Solo per mezzo suo ci avviciniamo a lei. Essa scava
abissi fra le sue creature; ma tutte aspirano a riunirsi. Ha isolato ogni cosa,
per ricongiungerle tutte. Con pochi sorsi alla coppa dell'amore, rende lieve il
tormento di tutta una vita.
È tutto. Si premia e si punisce, si diletta e si tormenta. È rude e dolce,
piacevole e terribile, debole e onnipotente. In essa, tutto è sempre lì. Non
conosce passato né avvenire; la sua eternità è presente. È benigna. La lodo
con tutte le sue opere. È saggia e muta. Non le si strappa alcuna spiegazione,
non le si carpisce alcun beneficio ch’essa non dia spontaneamente. È astuta
ma a fin di bene; e il meglio è ignorarne le astuzie. È un tutto; ma, non è
mai compiuta. Come fa oggi potrà fare sempre.
A ciascuno appare in una forma diversa. Si nasconde sotto mille nomi e termini,
ma è sempre la stessa. Mi ha portato in scena: me ne butterà fuori. Mi affido
a lei. Disponga di me a piacer suo. Non odierà l'opera delle proprie mani. Non
sono stato io a parlare di lei. No, ciò che è vero e ciò che è falso, essa
l’ha detto. Tutto è colpa sua, tutto merito suo.
J. Wolfgang von Goethe
(1749-1832)
7 - Canto degli spiriti sopra l'acqua (J. W. von Goethe)
L'anima dell'uomo somiglia
all'acqua; essa, viene dal cielo, al cielo sale, e di nuovo ritorna sulla terra,
perennemente cangiando.
Sgorga dall'alta scoscesa roccia il limpido raggio, poi ondeggia dolcemente sul
sasso levigato in nube di pulviscolo e, morbidamente accolto, fluttua come in un
velo, dolce – mormorando - giù nel profondo. Anche se le pietre s'oppongono
alla sua caduta, furioso spumeggia di balza in balza verso l'abisso. Nel piano
letto s'insinua a valle nella prateria, e nel placido lago si deliziano del loro
viso tutti gli astri. Il vento è dell'onda leggiadro amante; il vento mescola
fino in fondo l'onde spumeggianti.
Oh, come tu somigli all'acqua, anima dell’uomo! Oh, come tu somigli al vento,
destino umano!
J. Wolfgang von Goethe
(1749-1832)
8 - Canzone di maggio (J. W. von Goethe)
Come
splende magnifica a me la natura! Come brilla il sole! Come ride il prato!
Germogli erompono da ogni ramo e mille voci dai cespugli e gioia ed ebbrezza da
ogni petto: o terra, o sole, o gaudio, o giubilo!
O amore, amore d'aurea bellezza come nuvole all'alba là su quei monti!
Sovrano fecondi la zolla giovine e nel gemmato nembo l’intero mondo.
O mia fanciulla come ti amo! Come rifulge il tuo occhio! Come tu m'ami!
Così l'allodola ama il canto e l'aria e i fiori del mattino il profumo celeste,
come ti amo con fervido sangue, tu che mi doni la giovinezza e gioia e ardire e
nuovi canti e danze. E così come m'ami sii in eterno felice!
J. Wolfgang von Goethe
(1749-1832)
9
- Dal contrasto fra emozione e passione (Immanuel Kant)
L’emozione
è il predominio delle sensazioni tale che ne viene soppressa la padronanza
dell'animo (animus sui compos). Essa è dunque precipitosa, cioè cresce
rapidamente a tal grado di sentimento, che rende impossibile la riflessione. La
mancanza di emozioni senza diminuzione della forza degli impulsi attivi è la
flemma nel senso proprio della parola, cioè la proprietà dell'uomo forte
(animi strenui) di non lasciarsi trasportare dalla forza emotiva al di fuori
della calma riflessione. Ciò che l'emozione della collera non compie
nell'impetuosità sua, essa non compie più, e facilmente dimentica. Invece la
passione dell'odio prende tempo per metter radici profonde e pensare al nemico.
Un padre, un maestro non possono punire quando essi hanno avuto soltanto la
pazienza di udire la scusa (non dico la giustificazione). Se colui che entra
adirato nella vostra stanza, per dirvi nel violento suo trasporto delle dure
parole, fate invito cortese a sedersi, e se lo ottenete, allora le sue grida si
faranno già minori, perché la comodità di star seduto è una espansione, che
non bene si accorda con i gesti minacciosi e le grida di chi sta in piedi. La
passione invece (come disposizione spirituale che appartiene al potere
appetitivo) prende tempo ed è riflessiva, sebbene possa essere violenta, per
raggiungere il suo scopo.
L'emozione agisce come un fiotto che rompe la diga; la passione come una
corrente che si scava sempre più profondo il suo letto. L'emozione agisce sulla
salute come un salasso, la passione come l'etisia o la consunzione. L'emozione
è come l'ebbrezza, che si smaltisce sebbene ne segua il mal di capo; la
passione invece è come una malattia per intossicazione o per deformazione, che
ha bisogno di un medico interno o esterno dell'anima, il quale tuttavia per lo
più non sa prescrivere una cura radicale, ma quasi sempre solo un palliativo.
Dove c'è molta emozione, c'è comunemente poca passione; come, presso i
Francesi, che per la loro vivacità sono mutevoli in paragone degli Italiani e
degli Spagnoli (anche degli Indiani e dei Cinesi), che nell'ira arrivano alla
vendetta o nell'amore sono tenaci fino alla pazzia. Le emozioni sono leali e
aperte, le passioni invece subdole e nascoste. I Cinesi rimproverano agli
Inglesi di essere impetuosi e violenti come i Tartari, ma gli Inglesi ai Cinesi
di essere ingannatori esperti (ma calmi), che non si lasciano affatto deviare da
questo rimprovero alla loro passione.
L'emozione è come una ubriacatura che si smaltisce; la passione come una
follia, che aderisce a un'idea, la quale si insinua sempre più a fondo. Chi ama
può tuttavia ancora vederci; ma chi
è innamorato rimane cieco sui difetti dell’oggetto amato, sebbene questi,
otto giorni dopo le nozze, soglia riprendere il suo aspetto. Colui che suole
esser preso dall'emozione come un “raptus”, per quanto possa essere anche
ben educato, è tuttavia simile a un pazzo; ma siccome egli rapidamente se ne
pente, si ha soltanto un parossismo, che si chiama stordimento. Taluni
desiderano bene di potersi adirare e Socrate dubitava se non fosse bene talvolta
adirarsi; ma avere in proprio dominio l'emozione cosicché si possa riflettere a
sangue freddo, se ci si deve incollerire o no, sembra essere qualcosa di
contraddittorio. Invece nessun uomo può desiderare per sé la passione. Perché,
chi vuol lasciarsi mettere in catene quand’egli può esser libero?
Il principio secondo cui il saggio non deve mai subire l'emozione, neppure
quella della compassione per i mali del suo miglior amico, è un principio
morale giusto e nobile della scuola stoica, perché l'emozione rende (più o
meno) ciechi. Ma fu saggezza della natura averci data la disposizione alla
simpatia per guidarci provvisoriamente prima che la ragione sia giunta alla
propria forza, l’aver cioè aggiunto all'impulso morale verso il bene anche lo
stimolo sensibile, come surrogato temporaneo della ragione. Perché del resto
l'emozione considerata per sé sola, è sempre imprudente; essa si rende
incapace di conseguire il proprio scopo, e non quindi saggio il lasciarla di
proposito sorgere in sé. Tuttavia la ragione può nella rappresentazione del
bene morale ravvivare il volere per mezzo della connessione delle sue leggi con
le intuizioni che ad esse si conformano, e quindi essere, non come effetto, ma
come causa della emozione eccitatrice dell'anima verso il bene. In questo caso
la ragione tiene sempre in mano la briglia, e si produce un entusiasmo della
buona decisione, il quale però deve essere attribuito alla ragione, e non alla
emozione come sentimento sensoriale più forte.
In genere non è la forza di un certo sentimento quella che costituisce lo stato
d'emozione bensì la mancanza di riflessione sul rapporto fra questo sentimento
e la somma di tutti i sentimenti (di piacere o di dolore).
Il ricco signore, a cui il servitore in un convito abbia spezzato, per
incompostezza di movimento, un vaso di cristallo bello e raro, non farebbe
nessun caso della cosa, se egli nel medesimo momento paragonasse questa perdita
di un piacere con la quantità di tutti i piaceri, che a lui offre la sua felice
condizione di ricco. Se egli invece si abbandona interamente a quest'unico
sentimento di dolore (senza far prontamente quel computo nel suo pensiero)
nessuna meraviglia, che l'animo gli si commuova così come se tutta la sua
fortuna fosse andata perduta.
Immanuel Kant (1724-1804)
10
– Frammento (Novalis)
Ogni
grado della cultura incomincia con la fanciullezza. Quindi l'uomo terreno che più
è colto è così simile al fanciullo.
L'uomo è un sole, i suoi sensi sono i suoi pianeti.
L'uomo vero deve, per così dire, vivere contemporaneamente in più luoghi e in
più uomini: gli devono essere costantemente presenti un largo campo e
molteplici avvenimenti. Qui si forma poi la vera grandiosa presenza dello
spirito che fa dell'uomo un vero cittadino del mondo, che in ogni istante della
sua vita, con le più benefiche
associazioni, lo attrae, lo fortifica, e lo trasporta nella chiara disposizione
di una meditata attività.
L'uomo appare più degno quando la prima impressione di lui è l'impressione di
un'idea assolutamente spiritosa; cioè di essere contemporaneamente spirito e
individuo determinato. In ciascun uomo eccellente deve, per così dire, sembrare
che aleggi uno spirito che fa la parodia ideale della sua apparenza visibile. In
alcuni uomini è come se questo spirito facesse le smorfie all'apparenza
visibile.
Un uomo siffatto dovrebbe essere una bella satira, capace di dare a ciascuna
cosa una forma a piacere, di riempire e muovere ogni forma con la vita più
varia. L'uomo che si educa deve gradatamente provare le sue forze in tutto ciò
che gli appare ancora grave, per sollevarlo, e per poterlo sollevare e spostare
con sempre maggiore facilità e disinvoltura. Così se lo fa caro. Si ha caro ciò
che costa fatica.
L'uomo consiste nella verità. Se rinunzia alla verità, rinunzia a se stesso.
Chi tradisce la verità tradisce se stesso. Non si fa qui discorso della
menzogna, ma dell'agire contro il proprio convincimento.
Se un uomo d'un tratto credesse veramente di essere morale, egli lo sarebbe.
Avere delle inclinazioni e dominarle è più glorioso che evitare le
inclinazioni.
La morale è così difficile nella prassi proprio a causa della semplicità,
delle sue leggi fondamentali. Il popolo è un'idea. Noi dobbiamo diventare un
popolo. L'uomo perfetto é un piccolo popolo. Un uomo può nobilitare (far degna
di sé ogni cosa per il fatto che egli lo vuole.
L'uomo deve dominare la propria natura e creare diritti e poteri all'individuo
in sé; a lui spetta il dominio della volontà e la sommissione della sensibilità.
L'uomo può desiderare ciò che è sensibile in forma razionale, la donna ciò
che è razionale in forma sensibile.
La donna è il simbolo della bontà e della bellezza; l'uomo è il simbolo della
verità e della giustizia. Ciò che dà il tono nell'uomo è la ragione, nella
donna è il sentimento. La superiorità della donna nel sentimento è pari a
quella dell'uomo nella ragione.
Tutti gli uomini sono variazioni di un unico individuo completo cioè di un
unico matrimonio. Il matrimonio è il mistero supremo. Il matrimonio segna una
nuova e più alta epoca dell'amore; l'amore socievole, l'amore-obbligo, l'amore
vivente. La filosofia sorge con il matrimonio. È male che da noi ci sia
soltanto la scelta tra il matrimonio e la solitudine. Questi sono gli estremi.
Ma quanto son pochi gli uomini capaci di un vero e proprio matrimonio; quanto
sono pochi anche quelli che possono sopportare la solitudine.
Ci sono legami di ogni genere. Il matrimonio è un legame senza fine. Un
matrimonio dovrebbe essere propriamente un lento continuato amplesso,
generazione, vera nutrizione, educazione di un armonico essere comune?
Educazione di sé, osservazione di sé e nutrizione di sé, generazione di sé.
C'è un solo tempio nel mondo, e questo è il corpo umano. Nulla è più sacro
di questa sublime figura, l'inchinarsi davanti all'uomo è un omaggio a questa
rivelazione della carne. Si tocca il cielo quando si tocca il corpo umano.
Tutti i casi della nostra vita sono materiali di cui noi possiamo fare ciò che
vogliamo. Chi ha molto spirito, fa molto della sua vita. Ogni conoscenza, ogni
avvenimento sarebbe, per chi ha veramente dello spirito, il primo anello di una
serie infinita, il principio di un romanzo senza fine.
Si può compiere la propria missione anche senza filosofia, se si vive in
conformità con quanto hanno fatto e insegnato i più saggi e i migliori, e se
prende per propria guida l'esperienza e il sano buon senso. Con queste due doti
e con la diligenza ci si può trovare a proprio agio in tutte le contingenze
della vita, e non restare senza risorse. Se rendersi chiaro conto della natura
di una cosa si chiama sano buon senso, ed é indispensabile anche ai dotti, agli
architetti scientifici. La pratica può facilitarne l'uso, e la pura forza
vitale, non impedita dalle opinioni lo mantiene puro.
Non si sbaglierà mai strada, se si bada all'universale, in noi e intorno a noi.
Qui intendiamo per universale, l'universale della ragione.
I "filistei" vivono solo la vita di tutti i giorni. Di domenica il
lavoro ha posa, i "filistei" vivono un po' meglio del solito, e
quest’ebbrezza domenicale termina con un sonno un po' più profondo del
consueto; quindi incominciando dal lunedì tutto s'avvia con un’andatura più
svelta. I “filistei” sono abituati a interrompere periodicamente (è di
tanto in tanto) le loro comuni occupazioni quotidiane. Stando alla regola questa
interruzione ha luogo ogni sette giorni, e si potrebbe chiamare una febbre
settana "poetica". Le loro “parties de plaisir”, devono essere
convenzionali, abituali, secondo la moda: ma essi elaborano anche i loro
piaceri, come ogni cosa, con fatica e formalismo.
Il “filisteo” raggiunge il grado più alto della sua esistenza
"poetica" in un viaggio, in una cerimonia nuziale, a un battesimo e in
chiesa. Qui i suoi più audaci desideri vengono appagati e spesso superati. La
cosiddetta religione di codesti "filistei" opera semplicemente come
una bevanda oppiata: seduce, stordisce, acquieta nella debolezza i dolori. Le
preghiere del mattino e della sera sono loro necessarie come la colazione e il
pranzo. Non ne possono più fare a meno. Il "filisteo" grossolano si
immagina il paradiso sotto specie di una sagra, di una festa di nozze, di un
viaggio o di un ballo; il raffinato fa delle gioie del paradiso una chiesa
sontuosa con bella musica, molto fasto, con sedie per il popolino nella navata,
e cappelle e gallerie per i nobili.
Novalis (pseudonimo di Friedrich
L. von Hardenberg – 1772-1801)
11
- Dignità dell'uomo (G. Pico della Mirandola)
Statui
quindi alla fine l'ottimo supremo Autore che a quello a cui non poteva esser
dato nulla di proprio, fosse comune tutto ciò che alle singole creature era
stato dato in particolare. Prese dunque l'uomo, quest'opera di tipo indefinito,
e postolo nel mezzo dell'Universo, così gli parlò: “Né determinata sede, né
proprio aspetto, né dono veruno speciale ti abbiamo dato, o Adamo, affinché
quella sede, quell'aspetto, quei doni che coscientemente, tu abbia bramato,
quelli, di tua volontà, per tuo sentimento, tu abbia e possegga. L'altrui già
definita natura è costretta entro leggi da noi prescritte. Tu, non costretto
entro chiusa veruna, di tuo arbitrio, nel cui potere t'ho posto, la tua natura
ti determinerai. T'ho collocato nel mezzo del mondo, perché d'intorno più
comodamente tu vegga quel ch’esiste nel mondo. Non ti facemmo né celeste né
terreno, né mortale né immortale affinché tu, di te stesso quasi arbitrario
e, per così dire, onorario plasmatore ed effigiatore, ti componga in quella
forma che avrai preferita. Potrai degenerare in quelle inferiori che sono brute;
potrai, per decisione dell'animo tuo, rigenerarti nelle superiori che sono
divine”.
O somma liberalità di Dio Padre, somma e meravigliosa felicità dell'uomo! A
cui è dato di aver ciò ch’ei brami, d'esser ciò che voglia. I bruti, appena
nascono, traggono seco, dalla vagina materna quello che possederanno. I sommi
spiriti fin dal principio o subito dopo furono quello che in eterno saranno.
All'uomo, nel nascere, il padre diè ogni vario seme e i germi di ogni specie di
vita. Quali ciascuno avrà coltivato, codesti alligneranno e in lui produrranno
i lor frutti.
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)
12
- Alcune parole sulla universalità e l'amore nell'arte (W. H. Wickenroder)
Il
Creatore che ha fatto il nostro pianeta e tutto ciò che su esso si trova,
abbracciò col suo sguardo la terra e sparse ovunque la piena della sua
benedizione. Ma dalla sua misteriosa officina Egli ha disseminato sul nostro
globo infinti e svariati germi, i quali recano frutti alla loro volta
infinitamente diversi e che in suo onore crescono nel più grande e nel più
variopinto dei giardini. Meravigliosamente Egli guida il sole intorno al globo
terrestre in giri regolati in maniera tale che i raggi arrivano sul nostro
pianeta in mille direzioni, ma sotto ogni cielo riscaldano il midollo della
terra e ne fanno venir fuori esseri di forme diversissime.
Con occhio uguale Egli riposa, in un grande attimo, guardando l'opera delle sue
mani e riceve con soddisfazione, l'offerta di tutta la natura animata e di
quella inanimata. Il ruggito del leone gli è caro come il grido delle renne,
l'aloe ha per lui il profumo ugualmente gradito come quello della rosa e del
giacinto.
Anche l'uomo è uscito in mille forme diverse dalla sua mano creatrice: i
fratelli di una stessa casa non si conoscono e non si comprendono: essi parlano
lingue diverse e si meravigliano l'un dell'altro: ma Egli le conosce tutte e di
tutte si compiace; con occhio uguale guarda tranquillamente all'opera delle sue
mani ed accoglie l'offerta di tutta la natura.
Ode le voci degli uomini parlare in maniera molteplice delle cose divine e sa
che tutti ‑ anche se contro la loro conoscenza e volontà, tutti intendono
parlare di Lui, l'Ineffabile.
Così Iddio ascolta anche come l'intimo sentimento degli uomini parli linguaggi
diversi in diverse zone della terra e in diverse epoche, e ode come essi tra di
loro combattano e non si capiscano; ma per lo spirito eterno tutto si risolve in
armonia; sa che ognuno parla la lingua che Egli ha creato per lui, che ciascuno
esprime la sua anima come può e deve esprimerla. E se gli uomini nella loro
cecità combattono fra di loro, Egli sa e riconosce che ognuno ha ragione per sé;
guarda con benevolenza a ogni uomo e a tutti, e si compiace della variopinta
mescolanza delle creature.
Si può dire che l'arte è il fiore del sentimento umano. In forme eternamente
mutevoli questo fiore si eleva al cielo da punti diversi della terra, e al padre
comune, che tiene nella sua mano il globo terrestre con tutto ciò che vi è
dentro, arriva anche da questa fioritura un profumo unico e concorde.
Egli scorge in ogni opera d’arte, da qualunque punto della terra provenga, la
traccia di quella scintilla divina che, partita da lui, attraverso il petto
dell’uomo passò alle piccole creazioni di questi, dalle quali la scintilla
ritorna di nuovo fiammeggiando al grande creatore. A lui il tempio gotico è
caro come il tempio dei Greci.
Per gli stolti non è concepibile che sul nostro globo terrestre vi sia gente
agli antipodi e che essi stessi siano antipodi agli altri. Pensano che il luogo
dove tengono i piedi sia sempre il centro di gravità del mondo, e al loro
spirito mancano le ali per volare intorno a tutta la circonferenza terrestre e
per abbracciare con uno sguardo l'universo, il quale non ha altro fondamento che
se stesso.
Oh, cercate d’indovinare le anime lontane da voi e ricordate come voi, al pari
dei vostri misconosciuti fratelli, avete ricevuto i doni dello spirito da una
stessa mano! E vogliate comprendere che ogni essere, soltanto dalle forze che ha
ricevuto dal cielo, può trar fuori le sue fantasie, e che le creazioni non
possono non esser rispondenti alla natura di ogni artista. E se non potete
penetrare nella natura a voi lontana e non potete sentire attraverso la loro
anima l'opera loro, cercate almeno attraverso i sillogismi dell'intelletto di
arrivare a questa convinzione.
L'abbici della ragione segue presso tutti i popoli della terra le stesse leggi,
soltanto che qui viene impiegato un vastissimo campo di argomenti, là per uno
assai ristretto. Nello stesso modo, il senso dell'arte è un unico raggio di
luce celeste, il quale però, attraverso il vetro variamente sfaccettato dei
sensi e sotto diversi climi, si frange in mille diversi colori.
Bellezza: che strana meravigliosa parola! E provatevi a trovare nuove parole per
ogni singolo sentimento d'arte, per ogni singola opera d'arte! In ognuna di
queste scintille un colore diverso e per ognuno, sono state create, nella
struttura del corpo umano, diverse sensibilità nervose.
Ma da questa parola: “bellezza”, voi tirate fuori i fili attraverso gli
artifici dell'intelletto, di un sistema severo d'idee e volete costringere tutti
gli uomini a "sentire" secondo le vostre prescrizioni e regole ... e
voi stessi non sentite nulla!
A noi, figli di questo secolo, é stato concesso il privilegio di stare sulla
cima di un alto monte, dal quale vediamo distendersi chiari, intorno ai nostri
occhi e ai nostri piedi, molti paesi e molte epoche. Lasciateci dunque, godere
di questa fortuna e vagare con occhi sereni su tutti i tempi e tutti i popoli e
tentare di tirar fuori dalle loro sensibilità, e dalle opere di questa
sensibilità, sempre ciò che è umano.
Come in ogni occhio mortale arriva un'immagine diversa dell'arcobaleno, così a
ognuno dal mondo circostante si riflette un’immagine diversa della bellezza.
Ma la bellezza universale e originaria che soltanto in momenti di trasfigurata
visione noi possiamo nominare ma non spiegar con le parole, si rivela a Colui
che, e l'arcobaleno e l'occhio stesso che lo vede, ha creato.
Io ho cominciato il mio discorso da Lui e torno di nuovo a Lui poiché lo
spirito dell'arte come ogni spirito che da Lui procede, attraverso l'atmosfera
della terra a Lui ritorna in offerta.
Tilhelm H. Wackenroder
(1773-1798)
13
- Della vera libertà del Sapiente (C. Bovillus)
La mente
del Sapiente è ricchissima e sempre colma. Se un desiderio insorge essa procede
avanti come non avesse il minimo bisogno; non è angustiata da nessuna
privazione, non si amareggia per niente, ma qualunque privazione equivale per
lei all'abbondanza. Non è vinta da appetiti smodati, reprimendo la sete dei
piaceri tiene a freno gli impulsi inconsulti ed improvvidi.
Questo specialmente è proprio del Sapiente: il muoversi e l'operare
liberamente, spontaneamente, con la massima facilità. Liberamente, rispetto
alla volontà con cui volentieri intraprende tutto ciò che è ragionevole,
bello, buono, degno d'essere ricercato; facilmente rispetto alla potenza, poiché
può sempre moltissimo, con chi con la mente abbraccia tutte le cose, è, in
atto tutte le cose. Come un artista, il Sapiente scolpisce in sé tutte le
immagini, egli imita tutti ed ha presenti, senza veli, tutte le cose. Di qui
risulta chiaro che il Sapiente può e opera sempre moltissimo. Poiché tre sono
le cause delle nostre azioni, e tre i principi dell'agire: intelligenza,
potenza, volontà; assistono il Sapiente una limpida intelligenza e una lucida
cognizione a ciò che si deve fare. La sua mente, sotto il nobile influsso della
ragione, ha scosso ogni nebbia d'ignoranza e l'ha abbandonata tra i rifiuti
mondani; egli è aiutato, come si è detto, dalla potenza d'agire, poiché egli
è tutto e in qualche modo può tutto; lo assiste infine l'ultimo dei tre
principi, la volontà, che intende ciò che si deve fare, che ha capacità di
agire.
Quando dunque queste tre funzioni: intendere, potere, volere, si collegano in
una sola armonia, l'azione del Sapiente è libera, facile, senza ostacoli.
L’intelligenza gli rivela in primo luogo ciò che deve fare; la potenza valuta
quindi e misura le forze del soggetto; la volontà infine muove, asseconda,
segue il soggetto. Ché se mancasse qualcuna di queste cause, l'azione sarebbe
ostacolata o nulla, infatti se alcuno intende e può ciò che non vuole, o
intende e vuole ciò che non può, o può e vuole ciò che non conosce per
nulla; o non conosce, non può e non vuole: in ogni caso costui si muove invano.
Ne segue che lo stolto è inadatto, lento, incapace in qualunque azione, come
chi ha cieca e improvvida l'intelligenza, e manca di forza, di capacità.
Infatti vi sono forze dell'anima, facoltà e cause delle nostre operazioni,
ornamento della mente, abiti di buone azioni. Ma esse sono molto lungi dallo
stolto pigro e marcente la cui volontà, unita alla micropsicosi, cioè alla
piccineria d'animo, non osa proporsi niente che non abbia facoltà di eseguire e
trarre a compimento.
Carolus Bovillus (Charles de
Bouelles – 1481-1553)
14
- Mischie di pioggia e di venti (Leonardo
da Vinci)
Vedesi
l'aria tinta d’oscura nuvolosità negli apparecchi delle procelle del mare (le
quali sono mischie di pioggia e di venti), con serpeggiamenti delli tortuosi
corsi delle minaccianti folgori celesti, e le piante piegate a terra con le
arovesciate foglie sopra li declinanti rami, le quali pare voler fuggire dalli
loro siti, come spaventate dalle percussioni delli orribili e spaventosi voli
dei venti, fra li quali s'infonde li revertiginosi corsi della turbolenta
polvere e arena dei lidi marini; l'oscuro orizonte del cielo si fa campo di
fumolenti nuvoli, li quali percossi dalli solari raggi, penetrati per le
opposite rotture de’ nuvoli, percotano la terra, quella alluminando sotto le
loro percussioni; li venti persecutori della polvere, quella con grupolenti
globosità, levano a balzo infra l'aria, con colore cineruleo, mista con li
rosseggianti raggi solari ai quella penetratori. Li animali, senza guida,
spaventati discorrano a rote per diversi siti. Li tuoni, creati nelle
l’ombrose nuvole, scacciano da sé le infuriate saette, la luce delle quali
allumina l'ombrose campagne in diversi luoghi.
Se vuoi figurare bene una procella, considera e poni bene i sua effetti, quando
il vento, soffiando sopra la superfizie del mare e della terra, rimove e porta
con seco quelle cose che non sono ferme co’ la universal massa.
E per ben figurare questa fortuna, farai in prima li nuvoli spezzati e rotti
dirizzarsi per lo corso del vento, accompagniati da l'arenosa polvere levata
da’ lidi marini, e rami e foglie levati per la potenzia del furore del vento,
isparsi per l’aria, e in compagnia di quelle molte altre leggere cose. Li
arbori e l'erbe piegate a terra quasi mostrarsi voler seguire il corso de’
venti co’ rami storti fori del naturale corso e con scompigliate e rovesciate
foglie. E li omini che li si trovano, parte caduti e rovesciati, per li panni e
per la polvere quasi sieno irriconoscibili; e quelli che restano ritti sieno
dopo qualche albero abbracciati ad essi, perché il vento non li strascini;
altri con le mani a li occhi per la polvere, chinati a terra, e i panni e
capegli diritti al corso del vento. Il mare turbato e tempestoso sia pieno di
retrosi e schiuma infra le elevate onde, e il vento levare, infra la combattuta
aria, della schiuma più sottile a uso di spessa e avviluppata nebbia. I navili
che dentro vi sono, alcuni se ne facci col la vela rotta e i brani d'essa
ventilando infra l'aria in compagnia d'alcuna corda rotta, alcuni alberi rotti,
caduti, col navilio intraversato e rotto infra le tempestose onde; certi omini
gridanti abbracciare il rimanente del navilio. Farai li nuvoli cacciati
dagl’impetuosi venti, battuti nell'alte cime delle montagnie, fare contro a
quelle avviluppati retrosi a similitudine de l'onde percosse nelli scogli.
L'aria spaventosa per le iscure tenebre fatte in nell’aria dalla polvere,
nebbia e nuvoli folti.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
15 – Facezia (Leonardo da Vinci)
Una
lavava i panni e pel freddo aveva i piedi molto rossi, e, passandole appresso,
uno prete domandò con ammirazione donde tale rossezza dirivassi; al quale la
femmina subito rispuose che tale effetto accadeva, perché ella aveva sotto il
foco. Allora il prete mise mano a quello membro, che lo fece essere più prete
che monaca, e, a quella accostatosi, con dolce e sommessiva voce pregò quella
che ‘n cortesia li dovessi un poco accendere quella candela.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
16
- Il negromante (Benvenuto
Cellini)
Mi accadde per certe diverse
stravaganze, che io presi amicizia di un certo prete siciliano, il quale era di
elevatissimo ingegno ed aveva assai buone lettere latine e grecie. Venuto una
volta in un proposito d'un ragionamento, in nel quale s’intervenne a parlare
d'arte della negromanzia, alla qualcosa io dissi: grandissimo desiderio ho avuto
tutto il tempo della vita mia di vedere o sentire qualche cosa di quest'arte.
Alle qual parole il prete aggiunse: forte animo e sicuro bisogna che sia di
quell'uomo che si mette a tale impresa. Io risposi che della fortezza e della
sicurtà dell'animo me ne avanzerebbe, purché i’ trovassi modo a far tal
cosa. Allora rispose il prete: se di cotesto ti basta la vista, di tutto il
resto io te ne satollerò. Così fummo d'accordo di dar principio a tale
impresa. Il detto prete una sera infra l'altre si mise in ordine, e mi disse che
io travassi un compagno, insino a due. Io chiamai Vincenzio Romoli mio
amicissimo, e lui menò seco un pistoiese, il quale attendeva ancora lui alla
negromanzia. Andaticene al Colosseo, quivi paratosi il prete a mo’ di
negromante, si mise a disegnare i circuli in terra con le più belle cirimonie
che immaginar si possa al mondo; e ci aveva fatto portare profummi preziosi e
fuoco, ancora profummi cattivi.
Come e' fu in ordine, fece la porta al circolo, e presoci per mano, a uno a uno
ci messe drento al circulo; di poi compartì gli ufizi; dette il pintaculo in
mano a quell'altro suo compagno negromante, agli altri dette la cura del fuoco
per e' profumi; poi messe mano agli scongiuri. Durò questa cosa più d'una ora
e mezzo; comparvero parecchie legioni (di diavoli), di modo che il Culiseo (Colosseo)
era tutto pieno. Io che attendevo ai profumi preziosi, quando il prete cognobbe
esservi tanta quantità si volse a me e disse: Benvenuto, dimanda lor qualcosa.
Io dissi che facessino che io fussi con la mia Angelica siciliana. Per quella
notte, noi non avemmo risposta nessuna; ma io ebbi bene grandissima satisfazione
di quel che io desideravo di tal cosa. Disse il negromante, che bisognava che
noi andassimo un'altra volta e che io sarei satisfatto ai tutto quello che io
domandavo, ma che voleva che io menassi un fanciulletto vergine. Presi un mio
fattorino, il quale era di dodici anni in circa, e meco di nuovo chiamai quel
ditto Vincenzio Romoli, e per essere nostro domestico compagno un certo Agnolino
Gaddi, ancora lui menammo a questa faccenda.
Arrivati di nuovo al luogo deputato, fatto il negromante le sue medesime
preparazione con quel medesimo e più ancora meraviglioso ordine, ci misse in
nel circolo, qual di nuovo aveva fatto con più mirabile arte, e più mirabil
cerimonie; di poi quel mio Vincenzio diede la cura dei profumi e del fuoco;
insieme la prese il detto Agnolino Gaddi: dipoi a me pose in mano il pintaculo
qual mi disse che io lo voltassi secondo i luoghi dove lui m'accennava, e sotto
il pintaculo tenevo quel fanciullino mio fattore. Cominciato il negromante a
fare quelle terribilissime invocazioni, chiamato per nome una gran quantità di
quei demoni capi di quelle legioni, e a quelli comandava per la virtù e
potenzia di Dio increato, vivente ed eterno, in voci ebree, assai ancora greche
e latine; in modo che in breve di spazio si empiè tutto il Culiseo l'un cento
più di quello che avevan fatto quella prima volta. Vincenzio Romoli attendeva a
fare fuoco insieme con quell’Agnolino detto, e molta quantità di profummi
preziosi. Io per consiglio del negromante, di nuovo domandai potere essere con
Angelica. Voltosi il negromante a me, mi disse: senti che gli hanno detto? che
in ispazio di un mese tu sarai dove è lei; e di nuovo aggiunse, che mi pregava
che io gli tenessi il fermo (cioè stessi saldo), perché le legioni eran l'un
mille più di quel che lui aveva domandato, e che l'erano, le più pericolose; e
poi che gli avevano istabilito quel che io avevo domandato, bisognava
carezzargli, e pazientemente gli licenziare. Dall'altra banda il fanciullo, che
era sotto il pintaculo, ispaventatissimo diceva, che in quel luogo si era un
milione di uomini bravissimi, e’ quali tutti ci minacciavano: di più disse,
che gli era comparso quattro smisurati giganti, e’ quali erano armati e
facevan segno di voler entrare da noi. In questo il negromante, che tremava di
paura, attendeva ai profummi. Io, che avevo tanta paura quanto loro, m'ingegnavo
di dimostrarla manco, e a tutti davo meravigliosissimo animo; ma certo io m'ero
fatto morto, per la paura che io vedevo nel negromante. Il fanciullo s'era fitto
il capo infra le ginocchia, dicendo: io voglio morire a questo modo, perché,
morti siamo. Di nuovo io dissi al fanciullo: queste creature son tutte sotto di
noi, e ciò che tu vedi si è fumo e ombra; sí che alza gli occhi. Alzato che
gli ebbe gli occhi, di nuovo disse che era morto, e che non voleva più vedere.
Il negromante mi si raccomandò pregandomi che io gli tenessi il fermo, e che io
facessi fare profumi di zaffetica (quelli puzzolenti); così voltomi a Vincenzio
Romoli, dissi che presso profumassi di zaffetica. In mentre ch’io così
diceva, guardando Agnolino Gaddi, il quale era tanto ispaventato che la luce
degli occhi aveva fuor del punto, ed era più che mezzo morto, al quale dissi:
Agnolo, in questi luoghi non bisogna aver paura, ma bisogna darsi da fare ed
aiutarsi; sicché mettete su presto di quella zaffetica. Il ditto Agnolo, in
quello che lui si volse muovere, fece una istrombazzata di coregge con tanta
abundanzia di merda, la quale potette molto più che la zaffetica. Il fanciullo
a quel gran puzzo e quel romore alzato un poco il viso, sentendomi ridere
alquanto, assicurato un poco la paura, disse che se ne cominciavano andare a
gran furia. Così soprastemmo in fino a tanto che e' cominciò a sonare i
mattutini. Di nuovo ci disse il fanciullo, che ve n'era restati pochi, e
discosto. Fatto che ebbe il negromante tutto il resto delle sue cerimonie,
spogliatosi e riposto un gran fardel di libri che già gli aveva portati, tutti
d'accordo seco ci uscimmo del circulo, ficcandosi l'un sotto l'altro; massimo il
fanciullo, che s'era messo in mezzo, ed aveva preso il negromante per la vesta e
me per la cappa; e continuamente in mentre che noi andavamo inverso le case
nostre in Banchi lui ci diceva che dua di quelli, gli aveva visti nel Culiseo,
ci andavano saltibeccando innanzi, or correndo su pei tetti e or per terra. Il
negromante diceva che di tante volte quante lui era entrato nelli circuli, non
mai gli era intervenuto una così gran cosa, e mi persuadeva che io fussi
contento di voler esser seco a consacrare un libro, dal quale noi trarremmo
infinita ricchezza, perché dimanderemmo li demonii, che ci insegnassino delli
tesori, i quali n’è pien la terra, e a quel modo noi diventeremo ricchissimi;
e che queste cose d’amore si erano vanità e pazzie, le quali non rilevano
nulla. Io gli dissi, che se io avessi lettere latine, che molto volentieri farei
tal cosa. Pur lui mi persuadeva, dicendomi, che le lettere latine non mi
servivano a nulla, e che se lui avesse voluto, trovava di molti con buone
lettere latine; ma che non aveva mai trovato nessuno d'un saldo animo come era
io, e che io dovessi attenermi al suo consiglio. Con questi ragionamenti noi
arrivammo alle case nostre, e ciascuno di noi tutta quella notte sognammo
diavoli.
Benvenuto Cellini (1500-1571)
17
- Della virtù nell'arte medica (Paracelso)
Conchiusa (che ho) la trattazione riguardante la
scienza e le arti della medicina sul cui fondamento ogni medico deve basarsi e
su cui deve impiantare la propria professione, è necessario ora che il medico
possegga in sé un altro fondamento, il quale stia al servizio di questi tre
(filosofia, astronomia, alchimia).
Tale fondamento è quello che contiene questi ultimi e li sostiene secondo la
volontà d'Iddio, che ha dato e creato la medicina. Il medico, infatti, non è
costituito in modo da curare se stesso, bensì soltanto gli altri. Come una
pecora non porta con sé la lana, sibbene per il tessitore e il pellicciaio, così
anche il medico deve essere simile alla pecora e non essere utile a sé, bensì
agli altri, e non deve distaccarsi da questo esempio. Anche Giovanni Battista ha
infatti scorto nell'agnello un'immagine di Cristo. È ora quanto mai necessario
che un medico sia anche un agnello, giacché nell'arte sua stanno celate molte e
grandi cose, cioè, assassinii, strangolamenti, storpiamenti, provocazioni di
paralisi, devastazioni, scorticamenti, furti e rapine. Tutte queste cose
esistono in un medico lupo. Giacché, come il medico che deriva da Dio deve
essere un agnello e una pecora, così colui che opponendosi a Dio esercita la
sua medicina, è pari a un lupo. Come Dio paragona il lupo alle creature più
spregevoli e maledette, così è giusto che questo nome sia attribuito anche al
medico rapace. Quali sono i medici di tal fatta? Coloro che esercitano la
medicina essendo pienamente coscienti di non avere nessun potere e nessun
sapere, ciononostante l'esercitano soltanto per motivi venali: tra loro e i lupi
non v'ha differenza. Un medico di questo genere è un assassino. Infatti il suo
è un azzardo diretto al solo scopo di accrescere il proprio utile,
indipendentemente dalla guarigione o dalla morte dei malati. Questi medici
derubano l'infermo dei suoi averi, gli portano via la casa e la fattoria e gli
divorano le sostanze, spogliano lui e i suoi familiari di tutto. Tutto ciò è
rubato e depredato. Tali medici assassinano e strangolano, storpiano; riducono
in paralisi. Il medico non deve comportarsi in questo modo, non deve mirare al
proprio tornaconto, Quand'anche abbia potere e sapere, il suo potere e sapere
non sono già per gloriarsene, pavoneggiarsi e menarne vanto e perché si copra
di collane d'oro la sua donna, che era una contadina, una cuciniera, una serva,
una sguattera e forse una puttana, perché essa si metta a pari di una contessa
uguagliandola nell'abito e nel guardaroba. Costoro sono tutti lupi rapaci.
La medicina deve essere riposta in una pecorella e in un agnello, affinché una
tale disposizione d'animo e con un tal cuore leale, venga offerta e
somministrata e possa contare, dal canto suo, sulla lealtà del malato. Alla
lealtà infatti si deve lealtà, alla verità verità, alla giustizia giustizia.
Non è giusto dunque che io metta a fondamento e colonna della medicina anche
l'onestà del medico? Sì sí, no no. Questa è la sua onestà, su questa egli
deve fondarsi. Se dunque il sì deve essere sì, dovrà conoscere la medicina
nel suo retto fondamento, affinché il sì sia e diventi un sì. Quindi anche il
no dovrà essere un no. Perciò convien che egli sappia che cosa è il no nella
medicina. Dal che consegue che l'onestà del medico trova nella conoscenza
dell'arte sua la propria base, e questa conoscenza procede e discende dal
fondamento noto e specificato, e al di fuori di essa nessuno può darsi il nome
o il titolo di onesto rappresentante della medicina. Notate ora che a Dio è
particolarmente caro il medico, tra tutte le arti e facoltà degli uomini, e
predilige in maniera speciale impartire precetti ed ordini a lui. Poiché dunque
al medico è riservato da Dio un tale favore e una tale posizione, egli non potrà
essere, in definitiva, un simulatore, una vecchia comare, un boia, un bugiardo,
uno sconsiderato; dovrà essere invece un uomo verace. Poiché come Dio non
lascia allievi e discepoli ai falsi profeti, così non lascia a questi medici
l'arte della medicina. Voi vedete infatti che i falsi profeti, apostoli, martiri
e confessori non prosperano né hanno successo, bensì, quando più in alto si
stimano e migliori, allora cadono e tutti i loro discepoli si levano contro di
essi. Sono quelli della loro parte ad avere il sopravvento su di loro. Dio,
infatti, non lascia che la sua parola e il suo ministero siano rivelati da un
mentitore. Se egli agisse tanto attraverso il mentitore quanto attraverso l'uomo
giusto e verace - che è senza perfidia - non avrebbe mai avuto bisogno di
scegliere i suoi apostoli, bensì a Satana avrebbe impartito i suoi ordini. Così
deve la medicina essere basata soltanto sulla verità sicura, non su un'arte
piena di dubbi, sibbene su un'arte sicura. Infatti Dio vuole che l'uomo sia
verace e non un dubbioso o un bugiardo. Egli ha creato la verità e non la
menzogna. Or bene la verità è l'onestà dell'uomo, adunque l'onestà del
medico sta nell'essere tanto costante e verace come gli apostoli eletti da
Cristo, giacché presso Dio egli non è da meno di loro. Quando invece qualcosa
non riposa sulla verità, immobile come Dio stesso, bensì ha nell'aria il suo
punto d'appoggio, vuol dire allora che è costruita su Satana. Similmente ai
falsi profeti, che fanno spalancare la bocca alla gente, similmente ai falsi
apostoli, che danno anche dei segni al cospetto degli uomini e ai falsi martiri,
che si fanno uccidere al pari dei giusti, similmente ai falsi confessori, che
pregano e fanno penitenze al pari dei veri fedeli.
Il falso medico non può essere nemmeno in buona fede. Perché chi è in buona
fede non mente e porta a compimento le opere di Dio. Giacché di quel che lui è,
egli stesso é la propria testimonianza, vale a dire: devi riporre in Dio una
fede onesta, integra, robusta, verace, con tutto l'animo tuo, il tuo cuore, la
tua mente e i tuoi pensieri, con tutto l'amore e tutta la fiducia. Poiché con
una tale fede ed un tale amore Dio non ti farà mancare la sua verità e ti
renderà manifesta le sue opere veridiche, certe e consolatrici. Ma se tu non
hai una tale fede in Dio, l'aiuto d'Iddio ti verrà meno nelle opere tue e ne
sentirai la mancanza.
È lo Spirito Santo, infatti, ad accendere la luce della natura. E perché? Che
cosa inventa l'uomo estraendolo da sé stesso o per mezzo di sé stesso? Non
tanto da lasciare una macchiolina su un paio di calzoni. Che cosa inventa il
diavolo? Sulla terra niente, un bel niente. Ma quando, mercé l'accesa luce
della natura, troviamo qualcosa in noi. il diavolo è la guida che prende
l'ardire di falsificare tutte le cose che Dio ci dà, trasformandole in menzogne
e inganni. Questo diventa allora l'ostacolo di ogni arte.
Da Dio tutti gli esseri umani vengono nutriti e guidati, e Dio deve nutrirci,
altrimenti nessuno ci può nutrire. Se uno vuole nutrirsi con l'aiuto della
verità, Dio ci dà il suo nutrimento. Poiché ha il debito verso di noi di
darci il nostro nutrimento. Egli ce lo dà nel modo in cui noi lo vogliamo. Se
vogliamo averlo con la menzogna, la verità presso di noi diventerà menzogna e
vivremo come mentitori. Adunque Iddio dà ai mendaci il suo nutrimento come lo dà
agli uomini veritieri giacché deve nutrirci tutti, buoni e cattivi, come mostra
di fare col sole e la terra e tutte le creature. Cosicché il medico deve essere
puro e casto, affinché il suo bene non venga malamente usato per nessuna
lascivia o vanagloria o malizia.
Affinché dunque il medico raggiunga la completezza e poggi su un perfetto
fondamento, sappiate che egli deve agire in tutte le cose secondo l'ordine della
opportunità. Dobbiamo ora dire, intorno all'opportunità, che essa è la
“congrui tas”, cioè l'agire secondo l'ordine imposto dalla natura e non
dagli uomini. Infatti il medico non è sottoposto all’uomo, ma solo a Dio
attraverso la natura. Dal che consegue che questa opportunità e questa
disposizione dell'ordine hanno nella specie del corpo e in quella della luce
della natura il loro punto di partenza. Giacché la luce che ha il corpo è di
specie diversa da quella della natura. Orbene queste specie devono connettersi
insieme. Se dunque simile deve venire a simile e questo è la “congruitas”,
sì che prenda l'altro per il suo verso e l’una cosa si armonizzi con l'altra,
il sapere intorno alla specie del corpo deve essere al primo posto. Se il corpo è cresciuto e si è sviluppato, non lo deve a nessun
medico, il corpo già compiuto è quello che si è fatto in cose estranee. In
questo suo farsi adulto avverte il suo intimo sé. Così la qualità specifica
della luce della natura sta nel fatto che essa penetra nella culla e s'insinua
in modo tale che è più esigua del granello di senape ed è dalla senape che
allora comincia a crescere. Poiché dunque un albero di senape ha uccelli sopra
di sé e il suo seme è il più piccolo di tutti, che cos'altro vuol significare
tutto questo, salvo il fatto che quanto noi riceviamo nella giovinezza, diventa
grande nella vecchiaia e così grande che l'uomo non esisterebbe soltanto per sé,
bensì anche per tutti gli altri? Perciò l'uomo deve diventare albero e
adempiere la dottrina di Cristo e l'esempio dell'albero di senape. Perciò se
l’arte del medico deve consistere su un fondamento, il seme dei medici deve
esser gettato nella culla come un granello di senape e quivi crescere, come
cresce il seme dei grandi e dei santi presso Dio. E devono i medici crescere
in modo da svilupparsi nelle cose della medicina similmente agli alberi di
senape che grandeggiano su tutti gli altri. Tutto ciò deve aver inizio e il suo
primo germoglio con la, giovinezza. Sappiate perciò che deve esistere una ”congruitas”,
cioè che la qualità specifica del corpo concresca con quella della luce
naturale, e che s'accordino insieme. Giacché l'uomo non può comporle né
coordinarle, non essendo ciò affar suo. Dunque il fondamento deve starsene
piantato ed essere consolidato fin dalla giovinezza. E quel che viene seminato a
tempo giusto, farà sbocciare un buon germoglio. Lealtà e amore sono una cosa
sola. Orbene, in che consiste la lealtà di un medico? Non tanto nel visitare
accuratamente il malato, quanto nell'imparare a conoscerlo, a vederlo e
ascoltarlo; e se la lealtà è entrata nel suo cuore, questo significa che egli
deve aver appreso con diligenza e lealtà ciò di cui il malato ha bisogno.
Giacché massimamente la lealtà viene trascurata quando uno vuole imparare
soltanto per farne sfoggio, per le apparenze, per le chiacchiere, per il nome, e
di tali cose vuole esser saziato. Tutti costoro sono sleali e privi di ogni
amore.
Inoltre il medico deve essere ingegnoso. Colui che appunto vuole essere
ingegnoso, deve avere pratica d'ogni cosa. Come puoi infatti esprimere un
giudizio su qualche cosa, se non puoi giudicare sulla base di cose diverse? In
che consiste dunque la ingegnosità di un medico? Nel sapere che cos'è utile e
contrario alle cose insensibili, che cosa è gradevole e sgradevole ai mostri
marini, che cosa è salutare per loro o dannoso allo loro salute. È questa
un'ingegnosità che concerne le cose naturali. E che cos'altro ancora? Le
incantagioni vulnerarie e le loro forze, ciò da cui e per cui giungono al loro
effetto, e come dovrebbero perfettamente essere intese e comprese. Che cosa è
oltre la natura, che cosa oltre la specie, che cosa il visibile e l'invisibile,
che cosa dà il dolce e l'amaro che cos'è la morte, che cosa serve al
pescatore, che cosa dovrebbero sapere il cuoiaio, il conciatore, il tintore, il
forgiatore di metalli, il carpentiere, che cosa va messo nella cucina, nella
cantina, nel giardino, che cos'è dovuto al tempo, che cosa sa un cacciatore, un
minatore, che cosa tocca a un vagabondo, che cosa a un sedentario, che cos'è
uso di guerra, che cosa crea la pace, che cosa determina uno stato
ecclesiastico, uno stato secolare, che cosa costituisce ogni stato, che cosa
veleno, che cosa contravveleno, che cosa c'è nelle donne e negli uomini, qual
è la differenza tra donne e vergini, tra i gialli e i pallidi, tra i bianchi e
i neri, tra i rossi e i lionati, in tutte le cose, perché qui ci sia questo
colore, là un altro, perché una cosa sia lunga, un'altra corta, una riuscita,
un'altra malriuscita. E come tutte queste cognizioni debbano essere conseguite.
Non è che questa sia già la medicina, bensì la qualità connessa alla
medicina.
Sappiate allora quel che deve esserci nel malato: una naturale infermità, una
naturale volontà, una naturale forza. Da queste tre cose dipende il compimento
dell'opera del medico. Se c'è nel malato qualcosa di diverso gli quel che si è
indicato, egli non può aspettarsi dal medico nessuna guarigione. Quelli infatti
che Cristo ha risanato, dovevano essere idonei a ricevere in sé tale
guarigione. Nessuno mai fu risanato di coloro che non avevano tale disposizione.
Esiste in Dio una distribuzione dei destini assegnati all'uomo e alla natura,
che nessuno può valutare o intendere alle sua radici, e nessuno può rendersi
conto quale destino sia riservato a ognuno. È un grande mistero divino celato
all'uomo. Il medico deve essere consolidato nella conoscenza del cielo,
dell'acqua, della terra e dell'aria e su questa base deve conoscere il
microcosmo e, confidando in questa conoscenza, salvaguardare la sua coscienza, né
deve sottrarre o aggiungere qualche cosa a Dio, bensì stare costantemente in
attesa di grazia e di misericordia.
Paracelso (Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim, detto Philippus Aureolus
Theophrastus Paracelsus, 1493-1541)
18
- Della differenza esistente fra gli uomini (M.
G. de Montaigne)
In qualche luogo Plutarco scrive
che non esiste tanta differenza tra bestia e bestia, quanta fra uomo e uomo.
Egli si riferisce al valore dello spirito e alle qualità dell'animo. Ma in
verità, fra il tale che conosco ed Epaminonda (quale l'imagino), corre tanta
distanza che son portato volentieri a rincarare la dose di Plutarco e affermare
che c'è tanta differenza tra quello di mia conoscenza ed il grande capitano
quanta ce ne sia tra l'uomo e la bestia e che vi sono tante e innumerevoli
sfumature, tra uomo e uomo, quante braccia corrono fra cielo e terra.
Ma a proposito della stima degli uomini, è singolare come - noi eccettuati -
ogni cosa venga apprezzata per le qualità che le sono proprie. Lodiamo un
cavallo perché è vigoroso e veloce, non per i suoi finimenti; un levriere per
la sua rapidità, non per il suo collare; un uccello per l’ampiezza dell'ala
non per le correggie o i campanelli (correggie di lancio e campanelli che
venivano usati con gli uccelli da preda nell'esercizio della caccia).
L'uomo invece, perché non lo apprezziamo per ciò che è? “Conduce vita
fastosa, possiede un magnifico palazzo - si dice -, tanto di rendita, tanto di
conto in banca". Ma, tutto ciò è intorno a lui, non è lui.
Michel E.
de Montaigne
(1533-1592)
19 - Dell’incostanza e delle nostre azioni (M. G. de Montaigne)
Chi si diletta nel vagliare le
azioni umane, incontra il maggior imbarazzo nel porle tra loro in relazione e
presentarle sotto una medesima luce; si profilano infatti, il piú delle volte,
così straordinariamente contradditorie, che non sembrano nemmeno uscite dalla
medesima bottega: Mario pare ora figlio di Marte ora di Venere; papa Bonifacio
VIII, si dice, assunse la tiara col fare della volpe, la tenne come un leone,
morì come un cane; e chi crederebbe che proprio Nerone - questo prototipo della
crudeltà - dinanzi a una sentenza di morte portatagli per la firma, abbia
esclamato: "Piacesse a Dio che non avessi mai imparato a scrivere”, tanto
lo tormentava l'idea di condannare a morte un uomo ?
La storia è così ricca di simili esempi, e ciascuno, d'altra parte, può
fornirne per proprio conto, che mi par strano che i dotti si siano talvolta
ingegnati di conciliare tante contraddizioni, quando la contraddizione è il
segno più vistoso e caratteristico della natura umana.
Seguiamo, di solito, gl’impulsi del nostro desiderio - a destra, a manca, in
alto, in basso, secondo il vento dell'opportunità. Non pensiamo ciò che
vogliamo, se non nell'istante in cui lo vogliamo, e cangiamo di colore come gli
animali che si mimetizzano secondo l'ambiente in cui vivono. Mutiamo un istante
dopo ciò che abbiamo deciso in questo istante, per tornare immediatamente sui
nostri passi; oscillazione ed incostanza ci sono proprie.
‘Ducimur ut nervis alienis mobile lignum’ (Orazio)
(siamo mossi come marionette di legno da braccia estranee).
Non procediamo per conto nostro; ci lasciamo trasportare, come cose che
scivolano, ora più, ora meno dolcemente, a seconda che le acque sono in
tempesta o in bonaccia. Ogni nuovo giorno reca una nuova fantasia, e i nostri
umori si agitano secondo il ritmo del tempo.
Oscilliamo fra pareri discordi; non vogliamo niente liberamente, niente
assolutamente, niente con costanza.
Michel E. de Montaigne
(1533-1592)
20
- Quanto sia ingiusto il risentimento verso quelli che mancano di riconoscenza (P.
Nicole)
Nulla
indica maggiormente quanto la fede sia spenta e poco attiva nei cristiani, come
il loro rispetto quando non si ha per essi tutta la gratitudine che ritengono di
meritare. Tale pretesa è la più opposta alla luce della fede.
Se i cristiani riguardassero come si deve, i servigi resi agli altri, li
considererebbero come grazie ricevute da Dio e che essi devono alla sua bontà,
e come opere che avrebbero dovuto offrirgli e consacrargli senza alcun riguardo
alle creature. Come unire allora questi sentimenti di riconoscenza a Dio - (a
cui deve condurre la fede), al dispetto e al dispiacere che si prova quando gli
uomini mancano a ciò che immaginiamo essi ci debbano?
Tuttavia la mente della maggior parte degli uomini è continuamente occupata a
esaminare se vien loro reso ciò che è loro dovuto, se quelli ch’essi hanno
servito sentono i propri obblighi, e se compiono puntualmente i doveri che le
consuetudini hanno stabilito per esprimere la gratitudine. Se si avessero i veri
sentimenti che la fede deve ispirare, si sarebbe persuasi che, come Dio ci fa
una grande grazia dandoci il mezzo di servire gli altri, cosí ce ne fa un'altra
non minore permettendo che gli uomini non ci dimostrino la riconoscenza che ci
debbono, Poiché è giusto che, dandoci un tesoro inestimabile, esso ci resti e
nessuno ce lo tolga. Ma la nostra gioia dev'essere piena e completa quando
possiamo credere che le persone che parrebbero mancar di riconoscenza verso di
noi, ne sono invece molto capaci in se stesse, ma non possono esprimerla perché
ignorano di esserci obbligati. E quantunque sia realmente vantaggioso per noi
che gli altri ci manchino di gratitudine, non dobbiamo però desiderarlo, perché
sarebbe un male per loro.
Dobbiamo inoltre persuaderci che non solo c'è molta ingiustizia in quest'attesa
della gratitudine degli altri, ma anche molta bassezza, questi doveri di
riconoscenza che esigiamo, si riducono sovente a un semplice complimento o a
qualche gentilezza inutile, e queste son le cose che preferiamo a Dio e ai beni
ch’egli ci promette. Sovente siamo anche noi la causa del difetto che
imputiamo agli altri. Noi spegniamo la gratitudine nel loro cuore per il modo
con cui li serviamo, ed abbiamo sempre quasi l'aria di credere, quando li
vediamo essere verso di noi meno riconoscenti di quanto lo siamo verso altri,
che v'è qualcosa che non attira la riconoscenza. Ma sia che ciò accada per
nostra colpa, sia per colpa altrui, è sempre una debolezza l'offendersi quando
non ci vengon resi dei ringraziamenti che noi vediamo chiaramente non poter
essere che pericolosi.
Pierre Nicole (1625-1695)
21
- Osservazioni su parecchi difetti delle giovinette (F.
Fenelon)
Abbiamo a
parlare della cura che bisogna prendere per preservare le fanciulle da parecchi
difetti che di solito si riscontrano nel loro sesso. Si fanno crescere in una
mollezza ed in una timidità che le rendono incapaci di una condotta ferma e
regolata. Da principio vi è molta affettazione, e in seguito molto di abitudine
nei timori senza fondamento e nelle lacrime che versano a buon mercato; il
disprezzo verso queste affettazioni può giovare molto a correggerle, poiché la
vanità ne è in gran parte la cagione.
Bisogna pure reprimere in esse le amicizie troppo tenere, le piccole gelosie,
l'eccesso dei complimenti, le moine, le sollecitudini; tutto ciò le guasta e le
abitua a considerare come troppo dura e troppo austera ogni cosa grave e seria.
Occorre anche mirare a far sì che si studino di parlare con brevità e
precisione. Il buon spirito consiste nel sopprimere tutti i discorsi inutili e
nel dir molto con poche parole, mentre la maggior parte delle donne dicono poco
con molte parole. Esse fanno consistere lo spirito nella facilità di parola e
nella vivacità dell'immaginazione; non fanno scelta alcuna tra i loro pensieri;
non mettono alcun ordine nelle cose che hanno da esporre; esse si appassionano
in quasi tutto ciò che dicono e la
passione fa molto parlare; perciò non si può sperare niente di buono da una
donna, se non la si riduce a riflettere con ordine, ad esaminare i propri
pensieri, ad esporli con brevità, ed a saper anche tacere.
Le donne hanno una naturale disposizione a ogni sorta di commedie; le lacrime
non costano niente, le loro passioni sono vive e le loro conoscenze assai spesso
limitate: ne viene che non trascurano nulla per raggiungere il loro scopo e che
i mezzi i quali non converrebbero a dei caratteri più assestati ad esse paiono
buoni; non fanno alcun ragionamento per esaminare se una cosa bisogna
desiderarla; ma sono industriosissime per conseguirla.
La bellezza inganna ancor più la persona che la possiede che non quelli che ne
sono abbagliati; essa turba inebria l'anima. Si è più scioccamente idolatri di
se stessi che non gli amanti più appassionati lo siano per la persona di cui
sono innamorati. Non v’è che un piccolissimo numero di anni di differenza fra
una bella donna ed una che non è più tale. Le persone che traggono tutta la
loro gloria dalla loro bellezza, diventano spesso ridicole.
Dalla bellezza passiamo all'abbigliamento: le vere grazie non dipendono punto da
un ornamento vano ed artificioso. Io vorrei far vedere alle giovani fanciulle la
nobile semplicità che appare nelle statue, e nelle altre figure che ci restano
delle donne greche e romane; esse vedrebbero come capelli annodati
negligentemente all'indietro, e frappi pieni e fluttuanti a lunghe pieghe sono
gradevoli e maestosi.
Per poco che il loro spirito si elevi sopra la preoccupazione delle mode, esse
avrebbero presto un gran disprezzo per i loro riccioli così lontani dal
naturale e per gli abiti di disegno troppo studiato. C'è da far notare per
tempo alle fanciulle la vanità e la leggerezza di spirito che produce
l'incostanza delle mode. È una cosa molto male intesa, per esempio,
l'ingrossarsi la testa con non so quali tuppi e reticelle; le vere grazie
seguono la natura e non l'impacciano giammai.
Ma la moda si distrugge da sé; essa mira sempre al perfetto, e non lo trova
mai, almeno non vuol mai arrestarvisi; sarebbe ragionevole se non cangiasse che
per non cangiare più, dopo raggiunta la perfezione della comodità e della
buona grazia; ma cangiare per cangiare senza posa, non è forse voler piuttosto
l'incostanza e la sregolatezza che non la vera convenienza e il buon gusto? Così
d'ordinario nelle mode non vi è altro che capriccio. Le donne sono arbitre
nella scelta. Le più leggere e senza un proprio personale gusto, trascinano le
altre; esse non scelgono e non rifiutano nulla secondo una regola; è
sufficiente che una cosa ben inventata sia stata lungo tempo di moda, perché
essa non lo debba piú essere, e che un’altra, ancorché ridicola, a titolo di
novità, ne prenda il posto e sia ammirata.
Ma quando si cerca di piacere, che cosa si pretende? Non è forse per eccitare
le passioni degli uomini? Quel che rimane a fare sì è di distogliere le
fanciulle dal far le spiritose. Se non ci si guarda, quando esse sono un po'
vivaci, cacciano il naso dappertutto, di tutto voglion parlare, sentenziano
sulle cose più lontane dalla loro capacità, affettano d'annoiarsi per
delicatezza. Una fanciulla non deve parlare se non per veri bisogni ed avere un
contegno di deferenza.
Niente è più stimabile come il buon senso e la virtù; l'uno e l'altra
inducono a riguardare il disgusto e la noia non come una delicatezza lodevole,
ma come una debolezza da spirito ammalato.
François Fénelon (1651-1715)
22
- Uomo di fondo, uomo assennato (Baltasar
Gracian)
Più c'è di fondo, e più si è
uomo. L'interno deve valere altrettanto di più di quanto è l'esterno. Vi sono
persone che hanno una sola facciata, come casa non ancora finita di costruire
perché è venuto meno il capitale: hanno l'entrata di un palazzo e l'abitazione
di una capanna. Con simili persone, non sai mai su che intrattenerti, su che
indugiarti perché, dopo lo scambio dei saluti, è finita la conversazione.
Entrarono a farti le prime cortesie col buio dei cavalli siciliani e poi, subito
diventarono taciturni, giacché le parole subito si esauriscono dove non c'è
continuità di concetti. Costoro ingannano facilmente quelli che, anch’essi,
hanno la vista corta, ma non già la perspicacia, la quale, poiché mira al di
dentro, li giudica vuoti, fatti per essere oggetto di favola degli uomini saggi.
Uomo assennato e penetrativo
- Egli signoreggia gli oggetti, non gli oggetti lui. Scandaglia subito il fondo
della maggior profondità; sa far la perfetta anatomia della capacità di un
altro. Nel vedere un uomo, lo comprende e lo esamina nella sua essenza. Di rare
osservazioni, gran decifratore della più riposta segretezza d'un cuore. Severo
nell'osservare, fine nel concepire, assennato nel trarre le conseguenze: tutto
scopre, osserva, intende e comprende.
Non venir mai meno al rispetto verso
se stesso - Nemmeno quando è solo, l'uomo savio sia triviale. La
medesima sua integrità sia norma della sua rettitudine, e sia più debitore
alla severità dei suoi principi che a tutti i precetti estrinseci. Si astenga
dal far ciò ch'è sconveniente, più per tema di offendere la sua saggezza che
per il rigore dell'altrui autorità. Arrivi a temere se stesso, e non avrà
bisogno del pedagogo immaginario di Seneca.
Non iscomporsi mai ‑
Gran compito della prudenza è quello di non iscomporsi mai. Prova che si è in
tutto un uomo, di possedere il cuore di un re, perché tutti i grandi animi
difficilmente si turbano. Le passioni sono gli umori dell'animo, e qualunque
eccesso di esse cagiona infermità alla saggezza; e se il male va sino alla
bocca, correrà pericolo la reputazione. Bisogna dunque che il savio sia così
signore di sé, e così gran signore che, sia nella maggiore prosperità che
nella maggiore avversità, non possa alcuno censurarlo di essere perturbato, ma
ammirarlo, invece, sereno.
Baltasar Gracian (1601-1658)
23
- Sui cenni con l'occhio (Ibn
Hazm)
Alle allusioni in parole seguono, una volta gradito
l'amore e stabilitasi un'armonia fra i due, i cenni con l'occhio. Questi sono
assai apprezzati in tale situazione, e raggiungono effetti meravigliosi; coi
cenni dell'occhio si troncano e si allacciano legami, si fanno promesse e
minacce, si sgrida e si rincuora, si fanno comandi e divieti, si colpiscono gli
sciocchi, si ride e ci si rattrista, si domanda e si risponde, si nega e si
dona. Ognuno di questi sensi ha un suo genere di occhiata che solo la diretta
visione può definire, e di cui solo una piccola parte può raffigurarsi e
descriversi. Dirò di quelli fra questi significati che si possono più
facilmente spiegare: un cenno con la coda d'un occhio solo equivale a un
divieto; un'occhiata languida è segno di consenso, uno sguardo fisso indica un
dolersi e rammaricarsi, un batter l'occhio è segno di gioia; un serrar l'occhio
indica minaccia, un volger la pupilla da una parte e poi subito ritrarla è un
metter in guardia contro una persona indicata, un occulto cenno con ambedue gli
occhi è una domanda, un rapido spostare la pupilla dal centro all'angolo
interno dell'occhio attesta il diniego, un far rotare ambedue le pupille dal
centro degli occhi equivale a un assoluto divieto; il resto non può intendersi
che con la visione diretta.
Gli occhi tengon le veci dei messaggeri, e per mezzo loro si viene a capire ciò
che si desidera. I quattro sensi sono delle porte pel cuore, e degli spiragli
per l'anima, e l'occhio è il più efficace e valido dei sensi nell'indicare e
il più comprensivo nell'agire. Esso è il verace esploratore dell'anima, la sua
retta guida, il suo lucido specchio con cui essa contempla il vero, afferra le
qualità, percepisce le sensazioni. Si è ben detto: "Chi sa per relazione
avuta non è pari a chi vede coi propri occhi". E di ciò parla Filemone,
l'autore della “Fisiognomica”, e sull'occhio appunto ha fondato i suoi
giudizi. Ti basti pensare, circa la facoltà di percezione dell'occhio, che
quando il raggio che da esso si diparte incontra un raggio lucido e limpido, o
d'una lama forbita o di un vetro o d'acqua o di una pietra polita, o di altra
cosa levigata e lucente che brilli e scintilli o lampeggi, le cui estremità
siano in contatto con un corpo opaco, non trasparente, ed oscuro, allora il
raggio dell'occhio si rifrange indietro, e il riguardante vede se stesso e
coglie coi suoi occhi la sua propria immagine: è appunto ciò che vedi nello
specchio, là dove è come se tu guardassi a te con l'occhio di un altro. Una
prova oculare di questo è che se prendi due grandi specchi e ne tieni uno con
la destra dietro il tuo capo, e l'altro con la sinistra di fronte al viso, e poi
lo sposti leggermente ad angolo in modo che i due specchi si incontrino
affrontati, riesci a vedere la tua nuca e tutto ciò che sta dietro di te, per
il riflettersi della luce dell'occhio verso quella dello specchio che ha dietro,
non trovando essa modo di penetrare in quello che hai davanti: non trovando del
pari passaggio di là dal secondo specchio, essa si dirige verso il corpo che le
sta di fronte.
Basterebbe notare, circa la virtù dell'occhio, che la sua sostanza è la più
elevata, perché fatta di luce: solo con esso si percepiscono i colori, né
esiste cosa che più di esso abbia lontana mira e remoto obbiettivo, giacché
grazie ad esso si scorgono i corpi stellari nelle remote sfere celesti, e il
cielo con tutta la sua altezza e lontananza; il che accade solo per il fatto
dell'occhio è congiunto nella sua propria natura con quello specchio del cielo,
e quindi lo percepisce e giunge ad esso d'un balzo, non già percorrendo un
luogo dopo l'altro, fermandosi a tappe, e con momenti successivi di marcia. Ciò
non avviene a nessun altro dei sensi, come il gusto e il tatto, che percepiscono
solo per l'immediata contiguità dell'oggetto, e l'udito e l'odorato che
percepiscono solo da vicino. Prova del balzo di cui abbiam parlato è il fatto
che tu vedi la fonte del suono prima di udire il suono stesso, anche se cerchi
di cogliere le due percezioni insieme; se le due percezioni ne facessero una
sola, l'occhio non precederebbe l'udito.
Ibn Hazm (994 - 1064)
24 - Sulla corrispondenza epistolare (Ibn Hazm)
A questo segue, quando i due
amanti hanno allacciata la relazione, la corrispondenza epistolare. Gli scritti
sono dei segni denunziatori: e ho visto chi si trovava in tali condizioni
affrettarsi a farli in pezzi e a farne sparire le tracce.
Quanto spesso uno scandalo è scoppiato per causa di uno scritto! A tal
proposito ho scritto questi versi:
Ben
mi rincresce oggi il dover
la vostra lettera lacerare, ma l'amore
non si è trovato ancor chi lo laceri.
Ho quindi preferito che rimanesse l'affetto
e l'inchiostro si distruggesse,
ché il ramo vien dietro alla radice.
Quanti scritti han contenuto in sé
la morte del loro autore, né egli lo sapeva
quando le dita li vergavano!
Bisogna che la forma dello
scritto sia quanto mai fine, e il suo genere quanto mai leggiadro, giacché
davvero lo scritto è talvolta come una parola, sia per un impedimento in cui
l'uomo si trovi a usarla direttamente, sia per pudore o per soggezione. Tanto
che l'arrivo stesso dello scritto all'amato, e la conoscenza dell'amante che
quello è pervenuto in mano al destinatario e che quegli l'ha visto, hanno in sé
per l'amante un mirabile piacere che tien luogo della diretta visione; così
come la risposta e il poterla leggere contengono una gioia pari a quella che dà
l'incontro. Perciò vedi l'amante mettersi la lettera sugli occhi e sul cuore, e
abbracciarla; e io ho conosciuto un innamorato che sapeva bene come esprimersi,
parlava ottimamente, e diceva oralmente benissimo quanto aveva nell'animo, che
era un buon osservatore e preciso e sottile, e con tutto ciò non tralasciava
punto la corrispondenza epistolare, pur avendo la possibilità di trovarsi
assieme all'amor suo, con la casa vicina, e facile opportunità di visita. Si
dice che vi siano qui vari generi di piacere: mi è stato persino raccontato di
un volgare mascalzone che si metteva la lettera della persona amata sul membro:
genere ignobile, questo, di piacere venereo, e abbietta sorta di libidine. Ma
conosco chi soleva stemperare le lacrime nell'inchiostro, a cui l'amato rendeva
la pariglia stemperando nell'inchiostro la saliva; sul che io ho fatto questi
versi:
Mi
è giunta una risposta a una lettera
da me inviata, e ha calmato un'eccitazione,
ed eccitato una calma.
Irrorai lo scritto delle lacrime dell'occhio
quando lo scrissi,
come fa un amante dal sincero amore.
E le lacrime dell'occhio ne andaron
via via cancellando le righe;
o lacrime mie, avete cancellato delle bellezze!
Il principio dello scritto fu reso chiaro
dalle mie lacrime, e la sua fine scomparve
per effetto delle mie lacrime stesse.
Vidi una volta una lettera
d’un amante al suo amato: l'autore si era incisa la mano con un coltello e
aveva usato come inchiostro il sangue sgorgato, scrivendo con esso l'intera
lettera. Vidi la lettera dopo che s'era asciugata, e non avrei dubitato che
fosse scritta con tinta lacca.
Ibn Hazm (994 - 1064)
25
- Ascesi ed erotismo (Rosa
Mayreder)
Nelle condizioni sociali come
nell'anima nostra il passato permane più di quel che non si creda. Tale
permanere di un passato del quale non acquistiamo conoscenza in maniera diretta
rende confuso e contraddittorio il presente ove non si comprendano i nessi
storici. Ciò è vero soprattutto nel campo sessuale. Lo stato di cose che in
esso si è venuto formando durante il corso della storia presenta una tale
confusione, sia degli istinti che delle valutazioni, da far pensare ad una vera
e propria degenerazione.
Il paragone fra il nostro modo di procedere nelle cose sessuali e quello dei
popoli primitivi non ridonda a favore dell'umanità civile; né si può negare
che la vita sociale di quei popoli, come pure le loro idee intorno alla
sessualità, rispondano molto meglio delle nostre all'importanza che spetta
all'istinto sessuale come mezzo di conservazione della specie. In se stesso,
quale sorgente di un eterno rinnovamento della vita, l'istinto sessuale va
considerato con rispetto; è quindi logicamente comprensibilissimo il fatto che
nelle primitive concezioni religiose l'atto sessuale fosse inteso come alcunché
di sacro agli dei, come sacrificio da offrirsi.
Fanno testimonianza di ciò molti usi in vigore presso diversi popoli
dell'antichità; così il costume babilonese che obbligava ogni donna a
sacrificare la propri verginità nel tempio di Astarte, così l'istituzione
greca dei “servitori del tempio” nei luoghi destinati al culto d'Afrodite.
La concezione dell'atto sessuale quale atto sacrifico appare con la massima
evidenza in quegli antichi culti dei boschi e dei campi che mettevano in
relazione la fertilità del suolo con la prolificazione umana. La caratteristica
per cui questi costumi contrastano essenzialmente con le idee appartenenti a
stadi posteriori di civiltà è il loro legame con il campo religioso della vita
psichica.
Questo atteggiamento reverente nei riguardi delle cose sessuali scompare
interamente nelle epoche successive. Allora non solo la dissolutezza e la
lascivia trasformano nella vita tutto ciò che è inerente al sesso in qualche
cosa di osceno, di volgare, di ridicolo, ma persino gli uomini più seri, quelli
che sentono più elevatamente la vita, rinnegano la sessualità, la fanno
oggetto di vergogna, di rimorso di rivolta morale.
Donde proviene - considerata come sintomo di uno stato d'animo generale - l'ac
canita ostilità che la sessualità scatena nei moralisti d'ogni tempo? Donde
l'importanza metafisica che l'ascesi assume in ogni concezione della vita intesa
ad elevare l'uomo? Perché in tutte le civiltà coloro che sono considerati
modelli, maestri, conduttori siano essi profeti ebraici, filosofi greci o
romani, santi buddisti o cristiani sogliono prendere di fronte allo sfrenato
esplicarsi dell'istinto naturale un atteggiamento di opposizione? Questi uomini
superiori non hanno forse causato un fatale traviamento nella vita sentimentale
dell'uomo mettendola irreparabilmente in contrasto con le insopprimibili
esigenze della natura?
Le cause della opposizione ascetica alla sessualità si sogliono far risalire
alle idee cristiane che per tanti secoli dominarono il mondo occidentale. Ma
quella opposizione non è originale del Cristianesimo. Essa ha ben più lontane
radici nella storia dello spirito umano. Effettivamente la tendenza ascetica
della rinunzia è di molto anteriore al Cristianesimo. Già nella libertà
sessuale dei popoli meno evoluti esiste una incoerenza; si ritrova infatti
presso di essi l'idea di “impurità” connessa con gli atti sessuali, idea
che particolarmente informa le prescrizioni riguardanti le funzioni religiose.
“È regola ampiamente diffusa - dice il Westermark parlando dei popoli
primitivi - che chiunque compia un atto sacro o entri in un luogo consacrato
debba essere assolutamente puro; e non v'è impurità più temuta di quella
sessuale". L’imposizione della continenza in determinate epoche e a
determinati scopi si ritrova anche presso popoli altrimenti liberi da idee
ascetiche, ad esempio presso i Maomettani ai quali durante i pellegrinaggi alla
Mecca è prescritto di mantenersi casti.
Anche là dove non appare ancora traccia di ascetismo nel senso di opposizione
alla sessualità, viene attribuita alla castità una grande importanza. Infatti
i popoli selvaggi che si impongono la castità in tempo di guerra sanno per
esperienza che la soddisfazione del desiderio sessuale non è compatibile con
uno speciale impiego di forze in altro campo. E poiché un tale impiego di forze
è richiesto in particolar modo dalle opere spirituali, il clero, quale
intermediario col divino, manifesta sin dagli inizi la tendenza ad eliminare
mediante l'austerità della vita la propria disposizione alla sessualità. I
popoli più diversi sviluppano indipendentemente l'uno dall'altro questa idea
dell'importanza della castità. Così, i Neoplatonici insegnavano che l'uomo non
arriva alla sfera del divino, che le sue preghiere non vengono esaudite, se egli
non è diventato “puro” mediante la castità. In tutt'altra cerchia di
civiltà i Mori professavano la credenza che i passi del Corano avessero
efficacia contro gli spiriti maligni soltanto se pronunciati da un uomo casto.
L'osservazione che il resistere alla violenza dell'istinto naturale cresce la
forza dell'uomo in altre direzioni sembra risalire a tempi molto remoti. Questo
fatto vien definito dalla psicologia moderna come sublimazione. Sublimazione
degli impulsi sessuali, cioè trasformazione di un atto fisico in un atto
spirituale. Ciò presuppone che l'energia destinata all'atto fisico venga invece
impiegata in un'attività spirituale. Se una tale trasposizione di valori fosse
realmente possibile, essa giustificherebbe l'idea primitiva che la castità
produca una elevata potenza spirituale, o, per esprimerci col linguaggio degli
antichi, che essa conferisca un potere “magico”.
Di qui sorge nell'uomo il primo dissidio fra la vita spirituale e la sessualità.
Non appena l'attività spirituale è subordinata ad una limitazione
dell'elemento sessuale, le pretese della sessualità non possono più essere
illimitate. E quanto più crescono le esigenze spirituali, tanto maggiore
importanza acquistano anche il superamento e la repressione degli impulsi
sessuali.
A questo riguardo due mondi si distinguono nella natura umana. Da essere
sensuale sottoposto alle potenze elementari della natura l'uomo incomincia a
trasformarsi in essere spirituale ed a contrastare tali potenze in virtù di una
facoltà che fra tutte le creature egli solo possiede. Corpo e anima appaiono
allora alla coscienza umana come campi separati, anzi come principi opposti. Da
questa separazione scaturisce una mirabile idea che per millenni dominò
l'umanità con religiosa potenza: l'idea che un demone di natura superiore,
l'anima, abiti nel corpo umano, che il corpo altro non sia che una prigione
dell'anima, e che questa abbia la sua vera patria nell'aldilà, nel mondo
divino.
L'origine di tale idea si perde nelle tenebre della storia. Dapprima essa è
tenuta celata quale dottrina segreta, ed è comunicata soltanto a pochi
iniziati. Nel mondo greco, tutto proteso, verso la gioia terrena, essa appare
con gli Orfici ed i Pitagorici, per assumere più tardi con Platone una forma
filosofica accessibile a tutti ed estendersi poi sempre più nel pensiero
dell'umanità civile. Quale dottrina, infatti, potrebbe avere sull'uomo maggior
presa di questa che afferma l'immortalità dell'anima? L'uomo non più essere
effimero abbandonato ai demoni delle potenze naturali, ma creatura unita al
divino, viene a trovarsi in una nuova relazione col mondo. Ma la condizione per
giungere a questo è appunto l'ascesi. L'ascesi, cioè il freno creato dalla
volontà, o più ancora la completa mortificazione dei desideri corporei e delle
passioni a pro di una idea superiore. Infatti tutto ciò che lega l'anima al
corpo ne ostacola o ne impedisce l'elevazione nel mondo tutto spirituale e
divino.
Soltanto da ultimo questa concezione ha raggiunto nell'ascesi cristiana le sue
estreme conseguenze quale idea fondamentale della coscienza religiosa. Perciò
l'asceta cristiano diventa sempre più recisamente avverso alla sessualità. Le
lotte e i turbamenti che questa gli procura rafforzano in lui la credenza che
essa sia campo di potenze nemiche contrarie al divino. L’interpretazione
fantastico-metafisica degli stati intimi dell'individuo, alimentata dagli
effetti fisici della castità i quali nei temperamenti violenti, passionali,
esuberanti assumono le forme più strane, dà luogo ad un sistema di idee in cui
persino la più importante funzione della vita sessuale, la riproduzione, viene
deprezzata in confronto ai vantaggi della castità. All'obiezione che la specie
umana si estinguerebbe se tutti gli uomini rimanessero incondizionatamente
casti, Sant'Agostino risponde: “Così fosse! Il regno di Dio si sostituirebbe
allora all'esistenza terrena".
Se è vero che il Cristianesimo è una sintesi di elementi spirituali ellenici e
giudaici, la sua tendenza ascetica deriva presumibilmente da influssi
orfico-platonici. Nell'etica sessuale giudaica quale ce la tramanda l'Antico
Testamento, non riscontriamo alcuna traccia di opposizione ascetica alla
sessualità. L’istinto sessuale L’istinto sessuale è giustificato allo
scopo della riproduzione, e la caduta della prima coppia umana, che ebbe per
conseguenza la cacciata dal paradiso, non viene attribuita ad un atto sessuale.
Geova che impone al suo popolo di moltiplicarsi illimitatamente, punisce
soltanto gli atti sessuali che contrastano con tale scopo. C'é tuttavia nella
dottrina segreta giudaica, la Cabala, un'idea non conciliabile con
l'incondizionata adesione alla sessualità. La Cabala insegna che esiste una
maniera di procreazione superiore a quella sessuale, cioè la procreazione per
mezzo di “immaginazione magica”. Il primo Adamo, l'Adamo Cadmone, essere
androgino, avrebbe posseduto la facoltà di riprodursi per mezzo della
immaginazione magica. Solo con la caduta, che rappresenta la discesa dal mondo
spirituale al mondo dei sensi, Adamo perdette questa facoltà e con essa il
paradiso, per condurre da allora in poi, come creatura distinta in due sessi,
una esistenza terrena infelice e soggetta alla morte. Osserviamo che alla
possibilità della generazione per mezzo dell'immaginazione magica credeva
ancora il grande naturalista Paracelso. Egli chiamò "salnitrica" la
riproduzione per via sessuale e la considerò riprovevole in quanto impedimento
alla procreazione magica alla quale diede il nome di "iliastrica".
Questi strani concetti hanno per noi unicamente valore di sintomo, poiché ci
rivelano l'atteggiamento, assunto dallo spirito umano, durante la sua
evoluzione, rispetto alla sessualità. Il fatto che questo atteggiamento sia
identico nelle epoche e presso i popoli più diversi ci induce a ricercarne la
prima ragione nella natura umana. Per quanto errata ed assurda appaia la
negazione ascetica della vita sessuale considerata soltanto in rapporto con le
leggi naturali della riproduzione, accade tuttavia che il controsenso si
trasformi in una conseguenza logica non appena si ammetta che un'esistenza
puramente spirituale, un'attuazione del regno di Dio, si possa realizzare
mediante il superamento di tutti i così detti desideri carnali. La forza eroica
con la quale lo spirito lotta per predominare nella natura umana si manifesta
con la massima evidenza nelle idee che lo spirito crea attorno all'importanza
metafisica della condotta sessuale dell'uomo e nelle valutazioni ad esse
inerenti.
Quanto più forti sono le esigenze dello spirito, tanto maggior danno questo
risente dalle esigenze della sessualità. Il primo tra i cristiani a farne
testimonianza fu S. Paolo. Infatti i Vangeli, espressione di anime semplici, non
contengono alcuna tendenza ascetica, a meno che a causa della parentela con la
generazione per via di immaginazione magica non si voglia far derivare l'idea,
della immacolata concezione di Gesù da una negazione ascetica della
pirocreazione naturale. È bensì vero che l'origine di certi eroi fu
anticamente ricondotta a fatti meravigliosi esulanti dalla sfera sessuale, senza
che ciò implicasse una svalutazione della generazione naturale.
In San Paolo la tendenza ascetica si rivela evidente; egli è il primo della
lunga serie di santi cristiani che cercarono nella mortificazione della carne la
via per giungere a Dio. Egli esprime con accenti commoventi il dissidio della
natura umana divisa fra le esigenze del corpo e quelle dello spirito: "Io
veggo una legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente
(...) Poiché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio quello fo
(…) Io stesso adunque con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne
quella del peccato".
In questo dissidio si rivela anche in parte il motivo 'psicologico' dell'ideale
di vita ascetico. Il motivo obiettivo - spirituale ebbe origine dalla
persuasione che il senso della vita sia soltanto una preparazione, una prova in
vista del destino ultraterreno dell'uomo. Con ciò si veniva ad ammettere che
l'anima è immortale e di appartenenza divina, mentre il corpo coi suoi istinti
è soggetto alla morte ed escluso dal regno di Dio.
Il motivo soggettivo - psicologico dell'ascesi non è invece altrettanto
evidente. Qui sorge la domanda: Quale fu il fatto spirituale che determinò
l'opposizione alla sessualità? Quale processo psichico indusse gli asceti del
passato a vedere proprio nella sessualità qualche cosa di peccaminoso, un
impedimento alla redenzione, un allontanamento da Dio?
Oltre alla limitazione delle esigenze spirituali prodotta dagli impulsi
sessuali, limitazione che pone il cervello ed il sesso quali termini antitetici,
la vita dell'anima subisce anche un'altra menomazione da parte della sessualità.
È la legge fisiologica che ad ogni eccitazione segua un rilassamento, il grado
del quale è determinato dal grado di tensione. Nella sfera sessuale, in cui
l’organismo compie il suo massimo sforzo fidiologico, anche la reazione è
massima. “Omne animal post coitum
triste". Nell'uomo la reazione somatica dà luogo ad una reazione
psichica il cui effetto può essere funesto. Il ritorno allo stato normale,
creando una specie di ripugnanza fisica e persino di schifo per ciò che poco
prima era oggetto del più violento desiderio, analogamente a quanto avviene
nella nutrizione dopo il soddisfacimento della fame, assume facilmente nella
coscienza il carattere di sazietà o di pentimento. Le sensazioni spiacevoli
della reazione fanno sì che se ne condanni la causa come qualche cosa di
ingiusto, di peccaminoso, di ostile alla natura superiore dell'uomo.
L’aspirazione all'equilibrio psichico, che in così larga misura determina i
valori della vita, viene turbata dall'atto sessuale, e quanto più l'individuo
è sensibile tanto più penoso gli riesce questo turbamento del suo equilibrio
interno, specie se egli è dominato dall'ambizione spirituale. Questa ambizione
non tollera che alcun'altra potenza venga a menomarla per far luogo ad impulsi
elementari. A ciò si aggiunge che i mali e le sofferenze di cui è afflitta
l'esistenza terrena diventano sempre meno sopportabili con l'approfondirsi della
vita spirituale. Il miglior modo per sfuggir loro è rifugiarsi in uno stato
d'animo contemplativo il cui equilibrio non venga compromesso dalle passioni.
Questo è il motivo dominante dell'ascesi buddistica. Poiché non solo il
piacere, ma anche il dolore porta con sé un perturbamento dell'equilibrio
psichico, la vita dello ”yogi” tende ad uno stato di isolamento immobile che
per lui significa preparazione al “nirvana”. Tuttavia non gli è lecito
concepire nemmeno il nirvana come uno stato di beatitudine; non l'amor di Dio lo
induce a superare il mondo, bensì unicamente l'aspirazione ad annientare in lui
una forma d'esistenza che in nessun altro modo può essere liberata dal dolore.
Interamente diverso è l'atteggiamento dell'ascesi cristiana di fronte al
dolore. Per essa il dolore rappresenta la via per giungere a Dio. Essa distingue
tra affetti inferiori e affetti superiori; quelli che appartengono al dominio
transitorio e spregiato della corporeità, questi al divino ed eterno regno
dello spirito di cui l'estasi con le sue rivelazioni celesti è la forma più
sublime. Gli stati di estasi a quanto sembra, si possono ottenere soltanto a
prezzo di assidue macerazioni, e specialmente mediante il digiuno. Infatti molte
persone sottopostesi per motivi di salute alla cura del digiuno attestano di
aver avvertito negli stadi avanzati di questa una particolare chiarezza e levità
spirituale.
All'asceta cristiano del primo millennio erano negati i piaceri puramente
sessuali, né la sua costituzione gli concedeva le estasi derivanti dalla
fusione dell'anima coi sensi. Egli, concependo l'amore unicamente come uno stato
d'animo privo di qualsiasi carattere sessuale, si adoperava con ardore a
svilupparlo in sé sottoforma di amor del prossimo e di amor di Dio, allo scopo
di impedire con ogni sforzo che moti sessuali venissero a turbarlo.
Per una siffatta costituzione psichica la mortificazione della carne è l'unica
via di liberazione dalle strettoie di un dilemma insolubile. Nelle persone
spiritualmente orientate il dissidio fra spirito e corpo, il fatto che la
capacità d'amore non eserciti la sua azione mediatrice fra l'istinto sessuale e
personalità, genera una ripugnanza alla sessualità congiunta a valutazioni
negative ed accompagnata tra l'altro da giudizi sfavorevoli sulla donna. Basti
ricordare San Gerolamo che chiamò la donna “porta dell’inferno” mentre
l'inferno era probabilmente nel dissidio esistente in lui. Gli è che l'uomo
cerca di giustificare con la propria concezione della vita le sue disposizioni
individuali; il modo con cui ciascuno spiega la vita è il commento
intellettuale del suo io. Ma il rapporto fra il processo intellettuale da cui
sorge la concezione di vita e la costituzione psichica dello individuo pensante
si rivela raramente con segni visibili. Si è cercato di determinare il suddetto
rapporto in taluni pensatori moderni, in Schopenhauer ad esempio, ed in
Weininger, entrambi degni seguaci di San Gerolamo nella loro estimazione della
donna, quanto ai pensatori antichi le cui vicende noi conosciamo, nella migliore
delle ipotesi, sotto l'aspetto esteriore, ci mancano quasi interamente i punti
di riferimento. Risulta tuttavia dalle succitate parole di S. Paolo che alla
base delle loro concezioni stava il dissidio fra le esigenze della vita
spirituale e quelle della vita sensuale. A questo dissidio allude anche Sant'Agostino
nelle Confessioni: “È la medesima anima che vuole con volontà non integra e
piena questo o quello, e prova uno strazio dolorosissimo”. San Paolo e Sant'Agostino
sono i primi testimoni di uno stato d'animo che molti secoli più tardi il vate
di una nuova umanità (Goethe) esprimeva con le famose parole: “Misero, due
anime albergano nel mio petto, e vi si guerreggiano continuamente, e l'una
vorrebbe pur svilupparsi dall'altra. L'una con intenso indomabile amore si tiene
alla terra, e vi si aggrappa duramente con gli organi del corpo; l'altra si leva
impetuosa su questo oscuro soggiorno verso le sedi dove abitano gli alti nostri
progenitori”.
Per trovare nella storia una valutazione dell'ascesi indipendente dalle
illusioni religiose a questa congiunte, dobbiamo fermarci al tempo in cui, dopo
gli sconvolgimenti prodotti in Germania dalla guerra dei Trent'anni, sorgono
nuovi ideali di vita spirituale.
Intendiamo parlare dell'epoca che va dalla metà del diciottesimo secolo alla
prima metà del diciannovesimo. Sorvoliamo sul fenomeno della galanteria
prodottosi in Francia sotto Luigi XIV, essendo esso più affine all’”Ars
amansi” ovidiana che all'erotismo interiorizzato che forma l'oggetto della
presente trattazione. Un secolo più tardi si inizia in Germania una notevole
trasformazione dei costumi e delle idee, avente di mira l'ideale del matrimonio
d'amore. Fino allora si era generalmente riconosciuta come motivo fondamentale
del matrimonio la convenienza sociale ed economica.
Da quel momento l'amore reciproco si afferma sempre più quale movente primo
dell'unione matrimoniale. La concezione del matrimonio come vincolo d'amore
significa il trionfo dell'erotismo su tutte le barriere separatrici esterne e
interne. Contemporaneamente però emerge nell'ideale di vita proprio dell'epoca
classica l'elemento ascetico, il quale solo può garantire la durata del
matrimonio d'amore.
Il suddetto ideale si serve dell'ascesi a vantaggio di un ordine di vita
estetico; esso oltrepassa tanto la concezione della pietà cristiana ostile ai
sensi quanto la superficiale arte di vivere del libertinismo galante.
Mentre nella sua forma assoluta l'ascesi rappresentò una tirannia dello spirito
intollerante di qualsiasi altra elementare potenza di vita, l'ideale della
civiltà classica fu un regime di maggiore libertà sia nelle relazioni sociali
che nella costituzione della personalità. Esso, valse dell'ascesi non come
mezzo per superare il mondo, ma come strumento di conciliazione interiore, come
via per raggiungere l'armonia della vita psichica. La sensualità, se frenata,
può sussistere onoratamente in quel regime oligarchico nel quale la personalità
umana governa in accordo con le potenze della vita elementare. Anche qui
l'ascesi corrisponde al significato originario del termine. Essa è un
esercitarsi a dominare la vita istintiva mediante le superiori forze dell'anima;
a dominare, non a reprimere o a distruggere. L'istinto non dominabile sarà
nemico della personalità, l'istinto come forza frenata sarà il suo più valido
appoggio. È quindi necessaria una differenziazione di grado degli impulsi
inferiori, una valutazione della vita conforme alle necessità superiori di cui
le principali sono l'accordo con se stessi e la difesa della personalità contro
le irruzioni delle forze elementari. Se la libertà esteriore consiste
nell'essere sciolti dalle obbligazioni e dalle convenzioni esterne, la libertà
intima consiste invece nell'indipendenza degli incalcolabili impulsi della
natura fisica. Solo chi abbia costituito la propria persona in modo che essa,
superando gli impulsi inferiori, si attenga a quelli superiori, non per
capriccio ma per inclinazione, può dirsi intimamente libero.
La più bella definizione di questa forma di esistenza, documento imperituro di
un alto sviluppo della personalità, è stata data dallo Schiller nel trattato
sulla "leggiadria e la dignità". Ciò che Schiller chiama
"leggiadria" è l'espressione della sensualità bella. Come la libertà
sociale sta tra la pressione legale e l'anarchia, così per lui la bellezza sta
nel punto intermedio fra la dignità quale espressione dello spirito dominante e
il piacere quale espressione dell’istinto dominante. La condizione a che
l'elemento estetico insito nell'uomo si realizzi è uno stato d'animo nel quale
si accordano ragione e sensualità, dovere e inclinazione. Gli amanti esigono
dall'oggetto del loro amore la dignità, sola garanzia che il loro legame sia
stato stretto non dal bisogno ma dalla libera scelta. L'amante non vuol essere
desiderato come una cosa, ma stimato come una persona.
Noi vediamo che il concetto schilleriano della dignità come parte costitutiva
dell'erotismo psichico contiene un elemento dell'ascesi, quando per ascesi si
intenda non l'arbitraria repressione della natura sensuale ma il dominio di essa
per opera dello spirito, il che per l'appunto noi abbiamo definito come
“ascesi affermatrice della vita” e come “condizione per la sublimazione
della sessualità nell'amore sessuale”.
La concezione dell'ascesi come valore della personalità fu propria di quasi
tutti i grandi di quell'epoca. Dice Fichte: “Ogni forza umana si conquista
nella lotta con se stessi”. Goethe altresì celebra uno stato ascetico quale
ultimo segreto dell'intima superiorità personale: “L'uomo che domina se
stesso si libera dalla forza che incatena tutte le altre creature”.
Con questo non si propugna il rinnegamento del mondo terreno nel senso
dell'ascesi assoluta, e ancor meno la negazione paolina della autocoscienza
umana di fronte a Dio, l’onnipotente vasaio che dispone a suo talento
dell'uomo come un mero oggetto, bensì, in evidente accordo e nello stesso tempo
in contrasto con ciò, la massima esaltazione della personalità umana il cui
valore si manifesta appunto nel superamento.
Ne abbiamo una testimonianza nelle parole che precedono il passo citato: “Non
è meraviglia che l'uomo posto in alto da natura compia opere egregie; di ciò
sia lode al Creatore che tanto eleva la fragile argilla; ma lietamente si additi
l’uomo che dominando se stesso ha superato la più ardua prova della vita,
giacché si può dire che quella è veramente opera sua".
Queste parole aprono infinite prospettive. Tutto ciò che
di più profondo è stato detto intorno alla grazia, alla predestinazione, al
libero arbitrio e al determinismo si concentra qui come un fuoco ottico per il
trionfo della personalità umana. La coscienza della personalità, al grado di
sviluppo a cui è giunta dopo diciotto secoli, rende il problema logicamente
insolubile e lo trasferisce nell'atto del dominio di sé. La catena della
necessità è spezzata, la volontà sta libera di fronte al destino incapace di
infrangerla.
Rosa Mayreder
26
- Un diario (Enrico
Federico Amiel)
Berlino, 16 dicembre 1847.
- Povero giornale intimo! tu aspetti da sette mesi, ed è in dicembre che ricevi
la prima prova della risoluzione presa in maggio. O meglio, povero me! Non sono
libero, perché non ho la forza di eseguire la mia volontà. Ho riletto le mie
note di quest'anno. Ho previsto tutto, mi son dette le cose più belle, ho
intravisto le più seducenti prospettive, e sono ricaduto, ed ho, oggi,
dimenticato tutto.
Non mi manca l'intelligenza, ma il carattere; quando mi rivolgo al mio giudice
interiore, ne ricevo parole assai chiare e giuste. Mi riconosco, ma non so farmi
obbedire; di più, in questo momento godo nello scoprire i miei difetti e le
loro cause, senza che la scoperta mi renda più forte contro di loro. Io non
sono libero: chi lo dovrebbe essere più di me? Non ho legami esteriori, sono
padrone di tutto il mio tempo e di scegliermi un fine qualsiasi; tuttavia lascio
fuggire le settimane, i mesi intieri; cedo ai capricci del giorno, sono lo
sguardo dei miei occhi ciechi. Pensiero terribile: ciascuno si foggia il proprio
destino. Gli Indiani dicevano: “Il destino non è una parola, ma è la
successione delle azioni svolte in un'altra vita”. Non è necessario salire
così in alto: ogni vita si crea il proprio destino.
- Perché sei debole? -.Perché hai ceduto diecimila volte; così sei divenuto
il giochetto delle circostanze; sei stato tu a creare la loro forza, non esse a
fare la tua debolezza. Ho fatto scorrere davanti agli occhi della mia coscienza
tutta la mia vita anteriore: infanzia, collegio, famiglia, adolescenza, viaggi,
giochi, tendenze, pene, piaceri: tutto il buono e tutto il cattivo. Ho cercato
di sceverare la parte della natura da quella della libertà; di ritrovare nel
fanciullo e nel giovane le linee dell'essere attuale; mi sono visto in relazione
con le cose, con i libri, con i parenti, le sorelle, i compagni, gli amici. Io
lotto contro mali di vecchia data: è una storia lunga che un giorno dovrò
scrivere. Se l'antagonismo è la condizione del progresso, ero nato per fare dei
progressi.
- Tu non sei libero, perché? -. Perché non sei d'accordo con te stesso ed
arrossisci davanti a te stesso; perché cedi alle tue curiosità, ai tuoi
desideri. Ciò che più ti costa è la rinuncia alla tua curiosità.
Sei nato per essere libero, per realizzare coraggiosamente e pienamente la tua
idea: tu sai che la pace consiste in questo: equilibrio, armonia; sapere, amare,
volere; idea, bellezza, amore; vivere della volontà di Dio, della vita eterna;
essere in pace con te stesso, con il
tuo destino; lo sai perfettamente, hai riconosciuto e sentito sovente che quello
era il tuo dovere, la tua natura, la tua vocazione, la tua felicità. Ma ad
eccezione del tuo dovere in generale, non ha sufficientemente determinato la tua
speciale vocazione, o meglio, non hai seriamente creduto al risultato a cui sei
giunto; ti sei distratto. Dovresti rinunciare alla distrazione, concentrarti
nella volontà, sopra un pensiero: ed è ciò che ti costa tanto.
Esprimere, realizzare, finire, produrre; preoccuparti di questo pensiero: esso
è la sintesi dell'arte. Trova la forma in ogni cosa; il tuo pensiero vada alla
conclusione, la tua parola esprima il tuo pensiero; finisci le tue frasi, i tuoi
gesti, le tue letture. Semi-pensiero, semi-parola, semi-conoscenza: triste cosa.
Bisogna o rinunciare alla curiosità o precisare, circoscrivere, esaurire;
altrove io chiedevo ordine, energia, perseveranza.
Per la tua vita interiore, la dissipazione è lo scoglio che ti fa perdere di
vista il tuo Io ed i tuoi progetti; nulla è per te più interessante di ciò
che non dovrebbe interessarti; pertanto cedere a questa pigrizia, equivale ad
aggiungere forza al tentatore, peccare contro la tua libertà, incatenarti per
il domani. La forza fisica non si acquista che con esercizi graduati, costanti
ed energici; graduazione, energia, continuità sono pure le condizioni della
vita intellettuale e morale.
Donde mi viene il singolare difetto di prendere sempre la strada più lunga, di
preferire il meno importante al più importante, di dirigermi verso il meno
urgente; questo zelo per l'accessorio, quest'orrore per la linea diritta? Donde
mi viene il piacere che mi fa preferire fra molte lettere da leggere, la meno
interessante; fra molte visite, la meno necessaria; fra molti studi precisamente
quello che più si al lontana dal cammino naturale; fra mille commissioni, la
meno urgente? Trattasi soltanto della tendenza di mangiare per prima cosa il
proprio pane nero? di una raffinatezza di gusto? del desiderio del completo?
della fretta di approfittare dell'occasione che può fuggire, poiché il tempo -
per il necessario - si trova sempre? Zelo, o mezzo di eludere il dovere,
ingegnosa furberia per rinviare ciò che più importa e ciò che ordinariamente
è più penoso? inganno dell'io indocile e pigro? O irresolutezza, mancanza di
coraggio, rinvio dello sforzo ad altra occasione?
Le due ultime spiegazioni, che assommano in una sola, mi sembrano le vere.
"Tempo guadagnato, tutto guadagnato" dicono i diplomatici. Il cuore,
fine diplomatico, fa la stessa cosa: non rifiuta, rinvia soltanto. Il rinvio, se
non è effetto di risoluzione, è disfatta della volontà. Non rimandare a
domani che ciò che è possibile fare oggi ...
Considerato tutto questo, il cuore prende nota della seguente decisione: 1. Come
garanzia, scrivere tutte le sere qualche parola di giornale; la domenica,
revisione della settimana; la prima domenica del mese, revisione del mese; e
alla fine dell'anno, revisione dell'anno. 2. Conclusione positiva: decidere ciò
che devo fare, in relazione al tempo e ai mezzi concessimi. Ritornerò su questo
punto.
Quando la durata d'una vita umana o di un popolo ci appare microscopica quanto
quella di un moscerino; e, inversamente, la vita d'un effimero infinita quanto
quella di un corpo celeste con tutta la sua polvere di nazioni, noi ci sentiamo
ben piccoli e ben grandi, e possiamo dominare dall'altezza delle sfere la nostra
esistenza e i piccoli turbini che agitano la nostra piccola Europa.
Le cose che lasciamo indietro si drizzeranno più tardi al nostro cospetto e
ingombreranno il nostro cammino. Ogni nostro giorno regoli ciò che lo concerne,
liquidi i suoi affari, rispetti il giorno che segue, ed allora saremo sempre
pronti. L’ingombro nuoce al benessere, alla libertà, alla chiarezza, e
l'ingombro nasce dall'abitudine a differire.
Non rinviare dunque al domani ciò che puoi fare oggi. Nulla è fatto, finché
qualche cosa rimane da fare: il valore del maestro si misura dalla sua capacità
a finire.
Lancy, 12 agosto 1852. -
Ogni sfera dell'essere tende ad una sfera più elevata e ne ha delle rivelazioni
e dei presentimenti. L'ideale, sotto tutte queste forme, è l’anticipazione
simbolica di un'esistenza superiore, a cui aspiriamo. Così i vulcani portano i
segreti dell'interno del globo, l'ispirazione, l'entusiasmo, l'estasi sono
espressioni passeggere del mondo interiore dell'anima, e la vita umana non è
che graduale assunzione alla vita spirituale. Vi sono gradi innumerevoli tanto
nell'una quanto nell'altra; perciò prepara la tua futura rinascita, poiché
l'ascensione divina non è che una serie di metamorfosi sempre più eteree, in
cui ogni forma - risultato delle precedenti - è la condizione di quelle che
seguono. La vita divina consiste in una serie di morti successive, in cui lo
spirito si libera dalle sue imperfezioni e dai suoi simboli e cede
all'attrazione crescente del centro di gravitazione ineffabile, del sole dell'
intelligenza e dell'amore. Gli spiriti creati, che riconoscono la loro missione,
aspirano a forma e costellazioni e vie lattee nell'empirico della divinità;
divenendo dei, circondano il trono del sovrano di una corte abbagliante ed
incommensurabile. La loro grandezza è il loro omaggio; la loro investitura
divina è la più clamorosa corona di Dio. Dio è il padre degli spiriti, e il
vassallaggio dell'amore costituisce il regno eterno.
Gli altri due ci mettono in contatto con il genio e rivelano due grandi anime.
Mozart esprime la libertà interiore. Beethoven l'entusiasmo potente; l'uno ci
affranca, l'altro ci rapisce a noi stessi.
Non credo d'aver mai sentito così distintamente e con maggiore intensità la
differenza fra questi due maestri: le loro esistenze morali s'aprivano
trasparenti avanti al mio sguardo, e mi sembrava di leggere in loro fino in
fondo, come nel giudizio finale.
L'opera di Mozart, penetrata di spirito e di pensiero, esprime un problema
risolto, l'equilibrio fra l'aspirazione e la forza, fra il potere, il dovere e
il volere, la sovranità della grazia dominatrice di se stessa in cui il reale
forma un tutto con l'ideale, l'armonia meravigliosa e la perfetta unità.
Il quartetto racconta una giornata di un'anima attica, che anticipa la serenità
dell'Eliseo. La prima scena è un'amabile conversazione, come quella di Socrate
in riva all'Ilisso: il suo carattere è la squisita urbanità dal fine sorriso e
dalla parola leggiadra. La seconda scena è profondamente patetica. Una nuvola
è scivolata nell'azzurro del cielo greco: un uragano, di quelli che la vita
suscita inevitabilmente anche fra i grandi cuori che si stimano e che si amano,
è venuto a turbare questa armonia. Quale la causa? un malinteso, una mancanza
di riguardo, una negligenza? Non si sa, ma l'uragano scoppia. L'andante è una
scena di rimprovero e di lagno, ma quale non può avvenire che fra immortali.
Che elevatezza nel lamento, quale contenuta emozione e quale dolce nobiltà nel
rimprovero! La voce trema e diventa più grave, ma rimane dignitosamente
affettuosa. - La nuvola si è dileguata, il sole è ricomparso, la spiegazione
ha avuto luogo, la concordia è ristabilita. La terza scena dipinge l'allegrezza
della riconciliazione che, sicura ormai di se stessa, e come per mettersi
malignamente alla prova, si permette un po' di leggero motteggio e di amichevole
scherzo. Il finale riconduce la gaiezza temperata, la serenità felice, la
libertà suprema, fiore della vita interiore, tema fondamentale dell'opera.
L'opera di Beethoven esprime la tragica ironia che fa danzare il turbine della
vita sull'abisso sempre minaccioso dell'infinito. Qui non c’è più traccia
d'unità, di soddisfazione, di serenità. Noi assistiamo al duello eterno fra
due grandi forze, quella dell'abisso che assorbe ogni cosa finita e quella della
vita che si difende, s'afferma, si dilata, s'inebria. Le prime battute rompono i
sigilli ed aprono gli antri del grande abisso: la lotta comincia e continua a
lungo. La vita nasce, si sollazza e scherza, spensierata come la farfalla che
volteggia al disopra d'un precipizio, aumenta le sue conquiste e canta i suoi
successi; fonda un regno, costruisce una natura. Ma dall'abisso spalancato
s'alza il suono della tromba; i titani scuotono le porte del nuovo regno.
S'impegna una battaglia formidabile; si odono gli sforzi tumultuosi della
potenza caotica, simili alle contorsioni d'un mostro tenebroso. Vince finalmente
la vita, ma la vittoria non è definitiva, e nella sua ebbrezza v’è un fondo
di terrore e di stordimento. L'anima di Beethoven era tormentata: la passione e
il desiderio dell'infinito sembrano sballottarla dal cielo all'inferno: da
questo deriva la sua immensità.
Chi è più grande: Mozart o Beethoven? Vana domanda ! L'uno è più compiuto,
l'altro più colossale. Il primo è la pace dell'arte perfetta, il bello
immediato; il secondo è il sublime, il terrore e la pietà, e infine la
bellezza. L'uno dona ciò che l'altro fa desiderare: Mozart ha la classica
purezza della luce e dell'oceano azzurro, Beethoven la grandezza romantica degli
uragani dell'aria e dei mari; mentre l'anima di Mozart sembra abitare le cime
eteree di un Olimpo, quella di Beethoven s'arrampica rabbrividendo lungo i
fianchi dirupati d'un Sinai. Benediciamo l'uno e l'altro. Ciascuno d'essi
rappresenta un momento della vita ideale; ciascuno di essi ci fa del bene:
amiamoli tutti e due.
Heidelberg, 11 ottobre 1861
- … Ancor più in alto si staccano nell'oriente magico le forme vaporose delle
due torri-belvedere del Kaiserstuhl e del Trutz-Heinrich, separate da un vallone
sinuoso.
Ma lasciamo il paesaggio. Come si svolge la vita in questa casa? Il professore W… mi dice che il suo “Handbuch”
è già stato tradotto in polacco,
olandese, spagnuolo, italiano e francese, che ne son già state tirate per nove
volte tremila copie. La sua grande "Storia universale" ha già tre
volumi pubblicati. E per fare tutto questo, non ha che quattro ore al giorno, più
i giorni di festa e le vacanze. Questa capacità di lavoro è stupefacente e
questa tenacità prodigiosa, “O deutscher Fleiss!…”
Questa vita di sapiente lavoratore, di compilatore erudito mi turba un po'. Mi
sento così distratto, così dissipato, così sognatore, che provo un sentimento
di ignoranza e di incompetenza quando mi paragono ai favolosi lavoratori che
leggono, estraggono, combinano tutto, e non si arrestano mai. Perché tanto
lavoro? mi domando. Per rendere popolari le conoscenze. Il mio ospite trova
tempo per pensare e per sentire? Non mi pare. Il suo spirito è un specie di
meccanismo adatto a macinar libri e ad eseguire altri lavori, sempre in seguito
a macinatura. La sua opera principale è, a parer mio, quella di avere, per
mezzo del suo lavoro, allevato una bella famiglia e reso servizio
all'insegnamento generale della storia. Il suo merito è la “Gründlichkeit”;
le sue doti principali sono l'ordine pratico e la chiarezza; la sua attrattiva
personale la cordiale onestà. Ma non si può raccogliere presso di lui l'ombra
di un'idea originale: ecco il rovescio della medaglia.
Ogni ambizione, ricerca, inseguimento è per me lavoro ingrato, diminuzione,
concessione fatta all'uso per bonarietà. Non respiro a mio agio che deponendo
questo mio ufficio d'imprestito e rientrando nell'attitudine alle metamorfosi.
La virtualità pura, l'equilibrio perfetto è il mio rifugio prediletto: in esso
io mi sento libero, disinteressato, sovrano. È questo un invito o una
tentazione?
È l’oscillazione fra i due genii greco e romano, orientale e occidentale,
antico e cristiano; è la lotta fra i due ideali: quello della libertà e quello
della santità. La libertà ci divinizza, la santità ci prosterna; l'azione ci
limita, la contemplazione ci dilata; la volontà ci localizza, il pensiero ci
universalizza. La mia anima ondeggia fra due, quattro, sei concezioni generali e
antinomiche, poiché obbedisce a tutti i grandi istinti della natura umana e
aspira all'assoluto, non realizzabile che nella successione dei contrari. M'è
occorso molto tempo per comprendermi e talvolta mi sorprendo intento a
ricominciare lo studio di questo problema risolto tanto è difficile mantenere
in noi un punto immobile. Amo tutto e non detesto che una cosa:
l'imprigionamento irrimediabile del mio essere in una forma arbitraria anche
scelta da me. La libertà interiore sarebbe dunque la mia passione più tenace
forse, la mia sola passione. Questa passione è permessa? L'ho creduto, ma con
intermittenza, e non ne sono perfettamente sicuro.
La sfumatura è delicata, ed è facile superare il confine. Anche nel lirismo più
individuale, il poeta deve avere un valore generale; egli esprime uno stato
d'anima che può essere il suo, ma che deve essere anche quello di molti altri.
Tutta la poesia intima deve essere rappresentativa, cioè tradurre e manifestare
l'anima umana e non l'io del poeta. Il poeta, dev'essere l'organo dei lettori, e
non di colui che fa gli onori della sua persona. In termini scolastici, deve
obiettivare la sua soggettività, o generalizzare i suoi casi. La poesia è
dunque antiegoististica, ed il padre che piange in poesia deve piangere come
tutti i padri incapaci di cantare come lui, ma capaci di sentire quanto lui;
occorre ch’egli si dimentichi e che ogni lettore non pensi che a se stesso.
Il lirico dev'essere impersonale per essere psicologicamente vero e dev'essere
capace di rinchiudere il lettore nella stretta cerchia del sentimento che canta
nei suoi versi. Il poeta è dunque l'uomo per eccellenza, colui che soffre,
piange e canta con altrui e per altrui. Sarebbe poeta perfetto, se fosse
possibile supporre che in lui potesse essere ridotto a zero l'amor proprio di
artista, se egli non fosse più un uomo, ma l'uomo.
L'obiettività poetica è la guarigione; nello stesso modo abbiamo coscienza dei
nostri visceri che quando son malati, il vero poeta dev'essere impersonale e le
sue sofferenze devono essere puramente affettive, altrimenti la sua poesia
diventa meschina e malaticcia. Egli assiste alla sofferenza che lo attraversa,
ma l'avviluppa come il cielo tranquillo circonda un temporale. La poesia è
liberazione, perché è essa stessa libertà; lungi di essere un'emozione è lo
specchio di un'emozione; è al di fuori e al disopra, tranquilla e serena. Per
cantare una pena occorre essere, se non guarito, almeno convalescente. Il canto
è sintomo di equilibrio, ritorno della forza. Il poeta è, in piccolo, per la
sua vita, ciò che Dio è per il mondo: vi entra per mezzo della sensibilità,
ma la domina come essenza; la sua natura è contemplativa, e l'attività non è
che la sua espressione inferiore.
Il canto è un intermediario fra il pensiero e l'azione. L'arte è un simbolo
indebolito dell'opera del grande poeta, la Creazione.
Enrico Federico Amiel (1821-1881)
…
Quando San Luigi Gonzaga non ardiva guardare in faccia alla propria madre, per
tema di cadere in colpa di concupiscenza, il male covava in lui, non nella
madre. La falsa diagnosi vizia il metodo della cura. Quando l'asceta confonde il
peccato con il senso, non riesce a sradicarlo perché non va alla sorgente vera
che convien purificare: cioè la coscienza. In fine il buon metodo correttivo
non consiste tanto nella repressione quanto nello sviluppo: anche la strategia
suggerisce di prendere il nemico di fianco. È inutile cercar di uccidere i
cattivi pensieri col fare il vuoto nel cervello: bisogna invece arricchir la
mente di nuovi pensieri più puri e più gentili e più nobili. Date all'uomo un
più alto motivo di vivere; infondete in lui una più generosa passione che gli
conquida il cuore e lo avrete redento dalla servitù della colpa.
La conclusione alla quale si giunge, è che l’ideale estetico è superiore
all'ascetico, nonostante certi elementi di nobiltà che si contengono in questo
ultimo; perché la cultura ha, per lo meno, un fine positivo e può anche, anzi
dovrebbe, includere nel proprio schema le forme utili e buone dell'ascesi.
Ma è proprio difficile conciliare i due termini che sembrano così
irriducibilmente antitetici? Non ci sembra.
L'estetismo e l'ascetismo ignorano entrambi uno degli apetti della vita, una
delle esigenze dell'uomo. L'uno, fondandosi sull'idea ottimistica che non
occorra altro se non di svolgere tutte le forze latenti nella natura umana,
disconosce la necessità della disciplina. L'altro, fondandosi sul concetto
pessimistico che il mondo è tutto perverso, l'uomo è tutto maligno, i sensi
sono i tramiti della corruzione, non trova altra salvezza che nel sacrificio.
Noi possiamo accogliere ciò che i due sistemi o metodi contengono di positivo e
di fecondo per il perfezionamento dell'uomo: riconoscere che la natura umana è
ricca di magnifiche energie che vanno svolte sino al più alto grado di
rigoglio; e riconoscere in pari tempo che la disciplina è inevitabile mezzo
d'incremento, proprio come nell'ubbidienza alla legge morale si realizza la vera
libertà dello spirito.
Respingeremo soltanto le esagerazioni e le aberrazioni dell'uno e dell'altro
metodo. Riconosceremo in ogni uomo un «deus contractus», il dio che diventa.
In ogni uomo vogliamo, che si coltivino tutte le varie energie dello spirito,
simultaneamente, armonicamente. Non disprezzeremo il corpo, che dev'essere
tempio dell'anima; ma l'anima fatta bella e vigorosa, si trasformerà a propria
immagine il suo corpo, perché tutta la vita va dall'interno all'esterno. Noi
vogliam credere che il dolore valga come mezzo di purificazione e disciplina e
come stimolo ai sentimenti di simpatia, ove però sia accolto e sopportato con
animo virile; ma celebriamo altresì missione vivificatrice che la gioia adempie
nel cuore dell'uomo. Il riso, infatti, è esplosione di libertà, di superiorità,
di vittoria.
Non bisogna maledire il mondo come una valle di lagrime. Il mondo lo facciamo
noi, coi pensieri, coi sentimenti, con le azioni di cui siamo capaci; e la
felicità più che augurarcela, dobbiamo crearcela noi stessi con le nostre
proprie energie; allora solo ne saremo degni. E la natura che ci circonda con le
sue meraviglie di splendori ci parrà degna della nostra contemplazione, perché
“a thing of beauty is a joy for ever” (una cosa bella è una gioia per
sempre). L'esistenza presente non sarà per noi una “meditatio mortis”, ma
preambolo e tirocinio ad una vita più perfetta.
Necessaria è l'abnegazione, necessaria la disciplina; ma non occorre, anzi
nuoce il sequestrarsi dalla società che soffre e spera, che lavora e avanza con
fiducia verso giorni più lieti. L'intiera famiglia umana deve vivere immersa
nell'elemento dell'amore vicendevole come in una divina atmosfera. La
conversazione degli uomini implica tentazioni e pericoli, ma solo a questo patto
è possibile educarsi a vivere bene: a vivere non da soli e per noi stessi, che
sarebbe stolto e assurdo ma per l'immensa famiglia della quale siam parte.
Il pittore Romney se ne venne a Londra, lasciando a Kendal la
moglie e i due figlioli, un ragazzetto e una bimba: egli si proponeva di
richiamarseli vicino quando un giorno si fosse procacciato gloria e fortuna. Si
diè tutto all'arte, nella quale divenne celebre: e con la gloria gli giunse la
fortuna. Ma per trentacinque anni visse a Londra senza mai riveder la consorte e
i figli. Gli avevano detto che la vita di famiglia dissipa i talenti
dell'artista; e d'altra parte, ormai, egli si sarebbe vergognato di presentare
l'umile moglie a Lady Hamilton e ad altre cospicue dame che soleva ritrattare.
Solo nella tarda vecchiaia, desolato e senza aiuti, egli se ne tornò a Kendal:
la moglie gli perdonò, lo accolse, ed ebbe cura di lui sino alla morte.
La dolce pazienza e la generosa assistenza di quell'umile donna valevano più
che tutti i quadri famosi del pittore Romney. Questa, infine, è la più solenne
e grande lezione per tutti coloro che si travagliano nella propria cultura:
nessun ornamento estetico val quanto la virtù che si tempra nella lotta e nel
sacrificio.
Eduardo Taglialatela
28
- Erotica ed estetica (Otto
Weininger)
L'amore e il desiderio sessuale sono due opposti
tanto diversi, tanto escludentisi, che nei momenti in cui un uomo ama veramente
il pensiero d'un congiungimento corporale coll'essere amato gli è completamente
impossibile. Il fatto che non esiste speranza senza timore non cambia d'aspetto
all'altro fatto che speranza e timore siano degli opposti. Non avviene
altrimenti dell'istinto sessuale e dell'amore. Quanto più erotici si è, tanto
meno si è molestati dalla propria sessualità e viceversa. Se non esiste
ammirazione priva di desiderio, non si possono perciò identificare le due cose,
che al medesimo saranno delle fasi opposte, in cui un uomo più ricco di esse può
successivamente entrare. Mente, o non ha mai saputo che sia l'amore, chi
asserisce di amare ancora una donna ch’egli desidera: tanto diversi sono
l'amore e l’istinto sessuale. Perciò si deve considerare anche quasi sempre
come una finzione quando si parla dell'amore nel matrimonio.
L'attrazione sessuale aumenta con la vicinanza corporale, l'amore è più forte
che mai quando la persona amata è assente: esso ha bisogno della divisione,
d'una certa distanza per continuare a sussistere. Per l'uomo maggiormente
differenziato, per lo spirito superiore, la ragazza che egli desidera e quella
ch’egli ama ma non potrebbe mai desiderare, hanno tra loro figura diversa,
andatura differente, caratteri dissimili: sono due esseri diversi.
L'amore "platonico" esiste dunque a onta del parere contrario
dei professori di psichiatria. Vorrei anzi dire: non vi è che amore platonico.
Non c'è che un amore: è quello per Beatrice, la venerazione della Madonna.
L'enumerazione delle idee trascendentali fatta da Kant, dovrebbe subire un'estenisone
quando fosse riconosciuto vero quanto fu detto sopra. Anche l'alto amore privo
di desideri, l'amore di Platone e di Giordano Bruno sarebbe un'idea
"trascendentale", il cui significato come I’ideale non vien toccato
dal fatto che non la si è mai vista realizzata completamente.
È il problema del Tannhäuser. Dall’una parte Tannhäuser, dall'altra
Wolframo; dall'una Venere, dall'altra Maria. Il fatto che una coppia d'amanti,
che s'erano veramente trovati per sempre - Tristano e Isotta - vanno a morire
invece che arrivare al letto coniugale è pure una prova assoluta dell'esistenza
di un che di superiore, sia pure di metafisico, nell'uomo, di qualche cosa di
somigliante al martirio di Giordano Bruno:
Dir,
hohe Liebe, töne
begeistert mein Gesang,
die mir in Engelschöne
tief in die Seele drang!
Du nahst als Gottgesandte;
ich folg’ aus holder Fern,
so ührst du in die Lande,
wo ewig strahlt dein Stern.
Chi è
l'oggetto di tale amore? È la donna supremamente bella, angelicamente pura che
viene amata di tale amore. Si tratta ora di vedere come una donna arrivi a
questa bellezza e purità.
Si è discusso molte volte se sia vero che il sesso femminile è il più bello e
ancor più s'impugnò la sua designazione come il "bel sesso'' senz'altro.
Sarà bene vedere da chi la donna sia stata trovata bella e in quanto.
Ogni vero amore è pudico, come ogni vera compassione. La misura del bello e del
brutto nella donna sta nell'Amore (non nel desiderio) dell'uomo che è sempre
pudico. La bellezza è una proiezione, una emanazione del bisogno di amare; e
così anche la bellezza della donna non è qualche cosa di diverso dall'amore,
ma la bellezza della donna è l'amore dell'uomo, e ambedue non sono che lo
stesso identico fatto. La bellezza è intangibile, inviolabile, immescolabile;
soltanto osservandola da lontano la si ha vicina, essa si scosta a ogni
avvicinamento.
Come già accennammo, la nettezza del corpo è in generale un segno di moralità
e sincerità; persone sozze non hanno, almeno di solito, sentimenti troppo
nobili. Si può ora osservare che la gente, la quale di consuetudine non tiene
molto alla pulizia del proprio corpo, si lava anche più spesso e più
abbondantemente quando si sforzi di assumere un carattere più decoroso.
Altrettanto chi non seppe mai che voglia dir pulizia comincia d'un tratto a
desiderarla da sé per tutto il tempo che dura un amore e questo tratto di tempo
è spesso forse l'unico in sua vita in cui non sia sporco sotto la camicia.
Che se ci rivolgiamo al campo spirituale, vediamo come per molti l'amore cominci
col rivolgere delle accuse contro se stessi, con tentativi di mortificarsi e far
penitenza. Comincia un rivolgimento morale, sembra che dalla donna amata emani
una purificazione interiore, anche se non si è mai parlato con lei, se la si è
veduta poche volte in distanza. È impossibile che questo processo abbia
fondamento nella stessa persona amata: essa è spesso una ragazza giovanissima,
e in genere nessun'altro, tranne colui che l'ama, trova che essa possegga qualità
superiori. Dobbiamo dunque credere che questa persona concreta venga amata
nell'amore, o non serva piuttosto come punto di partenza per un movimento più
imponente?
In ogni amore l'uomo non ama che se stesso: non la propria soggettività (così
com'essa è), ma ciò che egli vuole essere o dovrebbe essere in tutto e per
tutto, il suo essere intelligibile più intimo, più profondo, libero da ogni
necessità terrena. Egli proietta il suo essere ideale dotato al valore assoluto
e completo – ch’egli non riesce a isolare entro se stesso - su un'altra
creatura umana. Ciò significa null'altro che il suo amore per tale creatura.
L'uomo è sotto ogni aspetto pari a se stesso soltanto quando ama. Così si
spiega che molti cominciano a credere nel proprio Io e al Tu soltanto dopo aver
incominciato ad amare: io e tu non sono nozioni equivalenti soltanto
grammaticalmente, ma, anche eticamente. Si comprenderà così anche la parte
importante che in ogni amore hanno i nomi degli innamorati. Si spiega anche come
solo nell'amore molti acquistino la conoscenza della propria esistenza e non
sappiano già anteriormente di possedere un'anima.
L'amore si mostra così essere un fenomeno di proiezione, non un fenomeno di
equazione come l'amicizia. La premessa per questa è un valore eguale, di ambo
gli individui; l'amore presuppone l'ineguaglianza, la differenza di valore.
Amare vuol dire accumulare su una persona tutto ciò che si vorrebbe essere e
che non può ancora essere, rappresentare in essa tutti i valori. La bellezza è
il simbolo di tale perfezione. La bellezza della donna non è che moralità
divenuta visibile; ma tale moralità è quella dell'uomo che egli ha traslato
sulla donna innalzandola a massima intensità e completezza. Tutte le forme
trovate belle dall'uomo sono altrettanti tentativi di realizzare visibilmente il
sommo valore in forza della di lui funzione estetica, che tramuta in forma
sensibile la morale e il pensiero. La bellezza è il simbolo rivelato della
perfezione. Perciò essa è intangibile, statica e non dinamica. È l’amore
per il proprio valore, il desiderio di perfezione che nella materia crea la
bellezza. Così nasce la bellezza della natura (che non viene mai percepita dal
malfattore), perché è solo l'etica che crea la natura. In tal modo si spiega
che la natura ci dà sempre in ogni momento e in ogni oggetto, nelle sue
formazioni maggiori e nelle più piccole, l'impressione della perfezione. Così
anche la legge naturale non è che il simbolo di quella morale, come la bellezza
naturale è la nobiltà dell'anima sensibilizzata. Come l'amore crea una nuova
donna per l'uomo in luogo di quella reale, altrettanto l'arte - l'eros
dell'universo - trae dal caos la molteplicità delle forme; e come non v'ha
bellezza naturale senza forma e senza legge naturale, non esiste nemmeno arte
senza forma né bellezza artistica senza che obbedisca a una legge. La natura,
che l'artista chiama eternamente sua maestra, non è che la forma del suo agire
datasi da lui stesso non in concentrazione concettuale, ma in perspicua infinità.
Otto Weininger
29
- Una lettera e alcune altre (M.
von Kleist)
Würzburg, 10 (e 11).10.1811
Cara Guglielmina!
Oggi pensi certamente a me, come io ho pensato a te durante tutto il 18 agosto,
non è vero? - Con quanto fervore penso anche adesso a te! E quale
indescrivibile godimento è per me la convinzione che ora in questo momento i
nostri pensieri certamente s'incontrano! Sì oggi è il mio compleanno, e mi
sembra ai udire gli auguri che il tuo cuore formula tacitamente per me, di
sentire la stretta della tua mano che mi comunica tutti insieme questi auguri. Sì,
si avvereranno tutti questi auguri, siine convinta, io lo sono. Se un re ci
augura un'onorificenza, non vuol dire che ce lo promette? Egli stesso ha in mano
l'attuazione del suo augurio - così anche tu, cara fanciulla. Tutto quello che
chiamo felicità, non mi può venire che dalla tua mano; e se questa felicità
me l'auguri tu, posso guardare tranquillamente all'avvenire, mi toccherà
certamente. Amore e cultura, ecco tutto ciò che desidero, e come sono lieto che
l’adempimento di questi due indispensabili bisogni, senza i quali ora non
potrei più essere felice, non appena dal cielo che, com'è noto, lascia così
spesso inappagati i desideri dei poveri uomini, ma unicamente da te.
La mia ultima lettera, che scrissi al principio di questo mese e che vorrei
definire una lettera capitale, se non dovesse apparirne presto una seconda che
sarà ancora più importante - l'hai ricevuta, vero? Forse l'hai ricevuta in
questi giorni, forse la ricevi in questo istante. – Oh, potessi essere ora
accanto a te, potessi commentarti questa lettera incomprensibile, potessi
preservarti dai malintesi, soffocare ogni moto irritato del tuo sentimento,
subito, al primo istante in cui sorgesse…Non essere in collera, cara
fanciulla, prima che tu mi corprenda interamente! Se ho peccato contro di te, ho
anche riparato coi più sacrifici. Lasciami la speranza che mi perdonerai, e io
troverò il coraggio di confessarti ogni cosa. Ascolta prima la mia confessione,
e sono sicuro che dopo non sarai più in collera con me.
In quella lettera ti promettevo che o sarei partito da qui entro otto giorni o
ti avrei scritto. Il termine è passato e la prima cosa non è stata ancora
possibile Non inquietarti: la partenza può avvenire domani o posdomani e ogni
giorno che mi porti qualche cosa che aspetto ancora. In seguito mi spiegherò più
chiaramente; per ora lascia stare. Adesso voglio mantenere la mia promessa e
mandarti, invece di me, almeno una lettera. Accontentati per ora di questa
sostituzione; presto la posta porterà me stesso da te.
Ma del nostro principale argomento non ti posso scrivere di più per ora. perché
prima devo sapere come hai accolto quella mia ultima lettera. Dunque parliamo
d'altro.
La mia anima assomiglia alla scrivania d'un filosofo che ha escogitato un nuovo
sistema e ha scritto alcuni pensieri fondamentali su fogli sparsi. Una grande
idea per te Guglielmina, mi si libra incessantemente davanti all'anima! Te ne ho
comunicato il pensiero principale già alla fine della mia ultima lettera, anche
prima su un foglio a parte. Non l'avrai mica dimenticato?...
Ti pregai un giorno di scrivere per me che cosa veramente ti riprometti dalla
felicità d'un futuro matrimonio - Non indovini perché? Ma come lo puoi
indovinare? Aspetto con grande desiderio questo saggio, che ancora non ho
ricevuto da Vienna. Il primo foglio che mi hai comunicato e che mi procurò una
gioia ineffabile, ma agrodolce, mi fece fuggire dalle tue braccia e affrettare
la partenza. Ricordi ancora con quanta commozione lo lessi il giorno prima della
nostra separazione e con quanta inquietudine me lo portai a casa - e sai forse
anche quali fossero i miei sentimenti quando mi trovai solo con quel foglio?
Esso attirò tutto il mio cuore verso di te, ma nello stesso tempo mi respinse
irrevocabilmente dalle tue braccia. – Ora, quando lo rileggerò, mi ci
riporterà. Allora non ero degno di te, oggi lo sono. Allora piansi, perché eri
così buona, così nobile, così degna di stima, così degna alla massima
felicità: ora tutto ciò sarà il mio orgoglio e la mia delizia. Allora ero
tormentato dalla coscienza di non essere in grado di appagare le tue più sacre
pretese, e ora, ora …. Ma silenzio!
Ora, Guglielmina, ti dirò anch'io che cosa mi riprometto dalla felicità d’un
futuro matrimonio. A suo tempo non dovevo farlo, ma adesso - Oh Dio, come ne
sono contento! - Ti descriverò la moglie che può rendermi felice adesso - e
questa è la grande idea che ho in mente per te. L'impresa è grande, ma lo è
anche il fine. A questa cosa dedicherò ogni ora che le mie future condizioni mi
lasceranno libera. Ciò conferirà alla mia vita un fascino nuovo, e ci farà
superare, entrambi, più rapidamente il periodo di prova che ci aspetta. Fra
cinque anni spero che l'opera sarà compiuta.
Non temere che la moglie da me descritta non sia di questa terra e che io debba
trovare soltanto in paradiso. Fra cinque anni la troverò su questa terra e la
stringerò fra le mie braccia mortali - Non chiederò al giglio di salire in
altezza quanto il cedro, né fisserò alla colomba la meta dell'aquila. Non
scolpirò una statua di tela né dipingerò sul marmo. Conosco la materia che ho
davanti a me e so che cosa se ne possa fare. È un minerale che contiene oro
puro e a me non rimane altro che sceverare il metallo dalla pietra. Il suono, il
peso e la resistenza alla prova del fuoco li ha avuti dalla natura, il sole
dell'amore gli conferirà lustro e splendore, e dopo la separazione del metallo
non avrò altro da fare che scaldarmi e illuminarmi ai raggi che il suo lucido
specchio ci rimanda.
Io stesso sento quanto sia scialbo questo linguaggio metaforico in confronto al
l'idea che mi anima – Oh, potessi comunicarti almeno un raggio di quel fuoco
che fiammeggia dentro di me! Potessi tu intuire come il pensiero di far di te un
giorno un essere perfetto riscalda in me ogni forza vitale, muove in me ogni
facoltà, rende viva e attiva ogni mia energia! - Tu forse non me lo crederai,
ma spesso sto per ore e ore a guardare dalla finestra, ed entro in dieci chiese
e visito questa città in tutte le sue parti, eppure non vedo nulla se non
un'unica immagine - te, Guglielmina, e ai tuoi piedi due creaturine e sulle
ginocchia una terza, e ti ascolto mentre insegni al più piccolo a parlare, al
secondo a sentire, al maggiore a pensare, e vedo come sai trasformare la
caparbietà dell'uno in tenacia, l'arroganza dell'altro in franchezza, la
timidezza del terzo in modestia e la curiosità di tutti in avidità di sapere:
vedo come, senza molte parole, insegni con l'esempio a fare il bene come nella
tua stessa immagine mostri loro che cosa sia la virtù e quanto essa sia
amabile. - C'è da stupirsi, Guglielmina, se per questi sentimenti non riesco a
trovare le parole?
Oh, posa intorno al tuo seno come uno scudo adamantino questo pensiero: io sono
nata per essere madre! Ogni altro pensiero, ogni altro desiderio sia respinto da
questa corazza impenetrabile. Quale altro fine potrebbe offrirti la terra che
non sia disprezzabile? Essa non ha nulla, che conferirti un valore quando non
sia la formazione di uomini nobili. A questa meta rivolgi le tue più sante
aspirazioni! È l’unica cosa per cui la terra possa un giorno esserti
debitrice. Non andartene da essa in condizioni che debba vergognarsi di averti
portata inutilmente durante una generazione. Disprezza tutti i bassi scopi della
vita. Quest'unico ti solleverà al di sopra di tutti. In esso troverai la tua
vera felicità , tutti gli altri non possono che soddisfarti per qualche
istante. Esso ti ispirerà rispetto per te stessa; tutto il resto non può che
solleticare la tua vanità; e quando un giorno sarai alla mèta, riguarderai,
contenta di te stessa alla tua giovinezza e non rimpiangerai in ore amare di
solitudine come mille altre creature infelici del tuo sesso, il fine perduto e
la perduta felicità.
Cara Guglielmina, non voglio che tu smetta di agghindarti o di frequentare
compagnie allegre o di ballare; ma vorrei soltanto istillare nella tua anima il
pensiero che esistono gioie più elevate di quelle che ci sorridono dallo
specchio o dalla sala da ballo. Il sentimento di essere belli interiormente e
l'immagine che lo specchio della coscienza ci rimanda nelle ore della solitudine
sono godimenti che soli possono appagare il nostro ardente desiderio di felicità.
Possa questo pensiero accompagnarti a ogni tuo passo: davanti allo specchio, in
società, nella sala da ballo. Offri pure alla moda o, diciamo meglio, al gusto,
i piccoli sacrifici che esso richiede, non proprio a torto, da giovani
fanciulle, bada a farti bella, chiedi allo specchio se la tua fatica è riuscita
- ma fallo in fretta e torna il più presto possibile al tuo fine supremo.
Frequenta pure la sala da ballo, ma sii lieta quando ritorni da un divertimento
nel quale soltanto i piedi hanno avuto il loro tornaconto, mentre il cuore e la
mente hanno cessato del tutto il palpito della loro vita e la coscienza era, per
così dire, spenta. Frequenta le gaie compagnie, ma scegli sempre la parola
migliore e più nobile, dalla quale puoi imparare qualche cosa - poiché questo
non devi trascurare in alcun momento della vita. Ogni minuto, ogni persona, ogni
oggetto può darti un utile insegnamento, purché tu lo sappia sviluppare. - Ma
di questo argomento ti dirò di più un'altra volta.
Andiamo dunque insieme, tenendoci per mano, incontro alla nostra meta, ciascuno
incontro alla sua, alla più vicina, e entrambi incontro all'ultima, alla quale
tutti e due aspiriamo. La tua meta prossima sia quella di prepararti ad esser
madre, la mia quella di diventare un cittadino dello stato, e la meta più
lontana, alla quale tendiamo entrambi, e che possiamo reciprocamente
assicurarci, sia la felicità dell'amore.
Buona notte, Guglielmina, mia sposa e un giorno mia moglie e un giorno madre dei
miei figlioli!
Non voglio che questa lettera
diventi un libro come la precedente e perciò ti comunicherò brevemente ancora
qualche cosa prima che parta la posta.
Adesso la regione intorno a questa città mi sembra molto più piacevole di
quando la vidi al mio ingresso; anzi direi quasi che adesso mi sembra bella, e
non so se sia mutato il paesaggio o il cuore che ne ricevette l'impressione.
Adesso, quando me ne sto sul ponte di pietra che attraversa il Meno e divide il
castello dalla città, e osservo il fiume che mi scorre incontro tra monti e
prati in mille curve, e fluttua via sotto i miei piedi, ho l'impressione
d'essere al di sopra di una vita. Perciò me ne sto spesso la sera sopra questi
archi e lascio che le correnti d’aria e dell'acqua mi sussurrino incontro.
Oppure mi volgo indietro e seguo il corso del fiume fin dove si perde fra i
monti, e io stesso mi perdo in tacite considerazioni. Specie uno spettacolo
attira la mia attenzione. Dal ponte del Meno scorre in linea diritta e rapido
come una freccia, quasi avesse già sotto gli occhi la meta, come se nulla
dovesse trattenerlo dal raggiungerla, come se, impaziente, volesse toccarla per
la via più breve - sennonché un colle coperto di vigneti flette il suo corso
impetuoso, dolcemente ma con ferma intenzione, come una moglie una volontà
impetuosa del marito, e con nobile fermezza gli addita la via che lo condurrà
al mare ed esso accetta il discreto monito e obbedisce all'amichevole
ingiunzione e abbandona la meta precipitata e non perfora il colle coperto ai
vigne, ma lo aggira baciandogli nel corso più calmo i piedi fioriti -
Persino dal monte dal quale vidi Würzburg per la prima volta la città mi piace
adesso e direi quasi che questa parte è più che mai bella. La vidi ultimamente
da questa cima nelle prime ombre della sera, non senza intima letizia. L'altura
scende con dolce declivio e la città si stende nel fondo. Catene di monti le
sorgono dietro da ambo i lati a semicerchio e si avvicinano amichevolmente quasi
volessero stringersi le mani come due vecchi amici dopo un'offesa d'altri tempi
– sennonché il Meno s'interpone fra loro come un amaro ricordo, ed essi
tentennano, e nessuno osa passare di là per primo, e tutti e due seguono
lentamente il fiume che si allontana, scambiandosi sguardi malinconici oltre
l'ostacolo.
Nel fondo, ho detto, giace la città come al centro d'un anfiteatro. Le terrazze
dei monti circostanti le facevano da palchetti, esseri d'ogni specie la
guardavano con gioia come spettatori e cantavano e applaudivano, mentre in alto,
nel palco del cielo, stava Iddio. Dalla volta del grande teatro scendeva il
lampadario del sole e si nascondeva dietro la terra - poiché si trattava di
rappresentare un dramma notturno. Un velo azzurro avvolgeva tutta la regione;
pareva che la volta del cielo fosse scesa sulla terra. Le case nel fondo
sorgevano come masse oscure, quasi gusci di chiocciole; ma alte nell'aria
notturna si elevavano le cime dei campanili come antenne d'un insetto, e il
suono delle campane squillava come il richiamo rauco del grillo - e nello sfondo
il sole moriva, ma ardendo incandescente dalla gioia come un eroe, e la pallida
luce zodiacale gli vibrava intorno come un'aureola intorno alla testa di un
santo...
Ieri l'altro sono uscito per dare la scalata a un altro monte del versante
settentrionale. Era un monte coperto di vigne e uno stretto sentiero conduceva
alla vetta, attraverso viti benedette. Non avevo immaginato che il monte fosse
così alto, e forse non lo era nemmeno, ma dai vigneti avevano buttato tutte le
pietre a destra e a sinistra su quel sentiero per rendere più difficile la
salita - esattamente come la sorte o gli uomini mi resero difficile la via verso
la meta che pure ho raggiunto. A questa palese somiglianza mi misi a ridere.
Cara fanciulla, tu non sai ancora tutto quanto mi è capitato a Berlino, a
Dresda, a Bayreuth e persino qui a Würzburg; tutto ciò richiederà ancora una
lunga lettera. Allora però m’indispettivo assai per le pietre che mi erano
state gettate sul cammino, senza però lasciarmene turbare; versai bensì gocce
di sudore cocente, ma - come ieri l'altro - raggiunsi tuttavia la meta. La
salita sui monti, come la via della virtù, è faticosa, particolarmente per la
prospettiva che si ha davanti a sé. Si vede a tre passi di distanza, ma non più
in là; non si vedono che i gradini da superare e appena si è scavalcata una
pietra, se ne trova subito un'altra, e ogni passo falso fa doppiamente male e
tutta la fatica è, per così dire, ruminata ma bisogna pensare alla vista che
si godrà dalla cima. Com'era stupendo il panorama dalla valle del Meno da
quell'altezza! Colline e valli e acque, e città e villaggi vi si mescolavano
come un tappeto ricamato! Il Meno si volgeva ora a destra ora a sinistra,
lambiva ora questo ora quel vigneto ed era incerto fra le due sponde, che gli
parevano ugualmente care, come un bimbo tra babbo e mamma. La rocca sorvegliava
la città e la custodiva, come un gigante il suo gioiello, e lungo le
fortificazioni esterne serpeggiava una stradicciuola come una spia, e si
insinuava in ogni bastione quasi volesse esplorarlo, ma non osava entrare in
città, preferendo perdersi fra i monti...
Ma nessun fenomeno della natura mi procura una gioia malinconica come la bufera
mattutina, specialmente quando i tuoni sono cessati. Qui abbiamo avuto questo
spettacolo alcuni giorni fa. Oh, è stata una scena stupenda! A occidente si era
addensato il temporale notturno e infuriava come un tiranno e da oriente il sole
sorgeva placido e silenzioso come un eroe. Il temporale gettava i lampi
sibilanti contro di lui e lo rimproverava con la voce del tuono, ma l'astro
divino taceva e saliva a guardare maestoso la nebbia irrequieta sotto i suoi
piedi e cercava benevolo gli altri soli che lo circondavano, quasi volesse
tranquillare gli amici. Poi il maltempo gli lanciò un ultimo tuono tremendo,
come volesse vomitare in una scintilla tutta la sua provvista di fiele e bava
velenosa - ma il sole non vacillò nella sua orbita e si avvicinò impavido e
salì sul trono del cielo - e, pallida come di spavento, la notte della
nuvolaglia si stinse e si squagliò come fumo sottile e sprofondò sotto
l'orizzonte mormorando qualche debole imprecazione...
Ma, quale giornata seguì quella mattina! Correnti d'aria tiepida mi alitavano
incontro, le fronde sussurravano lievemente, grosse gocciole cadevano a lunghi
intervalli dagli alberi, una luce scialba si era riversata sulla regione, e
tutta la natura pareva spossata da quel grande sforzo, come un eroe dopo la
fatica del combattimento. - Ma ho detto che non volevo fare un libro, e perciò
chiudo brevemente. Scrivimi se puoi perdonarmi e manda la lettera a Carlo,
affinché io la riceva subito al mio arrivo a Berlino. Poi ti scriverò più a
lungo.
H.
Heinrich von Kleist (1777 - 1811)
Berlino, 12 novembre 1811
Mia carissima Maria, se tu sapessi come la morte e l'amore si alternano per in
coronare di fiori - terreni e celesti - questi ultimi istanti della mia vita,
certamente mi lanceresti morire volentieri. Oh, ti assicuro, sono perfettamente
beato. La mattina e la sera m'inginocchio, come non ho mai saputo fare, e prego
Iddio; adesso lo posso ringraziare della mia vita, la più tormentata che un
uomo abbia mai condotto, perché me la compensa con la più splendida e più
voluttuosa di tutte le morti. Oh, potessi fare qualcosa per te, che valesse a
lenire l'acerbo dolore che ti procurerò! Può consolarti se ti dico che non
avrei mai scambiato te con questa amica (la Henriette Vogel), qualora non avesse
voluto altro che vivere con me? Sì è così, mia carissima Maria; ci sono stati
momenti in cui ho detto francamente queste parole alla mia cara amica. Oh, ti
assicuro, ti voglio tanto bene, mi sei così estremamente diletta e preziosa che
oso appena dire di amare più di te questa mia cara e adorata amica. La
risoluzione, sbocciata nella sua anima, di morire con me, mi attirò al suo
seno, non ti so dire con quale indicibile e irresistibile potenza; ricordi che
più volte ti ho domandato se volevi morire con me? Ma tu dicesti sempre di no -
Un vortice di mai provata beatitudine mi ha travolto, e non ti posso negare che
la sua tomba mi è più cara del letto di tutte le imperatrici del mondo. - Ah
mia diletta amica, voglia Dio chiamarti presto in quel mondo migliore dove noi
tutti, con l'amore degli angeli, potremo stringerci al cuore l'un l'altro…
Addio.
H.
(A Ernst Friedrich Peguilhen, un amico della famiglia Vogel)
da parte di Enrichetta Vogel:
Mio carissimo amico! All'amicizia che Lei finora mi ha sempre dimostrata così
fedelmente è riservato di sostenere una strana prova, poiché noi due, cioè il
noto Kleist e io, ci troviamo qui, da Stimming (J.F. Stimming, proprietario
della locanda), sulla strada di Potsdam, in uno stato molto imbarazzante, in
quanto giaciamo "uccisi con arma da fuoco" e ora facciamo assegnamento
sulla bontà di un benevolo amico per affidare le nostre fragili spoglie alla
sicura tutela della terra. Cerchi, carissimo Peguilhen, di arrivare qua questa
sera e di fare in modo che il mio buon Vogel ne rimanga atterrito il meno
possibile; questa sera o questa notte Luigi voleva mandare la carrozza a
prendermi a Potsdam, dove gli ho detto che mi sarei recata; glielo comunico,
affinché Lei possa regolarsi nel modo migliore. Mi saluti cordialmente Sua
moglie e la figlia, da me tanto cordialmente amate, e stia sicuro, diletto
amico, che l'amore e l'amicizia di Lei e dei Suoi mi danno la massima gioia fino
all'ultimo istante della mia vita. La Sua
H. Vogel
Presso Stimming Lei troverà una valigetta di cuoio, nera, suggellata e una
cassettina suggellata contenente notizie per Vogel, lettere, denaro, capi di
vestiario e anche libri. Per i 10 talleri in contanti che vi si trovano desidero
una bellissima tazza grigio-pallido, internamente dorata, con un arabesco dorato
su fondo bianco fino all'orlo, e col mio nome di battesimo all'esterno in campo
bianco, di quel tipo che ora è il più moderno. Se per questa commissione
volesse rivolgersi al contabile Meves della fabbrica di porcellane, pregandolo
di inviare la sera di Natale questa tazza a Luigi, ma Lei, mio caro amico,
dovrebbe affrettare l'ordinazione perché la tazza potrebbe non esser pronta.
Stia bene e sia felice . -
Nella cassetta troverà anche una piccola chiave suggellata: è la chiave del
lucchetto d'un baule in casa Vogel, nel quale ci sono parecchie lettere e altre
cose da recapitare.
Forse posso ricorrere anch'io, mio carissimo Peguilhen, alla Sua amicizia per
chiederLe qualche piccolo favore. Ho dimenticato di pagare il barbiere per il
corrente mese e La prego di dargli 1 tallero che troverà in un involto nella
cassetta di madame Vogel. Questa mi dice in questo momento che Lei dovrebbe
aprire la cassetta e provvedere a tutte le commissioni che vi sono contenute,
affinché Vogel non abbia subito queste noie - Infine, La prego ancora di
regalare al mio padrone di casa Miller, Mauerstrasse n. 53, in segno di modesto
riconoscimento della sua buona accoglienza e ospitalità, la valigetta di cuoio
nero, di mia proprietà, ad eccezione delle cose che potrebbero eventualmente
essere utili per il mio funerale. Stia bene, mio carissimo Peguilhen; il mio
saluto e i miei ossequi alla Sua ottima consorte e alla figlia.
H. von
Kleist
P.S. - Nel baule di Mad. Vogel
che si trova a Berlino, nella stanza della servitù, in casa sua, con un
lucchetto d'ottone che si può aprire con la chiavetta suggellata, chiusa qui
nella cassetta - in questo baule ci sono tre lettere mie che La prego vivamente
di recapitare. Sono:
una lettera per la consorte del Consigliere aulico Müller, a Vienna;
una lettera per mio fratello Leopoldo a Stolp, entrambe da spedire per posta (la
prima può essere forse affidata al buon Voss, l'occhialaio); e
una lettera per la signora von Kleist, nata von Gualtieri, che prego di
consegnare al maggiore von Below, governatore del principe Federico d'Assia, al
castello.
C'è infine,
4)
ancora una lettera per la signora von Kleist, qui nelle cassetta di Mad.
Vogel, che prego di consegnare ugualmente e contemporaneamente al maggiore von
Below. - Addio!
N.B. - Venga prestissimo da Stimming, mio carissimo Peguilhen, affinché possa
seppellirci. Le spese, per quanto riguarda me, Le saranno rifuse da mia sorella
Ulrica a Francoforte. - La Vogel fa notare ancora che qui nella cassetta di
legno è suggellata la chiave che apre il lucchetto d'ottone del baule che si
trova nella stanza della servitù a Berlino e che contiene molte commissioni.
– Credo di averlo scritto già una volta, ma la Vogel insiste perché io lo
scriva ancora.
H. v. Kl.
Da Stimming, presso Potsdam il ... la mattina della mia morte.
Tuo Heinrich
30
- Lettere d’amore di una monaca portoghese (1665-1667 - ?) (Mariana
Alcoforado)
Prima lettera:
Considera, amor mio, sino a qual estremo sei stato imprevidente: infelice, sei
stato tradito e mi hai tradito con ingannevoli speranze!
Una passione, dalla quale ti ripromettevi tanto piacere, non mi cagiona, ora,
che una disperazione mortale, solo comparabile, per me, alla crudeltà
dell'assenza che la causa.
E quest'assenza - alla quale il mio dolore, per sagace che possa essere, non può
dare un nome abbastanza funesto - mi priverà dunque, per sempre, di mirare
quegli occhi nei quali vedevo tanto amore, e svelavano sensi che mi colmavano di
gioia, ed erano tutto per me e bastavano alla mia vita?
Ahimè! che i miei occhi sono privi dell'unica luce che li animava: non restan
loro che le lacrime, né mi servono ad altro che per pianger senza tregua, da
quando ho appreso che voi siete ormai risoluto ad una lontananza, tanto
insopportabile che mi farà morire in breve tempo!
E tuttavia mi sembra di avere dell'affetto per le sventure di cui siete la sola
causa: vi ho destinato la vita appena vi ho visto, e mi dà diletto il
sacrificarvele. Vi invio mille volte al giorno i miei sospiri; questi vi
ricercano ovunque e, per tutta ricompensa a tante ingratitudini, mi riportano
solo l'avvertimento troppo sincero che mi manda la mia sventura, la quale ha la
crudeltà di non permettermi illusioni, e che mi dice in ogni istante:
"Cessa, povera Marianna, di consumarti invano e di cercare un amante che più
non rivedrai; che ha traversato i mari - per fuggirti; ch'è in Francia tra i
piaceri, senza pensare un istante ai tuoi dolori, e ti fa grazia di tutti gli
slanci, dei quali non ti è affatto grato"
Ma no, non posso risolvermi a giudicarvi così offensivamente, e ho troppo
interesse a giustificarvi: non voglio neppur pensare che m'abbiate dimenticata.
Non sono forse abbastanza infelice per tormentarmi con falsi sospetti? E perché
dovrei sforzarmi a dimenticare le premure che avete avuto per testimoniarmi
dell'amore? Di questo sono stata tanto felice, che sarei ben ingrata se non vi
amassi con l'impeto che la passione mi dava quando godevo della testimonianza
della vostra.
Come può essere che i ricordi di momenti così gradevoli siano divenuti tanto
crudeli; ed occorre proprio che, contro la loro natura, non servano se non a
torturarmi il cuore?
Ahimè, che la vostra ultima lettera me lo ridotto in un pietoso stato: i suoi
palpiti furono così forti che mi sembrò separarsi da me per venirvi a trovare.
Fui così oppressa da tutte queste violenti emozioni che rimasi più di tre ore
fuor di me, proibendomi di ritornare a una vita che dovrò perdere per voi,
poiché per voi non posso conservarla.
Tornai infine, mio malgrado, alla luce, lusingandomi nel sentirmi morir d'amore,
e mi sentivo a mio agio nel non essere più esposta a vedermi lacerare il cuore
dal dolore della vostra assenza.
Dopo queste traversie ho avuto molte e varie indisposizioni. Come potrò infatti
essere senza mali sinchè non vi rivedrò? Ma li sopporto senza lamentarmi perché
mi vengono da voi.
È questa la ricompensa che voi mi date per avervi così teneramente amato? Ma
non importa: sono risoluta ad adorarvi tutta la vita e a non vedere nessuno, e
vi assicuro che anche voi farete bene a non amar altri; come potreste essere
soddisfatto d'una passione meno ardente della mia? Vi trovereste forse maggior
bellezza (mi confidaste, tuttavia, un tempo, ch’ero abbastanza bella), ma non
trovereste mai tanto amore; e tutto il resto è nulla.
Non riempite più le vostre lettere di cose inutili e non scrivetemi più che mi
ricordi di voi. Io non posso dimenticarvi, e non dimentico neppure che mi avete
fatto sperare che verrete a passare qualche tempo con me. Oh, perché mai non
volete passarvi tutta la vita? Se mi fosse possibile uscire da questo infelice
chiostro, non attenderei in Portogallo l'esito delle vostre promesse: senza
ritegno verrei a cercarvi, vi seguirei e vi amerei ovunque.
Ma non oso lusingarmi che ciò possa essere: non voglio nutrire una speranza che
mi darebbe certo qualche piacere e non voglio essere più sensibile che ai
dolori.
Debbo confessarvi, ciononostante, che l'occasione di scrivervi, offertami da mio
fratello, ha destato in me qualche moto di gioia ed ha sospeso qualche istante
la disperazione in cui giaccio.
Vi supplico di dirmi perché vi siete dedicato tanto ad ammaliarmi, come avete
fatto, dal momento che sapevate bene di dovermi abbandonare, e perché vi siete
tanto impegnato a rendermi infelice e non mi avete lasciata tranquilla nel mio
chiostro. Vi ho forse offeso? Ma vi chiedo perdono: non vi accuso di nulla, non
posso pensare a vendicarmi; accuso solo l'asprezza del mio destino. Separandoci,
ci ha fatto tutto il male che potevamo temere, ma non saprebbe separare i nostri
cuori: l'amore, ch'è più potente di lui, li ha uniti per tutta la vita.
E se la mia vi interessa ancora, scrivetemi spesso; merito bene che voi vi diate
cura di farmi conoscere lo stato del vostro cuore e della vostra sorte. Ma
soprattutto tornate a vedermi.
Addio; amatemi sempre e fatemi soffrire più ancora.
Terza lettera:
Che sarà di me, e che vorrete ch'io faccia? Sono così lontana da quanto avevo
previsto; credevo che mi avreste scritto dai luoghi ove sareste passato, che le
vostre lettere sarebbero state lunghissime, che avreste sostenuto la mia
passione con la speranza di rivedervi, che una fiducia totale nella vostra
fedeltà mi sarebbe valso qualche sollievo, e che sarei rimasta tuttavia in uno
stato sopportabile senza addolorarmi troppo. Avevo anche vagamente pensato di
fare ogni sforzo per guarire, se fossi stata sicura che mi avreste dimenticata
del tutto.
Il vostro allontanamento, qualche risveglio di devozione, il timore di rovinare
completamente il resto della mia salute con tante veglie e tante inquietudini,
le poche probabilità del vostro ritorno, la freddezza del vostro amore e dei i
vostri ultimi addii, la partenza fondata su pretesti abbastanza futili e mille
altre ragioni (che non sono né buone né giuste) sembravano promettermi un
aiuto abbastanza sicuro, se fosse stato necessario.
Non avendo infine che da combattere contro me stessa, non potevo mai sospettare
tutte le mie debolezze né sapere quanto soffro oggi. Ahimè, come sono da
compiangere per non poter condividere i miei dolori con voi ed essere la sola
infelice!
Questo pensiero mi uccide, e mi sgomenta l'ammettere che voi non siate
estremamente sensibile a tutti i nostri piaceri. Conosco ora la falsità dei
vostri entusiasmi; mi avete ingannata tutte le volte che mi dicevate di essere
felice di rimanere solo con me; debbo esclusivamente alle mie insistenze le
vostre premure e i vostri slanci. A sangue freddo avevate divisato di
infiammarmi; non avete considerato la mia passione che come una vittoria e il
vostro cuore non n'è mai stato profondamente turbato.
Siete ben infelice e d'animo ben poco delicato se non avete saputo approfittare
che in questo modo dei miei sentimenti. E come è possibile che con tanto amore
non abbia potuto rendervi completamente felice?
Rimpiango solo per amor vostro i piaceri infiniti che avete perduti; bisogna
proprio che non abbiate voluto goderli. Ah, se li conosceste, trovereste
certamente che sono più dolci
dell'avermi sedotta, e provereste che non si è molto più felici e si sente
qualcosa di ben più profondo quando si ama violentemente che quando si è
amati.
Non so chi sono, né quel che faccio, né quel che desidero; mille sentimenti
contrari mi lacerano. Può immaginarsi uno stato più penoso? Vi amo
perdutamente ed ho per voi tanta delicatezza da non osare di augurarvi che siate
agitato dagli stessi sentimenti. Mi ucciderei, o morirei di dolore senza
uccidermi, se io fossi certa che non avete mai riposo, che la vostra vita non è
che affanno e agitazione, che piangete senza tregua e che tutto vi è odioso: se
non sopporto i miei mali, come potrei tollerare il dolore che mi darebbero i
vostri, per me mille volte più sensibili?
Nondimeno non so decidermi a desiderare che non mi pensiate e, a parlarvi
sinceramente, sono furiosamente gelosa di tutto quello che vi dà gioia e di
quanto commuove il vostro cuore e di quanto vi piace in Francia.
Non so perché vi scrivo: vedo bene che avrete solo della pietà, e pietà non
voglio.
M’indigno con me stessa quando penso a tutto quello che vi ho sacrificato; ho
perduta la reputazione, mi sono esposta al furore dei miei e alla severità
delle nostre leggi contro le religiose, e alla vostra ingratitudine, ciò che mi
sembra la maggiore delle disgrazie.
Nondimeno sento bene che i miei rimorsi non sono veri e che, con tutto il cuore,
avrei voluto correre, per amor vostro, pericoli maggiori.
Provo un forte piacere nell'aver arrischiato la mia vita e il mio onore. Quanto
ho di più prezioso non doveva essere per voi? E non debbo essere lieta di
averveli offerti, come ho fatto? Mi pare persino di non essere del tutto
contenta né dei miei dolori né della forza del mio amore, ancorché non possa
lusingarmi d'essere soddisfatta di voi. Con tutto ciò vivo, infedele che sono,
e faccio tanto per conservarmi la vita quanto per perderla. Muoio di vergogna:
la mia disperazione è dunque solo nelle lettere? Se vi amassi veramente come ho
detto mille volte, non dovrei essere già morta da molto tempo? Vi ho ingannato
e dovete voi lamentarvi di me; perché non lo fate? Vi ho visto partire e non
spero di vedervi più ritornare, e con tutto ciò respiro…
Vi ho tradito e ve ne domando perdono, ma non accordatemelo; trattatemi
duramente; trovate che i miei sentimenti non sono abbastanza ardenti, e siate più
difficile da accontentare; esigete che io muoia d'amore per voi.
Vi scongiuro di aiutarmi affinché possa vincere la debolezza del mio sesso e
finire le mie irresoluzioni in una vera disperazione: una fine tragica vi
obbligherebbe certo a pensarmi spesso; la mia memoria vi sarebbe cara e sareste
forse commosso di una morte insolita. E non è preferibile questa allo stato in
cui mi avete ridotta?
Addio, vorrei proprio non avervi mai visto! No: sento che questo è falso, e nel
momento in cui scrivo so che preferisco di molto essere disgraziata amandovi che
non avervi mai visto. Mi rassegno dunque al mio cattivo destino, poiché non
avete voluto renderlo migliore.
Addio: promettetemi di rimpiangermi teneramente se morrò di dolore, e che
almeno la violenza del mio amore vi dia il disgusto e l'allontanamento da tutto.
Questa consolazione mi basterà, se è necessario che io vi lasci per sempre,
poiché non vorrei proprio lasciarvi ad un'altra.
Sareste abbastanza crudele di servirvi della mia disperazione per rendervi più
interessante e dare a conoscere di aver suscitato il più grande amore del
mondo?
Addio una volta ancora: vi scrivo lettere troppo lunghe e non ho abbastanza
riguardo per voi; ve ne domando perdono ed oso sperare che avrete
dell'indulgenza per una povera pazza, che non lo era affatto - come sapete -
prima che vi amasse.
Addio: mi sembra di parlarvi troppo spesso dello stato insopportabile in cui mi
trovo; nondimeno vi ringrazio dal profondo del mio cuore della disperazione che
mi causate e detesto la tranquillità in cui ho vissuto prima che vi conoscessi.
Addio ... la mia passione aumenta ad ogni istante; quante cose avrei da dirvi
...
Mariana Alcoforado
31
- Una lettera di Kant (1792) (Immanuel
Kant)
(con
cui risponde alla signorina Maria von Herbert, la quale, abbandonata dall'amante
per un'innocente bugia, aveva mandato a Kant una disperata lettera per
chiedergli conforto. "Il mio cuore scoppia in mille pezzi (dice la povera
innamorata); ho letto la “Metafisica dei costumi” con l'imperativo
categorico, ma non mi serve... e quindi scongiura Kant che le mandi una lettera
di consolazione. La signorina von Herbert scrisse ancora a Kant qualche lettera
sconsolata, ma in tono più tranquillo; dopo una vita agitata, essa cercò la
morte nelle acque della Drava il 23 maggio 1803.)
La Sua lettera appassionata, scaturita da un cuore fatto per la virtù e la
rettitudine, perché così aperto ai loro ammaestramenti, pura e dignitosa, mi
trae nel senso che Ella desidera, cioè a mettermi nella Sua posizione ed a
riflettere sopra il modo di ricondurre con mezzi puramente morali - che sono i
soli definitivamente efficaci - la pace nell'anima Sua. Io ignoro se il rapporto
Suo con l'oggetto amato, la cui disposizione deve essere altrettanto pura e
rispettosa della virtù e della rettitudine - che è l'anima della virtù - sia
un vincolo legittimo o semplice amicizia. Ho creduto di capire dalla Sua lettera
che si tratti di amicizia: ma questo non porta in riguardo a ciò che La
addolora, nessuna differenza essenziale, perché l'amore, sia verso un marito o
verso un amico, presuppone sempre una vicendevole stima per il carattere
dell'altro, senza di che è soltanto una mobile illusione del senso.
Un tale amore, che solo è virtuoso (l'altro è inclinazione cieca), aspira a
parteciparti nella sua totalità e attende da parte dell'altro una simile
partecipazione d'affetto, non attenuata da alcun diffidente riserbo. Così
dovrebbe essere, così vuole l'ideale dell'amicizia. Ma dal cuore dell'uomo è
inseparabile una certa impurità la quale limita, dove più, dove meno, questa
perfetta lealtà. Sopra questo ostacolo ad una reciproca effusione del cuore,
sopra la segreta diffidenza e il riserbo, i quali fanno sì che anche nella più
stretta intimità con l'amico rimanga sempre una parte dei pensieri in cui
l'uomo rimane solo e chiuso in sé, hanno già gli antichi fatto sentire il
lamento: “o amici, non vi sono amici?” E tuttavia l'amicizia, la cosa più
dolce che abbia la vita umana, può solo vivere nella lealtà ed è
l'aspirazione più viva delle anime ben fatte.
Da un tale riserbo, inteso come mancanza di abbandono, che non può, come
sembra, essere attribuito in tutta la sua pienezza alla natura umana (poiché
ciascuno teme con il disvelarsi completamente di rendersi spregevole agli occhi
altrui), è tutta via ben diversa la mancanza di sincerità come menzogna
positiva nella comunicazione del pensiero. La prima appartiene ai limiti della
nostra natura e non corrompe propriamente il carattere, ma è soltanto un male
che impedisce di trarne tutto il bene possibile. La seconda invece è una
corruzione del carattere ed è un male positivo. Ciò che dice l'uomo schietto,
ma riservato (non d'animo aperto) è tutto vero: solo egli non dice tutta la
verità. Il non sincero invece dice qualche cosa della cui falsità egli è
conscio. Questo è ciò che la morale chiama menzogna. Essa può anche essere
senza cattive conseguenze, ma non è mai cosa innocente: che anzi essa è un
peccato contro il dovere più sacro che abbiamo verso noi stessi, la cui
trasgressione degrada la dignità umana nella nostra persona e attacca il
carattere nella sua radice; perché l'inganno rende dubbio e sospetto e toglie
anche di aver fiducia nella virtù, se si deve giudicarla dall'esterno.
Ella vede che, cercando per consiglio un medico, ne ha trovato uno che non è
prodigo di lusinghe; e, mentre attendeva in me un intermediario fra Lei e il Suo
amico del cuore, il mio modo di ristabilire l'accordo non è affatto schiavo dei
privilegi del bel sesso, perché io do ragione al Suo amato e gli indico le
ragioni che egli, come cultore della virtù, ha dalla sua parte e lo giustifico
se, nel suo amore è diventato un po' incerto sotto l'aspetto della stima.
Quanto al primo punto debbo anzitutto consigliarla ad esaminarsi se gli amari
rimproveri che Ella si fa per una menzogna, non inventata del resto per coprire
alcun atto riprovevole, sono semplici rimpianti d'una commessa imprudenza o
un'accusa interiore per l'immoralità contenuta nella menzogna. Nel primo caso
Ella si rimprovera solo la lealtà della confessione, quindi si pente d'aver
fatto il suo dovere (perché senza dubbio è dovere, quando alcuno ha tratto
altri in un errore, il ritrarmelo anche se ciò sia accaduto senza danno): e
perché Ella si pente di questa confessione? Perché essa Le è caramente
costata e Le ha fatto perdere la fiducia del Suo amico, questo pentimento non è
per nulla morale nel suo motivo, perché ne è causa non la coscienza dell'atto,
ma quella delle sue conseguenze. Se invece il rimorso che La cruccia è fondato
realmente sul puro giudizio morale della Sua condotta, sarebbe un cattivo medico
morale quello che Le consigliasse, poiché ciò che è fatto non può disfarsi,
di cancellare dal Suo spirito questo rimorso e solo attenersi d'ora innanzi con
tutto l'animo ad una rigorosa sincerità; perché la coscienza deve tener atto
di tutti i trascorsi, come un giudice che non annulla gli atti delle colpe
giudicate, ma le conserva nell'archivio per aggravare, conforme a giustizia, il
suo giudizio nel caso di nuova accusa per simili od altri misfatti. Ma covare
nell'anima questo pentimento e, poiché già si è entrati in un'altra
disposizione, rendersi impossibile la vita con continui rimorsi per una
disposizione passata e ormai irrimediabile sarebbe un superstizioso concetto del
merito del tormentarsi: che, come altri pretesi esercizi religiosi consistenti
nell'assicurarsi il favore delle potenze superiori senza aver bisogno di
diventare migliori, non ha nulla a vedere con la morale.
Se ora questo mutamento della disposizione interiore si riveli all'amico Suo
(perché la sincerità ha i suoi accenti), basterà il tempo a cancellare a poco
a poco le tracce di quel giusto corruccio fondato esso stesso sulle massime
della virtù ed a mutare la freddezza in un affetto più saldo di prima. E se
questo non riuscisse, ciò sarebbe segno che la sua inclinazione era più fisica
che morale e sarebbe scomparsa da sé col tempo anche senza di questo: una
disgrazia, che può capitare nella vita e di cui bisogna sapersi consolare:
perché il valore della vita non sta tanto in quello che possiamo godere da
parte degli uomini quanto nel bene che possiamo fare: solo sotto questo riguardo
essa è degna di venir apprezzata altamente e conservata con cura e seriamente
rivolta ai fini del bene. Così Ella ha, mia cara Signorina, come si usa nelle
prediche, dottrina, castigo e consolazione ad ogni tempo: io La prego di
fermarsi più sulla prima che sull'ultima, perché quando la dottrina abbia
fatto il suo effetto, la consolazione e la perduta serenità della vita, si
ritroveranno da sé.
Immanuel Kant
32
- Qualche lettera di Flaubert a Louise Colet (Gustave
Flaubert)
(Louise Révoil - 1810/1876
-, moglie del musicista Hippolyte Colet, godette negli ultimi anni della
monarchia di Luglio e nel primo decennio del Secondo Impero, di larga notorietà:
scrisse poemi, romanzi, drammi, studi storici; ebbe a Parigi un salotto
frequentato da V. Hugo, A. de Vigny, A. de Musset, E. de Girardin, F. David e
altri; meritò più volte i lauri dell'Accademia Francese. Alta, formosa, con
grandi occhi azzurri e splendidi capelli biondi ricadenti in lunghi riccioli,
“non priva né di vistoso splendore né di carnosa opulenza, ma senza
distinzione e senza castità…” come di lei diceva Barbey D'Aurevilly, era
stata per molti anni l'amante di Victor Cousin e fu poi fatta segno alle premure
galanti del de Musset. La sua relazione con il Flaubert durò - con varie
alternative e non poche crisi – dalla metà del 1846 al principio del 1855.)
Croisset, sabato 8 agosto 1846
Da quando ci siam detti che ci amiamo, tu mi chiedi perché io esiti ad
aggiunger "per sempre". Perché? perché prevedo l'avvenire, io; perché
l'antitesi si leva di continuo davanti ai miei occhi. Non ho mai guardato un
bambino senza mai pensare che sarebbe divenuto vecchio, né una culla senza
pensare a una tomba. La contemplazione di una donna nuda mi fa pensare al suo
scheletro. Per questo gli spettacoli allegri mi rendono triste, e quelli tristi
mi commuovono poco. Piango troppo dentro di me per versare lagrime al di fuori;
una lettura mi commuove più di una sventura reale. Quando avevo una famiglia
spesso desideravo di non averne, per essere più libero, per andare a vivere in
Cina o tra i selvaggi. Adesso che non l'ho più, la rimpiango e mi aggrappo ai
muri dove rimane ancora la sua ombra. Altri sarebbero orgogliosi dell'amore che
mi prodighi, la loro vanità vi si disseterebbe intera e il loro egoismo di
maschi ne sarebbe lusingato sin nelle più intime fibre. Tutto ciò invece mi fa
mancare il cuore di tristezza, quando i momenti di ardore son passati; perché
mi dico: "Lei mi ama e anch'io l'amo, ma non abbastanza. Se non mi avesse
conosciuto, le avrei risparmiato tutte le lagrime che ora versa"...
Ti debbo una franca spiegazione di me stesso per rispondere a una pagina della
tua lettera che mi lascia scorgere le illusioni che hai sul mio conto. Sarebbe
vile da parte mia (e la viltà è un vizio che mi disgusta, sotto qualunque
aspetto si mostri) farle durare più a lungo.
Il fondo della mia natura è, checché si dica, il saltimbanco. Nella mia
infanzia e nella mia giovinezza ho avuto un amore sfrenato per il palcoscenico.
Se il cielo mi avesse fatto nascere povero, sarei stato forse un grande attore.
Anche oggi, quel che amo più di ogni cosa al mondo è la forma, purché sia
bella, e niente più. Le donne, che hanno il cuore troppo ardente e la mente
troppo esclusiva, non capiscono questa religione della bellezza, astrazion fatta
dal sentimento. Hanno sempre bisogno di una causa, di uno scopo. Io ammiro tanto
l'orpello quanto loro. La poesia dell'orpello è, anzi, superiore, perché è
triste. Per me, al mondo - non ci sono che i bei versi, le frasi ben tornite,
armoniose, cantanti, i bei tramonti, i chiari di luna, i quadri pieni di colore,
i marmi antichi e le teste dalle linee risentite. Null'altro. Avrei preferito
essere Talma che Mirabeau, perché l'attore è vissuto in una sfera di bellezza
più pura. Gli uccelli in gabbia mi fanno pena quanto i popoli in schiavitù. Di
tutta la politica capisco una sola cosa: la sommossa. Fatalista come un Turco,
credo che fare tutto il possibile per il progresso dell'umanità o non
fare nulla, sia lo stesso. Quanto al progresso, ho la mente ottusa per le
idee poco chiare. Tutto quello che appartiene a tale linguaggio, mi annoia
smisuratamente. Detesto la tirannide moderna perché mi sembra stupida, debole e
timorosa di sé: ma ho un culto profondo per la tirannide antica, che considero
come la più bella manifestazione dell'uomo che sia mai stata. Sono, anzitutto,
l'uomo della fantasia, del capriccio, del saltuario. Ho sognato a lungo e
serissimamente (non ridere, è il ricordo delle mie più belle ore) di andar a
farmi rinnegato a Smirne. Un bel giorno andrò a vivere lontano di qui, e non si
sentirà più parlare di me. Quanto a ciò che di solito attrae maggiormente gli
uomini, e che per me è secondario, in fatto di amore fisico, io l'ho sempre
separato dall'altro. L'altro giorno, ho visto che, parlando di B., tu ridevi di
questo. Era la mia storia. Tu sei davvero la sola donna ch'io abbia amata e che
abbia avuta...
Ne ho amata una, dai quattordici anni ai venti, senza dirglielo, senza neppure
toccarla; e poi sono rimasto quasi tre anni senza sentire il mio sesso. Per un
momento ho creduto che sarei morto così, e ne ringraziavo il cielo. Vorrei non
avesse né corpo né cuore, o, meglio, vorrei esser morto, perché la figura che
faccio quaggiù è molto ridicola. È questo ciò che mi rende timido e
diffidente di me stesso. Tu sei la sola donna alla quale io abbia osato di voler
piacere, e forse la sola a cui sia piaciuto. Grazie, grazie, ma mi capirai sino
in fondo; saprai sopportare il peso della mia noia, le mie manie, i miei
capricci, le mie crisi di sconforto e i miei furiosi risvegli? Mi dice, ad
esempio, di scriverti tutti i giorni, pronta a redarguirmi se non lo farò.
Ebbene, il solo pensiero che vuoi una lettera ogni mattina m’impedirà di
scriverla. Lascia che ti ami a mio modo, conforme al mio carattere, con quella
che tu chiami la mia originalità. Non mi forzare a nulla e farò tutto. Cerca
di capirmi, e non rimproverarmi. Se ti giudicassi leggera e sciocca come le
altre donne, ti colmerei di parole, di promesse, di giuramenti. Che cosa mi
costerebbero? Nulla. Ma preferisco restare al di sotto che al disopra della
sincerità del mio cuore.
I Numidi - narra Erodoto - hanno una strana usanza. Bruciano ai loro piccoli la
pelle del cranio con dei carboni, poiché poi siano meno sensibili all'azione
del sole, che nel loro paese è divorante. Così, sono tra i popoli della terra
quelli più robusti. Fa' conto ch'io sia stato allevato in Numidia. Bella fatica
dir loro: "Voi non sentite nulla; neppure il sole vi brucia!" Oh, non
temere: benché incallito il mio cuore è buono!
G.
Gustave Flaubert (1821‑1880)
Croisset, 9 agosto 1846
...La deplorevole mania dell'analisi mi esaurisce. Dubito di tutto, persino del
mio dubbio. Mi hai creduto giovane e sono vecchio. Ho parlato sovente con i
vecchi dei piaceri di quaggiù, e son sempre rimasto stupito dell'entusiasmo che
rianimava allora i loro occhi spenti, mentre essi non riuscivano a capacitarsi
della mia maniera d'essere e mi ripetevano: "Voi! alla vostra età! alla
vostra età!" Se da me si togliessero l'esaltazione nervosa, la fantasia,
l'emozione del momento, resterebbe ben poco. Eccoti l'uomo nel suo intimo. Non
sono fatto per godere. Non devi prendere questa frase in un senso terra a terra,
ma sentirne l'intensità metafisica. Mi continuo a dire che ti renderò felice,
che senza di me la tua vita non sarebbe stata turbata, che verrà un giorno in
cui ci separeremo (e me ne indigno fin d'ora). Allora mi sale alle labbra la
nausea della vita, e sento un disgusto inaudito di me stesso e una tenerezza
tutta cristiana per te.
Mi parli di lavoro. Sì, lavora: ama l'Arte. Tra tutte le menzogne è la meno
fallace. Cerca di amarla di un amore ardente, esclusivo, devoto. Non ti deluderà.
Solo l’Idea è eterna e necessaria. Non ci sono più, come un tempo, di quegli
artisti la cui vita e il cui spirito erano lo strumento cieco della bramosia del
bello: organi di Dio, con i quali egli provava sé a se stesso. Per loro, il
mondo non esisteva; nessuno ha saputo nulla dei loro dolori; ogni sera si
coricavano tristi, e guardavano la vita con occhi colmi di stupore, come noi
contempliamo dei formicai.
Croisset, mercoledì, le dieci di sera (26 agosto 1846)
Dolce attenzione la tua d'inviarmi ogni mattina il resoconto della giornata
precedente. Per quanto uniforme sia la tua vita, tu almeno hai qualcosa da
dirmi. Ma la mia è un lago, un mare stagnante, che nulla agita e dove non
appare nulla. Ogni giorno somiglia al precedente; posso dire quel che farò tra
un mese, tra un anno, e considero ciò come un segno non solo di saggezza, ma di
fortuna. Così non ho quasi mai nulla da dirti. Non ricevo nessuna visita, non
ho a Rouen nessun amico, nulla del mondo esterno penetra sino a me. Non c'è
orso bianco sui suoi ghiacci polari che viva in un più profondo oblio della
terra. Ci sono portato smisuratamente dalla mia natura e, in secondo luogo, per
arrivarci ci ho messo dell'arte. Mi sono scavato il mio buco e ci resto, avendo
cura che la temperatura vi rimanga sempre costante. Che cosa potrebbero
insegnarmi quei benedetti giornali che tu desideri tanto di vedermi prendere al
mattino, con una tartina imburrata e una tazza di caffelatte? Che cosa vuoi che
m'importi di quel che dicono? Sono poco curioso di notizie; la politica
m'annoia, l'articolo d'appendice mi nausea: tutto ciò mi abbruttisce e mi
irrita. Mi parli di un terremoto a Livorno. Anche se aprissi la bocca per dire
le frasi d'obbligo in tali casi: "Che disgrazia! che orribile disastro!
com'è possibile? oh, Dio mio!", ridarebbe questo la vita ai morti, gli
averi ai poveri? C'è in tutto ciò un senso riposto che ci sfugge, e che è
certamente di una utilità superiore, come la pioggia e il vento: per il fatto
che le nostre poponaie sono state distrutte dalla grandine, non dobbiamo voler
sopprimere gli uragani. Chi sa se il vento che scoperchia la casa non dilati
un'intera foresta? E perché mai il vulcano che sconvolge una città non
potrebbe fecondare una provincia? Ecco ancora una volta il nostro orgoglio:
facciamo di noi stessi il centro della natura, lo scopo della creazione, la sua
suprema ragion d'essere. Tutto quello che non si conforma a quest'idea ci
stupisce, tutto quello che la contrasta ci esaspera...
Sì, sento un profondo disgusto per i giornali, ossia per l'effimero, per il
transitorio, per quanto oggi è importante ma domani non lo sarà più.
Non è insensibilità, la mia. Piuttosto, simpatizzo ugualmente, e forse ancor
più, con le miserie scomparse dei popoli estinti a cui nessuno pensa più, con
tutte le grida che hanno gettate, e che più non si sentono. Non
m’impietosisco sulla sorte delle classi operaie odierne di più che su quella
degli antichi schiavi, i quali giravano la mola; non di più o altrettanto. Non
sono più moderno che antico, più francese che cinese, e l'idea di patria , cioè
l'obbligo di vivere in un angolo di terra segnato sulla carta in color rosso o
blu e di detestare quelli segnati in verde o in nero, m'è sempre parsa angusta,
gretta e di una stupidità feroce. Sono fratello in Dio di ogni essere vivente,
della giraffa e dei coccodrillo come dell'uomo, e concittadino di tutto ciò che
abita nel grande albergo dell'Universo...
Ieri e oggi abbiamo fatto una bella passeggiata; ho visto delle rovine, delle
rovine amate sin dalla giovinezza, che conoscevo già, che mi ero recato spesso
a visitare con coloro che non sono più. Ho ripensato a loro, e agli altri morti
che non ho mai conosciuti e di cui i miei piedi calpestavano le tombe vuote. Mi
piace soprattutto la vegetazione che cresce tra le rovine; quell'invasione della
natura, che si stende subito sull'opera dell’uomo, quand'esso non è più lì
a difenderla, mi riempie di una gioia profonda e vasta. La vita torna a posarsi
sulla morte, fa spuntare l'erba nei crani pietrificati; e sulla pietra dove uno
di noi ha scolpito il suo sogno, in ogni fioritura di violacciocche gialle
riappare l'Eternità del Principio. Mi è dolce pensare che un giorno servirò a
far crescere dei tulipani. Chi sa! La pianta sotto cui mi metteranno darà forse
frutti eccellenti: sarò forse un ottimo concime, un guano superiore.
Croisset, domenica, ore quattro (27 marzo 1853)
L'impressione suscitata in te dalle mie note di viaggio (prese durante il
viaggio di Fl. in Oriente) mi ha ispirato, cara Musa, strane riflessioni sul
cuore dell'uomo e su quello delle donne. Sia ha un bel dire; ma decisamente non
è lo stesso.
Da parte nostra, c'è la franchezza, se non la delicatezza, e abbiamo torto,
perché questa franchezza è una forma di durezza. Se io non avessi scritto le
mie impressioni d’ordine femminino, nulla ti avrebbe ferito. Le donne, invece,
tengon tutto dentro il loro sacco; non si riesce mai a cavarne fuori una
confidenza completa. Tutt'al più lasciano indovinare e, quando raccontano le
cose, la salsa è tanta che la carne scompare. Ma noi, per due o tre misere
fedeltà, in cui il cuore non ha nessuna parte, il loro si mette a gemere.
Strano, strano! mi rompo la testa a comprendere tutto questo, sebbene vi abbia
riflettuto parecchio. Insomma (mi rivolgo al Tuo cervello, cara e buona donna),
perché codesto piccolo monopolio del sentimento? Tu sei gelosa della sabbia su
cui ho posato i piedi, senza che un granellino me ne sia penetrato nella pelle,
mentre ho nel cuore la profonda intaccatura che tu ci hai fatto. Avresti voluto
che il tuo nome ricorresse più spesso sotto la mia penna? Osserva però che non
ho scritto una sola riflessione: formulavo, e con la massima concisione il puro
indispensabile, cioè le impressioni, e non il sogno o il pensiero.
Quanto a Ruchouk-Hâanem, rassicurati e, insieme, correggi le tue idee
sull'Oriente. Persuaditi che, riguardo il morale, essa non ha sentito proprio
nulla, te lo garantisco io; e ho i miei dubbi anche riguardo al fisico. Essa ci
ha giudicato eccellenti 'signori' perché non abbiamo lesinato le piastre; ecco
tutto.
La donna orientale è soltanto una macchina; e non fa differenza tra un uomo e
un altro. Fumare, prendere il bagno, dipingersi le palpebre e bere caffè, ecco
le occupazioni tra cui si aggira la sua esistenza. Ho visto danzatrici il cui
corpo ondeggiava con la regolarità o la furia insensibile di una palma. Quell'occhio
così pieno di profondità, in cui ci sono densità di colori come nel mare,
esprime soltanto la calma; la calma e il vuoto come il deserto. Gli uomini sono
anch’essi così. Che teste stupende, sembra che in esse si agitino i più
profondi pensieri del mondo. Ma battici sopra, e vedrai quel che può venir
fuori da un boccale senza birra o da un sepolcro vuoto. Da che deriva, allora,
la maestà dei loro lineamenti? Probabilmente dall'assenza di qualsiasi
passione. Hanno la bellezza dei tori che ruminano, dei levrieri che corrono,
delle aquile che spaziano nei cieli. Il senso della fatalità che li riempie di
sé, la convinzione della nullità dell'uomo, dà alle loro azioni, ai loro
atteggiamenti, ai loro sguardi un carattere grandioso e rassegnato. Le vesti
molli e che si prestano docili a tutti i gesti, sono sempre in rapporto con le
funzioni dell'individuo per la linea, con il cielo per il colore, ecc. E poi, c'è
il sole, il sole! e un tedio immenso che divora tutto.
Quando farò della poesia orientale (anch'io ne farò, perché è di moda e
tutti ne fanno), cercherò di metter in rilievo tutto questo. Sinora l'Oriente
è apparso alcunché di scintillante, di urlante, di appassionato, di
contrastato. Si son viste in esso soltanto baiadere e scimitarre, il fanatismo,
la voluttà, ecc. In una parola, si è rimasti ancora a Byron. Io l'ho sentito
in tutt'altro modo. Ciò che a me piace nell'Oriente è la grandezza che ignora
se stessa, e l'armonia tra cose disparate. Mi ricordo un bagnante che portava al
braccio sinistro un braccialetto d'argento e all'altro un vescicante. Ecco
l'Oriente vero e, perciò, poetico; cialtroni con stracci gallonati e tutti
coperti di pidocchi. Lasciateli stare i pidocchi! al sole diventano arabeschi
d'oro. Tu mi dici che le cimici di Ruchouk-Hâanem te la degradano, esse invece
m'incantavano. Il loro odore nauseante si mescolava al profumo della sua pelle
mescolata di sandalo. Io voglio che per ogni cosa ci sia un'amarezza, che in
mezzo ai nostri trionfi risuoni un eterno colpo di fischietto e che pur
nell'entusiasmo ci sia la desolazione. Mi ricordo di Giaffa; entrandoci,
respiravo insieme l'odore degli aranceti e quello dei cadaveri, il cimitero
diroccato lasciava scorgere gli scheletri mezzo imputriditi, mentre gli arbusti
verdeggianti cullavano sopra le nostre teste i loro frutti dorati. Non senti tu
come que sta poesia è completa, e che costituisce la grande sintesi? Tutte le
brame dell'immaginazione e del pensiero ci trovano insieme il loro appagamento;
essa non lascia nulla dietro di sé. Ma gli uomini di buon gusto, le persone che
adorano gli abbellimenti, le purificazioni, le illusioni, che scrivono manuali
di anatomia per le dame che fanno della scienza alla portata di tutti, del
sentimento amabile e dell'arte galante, modificano, tolgono via e pretendono
d'esser classici, gli sciagurati! Ah, come vorrei essere dotto! Scriverei un bel
libro, intitolato "Su l'interpretazione, dell'antichità". Perché
sono sicuro di essere nella tradizione; ci aggiungo solo il sentimento moderno.
Ma, lo ripeto ancora una volta, gli antichi non conoscevano quel sedicente
genere nobile! non c'era per loro nulla che non si potesse dire. In Aristofane,
si caca sulla scena. Nell'Aiace di Sofocle, il sangue degli animali sgozzati
scorre intorno all'eroe che piange.
Cerchiamo di vedere, dunque, le cose quali sono, senza pretendere di essere più
intelligenti del buon Dio. Un tempo, si credeva che lo zucchero si potesse
estrarre soltanto dalla canna da zucchero, oggi invece lo si estrae pressoché
da tutto. Lo stesso avviene per la poesia. Ricaviamola non importa da dove,
perché si trova in tutto e dappertutto. Non c'è atomo di materia che non
contenga pensiero; e avvezziamoci a considerare il mondo come un'opera d'arte,
di cui bisogna riprodurre i procedimenti nelle nostre opere.
Quanto a me, più provo difficoltà a scrivere e più aumenta la mia audacia
(cosa che mi salva dalla pedanteria, in cui altrimenti cadrei di sicuro). Ho
progetti di opere per tutta la vita; e, se talvolta passo momenti agri che mi
fanno quasi urlare di rabbia, ce ne sono altri in cui stento a contenere la mia
gioia. Qualcosa di profondo e di supervoluttuoso trabocca da me, a getti
precipitosi. Mi sento rapito e inebriato dal mio pensiero come se attraverso uno
spiraglio interiore mi giungesse una folata di caldi profumi. Non andrò mai
molto lontano, so bene che cosa mi manca, ma il mio tentativo verrà portato a
compimento da un altro; avrò messo sulla via qualcuno meglio dotato di me e più
"nato". Voler dare alla prosa il ritmo del verso (lasciandola prosa,
arciprosa) e scrivere la vita ordinaria come si scrive la storia o l'epopea
(senza snaturare il soggetto) è, forse, un'assurdità (ed è quel che mi chiedo
qualche volta), ma è fors’anche un grande tentativo profondamente originale.
So bene qual'è il mio punto debole. (Ah, se avessi quindici anni!) - Non
importa, varrà sempre qualche cosa per la mia cocciutaggine, e poi, chi sa? un
giorno troverò forse un buon "motivo", un'aria pienamente adatta alla
mia voce, né un tono sopra né un tono sotto, e in ogni caso avrò sempre
passato la vita nobilmente e deliziosamente. C'è una sentenza di La Bruyère,
alla quale mi attengo: "Uno spirito retto crede di scrivere
ragionevolmente". Scrivere ragionevolmente; ecco la mia aspirazione, ed è
già una grande ambizione. Pure, c'è una cosa che rattrista: veder come i
grandi uomini conseguono facilmente l'effetto, senza tanta arte. Che cosa c'è
di peggio costruito in tante cose di Rabelais, di Cervantes, di Molière, di
Hugo? Ma che folgoranti colpi di pugno! che potenza in una sola parola! Noi
dobbiamo ammonticchiare l'uno sull'altro piccoli ciottoli per innalzare le
nostre piramidi, che non raggiungono la centesima parte delle loro, composte di
un blocco solo. Ma voler imitare i loro procedimenti tecnici, sarebbe perdersi:
sono grandi proprio perché non ne hanno. Victor Hugo ne ha molti, ed è questo
che lo sminuisce: manca di varietà, è sviluppato più in altezza che in
ampiezza.
Gustave Flaubert (1821-1880)
33 - Beethoven, Bettina Arnim-Brentano e Goethe
(Bettina
Brentano (1785-1859) di padre italiano, oriundo di Tremezzo sul lago di Como e
cattolico, e di madre tedesca e protestante: Massimiliana La Roche di
Francoforte sul Meno. La madre di costei, Sofia La Roche, famosa scrittrice del
Settecento sentimentale, fu una delle fiamme giovanili di Goethe, il che non
impediva alla nipote Bettina di nutrire per il cinquantottenne patriarca di
Weimar - nel 1807 quando con costui incominciò a scrivergli - e anche in
seguito - appassionati sentimenti di 'amicizia amorosa'. Bettina andò sposa col
giovane e bellissimo Achim von Arnim. Essa fu a Vienna nel 1810, accompagnata
dalla sorella - andata sposa al celebre giurista Carlo Savigny, amico d'infanzia
di Beethoven - e in tale occasione si strinse d'amicizia con il grande Maestro).
Lettera di Bettina a Goethe:
Vienna, 28 maggio 1810
È Beethoven di cui ti voglio parlare oggi. Quando sono in sua compagnia io
dimentico il mondo e dimentico anche te. Sono in grado di non sbagliare se
affermo ciò che oggi forse nessuno capirà o vorrà credere, che egli nella sua
interiore evoluzione avanza di gran lunga tutta l'umanità, e chissà se mai lo
raggiungeremo. Io almeno ne dubito. Purché gli sia concesso di vivere fino a
che sarà pienamente maturato in lui il portentoso e sublime mistero che anima
il suo genio. Sì, possa egli raggiungere la sua meta sublime, ché certo egli
ci lascerà in retaggio la chiave di una conoscenza divina, che ci avvicinerà
d'un gradino alla vera beatitudine.
A te posso ben confessarlo: io credo a un divino incanto come a un elemento
della natura spirituale. Ora, quest'incanto Beethoven l'esercita con l'arte sua.
Quando egli ne parla, ne parla come di un'arte magica. E invero in lui si va
organizzando un'esistenza superiore egli sente
di essere il creatore d'una nuova base sensibile della vita dello Spirito. Spero
che tu comprenderai ciò che voglio dire. Chi potrebbe sostituirci il suo genio?
O da chi potremmo noi aspettarci un'opera che eguagli la sua? - Tutta la vita
umana si svolge in lui come nel meccanismo d'un orologio, lui solo produce da se
stesso l'imprevedibile, l'increato. E che potrebbe dare a lui il mondo, a lui,
che prima del sorger del sole dà principio al suo sacro travaglio e quando è
tramontato, appena si guarda d'attorno, a lui, che dimentica il cibo, e rapito
nell'empito dell'entusiasmo, sorvola leggero sulla volgarità quotidiana?...
Egli ha tre ambizioni e si nasconde ora nell'una, ora nell'altra: la prima in
campagna, la seconda in città, la terza sulla Mölkerbastei. Qui lo trovai, al
terzo piano. Entrai senza farmi annunciare. Sedeva al piano. Gli dissi il mio
nome ed egli mi accolse gentilmente e mi chiese se volevo sentire una canzone
che aveva appunto composto. - Cantò allora, con voce ferma e incisiva, in modo
da comunicare a chi l'ascoltava la profonda mestizia del canto, la canzone di
Mignon. “È bella, non è vero?", mi domandò con calore, “è tanto
tanto bella! La voglio cantare ancora una volta”. Gli fece grande piacere il
mio giocondo applauso. "La maggior parte della gente", osservò,
"si commuove quando sente una bella canzone, ma son quelli che non hanno
attitudini artistiche; gli artisti, s’entusiasmano, non piangono." Cantò
un'altra tua canzone, che ha pure composto in questi giorni: "Non
v’asciugate, non v'asciugate, soavi lagrime, da amor sgorgate."
M'accompagnò a casa, e strada facendo mi disse cose meravigliose sull'arte. A
starlo ad ascoltare ci voleva del coraggio, perché parlava a voce alta e ogni
tratto si fermava. Parlava con passione e diceva cose così sorprendenti che
arrivai alla mia abitazione senz'accorgemene. C'era da noi a pranzo molta gente
e fu grande la sorpresa quando ci videro entrare insieme. Dopo il pranzo, si
sedette al piano e sonò a lungo, meravigliosamente... Ci vediamo ogni giorno: o
viene lui da noi, o vado io in casa sua. Per goder la sua compagnia, trascuro
ogni altra cosa; la società, le gallerie, il teatro, lo stesso campanile di S.
Stefano non hanno più attrattive per me. "Che vuol mai vedere lassù?"
m'ha detto Beethoven. “Verrò a prenderla verso sera e faremo piuttosto
insieme una passeggiata nei viali di Schönbrunn”.
Ieri sono stata con lui in un magnifico giardino. Tutto era in fiore, le serre
aperte, il profumo inebriante. Beethoven si fermò al sole, benché facesse un
gran caldo, e mi disse: "Le poesie di Goethe esercitano un grande fascino
su di me, non solo per il contenuto, ma anche per il ritmo. Quella sua lingua
meravigliosa, che quasi scala di Giacobbe ci guida a un'esistenza superiore e
racchiude già in se il segreto delle più sublimi armonie, mi rapisce in
un'atmosfera musicale, per cui la composizione ne viene spontanea. Dal centro
dell'ispirazione, l'onda melodica si diffonde libera in tutte le direzioni. Io
la seguo, la rincorro con ardore. Essa mi fugge dinanzi e scompare
nell'intreccio dei motivi più diversi. Ma ben presto la riafferro con rinnovato
ardore per non staccarmene più e rapito nel giubilo della creazione, ne
centuplico le modulazioni, finché da ultimo l'originario pensiero musicale
trionfalmente si afferma in tutta la sua pienezza. È così che nasce la
sinfonia. Sì; la musica è la mediatrice fra la vita dei sensi e quella dello
spirito. Vorrei parlare di quest'argomento con Goethe; forse lui mi
comprenderebbe. La melodia è la vita sensibile della poesia. Non è forse la
melodia che attraverso alla percezione dei sensi comunica al nostro sentimento
la sostanza spirituale d'una poesia? Così nella canzone di Mignon tu senti,
espresso nella melodia, tutto l'abbandono di quell'anima all'onda delle
sensazioni e dei ricordi. E da questo sentimento rampollano sempre nuove
creazioni melodiche. Lo spirito tende ad allargarsi fino ad abbracciare
l'infinito, l'universale, fino ad accogliere e ad esprimere in un organismo
complesso la fiumana dei sentimenti che, nati da un semplice pensiero musicale,
rimarrebbero altrimenti per sempre inespressi, ignorati. Quest'é l'armonia,
questo il significato delle mie sinfonie. Un'onda di motivi, di forme ricche,
lussureggianti liberamente si svolge fino a raggiungere la meta. Nulla meglio
della musica ti dà la sensazione che ogni opera dello spirito contiene in sé
alcunché d'eterno, d'infinito, d'inafferrabile, e benché il produrre sia
sempre accompagnato in me dal sentimento della riuscita, pure mi struggo
nell'insaziabile brama di ricominciare, come un bambino, daccapo, ciò che mi
sembrava interamente compiuto con l’ultima battuta, con la quale avevo cercato
d'imprimere indelebilmente nell'animo degli uditori la mia convinzione musicale,
il mio gaudio supremo. Parli a Goethe di me e gli dica che ascolti le mie
sinfonie; allora certamente converrà meco nell'affermare che la musica sola può
schiuderci col suo linguaggio incorporeo le porte di un mondo superiore di
conoscenza, di cui l'uomo è, sì, parte, ma che egli non riesce mai a esplorare
interamente...”
Gli promisi di scriverti tutto quanto aveva detto così come l'avevo potuto
capire. Mi condusse a una prova con piena orchestra ... Qui vidi come questo
genio titanico domina da sovrano il suo mondo. Ti dico che nessun re e nessun
imperatore è così compreso del suo potere, nessuno come lui ha la sicura
coscienza che tutta l’energia parte da lui solo ...
Bettina
In un'ora felice m'è giunta la tua lettera, mia cara bambina. Tu hai fatto del
tuo meglio per rappresentarmi una grande e bella natura dell'uomo nelle sue
opere e nelle sue aspirazioni, nei suoi bisogni e nell'esuberanza dei suoi
talenti. M'ha fatto grande piacere accogliere nel mio spirito l'immagine d'un
uomo veramente geniale.
Non è già ch'io lo voglia classificare; ma ci vuole a ogni modo una grande
penetrazione psicologica per poter stabilire quali siano i punti di contatto tra
me e lui. Non ho tuttavia nulla da opporre a quanto della tua entusiastica
effusione ho potuto afferrare; posso anzi fin d'ora assicurarti che fra la mia
natura e la sua, quale si esprime nelle sue molteplici considerazioni, v'è
un'intima corrispondenza. Forse una
mente volgare scoprirebbe delle contraddizioni; ma le parole di chi è
posseduto, come lui, dal demone, debbon esser accolte con umiltà dai profani, e
sia che in lui parli il sentimento, sia l'intelletto, esse rimangon vere, perché
son dono degli Dei, che vi spargono il seme d'una futura conoscenza, e a noi
altro non resta che desiderare che i germi giungano a piena e libera
maturazione. Ma prima che questa conoscenza divenga il comune patrimonio di
tutti, è necessario che si diradino le nebbie che ancora offuscano lo spirito
umano.
Dì a Beethoven, ti prego, tutto il mio affetto e assicuralo che farei
volentieri qualunque sacrificio per conoscerlo di persona, ché uno scambio
d'idee e di sentimenti sarebbero certo ad ambedue di grandissimo giovamento.
Forse a te riesce d'indurlo a venire a Karlsbad, dove vado quasi ogni anno e
avrei tutto l'agio di ascoltarlo e d'imparare da lui. Volergli insegnare
qualcosa sarebbe un delitto anche per chi dell'arte fosse più intendente di me,
perché il suo genio gli è lume sufficiente e spesso con un lampo gli rischiara
la via, mentre noi altri sediamo nelle tenebre e a malapena intravediamo da qual
parte spunterà il nuovo giorno.
Sarebbe per me una grande gioia, se Beethoven volesse mandarmi le mie due
canzoni con la sua musica, ma mi raccomando che sian scritte in modo leggibile.
Ho un gran desiderio di sentirle. È questo uno dei miei più grandi godimenti,
e sento per chi me li procura la più viva riconoscenza, quando la melodia ridà
forma sensibile (come bene s'esprime Beethoven) a sentimenti cui altra volta
diedi espressione in una poesia.
G. - 6 giugno 1810
Bettina a Goethe:
luglio ‘10
Della tua bella lettera ho comunicato a Beethoven la parte che lo riguardava.
Ne fu molto soddisfatto e disse: "Se vi è qualcuno che possa fargli capire
la musica, quest'uno sono io". Accolse con entusiasmo l'idea di venirti a
trovare a Karlsbad; disse anzo, battendosi la fronte: "Perché non l'ho
fatto prima? No, ch'io già ci pensai altra volta, ma poi non ne feci nulla, per
timidezza. Come se non fossi anch'io un uomo come tutti gli altri! Ma di Goethe
almeno ora non avrò più soggezione". Puoi dunque contare d'incontrarlo
l'anno venturo.
B.
Lettera di Bettina al Dr. Antonio Biehler di Landshut -Baviera
9 luglio 1810
Solo negli ultimi giorni della mia dimora a Vienna ho fatto la conoscenza di
Beethoven. Quasi sarei partita senza vederlo, perché nessuno, neppure i suoi più
intimi amici, voleva condurmi da lui, per paura della sua malinconia, la quale
per tal modo lo domina; ch’egli si disinteressa di tutto e di tutti ed è
sgarbato coi forestieri che lo vengono a visitare...Nessuno sapeva indicarmi la
sua abitazione; egli ha l'abitudine di rendersi spesso irreperibile. La sua
abitazione è strana davvero. Nella prima stanza ci sono due o tre pianoforti,
tutti senza gambe, alcuni bauli con la sua roba e una sedia che malamente si
regge su tre gambe. Nella seconda stanza c'è il letto, che consiste d'inverno e
d'estate d'un saccone e d'una coperta leggerissima, e su d'un tavolino di legno
d'abete una catinella; la veste e la camicia da notte giacciono a terra. In
questa stanza aspettammo una buona mezz’ora, perché Beethoven stava facendosi
la barba. Finalmente venne. È piccolo di statura e di carnagione bruna. Il viso
è deformato dal vaiolo, tanto che può dirsi brutto, ma ha una fronte divina,
che l'interiore armonia ha inarcato in una linea così nobile e pura, che non si
può fare a meno d’ammirarla come un magnifico capolavoro. I capelli ha neri e
lunghissimi, e usa gettarli, con un movimento istintivo all'indietro.
All'aspetto, dimostra appena trent'anni.
M'era stato detto che bisognava usare tutti i riguardi per non urtarlo; ma io,
nel mio interno, m'ero fatta tutt'altra idea della sua nobile natura, e non
avevo errato... Lo chiamano superbo, perché si rifiuta di sonare per il
divertimento dell'imperatore e degli arciduchi, i quali pur gli pagano un'annua
pensione. Ed è per Vienna un avvenimento quando suona in pubblico. Alla mia
preghiera di volermi suonare un pezzo, rispose bruscamente: "E perché mai
dovrei suonare?".
"Perché voglio arricchire la mia vita", gli risposi "delle
impressioni più grandi e più belle, perché questo giorno deve iniziare un
nuovo periodo nella mia esistenza".
Mi assicurò che avrebbe cercato di meritare questa lode e si sedette sull'orlo
d'una sedia accosto al piano. Preludiò dapprima con una sola mano, quasi a
vincere la ripugnanza che ha a farsi sentire da altri. Ma ad un tratto parve
aver dimenticato i presenti: la sua anima si espandeva libera nello sconfinato
oceano dell'armonia, ... Quando viene dal travaglio della composizione, è
affatto sordo e non distingue gli oggetti del mondo esterno; e ciò accade perché
l'armonia tiene ancora occupato il suo cervello ed egli non può rivolgere ad
altro la sua attenzione. Gli è tolto adunque del tutto il mezzo di comunicare
col mondo - l'udito -, per cui vive nella più profonda solitudine. A volte,
quando si è parlato a lungo con lui e s'attende una sua risposta, egli prorompe
improvvisamente in suoni sconnessi, prende fuori la carta da musica e si mette a
scrivere...
È largo d'aiuto e di consiglio a quanti, desiderosi di progredire nella musica,
si rivolgono alui. Il più modesto principiante può abbandonarsi con piena
fiducia alla sua guida. L'uomo che non vuole sacrificare un'ora sola della sua
libertà, è sempre pronto a consigliare, ad aiutare chiunque.
Prima lettera di Beethoven a Bettina:
Vienna, 11 agosto 1810
Amica carissima,
non c'è stata per me una primavera più bella della primavera di quest'anno,
poiché ho fatto la Sua conoscenza. Lei stessa avrà osservato che in società
io sono un pesce fuor d'acqua, che per quanto si svoltoli e rivolti nella rena,
resta sempre là finché una Galatea pietosa non lo prende e lo riporta
nell'ampio seno del mare. Sì, davvero, cara Bettina, io ero proprio come il
pesciolino sulla rena, e Lei mi sorprese in un momento ch’ero oppresso dalla
più nera malinconia. Ma non appena La vidi, ecco che la malinconia, come per un
incanto, svanì; compresi subito che Lei apparteneva a un altro mondo, diverso
da questo nostro così assurdo al quale, anche con la più buona volontà, non
si possono aprire le orecchie. Io, che sono così infelice, mi lagno degli
altri! Ma Lei vorrà perdonarmi, Lei che ha un così ottimo cuore, che Le parla
dagli occhi, e un così eccellente giudizio, che sta tutto nei Suoi orecchi. (Se
non altro, i Suoi orecchi sanno l'arte d'adulare mentre stanno in ascolto). Per
me gli orecchi non sono, ahimè, che un ostacolo, che si frappone fra me e gli
altri uomini, e non mi permette di comunicare amichevolmente con nessuno. Se non
fosse così Le avrei forse dimostrato maggior confidenza. Così non ho potuto
capire che lo sguardo pieno d'intelligenza dei suoi grandi occhi profondi, ed
esso m'ha così ammaliato, che non potrò giammai dimenticare.
Cara Bettina, cara bambina! L'arte, chi la capisce? Con chi mai si può parlare
di questa grande dea? Come m'è caro il ricordo dei pochi giorni che abbiamo
chiacchierato, o meglio, carteggiato insieme! Ho conservato tutti i biglietti
che contengono le Sue care e geniali risposte. Così, grazie alla mia sordità,
la parte migliore dei nostri colloqui non andrà perduta.
Da quando è partita, ho avuto molte ore brutte, ore nere, in cui non si può
far nulla. Per ben tre ore ho girato per i viali di Schönbrunn, ma non ho
incontrato nessun angelo che m'avesse affascinato come te, angelo mio. – Oh,
perdoni, amica mia, se sono uscito di tono; ho bisogno di questi intervalli per
dar sfogo al mio cuore. E a Goethe ha scritto, vero, di me? – Oh, potessi
ficcar la testa in un sacco per non sentire, per non vedere niente di quanto
succede al mondo, giacché non devo incontrarmi mai più con te, angelo mio
caro. Ma una lettera l’avrò da Lei? Vivo di speranza come i più degli
uomini, e guai se non l’avessi avuta compagna della mia vita! Che sarebbe
stato di me?
Le mando, scritta di mio pugno, la canzone di Mignon come ricordo dell'ora in
cui La vidi per la prima volta, e mando anche un'altra canzone, che ho musicato
dopo che presi congedo da te, cuor mio.
'Cuore, cuore, che t'accade?
perché mai t'affanni tu?
qual nuov’impeto m'invade?
Ritrovarti non so più.’
Sì, amica mia, mi risponda, mi scriva: che sarà di
me, dacché il mio cuore mi s'é fatto ribelle! Scriva al Suo affezionatissimo
amico
Beethoven
Seconda lettera di Beethoven a Bettina:
Vienna, 10 febbraio 1811
Cara, cara Bettina,
ho ricevuto già due lettere Sue e dalla Sua lettera all'Antonietta vedo che si
ricorda di me e mi giudica con troppa indulgenza. La Sua prima lettera l'ho
portata con me tutta l'estate, e spesso rileggendola ho provato un'ineffabile
gioia. Anche se non Le scrivo tanto spesso e Lei non riceve nulla da me, pure Le
scrivo mentalmente migliaia e migliaia di lettere.
Come Lei si trovi a Berlino, in mezzo a quella canaglia, me lo potrei facilmente
immaginare, anche se non me l'avesse scritto: ciarlare e ciarlare dell'arte
senza produr nulla! La miglior descrizione di codesta genia la si trova nei
“Doni votivi” dello Schiller, nella poesia "I fiumi", là dove fa
parlare la Sprea.
Lei si sposa, cara Bettina, o forse s'è già sposata, senza ch'io l'abbia
potuta rivedere ancora una volta. Oh, scendano sul Suo capo e su quello del Suo
sposo tutte le benedizioni che rendon felice il matrimonio. E che dirò di me?
"Compiangi il mio destino", dirò con la Vergine d'Orleans. Se riesco
a conservarmi in vita ancora per alcuni anni, voglio ringraziarne, come di tutto
il bene e di tutto il male, l'Altissimo, l’Onnipresente. Se scrive a Goethe,
cerchi le parole più efficaci per dirgli tutta la mia ammirazione e la mia
devozione più profonda. Fra giorni gli scriverò io stesso per l’Egmont, che
ho musicato per il grande amore che porto alla sua poesia, che mi rende così
felice! Ma chi saprebbe trovar parole per esprimere tutta la riconoscenza che
sentiamo per il grande poeta, il gioiello della sua nazione?
Ora basta, mia cara, mia buona Bettina. Stamane sono ritornato alle quattro da
un baccanale, dove non ho potuto fare a meno di ridere, per esser oggi costretto
a piangere. Così è: dopo essermi abbandonato all'ebbrezza d'una gioia
tumultuosa, devo rientrare in me stesso. E ora addio, amica mia cara. Io ti
bacio con dolore infinito sulla fronte; t'imprima questo bacio, come un
suggello, nell'anima tutti i pensieri che dal mio cuore volano a te.
Scriva presto, presto e spesso al Suo amico Beethoven
Beethoven
a Goethe:
Vienna, 12 aprile 1811
Eccellenza,
non dispongo che di pochissimo tempo per scriverle, dovendo l'amico che Le
recherà la presente, partire in gran fretta per un affare urgente. Egli è un
grande ammiratore di V.E., come lo sono pur io, che desidererei d'avere il tempo
e il modo d'esprimerle, come si conviene, tutta la gratitudine che fin da
fanciullo ho sentito per Lei; ma sarebbe tuttavia ben piccola cosa al paragone
del tanto bene che m'è venuto da Lei.
Bettina Brentano m'ha assicurato ch'Ella m'accoglierebbe come un amico. Ma come
potrei io pensare a una tale accoglienza, quando non oserei avvicinarmi a Lei,
che col più profondo rispetto, tutto compreso dell'ineffabile bellezza delle
Sue creazioni? Fra giorni Ella riceverà dalla Casa editrice Breitkopf & Härtel
di Lipsia la musica dell'Egmont. Esso mi ha così profondamente commosso che per
virtù della Sua arte l'ho ripensato, rivissuto, e, appena finita la lettura,
musicato - Ho un gran desiderio di sentire il Suo giudizio; anche il biasimo
gioverà a me e alla mia arte e mi sarà gradito al pari della lode.
Il grande ammiratore dell'E.V.
Ludwig van Beethoven
Risposta di Goethe:
Karlsbad, 25 giugno 1811
La Sua gentile lettera, stimatissimo Signore, m'è stata recapitata dal Signor
Oliva e m'ha recato grande piacere. Le serbo la più viva gratitudine per i
sentimenti ch'Ella mostra di nutrire per me, e Le posso assicurare che li
ricambio di tutto cuore. Ogni qualvolta dilettanti o artisti provetti m'hanno
sonato una Sua opera, ho sentito il desiderio di sentirla sonare dal suo autore,
per poterne ammirare il meraviglioso talento.
La buona Bettina Brentano merita bene il Suo interessamento. Essa parla di Lei
col più grande entusiasmo e con la più viva simpatia, e stima le ore passate
in Sua compagnia fra le più felici della sua vita.
La musica dell'Egmont ch'Ella mi ha voluto dedicare, la troverò, spero, al mio
ritorno a Weimar, ma fin d'ora gliene sono grato. Ne ho sentito parlare già da
molte persone con la più viva ammirazione e spero di poterla far eseguire
questo inverno al nostro teatro, procurando così un grande godimento artistico
tanto a me stesso quanto ai molti ammiratori ch'Ella ha nel nostro paese. Ma
quel che più mi sta a cuore è di poterla vedere, come mi ha fatto sperare, se
ben l'ho capito, il signor Oliva, nell'occasione d'un Suo prossimo viaggio a
Weimar. Sarebbe bene che Ella ci venisse quando vi sono la Corte e tutti
gl'intendenti di musica, ché allora certo non Le mancherebbe un'accoglienza
degna dei Suoi meriti e del Suo carattere. Nessuno può averci più interesse di
me, che mentre Le faccio i migliori auguri per il Suo benessere, mi raccomando
alla Sua memoria e Le porgo i più sentiti ringraziamenti per tutto il bene che
ho avuto da Lei.
Wolfgang
von Goethe
(Beethoven era animato dal
più ardente spirito di carità. L'inganno e l'ingratitudine potevano ben
contristarlo, ma non per questo gl'impedivano di continuare imperterrito nella
via del bene. Documenti della sua filantropia sono i documenti seguenti)
Al Procuratore camerale Dr.
Ignazio De Varena di Graz, inviandogli le partiture di alcune sue opere per un
concerto a favore degli istituti di carità delle Orsoline. Il concerto fruttò
l'importo netto di 5.000 fiorini.
Dicembre 1811
Dopo la mia prima malattia non ho mai cercato al mio zelo, nel soccorrere con la
mia arte l'umanità sofferente, altro compenso all'infuori dell'intima gioia che
dà ogni opera buona....
B.
Allo stesso:
Vienna, 8 maggio 1812
... Mi ricordi alle reverende madri, le amorose educatrici dell'infanzia, e dica
loro che ho pianto lacrime di gioia per il bel successo che ha arriso alle mie
buone intenzioni. Le assicuri che per quanto potrò giovar loro con le mie
deboli forze, troveranno sempre in me il più caloroso sostenitore ...
Si conservi sano e sappia che l'aver trovato in Lei un amico dei derelitti è
stato per me una grande gioia. Il Suo dev.mo
B.
Allo stesso:
Teplitz, l9 luglio 1812
I miei ringraziamenti per lo leccornie speditemi dalle buone madri, Le giungono
molto in ritardo perché, non migliorando a Vienna, il mio male, mi son dovuto
rifugiare in questo luogo di cura.
Ad ogni modo, meglio tardi che mai. La prego dunque di dire alle reverende madri
Orsoline tutta la mia riconoscenza. Per parte mia, non posso accettare i loro
ringraziamenti; sono io piuttosto che devo ringraziare chi mi ha dato il modo di
giovare con l'arte mia a chi soffre. Non appena Ella dovesse aver bisogno del
mio povero contributo per beneficarne le madri, non ha che a scrivermi...
Che se le reverende madri vogliono tuttavia dimostrarmi in qualche modo la loro
gratitudine, mi ricordino nelle loro devote preghiere e in quelle delle loro
bambine.
B.
Incontro di Beethoven con Goethe a Teplitz (1812)
Dal Diario di Goethe:
19 luglio - Visita a Beethoven
20 luglio - La sera sono stato in carrozza con Beethoven a Bilin
21 luglio - La sera, da Beethoven. Ha sonato stupendamente.
Lettera di Goethe alla moglie:
…Non ho mai veduto un artista più raccolto, più energico, più profondo. Ora
comprendo come si debba trovare in una strana posizione di fronte al mondo.
Teplitz, 19 luglio 1812
Lettera di Bettina al principe Pueckler‑Muskau:
…si conobbero a Teplitz. Goethe andò a trovarlo. Beethoven gli sonò un
pezzo, e vedendo ch’era rimasto profondamente commosso, gli disse:
"Signor mio, da Lei non mi sarei mai aspettato questo! Anni fa diedi un
concerto a Berlino. Avevo fatto del mio meglio e mi lusingavo di riscuotere un
caloroso applauso, ma invece, quando ebbi dato espressione a tutto il mio
entusiasmo sicché ero convinto d'averlo comunicato al pubblico, questo non
diede il minimo segno d'approvazione. Era troppo per me: non potevo in alcun
modo capacitarmene. Ma Presto l’enigma mi si chiarì, quando vidi tutto il
teatro, in piedi, agitare, in segno di riconoscenza, i fazzoletti bagnati di
lacrime. Già: era un pubblico colto e ben educato! Ma io, che sono stato sempre
un rude entusiasta, della loro commozione non sapevo che farmene: avevo creduto
d'aver da fare con gente che sentisse artisticamente, e mi trovavo invece
davanti un pubblico romantico. Ma da voi, Goethe, questo non posso assolutamente
tollerare, quando mi ronzavano nel capo le vostre poesie, ne usciva della buona
musica e io avevo l'ardire di sollevarmi alla vostra altezza; benché lo facessi
inconsapevolmente, e alla vostra presenza non l'avrei mai fatto. L'entusiasmo si
manifesta in tutt'altro modo. Lo dovreste pur sapere per propria e sperienza
come fa bene sentirsi applaudire dalle mani d'un artista. Se voi non apprezzate
la mia orera e non mi volete riconoscere come vostro pari, chi altri lo farà?"
A quest'intemerata, Goethe rimase dapprima senza rarole: egli ben sentiva che
Beethoven, in fondo, aveva ragione e non sapeva come riparare al suo errore.
C'erano allora a Teplitz l'imperatrice e gli arciduchi d'Austria, e Goethe, che
era stato colmato da loro di gentilezze e di onori, si dava un gran daffare per
dimostrare all'imperatrice in mille guise la sua profonda devozione. Anche a
Beethoven non poté fare a meno di parlarne e lo fece con tono solenne e
dimesso. “Macché!”, l'interruppe il Maestro: “codesto non è il modo di
trattare coi principi; così non verrete a capo di nulla. Voi dovete far sentir
loro chi siete, altrimenti non lo capiranno mai. Non v'è principessa che
riconosca il valore del Tasso, se non in quanto lusinga la sua vanità. Io ho
usato un altro metodo. Un giorno che l'arciduca Rodolfo, cui davo lezioni, mi
fece fare anticamera, per roco non gli slogai, con gli esercizi, le dita. E come
mi domandò perché fossi così impaziente, gli risposi che m'aveva fatto
perdere troppo tempo in anticamera, perché mi potessi ora permettere il lusso
d'esser paziente. Da quel giorno non feci più anticamera. E gli dissi ancora
che mi potevano ben appiccicare l'uno o l'altro dei loro ordini, ma che per
questo non mi sarei sentito punto migliore. Possono ben creare dei consiglieri
intimi, dei consiglieri aulici, ma un Goethe, un Beethoven non li creeranno mai.
È bene dunque che imparino a rispettare quel che non è opera loro, quel che
essi non sono”.
Terza lettera di Beethoven a Bettina:
Teplitz, 15 agosto 1812
Mia cara, mia buona Bettina, i re e i principi posson ben creare dei professori
e dei consiglieri segreti, possono conferire titoli e onorificenze, ma non
possono creare gli uomini grandi, degli spiriti che s’ergano alti, sublimi
sopra la canaglia umana. E per questo, quando due uomini come me e Goethe
s'incontrano, bisogna far capire a quei signori qual'è la vera grandezza.
Ieri, tornando a casa, incontrammo la famiglia imperiale. Appena la scorgemmo da
lontano, subito Goethe si staccò dal mio fianco per tirarsi rispettosamente in
disparte. A nulla valsero le mie proteste: non riuscii a portarlo avanti d'un
passo. Allora, calcatomi il cappello ben bene in testa e abbottonato il
soprabito, passai con le braccia incrociate framezzo alla compagnia, e principi
e cortigiani fecero spalliera al mio passaggio; l'arciduca Rodolfo si levò il
cappello, l'imperatrice salutò lei per prima. Le loro altezze mi conoscono
troppo bene! Io mi divertivo un mondo a veder sfilare la processione davanti a
Goethe, che se ne stava da un lato della strada, a capo scoperto e chino in atto
di riverente omaggio. Quando fummo soli, gli feci una buona lavata di capo. Non
gli diedi quartiere; a uno a uno gli feci passar davanti tutti i suoi peccati e
più di tutto lo rimproverai dei modi usati con Lei, cara Bettina, ché poco
prima s'era parlato di Lei. - Oh, se fosse stato concesso a me di godere la Sua
compagnia tanto tempo come lui, avrei compiuto, mi creda, opere ben più grandi.
Anche il musicista è poeta e due begli occhi possono rapire anche lui in un
mondo più bello, dove gli spiriti magni scherzano con lui e gl'impongono
compiti sempre più difficili. Quante cose mi turbinavano nella mente quando ti
conobbi! ... Dai Suoi occhi s'insinuavano nel mio cuore i temi più belli, più
meravigliosi, che formeranno la gioia delle future generazioni, quando Beethoven
non sarà più. Se Iddio mi concederà ancora alcuni anni di vita, io ti devo
rivedere, mia cara cara Bettina: così vuole l'intima voce della mia coscienza,
che mai non falla. Anche gli spiriti possono amarsi, e io amerò sempre il Suo;
la Sua approvazione mi sarà più cara che quella di chiunque altro.
A Goethe ho detto il mio sentimento. Gli ho fatto capire quale effetto abbia su
di me l’applauso, e che dai suoi pari voglio esser giudicato con l'intelletto;
la commozione (perdonamelo) sta bene alle donne, l'anima dell'uomo deve essere
infiammata dalla musica. - Cara bambina, da quanto tempo noi due andiamo
d'accordo in tutto e per tutto! Non vi è altra gioia al mondo che avere
un'anima buona e gentile, un cuore di cui conosciamo i più segreti palpiti e
per il quale non abbiamo segreti. Per parere, bisogna prima essere. Il mondo ci
deve conoscere; non sempre esso è ingiusto. Tuttavia questo a me non importa,
perché ho una meta ben più sublime.
Domani parte la Corte, oggi danno ancora un concerto. Goethe e il suo duca
vogliono sentirmi sonare qualcosa di mio; ma io mi sono rifiutato. Tutt'e due
vanno matti per le porcellane cinesi, e bisogna scusarli, perché hanno perduto
la testa. Ma io non mi presto a soddisfare i loro stravaganti capricci.
Addio, addio, mia buona amica! La tua ultima lettera ha riposato tutta la notte
sul mio cuore e m'ha dato una meravigliosa frescura. Oh, i musici si permettono
tutto!
Dio, come L'amo! Il tuo fido amico, il tuo sordo fratello
Beethoven
Lettera di Goethe a Zelter
Karlsbad, 2 settembre 1812
... Ho conosciuto Beethoven a Terlitz. Son rimasto meravigliato del suo talento;
ma egli è purtroppo una natura tuttavia indomita e selvaggia che ha, sì, tutte
le ragioni di trovar detestabile il mondo, ma con ciò non lo rende più
gradevole né a sé né agli altri. Conviene però scusarlo e compatirlo, perché
va perdendo l'udito, ciò che nuoce forse meno al musicista che all'uomo nei
suoi rapporti con la società; il difetto fisico viene ad accentuare più che
mai il suo naturale laconismo.
Lettera di Beethoven a Goethe
Vienna, 8 febbraio 1823
Eccellenza,
mentre vivo ancor sempre, come negli anni della mia giovinezza, nelle Sue opere
immortali, e sempre ancora ricordo con intima, ineffabile gioia le ore passate
in Sua compagnia, mi trovo questa volta nella necessità di fare appello alla
Sua buona memoria. Spero ch'Ella avrà ricevuto le due canzoni e dedicato a Lei,
“Calma del mare" e “ Felice navigazione” (op. 112). Scelsi queste,
perché mi sembravano, nel loro contrasto, particolarmente adatte alla
composizione.
Come avrei caro sapere se m'è riuscito di accordare la mia armonia alla Sua, e
Le sarei grato anche per le osservazioni e le critiche ch'Ella avesse a fare
alla mia opera, perché amo soprattutto la verità, né mai varrà per me il
detto “veritas odium parit”. Forse che in breve si pubblicheranno ancora
altre Sue poesie da me musicate, fra cui "Amore senza posa". Quanto
gradirei un Suo giudizio sulla composizione delle Sue poesie.
Devo pregare l'E.V. d'un favore. Ho scritto una grande Messa che, per ora, non
intendo pubblicare, volendola prima offrire manoscritta alle prime Corti di
Europa; l'onorario importa 50 ducati. A questo fine mi son rivolto, tra l'altro,
anche all'ambasciata del granducato di Weimar e ho presentato a mezzo di essa
un'istanza al Granduca. La Messa può eseguirsi anche come oratorio, e tutti
sanno che gli oratori s'adattano più di ogni altro genere di musica per serate
di beneficenza. Vorrei dunque pregarla di richiamare l'attenzione di Sua Altezza
su quest'opera, perché sia indotta a sottoscrivere. All'Ambasciata mi fu detto
che sarebbe stato bene se qualche persona influente ne avesse parlato prima al
Granduca.
Ho scritto già tanto, ma con poco frutto. Ma ora non sono più solo. Da sei
anni faccio da padre a un mio nipote, un giovinetto di sedici anni, che promette
bene; studia con grande ardore e si può dire che il mondo greco gli è fin
d'ora familiare. Ma tutto questo nel nostro paese costa molto, e quando s'ha a
provvedere per un giovane incamminato per la via degli studi, bisogna pensare
non solo al presente, ma ancora all'avvenire.
Finora il mio occhio era rivolto solo al cielo; ora devo guardare un po' anche
alla terra. Sul mio stipendio non posso contare. D'altra parte la mia malattia
non mi ha permesso d'intraprendere negli ultimi anni giri artistici e, in
genere, non ho potuto andar dietro ai guadagni.
L'E.V. non deve però credere ch'io Le abbia dedicato la composizione delle Sue
due canzoni per ottenere in contraccambio questo favore. Le canzoni le musicai
già nel maggio del 1822, mentre il pensiero di divulgare in questo modo la
Messa, m'è venuto appena nelle ultime settimane. Quella venerazione e quell'amore
ch'io nutrivo per il grande Goethe negli anni della mia giovinezza, li conservo
immutati anche adesso. Le parole non bastano a esprimere tutta la pienezza d'un
affetto profondo e sincero, e men che meno potrebbero bastarvi quelle di un
imbrattacarte come me, che non ha mai pensato ad altro che a conquistarsi il
dominio dei suoni. Ma poiché vivo, come dissi, nelle Sue opere, non posso fare
a meno di dirle almeno un tanto.
Sono convinto ch'Ella non rifiuterà d'interessarsi per un artista, il quale
troppo duramente sente come la caccia al guadagno è la negazione dell'arte, e
gli sarà largo del Suo aiuto in un momento in cui è costretto a lavorare non
soltanto per sé, ma anche per gli altri. Siamo uniti nella comune aspirazione
verso il bene; perciò confido ch'Ella non respingerà la mia preghiera.
Coi sensi della venerazione più profonda, più illimitata.
Il Suo Beethoven
(A questa lettera non fu risposto né dalla Corte di Weimar né dal Ministro
Goethe). Mentre si viveva nell'angosciosa attesa del risultato di questo passo,
venne improvvisamente un corriere dalla Corte di Parigi. Era il duca d'Achâts,
gran ciambellano di Luigi XVIII, il quale recava una medaglia d'oro del peso di
21 luigi d'oro con l'effigie del re come prezzo di sottoscrizione. Vi erano incise le parole: “Donné par le Roi à
Monsieur Beethoven”.)
34
- Ancora dal “giornale intimo” di Amiel (a proposito di Goethe) (Enrico
Federico Amiel)
19
gennaio 1871 (ore 23.30)
Ciò che oggi ho letto di Goethe (Epistole-Epigrammi; Le quattro stagioni) non
è atto a farmelo amare. Perché? Perché egli ha poca anima. Il suo modo di
concepire l'amore, la religione, il dovere, il patriottismo è un po' meschino e
spiacevole. Gli fa difetto la generosità ardente. Una segreta aridità, un
egoismo mal dissimulato penetrano nell'ingegno così flessibile e ricco. Si
saluta il poeta, ma ci si mette sulla difensiva davanti all'uomo, che pare assai
poco capace di sacrificio e che ha assai poca tenerezza per i piccoli ed i
diseredati di quaggiù. Perisca il mondo, pur che il poeta possa titillare
tranquillamente la sua lira e coltivare le sue disposizioni personali...
20 gennaio 1871 (ore dieci)
... Nell’egoismo goethiano è eccellente il rispetto della libertà di
ciascuno ed il lieto riconoscimento di tutte le originalità; tuttavia quest’egoismo
non aiuta nessuno a sue spese, non si tormenta per nessuno; non si incarica del
fardello di nessuno, in una parola, sopprime la carità, la grande virtù
cristiana. La perfezione per Goethe, consiste nella nobiltà personale, non
nell'amore: il suo centro è l'estetica. Ignora la santità e non ha mai voluto
riflettere sul terribile problema del male. Spinozista fino alle midolla, egli
crede alla fortuna individuale, non alla libertà né alla responsabilità. È
un greco integro, non mai sfiorato dalla crisi interiore della coscienza
religiosa; rappresenta dunque uno stato d'anima anteriore o posteriore al
cristianesimo, ciò che i prudenti critici del nostro tempo denominano spirito
moderno; e ancora lo spirito moderno considerato soltanto in una delle sue
tendenze, cioè il culto della natura, poiché Goethe è estraneo alle
aspirazioni sociali e politiche delle folle; s'interessa ai diseredati, ai
deboli, agli oppressi tanto quanto se ne interessa la Natura, madre noncurante e
feroce, sorda verso tutti gli sfortunati...
stesso giorno (mezzanotte)
Lettura di quindici sonetti e di nove poesie di Goethe.
L'impressione di questa parte delle "Gedichte" è assai più
favorevole di quella suscitata dalle Elegie e dagli Epigrammi, "Gli spiriti
delle acque", "La mia dea", "Il viaggio dello Harz",
"Il Divino" posseggono grande nobiltà di sentimento. Non bisogna mai
affrettarsi a giudicare queste nature multiple... Senza giungere al sentimento
dell'obbligo e del peccato, Goethe arriva ai grandi problemi per il cammino
della dignità. Il suo catechismo di virtù è la statuaria greca...
Enrico Federico Amiel
35
– Mignon
(J. W. von Goethe)
… Egli salì le scale verso la
sua camera, quando d'un tratto gli saltò incontro una giovane creatura, che
attirò la sua attenzione. Una vestina corta di seta con maniche aperte alla
spagnola, dei calzoncini lunghi e stretti con risgonfi vestivano molto bene la
figurina. Lunghi capelli neri in anellature e trecce erano arricciati e
intrecciati intorno alla testa. Wilhelm guardò ammirato l'apparizione e non poté
capire se fosse un ragazzo o una ragazza. Ma presto si convinse ch’era una
bimba e, mentre gli passava dinanzi, la trattenne, dandole il buon giorno e le
domandò a chi appartenesse, quantunque facilmente potesse vedere che ella era
un membro della compagnia dei saltimbanchi e dei ballerini. Con l'occhio nero e
penetrante, ella lo guardò di traverso, e staccandosi da lui, corse in cucina
senza rispondergli.
... Il popolo si era a poco a poco allontanato (dopo lo spettacolo) e la piazza
si era fatta vuota. Wilhelm vide, affacciato alla finestra, nella strada la
strana bambina presso a dei ragazzi che giocavano e richiamò l'attenzione di
Filina, che subito, nel suo modo vivace, la chiamò e le fece cenno, e siccome
la bambina non voleva venire, cantando e battendo i tacchi sulle scale, scese giù
e la ricondusse con sé. - Qui è l'enigma - ella disse, introducendo la bimba.
Questa restò ferma sulla soglia, come se avesse subito voluto sgusciar via, si
mise la mano destra sul retto, la sinistra dinanzi la fronte e s'inchinò
profondamente. - Non aver paura, piccola cara ‑ le disse Wilhelm
avvicinandosele. Ella lo guardò con sguardo incerto, e si apprestò di alcuni
passi.
- Come ti chiami? - le domandò. - Mi chiamano Mignon. - Quanti anni hai? -
Nessuno li ha contati. - Chi era tuo padre? - Il gran diavolo è morto. -
- Questo è meraviglioso! - esclamò Filina. Le fecero ancora qualche domanda;
ella dava le sue risposte in un tedesco stentato e con una certa solennità;
dopo ogni risposta si portava di nuovo le mani al petto e al capo e si inchinava
profondamente.
Wilhelm non si stancava di guardarla. I suoi occhi e il suo cuore furono
irresistibilmente attratti dalla condizione misteriosa di quella creatura. Le
dava dai dodici ai tredici anni; il suo corpo era ben costruito, solo che le
membra promettevano un più forte sviluppo o ne annunziavano uno rimasto
indietro. I suoi lineamenti non erano regolari ma piacenti: la fronte piena di
mistero, il naso straordinariamente bello, e la bocca, sebbene sembrasse, per
l'età della ragazza, troppo chiusa e contraesse le labbra, era pur sempre
sincera e graziosa. I colori bruni della faccia si potevano appena riconoscere
per il belletto. Questa figura fece a Wilhelm una profonda impressione: egli
seguitò a guardarla, in silenzio, e dimenticò, nelle sue osservazioni, i
presenti; Filina lo destò dal suo dormiveglia, mentre dava alcuni dei dolci
rimasti alla bimba e le faceva cenno di allontanarsi. Ella fece ancora una volta
il suo inchino e scappò come un fulmine fuor della porta.
Si fece un po’ tardi. I saltimbanchi avevan già cominciato a produrre le loro
arti. Sulla piazza si eran radunati molti spettatori, ma quando vi discesero i
nostri amici si accorsero di un gran scompiglio che aveva attirato gran numero
di gente verso la porta dell'albergo dove Wilhelm era alloggiato. Wilhelm corse
là per vedere cosa succedesse, e mentre si spingeva fra la folla vide con
orrore il padrone della compagnia dei saltimbanchi, che si sforzava di
trascinare per i capelli fuori della casa la bimba che l'aveva interessato, e
senza pietà le batteva il piccolo corpo col manico della frusta.
Wilhelm corse, come un fulmine, su quell'uomo e lo afferrò per il petto. -
Lasci star la bimba! - gridò come un forsennato - o uno di noi due resta qui
sul posto. - E così dicendo afferrò per la gola l'omaccio con quella forza che
solo l'ira può dare, si che questi credè di soffocare, lasciò la bimba, e
cercò di difendersi contro il suo assalitore. Alcuni, che avevan si compassione
della bimba, ma non ardivano cominciare una lite, si scagliarono subito alle
braccia del saltatore, lo disarma rono e lo minacciarono con invettive. Questi,
ridotto ormai solo alle armi della bocca, cominciò terribilmente a minacciare e
a imprecare contro quella creatura pigra e disattenta che non voleva eseguire il
suo compito: si rifiutava di ballare la danza delle uova, ch’egli aveva
promesso al pubblico, voleva perciò, batterla a morte e nessuno glielo doveva
impedire. E si sforzava di liberarsi per ricercare la bimba che s'era appiattata
dietro la folla. Wilhelm lo trattenne e gli gridò: - Tu non devi rivedere né
toccare questa creatura prima che tu non abbia dato conto dinanzi alla giustizia
dove tu l'hai rubata. Io ti spingerò agli estremi; tu non mi sfuggirai - Questo
discorso che Wilhelm nel calore aveva pronunziato, senza pensiero e senza
intenzione, per un oscuro sentimento, o, se si vuole, per ispirazione, calmò
finalmente l'uomo furente. Egli gridò: - Cosa ho da farmene io di codesta
creatura disutile? Mi paghi quel che mi costano i suoi vestiti, e se la può
tenere: questa sera stessa ci metteremo d'accordo. - Si affrettò quindi a
proseguire la rappresentazione interrotta e a quietare l'impazienza del pubblico
con qualche bell'esercizio.
Wilhelm, acquetatosi, ricercava intanto la bimba, che non si poteva trovare in
nessun luogo. Alcuni volevan averla vista in soffitta, altri sui tetti delle
vicine case. Dopo che si furon fatte ricerche da per tutto, si dovettero calmare
e attendere che la bimba volesse ritornare da sé.
Frattanto Narciso era venuto a casa e Wilhelm gli domandò della storia e della
provenienza della bimba. Ma questi non ne sapeva niente, poiché era nella
compagnia solo da poco.
Si conchiuse poi il contratto con l’impresario riguardo alla bimba, che fu
rilasciata al nostro amico per trenta talleri, di fronte ai quali il focoso
italiano dalla barba nera rinunciò completamente ai suoi diritti; della venuta
della bimba non volle però dir altro se non che egli l'aveva presa con sé dopo
la morte di suo fratello, che, per la sua straordinaria abilità, era chiamato
il gran diavolo.
La mattina di poi passò nella ricerca della bambina. Invano si frugò in tutti
i cantucci della casa e del vicinato: era sparita e si temè che fosse saltata
in acqua o si fosse fatta male in qualche altro modo. Wilhelm passò una triste
giornata. Anche la sera, quando i saltatori e i ballerini dispiegarono tutte le
loro forze per prender congedo nel miglior modo dal pubblico, l'anima sua non
poteva esser rasserenata e distratta.
Il giorno dopo, quando con gran chiasso i saltimbanchi se ne furono andati, si
ritrovò subito Mignon che si appressò, mentre Wilhelm e Laerte continuavano
nella sala i loro esercizi di scherma . - Dove ti sei nascosta? - le chiese
Wilhelm affabilmente; - ci hai tenuto molto in pensiero. - La bimba non rispose
nulla e lo guardò. - Tu sei nostra, ora - disse Laerte - noi ti abbiamo
comprata. - Che cosa hai pagato? - chiese la bimba, asciutta. - Cento ducati -
rispose Laerte; - se tu ce le rendi, puoi essere libera. - È molto? ‑
domandò la bimba. - Oh sì, ma, basta che tu ti porti bene. - Voglio servirvi -
rispose.
Da questo momento fece grande attenzione ai servizi che il cameriere prestava ai
due amici, e già il giorno dopo non volle più ch’egli entrasse nella stanza.
Voleva far tutto lei; sebbene facesse le sue faccende assai lentamente e talora
con un certa inabilità, pure le compiva con precisione e con molta cura.
Si fermava spesso innanzi a un bacino d'acqua e si lavava il viso con gran
premura e con forza, sì da scorticarsi quasi le guance, finché Laerte con
domande e con motteggi seppe ch’ella voleva a ogni costo levarsi il belletto
dalle guance e, per lo zelo con cui lo faceva, credeva belletto ostinato quel
rossore che strofinandosi s'era prodotto. Glielo spiegarono e allora, lasciò
andare e, ritornata calma, mostrò un bel volto di color bruno, sebbene
ravvivato solo da un poco di rosso delle guance. Allettato dalla misteriosa
presenza della bimba, Wilhelm passò alcuni giorni in questa strana compagnia e
giustificandosi dinanzi a se stesso con un assiduo esercizio di scherma e di
danza, per cui non credeva che avrebbe ritrovato così facilmente l'occasione.
Wilhelm pensò che non avrebbe dovuto trattenersi là così a lungo; si scusò e
volle prendere le disposizioni per proseguire il viaggio.
Intanto la figura e la natura di Mignon gli eran divenute sempre più gradite.
In tutto quel che faceva la bimba c'era qualcosa di straordinario. Non saliva o
scendeva le scale, ma andava saltellando. Montava su per le ringhiere dei
ballatoi e prima che ci si potesse accorgere, era seduta sopra un armadio e
stava lì a riposarsi. Wilhelm s'era anche accorto che, per ognuno, ella aveva
uno speciale modo di salutare. Lui lo salutava con le braccia incrociate sul
retto. Alcuni giorni se ne stava zitta zitta e a volte rispondeva più
diffusamente a diverse domande: sempre stranamente, ma così che non si potesse
distinguere se era spirito o ignoranza della lingua, poiché parlava un tedesco
spezzato e frammisto di francese e italiano. Nel suo servizio era instancabile e
la mattina era su col sole: invece scompariva per tempo la sera e dormiva in una
camera sulla terra nuda, e non si poteva convincerla per nulla ad accettare un
letto o un saccone di paglia. Wilhelm la trovava spesso che si lavava. Anche i
suoi abiti erano puliti, sebbene tutto fosse rammendato due e anche tre volte.
Si disse anche a Wilhelm che ogni mattina, molto presto, ella andava alla messa,
dov’egli la seguì una mattina e la poté vedere in un angolo della chiesa,
inginocchiata, con la corona, che pregava devotamente. Mignon non si accorse di
lui: egli ritornò a casa facendo mille riflessioni su questa creatura e non
potendo pensare di lei nulla di preciso.
- Vai, Mignon, - disse Felina - e - procuraci quel che abbiamo bisogno: dillo al
cameriere e aiuta a servire. -
Mignon si fece dinnanzi a Wilhelm e, nel suo modo laconico, chiese: Devo? posso?
- E Wilhelm rispose: - Fai, bimba mia, quel che dice Mademoiselle. –
La bimba provvide a tutto e servì tutto il giorno gli ospiti con la più gran
cura. Dopo pranzo, Wilhelm cercò di fare una passeggiata da solo e gli riuscì
lasciare l'amichevole compagnia.
Mignon lo aveva aspettato e gli fece luce per le scale. Quando ebbe posato il
lume, lo pregò di permetterle di fare quella sera un esercizio. Più volentieri
egli avrebbe rifiutato, tanto più che non sapeva di che cosa si trattasse. Ma a
quella buona creatura non poteva nulla rifiutare. Dopo breve tempo ella rientrò.
Portava sotto il braccio un tappeto che distese a terra. Wilhelm la lasciò
fare. Ella vi portò sopra quattro candele, mettendone una ad ogni angolo del
tappeto. Un cestino con delle uova, che andò a prendere, rese più palese
l'intenzione. A passi misurati con arte, camminava avanti e indietro sul tappeto
disponendo le uova a diverse distanze: poi chiamò dentro un uomo che aspettava
in casa e sapeva suonare il violino. Egli si mise in un angolo col suo
strumento; Mignon si bendò gli occhi, fece un cenno, e, come una macchina
caricata, insieme con la musica, cominciò tosto i suoi movimenti, accompagnando
la cadenza e la melodia col batter delle nacchere.
Agile, leggera, pronta, precisa eseguiva la danza. Ella passava così rapida e
sicura fra le uova, che ad ogni momento pareva avesse da romperne uno, o, nelle
veloci giravolte, lanciarne via un'altro. Per nulla! non ne toccava alcuno
quantunque passasse attraverso le file delle uova con salti, ed alla fine quasi
inginocchiata. Senza riposo, come un orologio, correva la sua via, e la strana
musica dava, ad ogni ripresa, un nuovo slancio alla danza sempre ripetentesi e
impetuosa. Wilhelm fu tutto preso dallo straordinario spettacolo; dimenticò
tutti i suoi pensieri, seguì ogni movimento della cara creatura ed era ammirato
come in questa danza si sviluppasse meravigliosamente il suo carattere.
Ella si mostrava severa, aspra, fredda, viva e in molte posizioni più solenne
che piacevole. Egli sentì in questo momento d'un tratto quel che già provava
per Mignon. Desiderò di adottare nel suo cuore quest'essere abbandonato al
posto d’un figlio, di prenderla nelle sue braccia e coll'amore di un padre
ridestare in sé la gioia della vita.
La danza finì: ella fece ruzzolare le uova coi piedi, le radunò in un
mucchietto, senza lasciarme fuori nessuno, e senza romperne punti, ci si sedette
vicino togliendosi la benda dagli occhi e terminando con un inchino l'esercizio.
Wilhelm la ringraziò di avergli mostrato con un'improvvisata così gentile la
danza, che desiderava di vedere. La carezzò e gli rincrebbe che ella avesse
sudato per lui. Le promise un vestito nuovo, ed ella rispose vivamente: - Il tuo
colore! - Anche questo le promise, sebbene non sapesse chiaramente quel
ch’ella intendeva con questo. Raccolse le uova, prese il tappeto sotto il
braccio, domandò se egli aveva altro da comandare e sparì dalla porta.
D’un tratto entrò l'oste e annunciò un suonatore di arpa. - Si divertiranno
molto - disse - alla musica e al canto di quest'uomo; nessuno di quelli che
l'ascoltano può trattenersi dall'ammirarlo e dall'offrirgli qualcosa. –
La figura di questo strano ospite mise in istupore tutta la compagnia. Egli si
era già impossessato di una seggiola, prima che qualcuno avesse cuore di
domandare o di offrirli qualche cosa. Il suo cranio calvo era circondato tutto
attorno da pochi capelli grigi, grandi occhi azzurri lucevano dolcemente sotto
folte sopracciglia bianche. Al naso ben fatto si ricongiungeva una lunga barba
bianca, senza coprire labbra piacenti, e una veste marrone scuro avvolgeva dal
collo ai riedi il suo gracile corpo. Egli cominciò intanto a far preludi
sull'arpa che si era messa dinanzi. I bei suoni che traeva dall'istrumento
rallegraron presto la compagnia.
- Voi sapete anche cantare, buon vecchio - disse Filina. - Dateci qualcosa che
allieti insieme coi sensi il cuore e lo spirito - disse Wilhelm. – Lo
strumento dovrebbe solo accompagnare la voce; poiché melodie passaggi e fughe
senza parole e senso, mi pare che somiglino a farfalle o a begli uccelli
variopinti che volan nell'aria innanzi ai nostri occhi, e che noi cerchiamo di
afferrare e desidereremmo di possedere; mentre il canto, come un genio, si eleva
verso il cielo, e eccita a accompagnarlo la parte migliore del nostro io. -
Il vecchio guardò Wilhelm, poi in alto; fece alcuni accordi sull’arpa e
cominciò la sua canzone. Essa conteneva una lode del canto, esaltava la felicità
dei cantori ed esortava gli uomini ad onorarli. Con tanta vita e verità
espresse la canzone, da parere che l’avesse poetata in quel momento e in
quell'occasione, Wilhelm si tratterme appena dal gettarglisi al collo; solo il
timore di eccitare una forte risata lo trattenne sulla seggiola; poiché gli
altri facevano già a mezza voce alcune sciocche osservazioni e si disputavano
se il cantore fosse un prete o un ebreo.
Quando gli chiesero dell'autore, del canto, non dette alcuna risposta decisa;
soltanto rassicurò, di esser ricco di canzoni e di desiderare solo che potesser
piacere. La maggior parte della società era lieta e allegra, anzi lo stesso
Melina, a modo suo, si era fatto più aperto, e mentre si chiacchierava e si
scherzava, il vecchio cominciò a cantare con la più alta ispirazione la lode
della vita socievole.
Con toni delicati esaltò l'unità e la socievolezza. D'un tratto il canto si
fece asciutto, aspro e confuso quando rimpianse l'odiosità della vita
solitaria, l’inimicizia bestiale e la discordia pericolosa, ed ogni anima
rigettò queste incomode catene, quand’egli, portato sulle ali di una
penetrante melodia, celebrò i fondatori della pace e cantò la felicità delle
anime che si ritrovano.
Egli aveva appena finito, che Wilhelm esclamò: - Chiunque tu sia, che vieni a
noi, spirito protettore ricco di canti, con una voce che benedice e che anima,
abiti la mia ammirazione ed il mio ringraziamento. Tu senti come noi tutti ti
ammiriamo; confidaci se ti occorre qualcosa! -
Il vecchio tacque, fece prima passare leggere le dita sulle corde, poi le scosse
più forte e cantò:
(Che odo mai fuor della porta, che odo risuonar sul ponte? fate che il canto
echeggi al nostro orecchio dentro la sala! Il re par1ò, il paggio accorse;
venne il ragazzo, il re esclamò: - Conduci dentro il vecchio. - Salute a voi
forti signori! Salute a voi, mie belle dame! Che ricco cielo! Stella con stella!
Chi mai sa tutti i vostri nomi? Dentro la sala piena di pompa e magnificenza
occhi chiudetevi: qui non è tempo di dilettarsi di meraviglie. - Il cantore
chiuse gli occhi ed arpeggiò a pieni suoni; il cavaliere riguardò commosso, e
in grembo suo la bella; il re cui piacque la canzone in premio dei suoi suoni
gli fece portare una catena d'oro.
Non dare a me questa catena d'oro, dà la catena ai cavalieri, poiché al loro
sguardo ardito si schiantano le lance dei nemici. Dalla a questo cancelliere che
hai, e fa che porti ancor dell'oro il peso oltre ai suoi altri pesi. –
- Io canto come pur canta l'uccello che abita fra i rami. Il canto ch’esce in
forza dalla gola è il ricco premio. Pure se posso chiedere, solo chiedo: fate
portare un sorso del migliore vino dentro a un vetro risplendente.
Prese il bicchiere e lo vuotò: - O coppa di dolci delizie! O casa tre volte
beata dove tu sei solo piccolo dono! Or vivetevi bene e ripensate a me, e
ringraziate Iddio così com’io ringrazio voi per questo dono).
Quando il cantore, terminata la canzone, prese in mano un bicchiere di vino, che
gli avevano versato e messo lì presso, e col volto sereno bevve volgendosi
verso i suoi benefattori, sorse nella riunione una generale gioia. Si batterono
le mani e gli si gridò di bere il bicchiere alla sua salute e al rinvigorimento
delle sue vecchie membra. Egli cantò ancora alcune romanze suscitando nella
compagnia sempre maggior gioia.
Wilhelm andò nella sua stanza e trovò Mignon occupata a scrivere. La bimba da
qualche tempo scriveva con gran diligenza tutto quel che sapeva a memoria, rer
darlo poi a correggere al suo padrone e amico. Era instancabile e capiva presto;
solo le lettere erano ineguali e le righe storte. Anche in questo pareva che il
suo spirito corrispondesse al suo corpo. Wilhelm cui l’attenzione della bimba
dava grande gioia quando era tranquillio, fece poca attenzione questa volta a
quel che gli mostrava; ella lo capì e si addolorò tanto più perché credeva
che questa volta di avere fatto molto bene.
Nella molesta inquietudine in cui si trovava, gli venne in mente di ricercare il
vecchio, con la cui arpa sperava di disperdere i cattivi spiriti. Quando domandò
di quest'uomo, gli si accennò un brutto albergo in un cantuccio lontano della
cittadina, ed in questo, su per le scale fino alla soffitta, dove da una camera
gli echeggiò incontro un dolce suono d'arpa. Erano melodie commoventi,
lamentose, accompagnate da un canto triste e angoscioso. Wilhelm si avvicinò
alla porta e siccome il buon vecchio suonava una specie di fantasia e ripeteva
sempre, ora cantando, ora recitando, alcune strofe, l'ascoltatore, dopo breve
tempo, poté intendere presso a poco quel che segue:
(Chi non mangiò con lagrime il suo pane, chi non passò le angosciose notti
piangendo nel suo letto, non vi conosce o potestà celesti. Lungo la vita voi ci
conducete, il misero per voi divien colpevole, poi lo lasciate con la sua pena;
poiché ogni colpa si sconta sulla terra).
Il lamento triste e sincero penetrò profondo nell'anima dell'ascoltatore. Gli
pareva che qualche volta il vecchio fosse impedito dalle lagrime di proseguire;
allora risuonavan solo le corde, sin che ad esse si mischiava di nuovo con rotte
parole, piano, la voce. Wilhelm stava ritto presso lo stipite, l'anima sua era
profondamente commossa, la tristezza dello sconosciuto dischiuse il suo cuore
oppresso; non si oppose alla simpatia e non poté e non volle trattenere le
lacrime che il tenero lamento del vecchio attiro alla fine anche dai suoi occhi.
Nello stesso tempo si sciolsero tutti i dolori che opprimevano la sua anima: si
dette tutto a loro e spinse la porta della camera; si fermò dinanzi al vecchio,
costretto a sedersi su un misero letto, l'unico mobile, l'unico mobile della
povera abitazione.
- Quali sentimenti hai risvegliato in me, buon vecchio! - egli disse - tutto
quello che ristagnava nel mio cuore, tu l'hai liberato: non ti scomodare ma
prosegui a far felice un amico, mentre mitighi i tuoi dolori. Il vecchio si
voleva rizzare e dire qualcosa, ma Wilhelm glielo impedì: poiché, il giorno,
si era accorto che il vecchio non parlava volentieri; e si sedè invece presso
di lui, sul saccone di paglia.
Il vecchio si asciugò le lagrime e chiese con un sorriso amichevole: - Come è
che viene qui? Io volevo stasera rifare il giro. -
- Qui siamo più tranquilli - rispose Wilhelm - cantami quel che vuoi, quel che
si adatta al tuo stato d'animo e fa come s'io non fossi qui. Mi pare che oggi tu
non possa sbagliare. Penso come tu sei felice di poterti occupare e dilettare
così piacevolmente nella solitudine, e siccome tu sei ovunque uno straniero,
puoi trovare nel tuo cuore la migliore compagnia. -
Il vecchio guardò le sue corde, e dopo aver preludiato dolcemente, intonò e
cantò:
(Chi si abbandona alla solitudine, ah! quegli presto è solo; ognuno vive,
ognuno ama e lo lascia alla sua pena. Ah si! lasciatemi al mio tormento! E se
pure una volta posso esser davvero solo, allora non sono solo. Spiando, attento,
scivola un amante: forse la sua amica è sola? Così s'insinua giorno e notte
sopra me solitario la pena, sopra me solitario il tormento. Ah, sol ch'io sia
una volta solo nella mia tomba, e allora sarò solo!).
Noi ci potremmo dilungare anche troppo, e tuttavia non arriveremmo mai ad
esprimere la grazia, della strana conversazione del nostro amico con
l’avventuriero. A tutto quello che il giovane gli diceva, il vecchio
rispondeva con la più pura corrispondenza, per mezzo di accordi che suscitavano
mille sensazioni affini e aprivano un gran infinito alla fantasia.
Chi abbia vissuto vicino a una riunione di uomini pii che, disgiunti dalla
chiesa, credono di edificarsi più puri, più cordiali, più ispirati, si potrà
anche fare un'idea della scena presente: si ricorderà come il cantore liturgico
sappia adattare alle sue parole il verso di un canto, che eleva l'anima là dove
l'oratore vuole che essa prenda il suo volo; e come, subito dopo, un altro della
riunione, in altra melodia aggiunga a quel verso il verso di un altro canto, e a
questo un terzo ne riannodi un terzo, per cui vengono suscitate le idee affini
dei canti da cui essi sono tolti; ma, ogni passo diviene nuovo e individuale per
il nuovo congiungimento, come se fosse inventato nel momento: e così da un noto
cerchio di idee, da noti canti e sentenze, sorge per questa speciale compagnia,
in codesto dato momento, un tutto proprio, dal cui godimento essa è animata e
riceve forza e conforto. Così il vecchio edificava il suo ospite mentre con
canti e passi noti e ignoti, portava in circolazione sentimenti prossimi e
lontani, e sensazioni deste e sopite, grate e dolorose, per cui, nello stato
presente del nostro amico, c'era da sperare meglio.
Wilhelm si affrettò alla sua stanza dove mille spiacevoli pensieri lo
oppressero. Si ricordò del tempo in cui il suo spirito era innalzato da un
ardore illimitato e ricco di speranza. Gli appariva chiaro d'esser ormai caduto
in un ozio senza scopo che gli permetteva di gustare solo a sorsi quel che prima
aveva succhiato con tutte le forze: ma non poteva veder chiaro quale invincibile
bisogno la natura gli aveva imposto come legge, e come questo bisogno,
esasperato soltanto dalle circostanze, veniva in parte soddisfatto, in parte
traviato.
Perciò nessuno si deve meravigliare che, considerando il suo stato e cercando a
pensarsene fuori, egli cadesse nella più gran confusione. Non bastava ch’egli
fosse stato trattenuto più a lungo dal bisogno, dalla sua amicizia per Laerte,
dalla sua simpatia per Filina, dal suo interesse per Mignon in un luogo e in una
società ove poteva nutrire la sua inclinazione prediletta, quietare
furtivamente i suoi desideri e, insieme, trascinarsi dietro i suoi antichi
sogni, senza proporsi uno scopo preciso. Credette di aver forza abbastanza per
liberarsi da codesti rapporti e staccarsene subito. - Devo andar via. - esclamò
- voglio andar via! - E si lasciò andare su una seggiola, assai commosso.
Mignon entrò e chiese se doveva fargli i ricci. Ella veniva silenziosa, ed era
profondamente addolorata per aver intuito che Wilhelm volesse separarsi anche da
lei.
Nulla è più commovente di un amore, nutrito in silenzio, di una fede, fatta
nel segreto più salda, che finalmente, nell'ora propizia, s'avvicina a quello
che sinora non ne era stato degno, e gli si palesa. Il boccio a lungo e a forza
rimasto chiuso, era maturo e il cuore di Wilhelm non poteva esser più
sensibile. Ella gli si fermò dinanzi e vide il suo turbamento. - Signore! -
esclamò - se tu sei infelice, che ne sarà di Mignon? - Cara creatura, diss’egli,
prendendole le mani, anche tu sei fra i miei dolori. Devo andarmene. - Ella lo
guardò negli occhi, che brillavano di lagrime trattenute, e gli si inginocchiò
con impeto dinanzi. Wilhelm le trattenne le mani, Mignon posò la testa sulle
sue ginocchia e restò silenziosa. Egli giocava coi suoi capelli ed era lieto.
Ella restò a lungo ferma. Alla fine Wilhelm sentì in lei una specie di
sussulto che cominciò pian piano e, crescendo, si propagò a tutte le membra. -
Che hai Mignon? che hai? - Alzò verso di lui la sua testina, lo guardò negli
occhi, portò ad un tratto una mano al cuore, come chi reprime uno spasimo.
Wilhelm la rialzò ed ella gli cadde sulle ginocchia; la strinse a sé e la baciò.
Non rispose con alcuna pressione di mano, con alcun movimento. Si premeva il
cuore, e ad un tratto mandò un grido, accompagnato da moti convulsi del corpo.
Si alzò e tosto gli ricadde dinanzi, come spezzata in tutte le membra. Era uno
spettacolo orribile! - Bimba mia! - gridò Wilhelm, sollevandola e bracciandola
stretta - bimba mia che hai? - La convulsione seguitava e si comunicava dal
cuore alle altre membra che si agitavano: ella pendeva solo dalle sue braccia.
Wilhelm la stringeva al cuore e la bagnava delle sue lagrime. D'un tratto parve
irrigidirsi come uno che sopporta un forte dolore fisico; e tosto con un nuovo
impeto riebbero vita tutte le sue membra, gli si gettò al collo come una molla
che scatta, mentre nel suo interno avveniva come un potente strappo e nel
momento stesso le sgorgava dagli occhi chiusi sul petto di lui un torrente di
lagrime. Wilhelm la teneva stretta. Ella piangeva e nessuna lingua può
esprimere la forza di quelle lagrime. I lunghi capelli si eran disciolti e
pendevano giù dalla fanciulla, e tutto il suo essere pareva fondersi
irresistibilmente in quel flutto di lagrime. Le sue membra irrigidite si
rifecero morbide, tutto il suo intimo si riversò, e nello smarrimento del
momento, Wilhelm temette che gli si dissolvesse nelle braccia, che non gli
restasse più nulla di lei. E la teneva più stretta, ancora più stretta. -
Bimba mia - esclamò - bimba mia! Si, tu sei mia! se questa parola ti può
consolare. Tu sei mia. Io ti voglio tenere per me, non ti voglio lasciare! - Le
sue lagrime scorrevano ancora.
Finalmente si rialzò. Una dolce serenità le splendeva nel volto - Padre mio! -
disse - tu non mi vuoi abbandonare! Tu sarai il mio babbo! Io sono la tua bimba.
-
Dolcemente cominciò l’arpa a suonare innanzi alla porta; il vecchio portava i
suoi canti più affettuosi, come sacrificio della sera, all'amico che, tenendo
sempre più stretta la bimba fra le braccia, godeva della più pura e più
indicibile gioia.
(Conosci tu la terra dove i cedri fioriscono, e fra le foglie oscure fulgono le
arance d'oro? Un vento lieve alita nel cielo azzurro; placido il mirto e gioisce
l'alloro. Di' la conosci tu? Laggiù laggiù andar con te o amato mio, vorrei!
Conosci tu la casa? Posa sopra colonne il tetto, splende la sala e le stanze
sono abbaglianti; statue di marmo s’ergono lì e mi guardano: - Povera bimba,
cosa t'ha fatto? Di' la conosci tu? Laggiù! laggiù, andar con te, o guida mia,
vorrei! Conosci il monte tu, e il sentier tra le nuvole? Cerca il mulo la strada
nella nebbia, e nidi d'antichi draghi nelle grotte s’ascondono; precipita la
roccia e sovr’essa i flutti. Di' lo conosci tu? Laggiù! laggiù la nostra
strada va; o padre fa' che andiamo.)
Quando la mattina Wilhelm cerco Mignon per la casa, non la trovò, ma sentì
ch’era già uscita. Passata qualche ora egli udì della musica davanti la
porta. Dapprima credette che il suonatore d'arpa fosse già di ritorno; ma
presto distinse il suono di una cetra, e la voce che incominciò a cantare era
la voce di Mignon. Wilhelm aprì la porta, la bimba entrò, e cantò la romanza
che abbiamo trascritto più su.
Specialmente la melodia e l'accento piacquero al nostro amico, sebbene non
potesse comprendere tutte le parole. Si fece ripetere e spiegare le strofe, le
trascrisse, e le tradusse in tedesco. Ma non poté che imitare l'originalità
delle frasi; la ingenuità infantile dell'espressione scompariva, dal momento
che la lingua, spezzata della bimba diveniva organica e quanto era stato detto
alla rinfusa prendeva connessione. Ed anche la squisitezza della melodia non
poteva essere uguagliata con nulla.
Ella incominciava ogni verso festosamente, con voce sonora, come volesse
richiamare l'attenzione su qualche cosa di straordinario, come volesse dire
qualche cosa d'importante. Al terzo verso il canto diveniva più fosco e cupo;
“Di’ lo conosci tu” ella lo esprimeva assorta e piena di mistero; nel
“laggiù! laggiù” c'era un'irresistibile malinconia; e ad ogni ripetizione
sapeva modificare talmente il suo “fa' che andiamo”, che ora era
supplichevole e stringente, ora incalzante e pieno di promesse.
Quand'ella ebbe cantato per la seconda volta la sua canzone, stette un momento
assorta, guardò Wilhelm intensamente e domandò: - Lo conosci tu il paese? -
Bisogna ben credere che sia l'Italia - rispose Wilhelm; dove hai imparato questa
canzoncina? - L'Italia! disse con intenzione Mignon; se vai in Italia, portami
con te, qui ho freddo! - Ci sei di già stata, cara piccola? - domando Wilhelm.
- La bimba stette zitta, e Wilhelm non poté più cavarle una parola. La cetra
faceva parte del guardaroba dei teatranti. Mignon l'aveva chiesta quella mattina
e l'artista l'aveva subito messo in ordine. In questa circostanza la bimba
dimostrò un talento che fin allora nessuno sapeva che avesse.
Quando la compagnia uscì all'aria libera, quasi tutti s'accorsero che per
quella sera avevan gustato un po' troppo del buon vino. Senza prender congedo si
spersero uno di qua e uno di là.
Appena Wilhelm fu nella sua stanza, gettò via i vestiti e spento il lume si
buttò sul letto. Il sonno voleva impossessarsi subito di lui; ma un fruscio,
che gli parve venire nella sua stanza di dietro la stufa, lo rese attento. In
quella si presentò davanti la sua fantasia accesa, l'immagine del re armato
(prodottosi sulla scena); egli si rizzò per parlare al fantasma, quando si sentì
circondato da due tenere braccia, la bocca chiusa da baci impetuosi, e premersi
contro il suo petto che egli non ebbe il coraggio di respingere.
La mattina dono Wilhelm si svegliò con un senso di malessere, e trovò il letto
vuoto. Aveva ancora il cervello annebbiato per l’ubriacatura non completamente
svanita ed il ricordo della misteriosa visita notturna lo rese inquieto. Il suo
primo sospetto cadde su Filina, eppure gli pareva che quel corpo amabile
ch’egli aveva stretto fra le braccia, non fosse il suo. Fra carezze impetuose
il nostro amico si era addormentato allato della singolare visitatrice, ed
oramai non se ne poteva scoprire più nemmeno una traccia. Balzò su, e
vestendosi trovò la porta, che egli di solito chiudeva a chiavistello, solo
socchiusa, e non poté rammentarsi se la sera prima l’aveva chiusa o no.
In quel momento entrò Mignon e gli recò la colazione. Wilhelm stupì
all'aspetto della bambina, anzi, si può dire, si spaventò. Pareva che ella
fosse divenuta più grande; si fermò con un alto e nobile atteggiamento davanti
a lui e lo guardò negli occhi così seria, ch’egli non poté sopportare lo
sguardo. Ella non lo toccò, come di solito, quando gli stringeva la mano e gli
baciava la guancia, la bocca, un braccio o una spalla, ma dopo aver disposto in
buon ordine le sue cose, riuscì silenziosa.
Venne l'ora stabilita per una prova di lettura; si adunarono, che tutti erano
pesti per la festa del giorno prima. Alla sera provarono in fretta qua e là e
quando, abbastanza tardi, si separarono, Filina congedandosi sussurrò a
Wilhelm: - Devo venir a prendere le mie pantofole; certo che tu non tiri il
chiavistello? - Quando fu nella stanza queste parole lo tennero in grande
imbarazzo; poiché la supposizione che l'ospite della notte prima fosse Filina
era così rinforzata; ed anche noi siamo costretti ad attenerci a questa
opinione. Egli andò inquieto parecchie volte su e giù per la stanza:
effettivamente non aveva ancora tirato il paletto.
D’un tratto Mignon si precipitò dalla porta, gli si aggrappò addosso e gridò:
- Meister! salva la casa! brucia! - Wilhelm balzò fuori dalla porta, ed un fumo
denso si spinse contro di lui giù dalla scala. Si sentiva di già in istrada
che gridavano: Al fuoco! L'arpista veniva giù per le scale, soffocato dal fumo,
col suo strumento in mano. Aurelia si precipitò dalla sua stanza e gettò il
piccolo Felice, che aveva con sé, fra le braccia di Wilhelm. - Salvi il
piccino! – ella gridò - noi ci occuperemo degli altri ! –
Wilhelm che non credeva tanto grave il pericolo, pensò da prima, di spingersi
verso l’origine dell'incendio con la speranza di spegnerlo nel suo principio.
Consegnò il fanciullo al vecchio, e gli ordinò di correre giù per la scala di
pietra a chiocciola che conduceva al giardino traverso una piccola volta e di
restare all'aperto coi ragazzi. Mignon prese una candela, per fargli lume.
Wilhelm pregò ancora Aurelia di salvare le sue cose per la stessa strada. Poi
corse attraverso il fumo, ma si espose invano al pericolo. Pareva che la fiamma
incalzasse dalla casa vicina: aveva già preso i corpi in legno della soffitta e
una scala volante; altri, ch’erano accorsi in aiuto, soffrivano come lui del
fumo e per il fuoco. Pure egli ispirò coraggio e gridò che si portasse
dell'acqua.
In quel momento Mignon corse su, e gridò: - Meister! Salva Felice; il vecchio
è impazzito, il vecchio lo uccide! – Wilhelm saltò, senza essersi ancora
raccapezzato giù dalla scala, e Mignon gli corse dietro alle calcagna.
Egli si fermò terrorizzato, sugli ultimi gradini che conducevano nella serra.
Grandi fasci di paglia e di canne, ammucchiati in quel posto, ardevano con
chiara fiamma, Felice giaceva a terra e urlava; il vecchio, col capo inclinato,
stava appoggiato sulla parete di fianco. - Che fai, sciagurato? - gridò
Wilhelm. Il vecchio tacque; Mignon aveva sollevato Felice e a fatica lo
trascinava nel giardino, mentre Wilhelm cercava di disperdere e di soffocare il
fuoco; ma con ciò aumentava solo la veemenza e la vivacità delle fiamme.
Infine dovette anch’egli fuggire nel giardino, con le ciglia e i capelli arsi,
trascinandosi dietro attraverso il fuoco il vecchio, che lo seguiva controvoglia
con la barba bruciata.
Wilhelm corse subito a cercare i bimbi in giardino. Li trovò sulla porta d'un
padiglione appartato, mentre Mignon faceva del suo meglio per calmare il
piccolo. Wilhelm lo prese in collo, lo interrogò, lo tastò, e non poté cavare
nulla di logico dalle labbra dei due ragazzi. Lo tastò su tutto il corpo, ma
non dette alcun segno di dolore; a poco a poco si quietò ed incominciò a
meravigliarsi guardando le fiamme, anzi a divertirsi per i bei travi e le
impalcature che ardevano in ordine, come in un'illuminazione. Strinse il
fanciullo contro il suo cuore con un senso tutto nuovo; volle abbracciare anche
Mignon, ma ella si sciolse dolcemente, gli prese la mano e la tenne stretta. -
Meister, - disse (ancora mai, prima di questa sera, ella l’aveva chiamato col
suo cognome perché prima usava chiamarlo Signore, e poi Padre) - Meister! noi
siamo scampati a un grande pericolo, poiché Felice stava per morire. –
Wilhelm seppe finalmente che l'arpista, appena arrivato nel portico, le aveva
strappato di mano la candela, e aveva dato fuoco alla paglia. Poi aveva deposto
a terra Felice, e stendendo una mano sul suo capo con strambe mosse, aveva
tirato fuori un coltello come se avesse voluto sacrificare il fanciullo. Mignon
gli era saltata addosso e strappato il coltello di mano; - aveva gridato e le
era accorso in aiuto uno della casa che cercava di salvare nel giardino alcuni
oggetti; ma nella confusione questi doveva essere corso subito via e aver
lasciati soli il vecchio e il bambino. Wilhelm era in pensiero per i suoi amici,
meno per le sue cose. Non si fidava di lasciar soli i ragazzi e vedeva il
disastro aumentare sempre più.
Passò alcune ore in uno stato angoscioso. Felice gli si era addormentato in
collo; Mignon gli stava vicino e gli stringeva sempre la mano. Finalmente i
soccorsi improvvisati misero argine al fuoco. Gli edifici incendiati crollarono,
sopravvenne il mattino, i bimbi incominciarono a tremar dal freddo e anche a
lui, col suo vestito leggero, la rugiada che cadeva, riusciva insopportabile.
Egli li condusse verso le rovine degli edifici crollati, e vicino al mucchio di
carboni e di cenere trovarono un calore molto gradito.
Il giorno sorgente portò a poco a poco insieme tutti gli amici e i conoscenti.
Tutti s’eran salvati, nessuno aveva perduto gran che e si ritrovò anche il
baule di Wilhelm.
Dal grande imbarazzo in cui Wilhelm si trovava per quel che fosse da fare per
l'infelice vecchio, che dava così chiari segni di pazzia, lo trasse Laerte
quella mattina stessa. Questi aveva veduto al caffè un uomo che qualche tempo
prima aveva sofferto di violentissimi attacchi di malinconia. L’avevano
affidato ad un parroco di campagna, che s'era fatto una speciale occupazione di
curare simile gente. Anche questa volta egli c'era riuscito; si trovava ancora
in città e la famiglia dell'uomo che aveva riacquistato la ragione, gli rendeva
grandi onori.
Wilhelm s'affrettò a cercare quest'uomo, gli confidò il caso, e si trovò
d'accordo ad affidargli il vecchio. La separazione addolorò profondamente
Wilhelm, e solo la speranza di rivederlo guarito, poté rendergliela
sopportabile.
Il fuoco aveva distrutto anche il piccolo guardaroba di Mignon, e quando
dovettero comprare qualche cosa di nuovo, Aurelia fece la proposta che smettesse
i calzoncini e si vestisse una buona volta da ragazza. – Niente affatto, no! -
e pretese con grande violenza il suo vecchio costume, tanto che infine dovettero
cedere .
.............................
Proprio in questo tempo cadde un lutto cittadino, per cui si fu costretti a
chiudere il teatro per qualche giorno. Wilhelm approfittò di questo frattempo
per visitare quel parroco da cui l'artista si trovava in cura. Lo trovò in
un'amena contrada, e la prima, cosa ch’egli incontrò nel cortile del parroco
fu il vecchio che impartiva una lezione ad un ragazzo sul suo strumento. Egli
mostrò gran gioia vedendo Wilhelm, si rizzò, gli tese la mano, e disse: - Vede
che sono ancora buono a qualche cosa in questo mondo. - Il parroco salutò
Wilhelm nella maniera più cordiale e gli raccontò che il vecchio stava già
proprio bene e che si aveva speranza di guarirlo completamente. - Io vo
lentamente all'opera; ma quando avrò potuto fargli smettere la barba e la
tunica, avrò guadagnato molto; perché nulla ci accosta di più alla pazzia che
staccarci dagli altri, e nulla rinsalda di più il retto intelletto, che vivere
nel senso comune di molti uomini. Purtroppo, quante cose ci sono nella nostra
educazione e nei nostri ordinamenti civili, con cui noi prepariamo noi stessi ed
i nostri figli alla pazzia!
Wilhelm tornò in città e dovette fare i preparativi per un nuovo viaggio che
sarebbe stato, questa volta, più lungo. Mignon che era presente, gli chiese se
viaggiava verso il sud o verso il nord; e quando ebbe da lui quest'ultima
risposta disse: - Allora, ti voglio aspettare qui. - Gli chiese il vezzo di
perle che appartenne a Marianna, ch’egli non poté negare alla cara creatura;
il fazzoletto da collo ella l'aveva di già. Il piccolo Felice era molto
contento durante i saluti, e quando gli chiese che cosa voleva che gli portasse,
rispose: - Senti! Portami un babbo. Mignon prese la mano del partente e
rizzandosi sulla punta dei piedi gli dette sulle labbra un bacio vivo e
cordiale, ma senza tenerezza, dicendogli: - Meister, non dimenticarci e ritorna
presto. -
E così noi lasciamo il nostro amico che fra mille pensieri e mille sentimenti
incomincia il suo viaggio, e notiamo qui ancora una poesia che Mignon aveva una
volta recitato con grande espressione e che noi fummo impediti di far conoscere
prima, per la rapidità di tanti e così strani avvenimenti:
(Non mi far parlar, lascia ch'io taccia poiché il segreto è per me un dovere;
io ti vorrei mostrar tutto l'animo mio ma non lo vuole il destino. A giusto
tempo, il corso del sole incalza la buia notte, che deve illuminarsi; e il duro
macigno spalanca il suo petto e non rifiuta alla terra le fonti profonde
nascoste. Ognuno cerca in seno all'amico la pace, e là può il petto
sciogliersi in lamenti; ma un giuramento suggella le mie labbra e solo un dio le
potrà dischiudere.)
Perduto nelle sue osservazioni, Wilhelm cavalcò avanti, lasciò il cavallo in
un albergo, e s'afrettò, non senza commozione, verso il castello.
Ur vecchio servo lo ricevé alla porta e con molta cortesia lo informò che gli
sarebbe stato assai difficile oggi farsi ricevere dal signore. Wilhelm si fece
più insistente, e alla fine il vecchio dovè cedere e annunziarlo. Ritornò e
introdusse Wilhelm, in una grande sala antica. Là pregò Wilhelm di aver
pazienza perché forse il padrone non sarebbe comparso per un certo tempo
ancora. Dopo qualche attesa, alla fine comparve da una delle porte laterali un
uomo di bella presenza in stivali e con un semplice soprabito. ‑ Cosa mi
porta di buono? disse con voce amichevole a Wilhelm - mi perdoni d'averla fatta
aspettare.
Non senza imbarazzo, Wilhelm gli tese il foglio di Aurelia e disse: - Reco le
parole di un'amica che Lei leggerà non senza commozione. –
Lotario prese la lettera e ritornò tosto nell'altra stanza. Wilhelm andò poi
fino alla soglia e voleva incominciare il suo discorso che in precedenza aveva
fissato in mente, quando una delle porte mascherate s'aperse e comparve un
abate. - Io ricevo il più singolare dispaccio del mondo - gli gridò incontro
Lotario, e proseguì, rivolto a Wilhelm: - Mi perdoni se in questo momento non
posso ulteriormente intrattenermi con Lei. Resti stanotte da noi! E Lei, abate,
prenda cura del nostro ospite, che nulla gli manchi. –
Con queste parole fece un inchino dinanzi a Wilhelm, e il prete prese per mano
il nostro amico che lo seguì senza opporsi. In silenzio, attraverso misteriosi
corridoi, giunsero a una bella camera. Il prete lo condusse dentro e ve lo lasciò
senza altre scuse. Poco dopo apparve un vispo ragazzo che si annunziò presso
Wilhelm come suo servitore e portò la cena.
Dopo si spogliò e sentì un irresistibile bisogno di dare aria al suo cuore,
lacrime spuntavano nei suoi occhi, né si poté riavere finché il sonno non lo
vinse.
L'indomani si destò e trovò la sua camera già illuminata dal chiaro sole.
Il ragazzo invitò Wilhelm per la colazione, questi trovò già l'abate in sala;
Lotario si disse, era uscito a cavallo; l'abate non era molto loquace, e pareva
piuttosto pensieroso; chiese della morte d'Aurelia e ascoltò con interesse il
racconto di Wilhelm.
Dopodiché la porta si aprì con violenza, una giovane ragazza entrò,
respingendo il vecchio servitore che le era venuto davanti. Corse dritta verso
l'abate, e afferratolo per il braccio, poté dal pianto metter fuori queste
poche parole: - Dov’è? Io so cosa accade! Voglio seguirlo! -
Si calmi, bimba mia, - disse con calma l'abate - venga nella Sua camera, deve
saper tutto: solo deve poter anche udire, se Le devo raccontare. - Le offrì il
braccio, con l’intenzione di portarla via. - Non andrò in camera mia - disse
-, ho saputo tutto, il colonnello lo ha sfidato, egli è uscito a cavallo per
trovarsi con il suo avversario e forse proprio in questo momento... - . Si sentì
venire una carrozza, ella spalancò la finestra: - Ecco lo portano/ È ferito,
se no verrebbe a cavallo. Lo portano! - Si precipitò fuori della porta e giù
per le scale. L'abate le corse dietro; Wilhelm li seguì e vide come la bella
s'incontrava con Lotario che saliva. Egli si appoggiava al suo compagno che
Wilhelm subito riconobbe per la sua antica conoscenza Jarno. Lotario parlò
all'inconsolabile ragazza con grande amore e cordialità, e appoggiandosi a lei,
salì lentamente le scale, salutò Wilhelm e fu condotto nel suo gabinetto.
Non molto dopo ne venne fuori Jarno e andò da Wilhelm: - Lei è predestinato,
come pare - disse - a trovare dovunque attori e teatri; siamo appunto ora presi
in un dramma che non è affatto allegro. -
- Io mi rallegro - disse Wilhelm - di ritrovarla in questo strano momento. Dica,
c’è pericolo? Il barone è ferito gravemente? - Non credo - rispose Jarno.
L'abate uscì dalla camera, fece cenno a Jarno di entrare al posto suo e disse a
Wilhelm: - Il barone La prega di restare qui ad accrescere per qualche giorno la
Sua compagnia e contribuire, in queste circostanze a intrattenerlo.
Da questo momento il nostro amico fu trattato in casa come se fosse stato della
famiglia. Qualche volta si leggeva al malato e Wilhelm adempiva con gioia a
questo piccolo servigio. Lidia, la ragazza, non si moveva dal letto, la sua cura
per il ferito assorbiva ogni altra attenzione; ma quel giorno Lotario era
distratto, e pregò che non si leggesse più.
Venne il medico, visitò il ferito e non parve affatto contento delle sue
condizioni. Ebbe poi luogo un lungo colloquio con Jarno, ma quando alla sera
vennero a tavola non lasciarono trapelare nulla. Il buon medico era quello
stesso che aveva in cura il suonatore d'arpa e Wilhelm lo salutò cordialmente e
s'informò sul conto del suo protetto. - Dovrebbero udirlo - disse il medico -
quando in ore confidenziali egli alleggerisce il suo cuore; io l'ho ascoltato
talora con la più grande commozione. Una sera che cantò una canzone sui suoi
capelli grigi sedevamo attorno a lui e piangevamo. Ma non ha scoperto nulla di
quello ch’egli chiama il suo delitto, - chiese Jarno - nulla della sua strana
condotta, del suo contegno durante l'incendio, della sua furia contro il bimbo?
- La sua fissazione maggiore è quella di credere di portare ovunque disgrazia,
e che gli sta dinanzi la morte per mezzo di un innocente ragazzo. Dapprima aveva
paura di Mignon, prima che sapesse ch’ella era una bimba; poi lo impauriva
Felice, e siccome, in tutta la sua miseria egli ama infinitamente la vita, da
questo sembra sia sorta la sua avversione contro il bambino. - Sono curioso di
leggere le sue canzoni - disse Jarno. - Gliene potrò dare qualcuna - disse il
medico Il figlio del pastore, il parroco, che è abituato a scrivere a memoria
le prediche di suo padre, ne ha notato qualche strofa, senza che il vecchio se
ne accorgesse, e ne ha rimesse insieme, un po' per volta, delle canzoni.
La mattina di poi Jarno andò da Wilhelm e gli disse: - Lei deve farci un
piacere; Lidia deve essere allontanata per un po’ di tempo: il suo violento
amore, la sua passione, impediscono la guarigione del barone. Le abbiamo fatto
credere che una buona amica sia qui nelle vicinanze e desidera vederla. Ella si
è lasciata convincere di andare da una comune conoscenza che abita soltanto due
ore da qua. Questa persona è informata e rimpiangerà che la signorina Teresa,
amica di Lidia, sia partita proprio in quel momento finché di luogo in luogo,
si trasporterà la ragazza, fino alla casa di Teresa ed ivi rimarrà finché
Lotario non sarà ristabilito.
- Mi da un incarico strano e difficile - rispose Wilhelm. –
Com’è penoso lo spettacolo di un amore fedele e dolorante! E io stesso devo
essere lo strumento di questo inganno? È la prima volta in vita mia che inganno
qualcuno in questa maniera. Io mi assumo l'incarico per il vivo desiderio di
facilitare la guarigione del Suo amico. - D'altra parte non L’attende una
piccola ricompensa – poiché conoscerà la signorina Teresa, una ragazza come
ce ne sono poche; ella fa vergogna a cento uomini per le doti del suo carattere
e per le sue capacità, realizzatrici. -
La carrozza stava davanti la porta, Lidia esitava un po' a
montare. Delle lagrime erano nei suoi occhi quando, partendo, si voltò ancora
una volta. Si voltò verso Wilhelm e, contenendosi, disse: - Lei conoscerà
Teresa, una persona molto interessante. Mi fa meraviglia che venga da queste
parti; poiché Lei saprà che essa e il barone si amavano vivamente. Nonostante
la distanza, Lotario era spesso da lei; io allora ero spesso insieme a loro e
pareva che dovessero vivere l'uno per l'altro. Ma ad un tratto tutto andò a
monte, senza che nessuno potesse capire il perché. Egli mi aveva conosciuto ed
io nascondevo appena la mia simpatia per lui e nemmeno lo respinsi quando ad un
tratto sembrò preferirmi a Teresa. Ella si comportò verso di me come non avrei
potuto desiderare meglio, sebbene potesse quasi sembrare ch'io le avessi rubato
un così degno amico. Ma quante lacrime mi è costato questo amore! –
La carrozza si fermò dinanzi a una casetta di campagna ben
costruita, una ragazza comparve dalla porta e aprì lo sportello. Lidia la guardò
fissa, si guardò attorno, la riguardò e cadde svenuta nelle braccia di
Wilhelm.
Wilhelm fu condotto in una camera porta in soffitta. La casa nuova era tanto
piccola e straordinariamente pulita e ordinata. Teresa era ben fatta, senza
essere grande, si moveva con molta vivacità, e nulla di quel che accadeva
pareva restasse nascosto ai suoi occhi chiari, azzurri e aperti.
Entrò nella stanza di Wilhelm e gli chiese se gli occorresse qualcosa. - Scusi
- disse - se io L'alloggio in una stanza, che l’odore della vernice rende
ancora spiacevole; la mia piccola casa è stata terminata da poco e Lei inaugura
questa stanzina, destinata ai miei ospiti. Fosse almeno qui per un motivo più
piacevole! La povera Lidia non ci procurerà dei bei giorni, e sopra tutto
bisogna, che Lei si adatti: la mia cuoca è andata via dal servizio in tempo
poco propizio, e un servitore si è ferito ad una mano. - Parlò ancora un po’
di diverse cosette. Wilhelm le chiese di Lidia, se potesse veder la buona
ragazza e scusarsi con lei. - Non avrebbe per ora nessun effetto - rispose
Teresa. - Il tempo perdona, come consola. -
Corse via e promise di venirlo presto a prendere per una passeggiata. La sua
presenza aveva avuto un buon effetto su Wilhelm, che desiderava di conoscere i
suoi rapporti con Lotario. Sentì chiamarsi, ella gli venne incontro dalla sua
camera.
Fecero una passeggiata attraverso campi, prati e alcuni frutteti. Teresa
informava il proprio fattore di tutto, gli sapeva render conto di ogni
piccolezza, e Wilhelm aveva ragione abbastanza per meravigliarsi delle sue
conoscenze, della sua sicurezza e della sua abilità di saper dare in ogni caso
il consiglio giusto. Wilhelm le mostrò le sua ammirazione per le sue conoscenze
d’economia.
Andarono, e per via Teresa disse al suo compagno: - Non è giusto che Lei faccia
parlare me soltanto: Lei sa già abbastanza di me, e io non so la minima cosa di
Lei; mi racconti intanto qualcosa che La riguardi perché io abbia coraggio di
esporle la mia storia e le mie condizioni. - Purtroppo io non ho da raccontare -
rispose Wilhelm - altro che errori sopra errori, deviamenti sopra deviamenti, e
non saprei a chi nasconderei più volentieri che a Lei i disordini in cui mi
trovai e mi trovo. -
Salirono la collina e si distesero sotto una grande quercia, che spandeva tutto
intorno la sua ombra.
- Qui - disse Teresa - sotto questo albero voglio raccontarle la mia storia; mi
ascolti pazientemente. Mio padre era un nobile benestante di questa provincia,
un uomo sereno, chiaro, attivo, leale, un padre affettuoso, un ospite eccellente
in cui riconoscevo un unico difetto: d’essere troppe indulgente verso una
donna che non sapeva apprezzarlo. Purtroppo devo dir questo della mia propria
madre. Il suo carattere era del tutto opposto a quello di mio padre. Ella era
inconsiderata, incostante, senza amore per la sua casa e per me, la sua unica
bimba; dissipatrice ma bella, ricca di spirito, piena di talento, la gioia di un
circolo, che aveva saputo raccogliere attorno a sé. In verità la sua compagnia
non era mai grande e durava poco. Questo circolo era formato sopra tutto di
uomini. Io somigliavo a mio padre di figura e di sentimenti. L'ordine e la
pulizia della casa sembravano esser anche quando giocavo, il mio solo istinto,
la mia sola attenzione. Mio padre se ne rallegrava e secondava gradatamente il
mio desiderio infantile con adeguate occupazioni. Io crescevo, cogli anni
aumentava la mia attività e l'amore di mio padre per me. Quando eravamo soli e
andavamo per i campi, quand’io lo aiutavo a rivedere i conti, potevo veramente
sentire com’egli era felice. Mia madre con grande entusiasmo a darsi alla
scena e fu costruito un teatro; uomini non ne mancavano di tutte le età e di
tutte le figure che si presentavano con lei sulla scena, ma donne invece ne
mancavano spesso. Lidia, una gentile ragazza ch’era stata educata con me e che
già nella prima giovinezza prometteva di divenire seducente, dovette prendersi
le seconde parti e una vecchia cameriera dovette rappresentare le madri e le
zie, mentre mia madre si riservò le parti delle prime amorose, le eroine e le
pastorelle di ogni genere. Mia madre era ricca di suo, ma divorava ancor più
che non dovesse. Non so bene quel che passò fra lei e mio pidre, ma egli
acconsentì a permetterle un viaggio ch’ella voleva fare nella Francia
meridionale. Eravamo alla fine liberi e vivevamo come in cielo. Si licenziò
tutta la servitù inutile, e la felicità, sembrò che favorisse il nostro
ordine; avemmo degli anni beati, tutto andava a nostro desiderio.
Inaspettatamente mio padre fu colpito d’apoplessia che gli paralizzò la parte
destra e gli tolse la parola. Una cosa sola mi era chiara, ch’egli non voleva
niente, non desiderava altro, aspirava solo a rivelarmi qualcosa, ch'io
purtroppo non potei apprendere. Il suo male si ripeté, di lì a poco divenne
completamente impotente e incapace di tutto e non molto dopo morì. Ero stata
sempre in buoni rapporti con una signora vicina che aveva grandi possessi; ella
mi accolse con piacere e mi fu facile mettermi presto a capo del governo della
sua casa. Ella viveva molto regolarmente, e amava in tutto l’ordine e io
l'aiutavo fedelmente nella lotta coll’amministratore e con la servitù. Ormai
ero di nuovo nel mio elemento e in silenzio piangevo la morte di mio padre.
Lidia ritornò; mia madre era stata crudele abbastanza per respingere la povera
ragazza. Essa aveva imparato da mia madre a riguardare le passioni come un
destino, era abituata a non contenersi in nulla. Quando ricomparve inaspettata,
la mia benefattrice accolse anche lei: voleva andare per mano con ne e non
sapeva conformarsi in nulla. In questo tempo i parenti e i futuri eredi della
mia signora, venivano spesso in casa e si divertivano con la caccia. Anche
Lotario era qualche volta con loro: io notai presto come egli si distingueva da
tutti gli altri, naturalmente non solo verso di me. Era cortese con tutti, e
presto parve che Lidia. Nessun uomo ascoltavo volentieri, come Lotario, quando
raccontava dei suoi, delle sue campagne. Il mondo gli era così chiaro, così
aperto, come a me il luogo che io amministravo. Ma indicibile fu la mia
contentezza, quando una sera lo sentii parlare delle donne: che si era ingiusti
contro il loro sesso, cioè che gli uomini volevan ritenersi una cultura
superiore, che non ci si voleva far accedere a nessuna scienza, che si
richiedeva da noi d'essere soltanto delle frivole bambole e governanti della
casa. Dopo questo fece una descrizione di come egli si desiderava sua moglie.
Divenni rossa, perché descriveva me, anima e corpo! Non mi ricordo nella mia
vita una più piacevole sensazione di questa che un uomo, ch'io stimavo, desse
la sua, preferenza non alla mia persona, ma alla mia più intima natura.
Che ricompensa sentivo e che incitamento mi fu! Io non avevo mai amato e neppure
allora amavo; ma sebbene mi, fosse infinitamente caro di vedere come la mia
natura era apprezzata da un uomo stimabile, pure non voglio nascondere che ciò
non mi rendeva a pieno soddisfatta. Desideravo anche che mi conoscesse,
prendesse personalmente parte a me. Sentii che la compagnia dei giovani aveva di
nuovo preparato con Lotario una partita di caccia; per la prima volta in vita
mia mi venne in mente di parere, o, per non farmi torto, di valere agli occhi di
quell’eccellente uomo per quello che ero. Indossai i miei abiti maschili,
presi il fucile in ispalla e uscii col nostro cacciatore per aspettare al
confine la compagnia. Essa giunse. Lotario non mi riconobbe subito. Un nipote
della mia benefattrice mi presentò a lui come un'abile guardia forestale,
scherzò sulla mia giovinezza e spinse così a lungo il suo giuoco in lode mia
finché alla fine Lotario mi riconobbe. Il nipote secondo la mia intenzione,
come se ci fossimo messi d'accordo prima. Raccontò minutamente e pieno di
gratitudine cosa avevo io fatto per i possessi della zia e, quindi, anche per
lui. Lotario ascoltò attento, s'intrattenne con me, chiese di tutte le
condizioni dei possessi e del luogo ed io ero lieta di potergli mettere davanti
le mie cognizioni. La mia contentezza cresceva ad ogni momento, ma
fortunatamente io volevo essere conosciuta, non amata poiché quando arrivammo a
casa, notai più del solito che l'attenzione ch’egli mostrava per Lidia
sembrava, tradisse una segreta simpatia. Io avevo raggiunto il mio scopo e pure
non ero tranquilla; da quel giorno e egli mostrò una vera stima, e una bella
confidenza verso di me. Mi tirava nel discorso addirittura quando si parlava di
economia nazionale in genere e di finanze, e io cercavo in sua assenza di
acquistare più cognizioni sulla provincia, anzi su tutto il paese. Mi era
facile, poiché si ripeteva solo in grande, quel che io sapevo e conoscevo in
piccolo così precisamente. Da quel tempo venne più spesso in cara nostra.
Comunque credevo di accorgermi sempre più che le sue frequenti visite erano per
Lidia e non per me. Essa mi fece sua confidente e con questo mi trovai in un
certo senso consolata. Quello che lei considerava come un suo grande vantaggio,
io lo trovavo affatto insignificante; dell'intenzione di un’unione seria,
duratura non si mostrava traccia alcuna, e tanto più chiaramente vedevo il
desiderio della appassionata ragazza di diventare sua ad ogni costo. Così
stavano le cose, quando la signora di casa mi sorprese con un'insospettata
collera. - Lotario, ella disse, Le offre la sua mano, e desidera di averla nella
vita sempre al suo fianco. - Data la mia approvazione, venne egli stesso, parlò
da solo con me, mi offrì la sua mano, mi guardò negli occhi, mi abbracciò e
premé un bacio sulle mie labbra. Il primo e l'ultimo. La cosa non era più un
segreto, Lidia lo seppe, credé di apprendere qualcosa, d'impossibile. Quando
alla fine non poté avere più dubbi, sparì d'un tratto e non si seppe dove si
fosse perduta. Un giorno vado verso la mia stanza, prendo la scatole, dei miei
gioielli e l'apro in presenza di Lotario; egli ci guarda appena dentro che
scorge un medaglione col ritratto di una giovane donna; lo prende in mano, lo
riguarda con attenzione e chiede con impeto: - Di chi è questo ritratto? - Di
mia madre - gli rispondo. - Avrei giurato - esclama - che fosse il ritratto di
una signora di Saint Alban, che incontrai anni fa nella Svizzera. – È la
stessa persona - risposi io sorridendo; - e così, senza saperlo, Lei ha
conosciuto Sua suocera. Saint Alban è il romantico nome sotto cui mia madre
viaggia, e con esso si trova in questo momento in Francia. - Io sono il più
infelice degli uomini! - esclamò ributtando il ritratto nella cassettina, si
coprì colla mano gli occhi e lasciò subito la stanza. Si gettò sul suo
cavallo, io corsi sul balcone e lo chiamai, si rivolse, agitò la mano, si
allontanò in fretta, e non l'ho più riveduto.
Il sole tramontava, Teresa guardava nel fuoco con occhio fisso, e i suoi begli
occhi si empirono di lagrime.
Tacque e pose la mano sulle mani del suo nuovo amico; egli gliela baciò con
simpatia, le asciugò le lagrime e si alzò. - Ritorniamo - ella disse - e
provvediamo ai nostri ospiti! -
Quando Wilhelm ritornò al castello, trovò il nobile Lotario sulla via della
guarigione; il medico e l'abate non erano presenti, Jarno solo era rimasto.
Così una sera Lotario se ne stava silenzioso a tavola, sebbene paresse
contento. - Quale paradiso, egli disse poi, avevo io sognato con Teresa! Non il
cielo di una gioia esaltata, ma quello di una vita sicura in terra: ordine nella
felicità, coraggio nella sventura, cura alle cose più piccole, e un'anima
capace di comprendere ogni cosa più sublime. Oh! in lei io ben vedevo quelle
disposizioni il cui sviluppo noi ammiriamo, quando nella storia troviamo donne
che ci sembrano molto più degne di tanti uomini. Lei può ben perdonarmi -
disse, rivolto a Wilhelm se Teresa mi strappò ad Aurelia; con quella potevo
sperare in una vita serena, con questa non c'era da pensare neppure a un'ora
felice. - Non Le nascondo - disse Wilhelm - ch'io sono qui con grande amarezza
in cuore contro di Lei e che mi ero proposto di biasimare molto severamente la
sua condotta verso Aurelia. - E merita d'essere biasimata davvero - disse
Lotario; - non avrei mai dovuto scambiare la mia amicizia per lei col sentimento
dell'amore, al posto della stima che meritava, non avrei dovuto fare entrare un
affetto ch’ella non poteva né suscitare né tenere in vita. - Ma presso la
tomba, dove dorme la madre infelice, lasci ch'io Le chieda, disse Wilhelm, perché
non prende con sé il bimbo? un figlio, che farebbe rallegrare chiunque, e che
Lei, a quel che pare trascura completamente. Come può Lei, coi suoi delicati
sentimenti, mostrare di non avere nessun affetto paterno? -
- Ma di chi parla? - chiese Lotario - io non La capisco. - E di chi altro, se
non di Suo figlio, del figlio di Aurelia, del bel bimbo, alla cui felicità
nulla manca se non un padre che s'interessi di lui? -
- Lei si sbaglia di gran lunga, amico mio - esclamò Lotario; - Aurelia non
aveva figli, altrimenti con gioia me ne sarei occupato: ma nel caso presente
voglio riguardare la creaturina come un suo lascito e pensare alla sua
educazione. Ha fatto capire qualcosa che il bambino fosse mio, che fosse suo? -
Non mi ricordo di averla mai sentita pronunziare una parola al riguardo; il
fatto era già sottinteso, e io non ne ho dubitato un momento - replicò
Wilhelm.
- Posso dare alcuni schiarimenti in proposito - esclamò Jarno. - Una vecchia,
che Lei deve spesso aver vista, portò il bimbo ad Aurelia, ella lo accolse con
passione e sperò di mitigare con la sua presenza i propri dolori. -
Per questa scoperta Wilhelm divenne molto inquieto, pensò vivamente alla buona
Mignon insieme col grazioso Felice, mostrò il suo desiderio di levare i due
ragazzi dallo stato in cui si trovavano. - Metteremo presto a posto tutto
‑ rispose Lotario. - La misteriosa bimba la daremo a Teresa, non può
certo capitare in mani migliori, e per quel che riguarda il ragazzo, penso,
potrebbe prenderselo Lei con sé poiché quel che le dorme lasciano che ancora
si formi, lo sviluppano poi i bimbi se ci occupiamo di loro. – Senza far
lunghi discorsi vorrei pregarlo di andar a prendere i ragazzi, il resto verrà
da sé. - Sono pronto a ciò – rispose Wilhelm. - sono inquieto e curioso, se
posso scoprire qualcosa di più sicuro sul conto del ragazzo e desidero rivedere
la bimba che si è affezionata così stranamente a me. Il giorno dopo egli si
era preparato, il cavallo era sellato e, congedatosi dagli amici, Wilhelm partì.
Nel suo cammino verso la città, Wilhelm aveva in mente le nobili creature
femminili che conosceva o di cui aveva sentito parlare e le loro strane sorti,
che contenevano così poche gioie, gli erano dolorosamente presenti. - Ah! -
esclamò - povera, Marianna! cosa dovrò apprendere di te ? -
In città nessuno dei suoi conoscenti era a casa; si affrettò d'andare al
teatro, credè di trovarli alla prova: tutto era in silenzio. Quando giunse
sulla scena, trovò la vecchia domestica di Aurelia occupata a cucire. Felice e
Mignon sedevano in terra presso di lei, tutt'e due avevano un libro, e mentre
Mignon leggeva ad alta voce, Felice ripeteva tutte le parole, come se conoscesse
le lettere, come se anch’egli sapesse leggere.
I bimbi saltarono su e salutarono il nuovo venuto; egli li abbracciò
teneramente e li condusse più vicino alla vecchia. - Sei tu - le disse in tono
severo - che ha condotto da Aurelia questo bambino? - Ella alzò gli occhi dal
suo lavoro e volse verso di lui il suo viso; egli la vide in piena luce, inorridì,
si fece indietro di alcuni passi: aveva riconosciuto la vecchia Barbara, la
governante di Marianna.
- Dov'è Marianna? - esclamò.
- Lontano di qui - rispose la donna. - E Felice? -
- È il figlio di quella ragazza sventurata, che solo La amava troppo
teneramente. Che Lei non abbia a provare mai quello che Lei ci ha fatto soffrire
e che il tesoro che Le consegno possa farla tanto felice, quanto ha reso
infelici noi. - Si alzò per andarsene, Wilhelm la tenne ferma. - Non penso di
scappare – ella disse , - lasci ch’io vada a prendere un documento che Le
farà piacere e dolore. - Si allontanò e Wilhelm, con gioia paurosa guardava il
ragazzo che non poteva ancora dire suo. – È tuo - esclamava Mignon - è tuo!
- e premeva il bimbo alle ginocchia di Wilhelm. La vecchia ritornò e gli tese
una lettera. - Ecco le ultime parole di Marianna - disse. È morta? - egli
esclamò. Morta - rispose la vecchia, - vorrei
poterle risparmiare ogni rimprovero. - Sorpreso e perplesso Wilhelm aprì la
lettera; ma aveva appena letto le prime parole che un amaro dolore lo afferrò;
lasciò cadere la lettera, egli cadde su una banchina e restò là disteso per
del tempo. Mignon si dava da fare attorno a lui. Intanto Felice aveva raccolto
la lettera e tormentò la sua compagna di gioco, finché questa cedette, gli si
inginocchiò accanto e gli lesse la lettera. Felice ripeteva le parole, e
Wilhelm fu costretto a udirle due volte.
“Se questo foglio giungerà una volta a te, compiangi la tua infelice amante,
il tuo amore le ha dato la morte. Il bimbo, alla cui nascita io sopravvivo solo
pochi giorni, è tuo; muoio fedele a te anche se l'apparenza mi può essere
contraria; con te perdei tutto quello che mi legava alla vita. Muoio contenta,
poiché mi si assicura che il bimbo è sano e vivrà. Ascolta Barbara,
perdonale, sta bene e non mi dimenticare.” - Ecco, qua tutto! - esclamò la
vecchia, senza attendere che Wilhelm si fosse riavuto.
- Faccia che resti segreto che Felice Le appartiene: io avrei da aspettarmi
dalla compagnia forti rimproveri - disse Barbara - per aver taciuta la cosa.
Mignon non parlerà, è buona e riservata.
Lo sapevo da lungo tempo e non dicevo niente, - rispose Mignon.
Com'è possibile? - chiese la vecchia - Da chi? - chiese Wilhelm.
- Lo spirito me l'ha detto. - Dove? come? -
Nel sotterraneo, quando il vecchio estrasse il coltello, mi sentii gridare:
chiama suo padre, e allora mi venisti in mente tu.
Dopo i chiarimenti avvenuti, Wilhelm si spiegò con Barbara: egli voleva
prendere Felice con sé, mentre essa doveva portare Mignon da Teresa e poi
consumarsi dove avesse voluto, una piccola pensione ch’egli le promise. Egli
fece chiamare Mignon per prepararla a questo mutamento. – Meister - ella disse
- tienmi presso di te, mi farà bene e male insieme. - Egli le fece osservare
che era cresciuta e che bisognava fare qualcosa per una sua migliore educazione.
- Sono colta abbastanza - rispose - per amare e per essere triste. - Wilhelm le
richiamò l’attenzione sulla sua salute che aveva bisogno di una durevole cura
e della guida di un abile medico. - Perché ci si deve curare di me, quando ci
sono tante altre cose cui bisogna pensare? Dopo ch’egli si fu data tanta
premura per convincerla che non poteva al momento prenderla con sé, che voleva
portarla presso persone, dove spesso l'avrebbe vista, parve che Mignon non
avesse ascoltato nulla di tutto questo. - Non mi vuoi vicino a te? chiese. -
Forse è meglio, mandarmi dal vecchio suonatore d'arpa, il pover'uomo è così
solo. - Wilhelm cercò di farle comprendere che il vecchio era in buone mani -
Ma io non mi sono accorto - rispose Wilhelm - che tu gli fossi così
affezionata, quand’egli era con noi. - Avevo paura di lui, quand’era desto;
ma, quando dormiva, mi sedevo volentieri presso di lui, gli scacciavo le mosche
e non mi saziavo mai di guardarlo. avessi saputa la strada, sarei già corsa da
lui. - Wilhelm le disse che lei era una bambina ragionevole e che non doveva
rifiutare di seguire il suo desiderio, al che ella disse: - La ragione è
crudele, il cuore è migliore. Voglio andare dove tu vuoi, ma lasciami il tuo
Felice -
Dopo molto parlare e riparlare ella era restata sempre nel suo pensiero, e
Wilhelm alla fine pensò d'affidare tutti e due i ragazzi alla vecchia e
mandarli dalla signorina Teresa. Ciò gli riusciva tanto più facile, poiché
esitava sempre a considerare il bel Felice come suo figlio. Lo prese in braccio
e lo portò attorno: il bimbo desiderava di esser alzato dinanzi lo specchio, e
Wilhelm, senza confessarselo, ve lo portò volentieri cercando là di
rintracciare somiglianze fra sé e il bimbo. Un momento gli apparve proprio vero
e si premé il bimbo in seno, ma d’un tratto, atterrito dal pensiero che
poteva ingannarsi, mise il bimbo in terra e lo lasciò correre via. - Oh! -
esclamò - se potessi dir mio questo inestimabile tesoro, e poi mi dovesse
essere strappato, sarei il più infelice degli uomini!
I bimbi erano andati via in carrozza. Il bel bimbo gli stava davanti la fantasia come una seducente ed incerta
apparizione; lo vedeva, per mano a Teresa, correre per i campi e foreste
all'aria libera ed educarsi presso una libera e serena accompagnatrice; Teresa
gli era divenuta ancora più degna, dopodiché egli si pensava il bimbo in sua
compagnia.
Egli prese finalmente congedo dai teatranti e s'intrattenne con la Signora
Melina, sposa del direttore amministrativo. Wilhelm si rammaricava con lei di
non aver potuto adempiere a tutte le promesse a suo tempo fatte a quanti avevano
con lui condiviso la vita di teatro. - Non sia ingiusto verso se medesimo –
rispose la giovane donna, - se nessuno riconosce quel che Lei ha fatto per noi,
io non lo disconoscerò mai. - Con la Sua cordiale spiegazione - replicò,
Wilhelm – Lei non quieterà la mia coscienza e mi parrà sempre d'essere
debitore. -
- È anche possibile che Lei lo sia - rispose Madame Melina, - ma non nel modo
in cui Lei pensa. Ci attribuiamo la colpa di non aver adempiuto una promessa,
che abbiamo fatto con la bocca. Oh, amico mio, un uomo buono solo con la sua
presenza promette sempre troppo! La fiducia che egli attira, la simpatia che
ispira, le speranze che suscita, sono infinite, egli diviene e resta, senza
saperlo, un debitore.
Wilhelm, ritornato alla campagna di Lotario, trovò grandi cambiamenti. Un suo
zio era morto e Lotario era andato là per prender possesso dei beni lasciatigli
in eredità. - Lei viene proprio a tempro opportuno gli disse Jarno - per
aiutare l'abate e me. Lotario ci ha dato l'incarico dell'acquisto di importanti
possessi qui in vicinanza; la cosa era già in discussione da lungo tempo, e ora
troviamo, proprio nel momento opportuno, danaro e credito. - Mostrarono le carte
a Wilhelm, riguardarono i campi, le praterie e i castelli, e sebbene Jarno e
l’abate dessero a capire di intendersene molto, pure Wilhelm desiderò che la
signorina Teresa fosse della compagnia (...)
Wilhelm udì rumore dietro di sé, si voltò e vide un viso furbo di bimbo che
guardava dietro i tappeti dell'entrata: era Felice. Il ragazzo quando
s’accorse d'esser visto si nascose tosto scherzando. - Vieni fuori! - gridò
l'abate. Egli venne correndo, suo padre gli corse incontro, lo prese nelle sue
braccia e se lo strinse al cuore.
- Sì lo sento - disse - tu sei mio! - quale dono del cielo devo ai miei amici!
Di dove vieni, bimbo mio, proprio in questo momento? - Non domandi. - disse
l’abate. - Salute a te, giovane! Il tuo tirocinio è finito, la natura ti ha
emancipato. -
Felice saltò in giardino e Wilhelm, rapito, lo seguì; il più bel mattino
mostrava ogni oggetto con nuove grazie, e Wilhelm poté godere del più lieto
momento. Felice era nuovo nel libero e splendido mondo e suo padre non conosceva
molto più di lui gli oggetti, di cui il piccino gli chiedeva ripetutamente e
instancabilmente. Alla fine incontrarono il giardiniere che dovette raccontare
loro dei nomi e dell'uso delle varie piante; Wilhelm vedeva la natura attraverso
un nuovo organo, e la curiosità e l'ardore di sapere del bimbo gli fecero
capire quale debole interesse egli aveva preso, fino ad allora per le cose al di
fuori di lui, quante poche cose conosceva e sapeva. In quel giorno, il più
lieto della sua vita, gli parve che cominciasse anche la sua cultura; sentì la
necessità d’imparare, giacché era chiamato a insegnare.
Quando Wilhelm pensava quanto poco aveva fatto fin qui per il bimbo, di quanto
poco egli stesso era capace, sorgeva allora in lui l’inquietudine, che
riusciva a controbilanciare la sua felicità. - Noi uomini, diceva a se stesso,
siamo davvero nati così egoisti che ci è impossibile di curarci di un essere
al di fuori di noi? Riguardo al bambino, non sono sullo stesso cammino che
riguardo a Mignon? Io attirai a me la cara creatura, la sua presenza mi faceva
contento e con questo la trascurai nel modo più crudele. Che feci per educarla,
mentre lei desiderava tanto di esserlo? Nulla! La lasciai a sé e a tutte le
eventualità cui poteva essere esposta in mezzo a una rozza compagnia, e poi per
questo bimbo che ti interessava tanto, prima ancora che avesse per te un così
gran valore, ti ha mai detto il cuore di fare per lui anche la cosa più
piccola? È ormai passato il tempo di dissipare gli anni tuoi e quelli degli
altri; raccogliti e pensa a quel che hai da fare per te e le buone creature che
natura e affetto han legato così strettamente a te.
In verità, questo monologo non era che un'introduzione a confessarsi ch’egli
aveva già pensato, provveduto, cercato e scelto: né poteva a lungo indugiare a
confessarselo. Doro il dolore spesso e invano rinnovato per la perdita di
Marianna, egli sentì troppo chiaramente che doveva cercare una madre per il
bambino (e per Mignon) e che non la poteva trovare con maggior sicurezza, che in
Teresa. Conosceva interamente quella eccellente ragazza. Una sposa e una
compagna come lei gli parve la sola cui potesse affidare sé ed i suoi. Il suo
nobile affetto per Lotario non gli dava affatto da pensare. Per uno strano
destino erano separati per sempre; Teresa si riteneva libera, ed aveva bensì
parlato del matrimonio quasi con indifferenza, ma pure come una cosa naturale e
necessaria.
Doro essersi a lungo consigliato con se stesso, si propose di narrarle di sé
quanto più poteva. Ella doveva conoscerlo, com’egli conosceva lei e cominciò
così a ripensare la propria storia. È una terribile sensazione quando un uomo
nobile è coscientemente sul punto di essere messo in chiaro su se stesso. Tutti
i trapassi sono crisi e ogni crisi
non è una malattia? Come si va a malincuore, dopo una malattia, davanti a uno
specchio! Si sente in sé un miglioramento, ma si vede soltanto l'effetto del
male passato.
Wilhelm si occupò d'allora in poi a comporre per Teresa la storia della sua
vita e quasi si vergognò di non poter opporre, di fronte alle grandi virtù di
lei, nulla che potesse provare in lui un'attività misurata a uno scopo. Per
quanto dettagliato fosse nella sua storia, altrettanto brevemente si restrinse
nella lettera che stese; la pregò di volergli concedere la sua amicizia, il suo
amore se fosse possibile, le offrì la sua mano e la pregò di una sollecita
decisione.
Dopo un po' di dibatto interno se per
questo passo importante si fosse dovuto consigliare prima coi suoi amici, con
Jarno e l'abate, si decise a tacere; egli ebbe la precauzione di portare da sé
la lettera alla posta vicina.
La lettera era stata appena spedita che Lotario ritornò. Ognuno si rallegrava
di veder presto conchiusi e terminati tutti gli affari preparati e Wilhelm era
ansioso di vedere come tanti fili si sarebbero in parte annodati, in parte
disciolti e come si sarebbe fissata per l'avvenire la sua sorte. Lotario li
salutò tutti cordialmente: si era ristabilito pienamente ed era sereno, aveva
l’aspetto di un uomo che sa quel che deve fare e al quale nessun ostacolo
attraversa la via. - Questi è, dovè dire Wilhelm a se stesso, l’amico,
l'amato, il fidanzato di Teresa al cui posto tu pensi di metterti. Credi di
poter mai spegnere o scacciare questa impressione? - Se la lettera non fosse già
stata spedita, forse egli non avrebbe osato di mandarla.
Per fortuna il dado era tratto, forse Teresa era già decisa, solo la lontananza
copriva ancora con un velo un felice compimento. Guadagno o perdita dovevano
presto decidersi. Egli cercò di calmarsi con tutte queste osservazioni, eppure
i moti del suo cuore erano quasi febbrili.
Si passò ad altri discorsi e poi Lotario disse a Wilhelm: - Devo ora mandarla
in un luogo dove Lei è più necessario di qui. Mia sorella La prega di andare
da lei al più presto possibile, sembra che la cara Mignon deperisca e si crede
che la presenza di Lei possa forse lenire il male. Mia sorella mi manda questo
biglietto, da cui Lei può vedere quanto la cosa le stia a cuore. Lotario gli
consegnò il biglietto; Wilhelm lo prese e non seppe cosa rispondere. - Prenda
Felice con sé - disse Lotario - affinché i ragazzi si divertano insieme. Lei
dovrebbe partire domattina per tempo, la vettura di mia sorella è ancora qui,
io Le le dò i cavalli fino a metà strada, poi può prendere la posta. Stia
bene, e porti i miei saluti. Dica inoltre a mia sorella che ci rivedremo presto
e che si deve preparare soprattutto, a ricevere alcuni ospiti.
Il vetturino non gli lasciò il tempo di continuare nelle sue riflessioni e
innanzi giorno lo costrinse a prender posto nella vettura; egli ravvolse bene il
suo Felice, la mattina era fredda, ma serena, ed era la prima volta in vita sua
che il bimbo vedeva nascere il sole. La sua meraviglia per la vista dei primi
raggi, per la presenza crescente della luce, la sua gioia e le sue liete
osservazioni rallegravano il padre e gli facevano gettare uno sguardo nel
giovane cuore, dinanzi a cui, come su un mare tranquillo e silenzioso, si alzava
e fluttuava il sole. In questo momento, Wilhelm tirò fuori dalla tasca interna
il bigliettino che non aveva avuto il coraggio di guardare nel primo momento;
esso conteneva le seguenti parole: “Mandami presto il tuo giovane amico: in
questi due ultimi giorni, Mignon è peggiorata. Per quanto triste sia, quest’occasione,
pure io mi rallegro di conoscerlo”. Natalia.
- Allora questa Natalia è l’amica di Teresa. Che scoperta, che speranza e
quante cose mi attendono. - Per il bimbo e per sé, Wilhelm aspettava la
migliore accoglienza.
Si era fatta notte, la vettura rumoreggiò dentro una corte e si fermò, un
servitore, con una fiaccola di cera, uscì da un magnifico portale e scendendo
per le ampie scale venne fino alla carrozza. – È già atteso da tempo, -
disse aprendo lo sportello. Wilhelm scese, prese in braccio Felice che dormiva,
e il primo servo ne chiamò un secondo, che con una lampada era restato sulla
porta: - Conduci subito il signore dalla baronessa. -
Un lampo traversò l’anima di Wilhelm: - Che fortuna, sia un proposito sia un
caso che la baronessa sia qui! Io devo vedere lei prima di tutti! Forse la
contessa dorme già? -
Entrò nella casa e si trovò nel luogo più severo, per il suo sentimento, il
più santo dove fosse mai entrato. Un'abbagliante lanterna appesa illuminava una
scala lunga e piana che gli stava dinanzi e in alto si divideva in due rami.
Statue di marmo e busti erano messi in ordine sui piedistalli e dentro a
nicchie; alcune gli sembravano note. Gli pareva quasi d'essere un personaggio di
una favola. Il bimbo gli pesava, si fermò sugli scalini e s’inginocchiò come
per prenderlo più comodamente. In realtà però aveva bisogno di un momento di
riposo. Il servo che andava avanti facendo luce voleva prendergli il bimbo, ma
egli non poté distaccarsene. In questo giunse nell'anticamera e il servitore lo
invitò ad attraversare un paio di stanze e ad entrare in un gabinetto. Qui,
dietro un paralume che le gettava addosso un'ombra, sedeva una signorina e
leggeva. Mise giù il bimbo, che pareva destarsi, e pensò d’avvicinarsi alla
signorina, ma il bimbo tutto insonnolito cadde giù, la signorina si alzò e gli
venne incontro. Le prese la mano e la baciò con effusione. Il bimbo giaceva fra
loro due sul tappeto e placidamente dormiva.
Portarono Felice sul canapè, Natalia gli si sedette vicina, invitò Wilhelm a
sedersi sulla poltrona lì accanto. Ella gli offrì alcuni rinfreschi ch’egli
rifiutò e gli narrò in generale della malattia di Mignon: che la bimba a poco
a poco era consumata da alcuni sentimenti profondi e che nella sua grande
sensibilità (ch’ella nascondeva), spesso soffriva in modo violento e
pericoloso di un crampo al suo povero cuore. Quando questo pauroso crampo era
passato, la forza della natura si riespandeva in forti pulsazioni e opprimeva la
bimba con l’eccesso, come prima l’aveva fatta soffrire per la mancanza.
- Uno strano cambiamento troverà in lei - aggiunse Natalia, - ella porta ora
abiti da donna, di cui pareva avesse prima un così gran spavento.
- Come ha potuto ottenere ciò? - chiese Wilhelm. - Se ciò era desiderabile, ne
siamo ora debitori solo al caso. Ascolti com’è andata. Lei forse sa ch'io ho
attorno a me un certo numero di ragazze i cui pensieri io cerco di educare verso
il vero e il giusto mentre esse crescono vicino a me. Dalla mia bocca non odono
nulla se non ciò ch’io stessa credo sia vero; però non voglio impedire che
apprendano anche dagli altri quello che nel mondo passa ed è dato come un
errore e un pregiudizio. Se m’interrogano su ciò io cerco di riannodare quei
concetti estranei e indebiti a un qualche giusto concetto, per renderli, se non
utili almeno innocui. Già da qualche tempo le mie ragazzine avevano appreso
dalla bocca dei ragazzi dei contadini qualcosa degli angeli, del babbo Natale e
che, in certi tempi questi esseri compaiono in persona per far regali ai bambini
buoni e punire i cattivi. Avevano il sospetto che fossero persone travestite e
volli confermar loro questa verità
Si avvicinava il giorno natalizio di due sorelle gemelle che si erano sempre
comportate bene; promisi questa volta, che un angelo avrebbe loro portato i
regali che si erano così bene meritate. Erano straordinariamente curiose di
questa apparizione. Mi ero scelta Mignon per questa parte, e per quel giorno
ella si vestì decorosamente di un lungo e leggero abito bianco. Attorno al
petto non le mancava la cintola d'oro e un simile diadema sui capelli. Dapprima
io volevo tralasciare le ali, ma le ragazze che l'adornavano, insisterono perché
le mettessi due grandi ali d'oro, con cui volevano mostrare proprio tutta la
loro arte.
Così, con un giglio in una mano e un panierino nell'altra, entrò la
meravigliosa apparizione in mezzo alle ragazze, e sorprese me pure. - Ecco che
viene l'angelo - dissi io. Le ragazze fecero come per ritrarsi indietro e alla
fine esclamarono: È Mignon! - eppure non osavano appressarsi all'immagine
miracolosa.
- Qui sono i vostri doni, - diss’ella tendendo il panierino.
Si radunarono attorno a lei, osservando, toccando, interrogando.
- Sei un angelo? - chiese una bambina. - Vorrei esserlo, - rispose Mignon.
- Perché porti un giglio? - Se così puro e aperto fosse il mio cuore, sarei
felice, - ancora replicò. - Come sono le ali? Falle vedere. -
E così ad ogni ingenua domanda ella rispondeva con qualche simbolo. Quando fu
quietata la curiosità della piccola compagnia e l’impressione
dell’apparizione cominciava a diminuire, la vollero spogliare. Ella si oppose,
prese la sua cetra si sedé su quell'alta scrivania e con grazia incredibile
cantò una canzone:
- Oh! lasciatemi sembrare, finché io sia
veracemente; oh! non mi togliete la bianca veste! Via m'allontano dalla terra
bella, verso la casa laggiù.
Là poserò per breve quiete e poscia fresche visioni mi s'apriranno, e lascerò
la tunica pura in abbandono e la corona e la cintola.
Ma le creature celesti non chiedono, s'uno sia uomo o sia donna né v'è vestito
né panno alcuno, che il corpo circondi.
Certo non vissi con pene e fatica, ma profonda doglia ho già sentito assai. Pei
miei dolori sono sì presto adulta - oh, ridatemi per sempre la gioventù! -
- Io mi risolsi tosto, proseguì Natalia, a lasciarle l'abito e procurargliene
ancora altri dello stesso genere che porta ancor oggi e in cui, come a me pare,
il suo essere ha tutt'un'altra espressione. -
Siccome era già tardi, Natalia lasciò il nuovo venuto che non senza timore si
separò da lei: - È sposata o no? - pensava fra sé. Il servo che l’accompagnò
nella sua camera si allontanò più presto ch’egli non avesse preso coraggio
d’informarsi della cosa.
La mattina di poi, mentre tutto era ancora silenzioso e quieto, egli uscì per
visitare un poco la casa.
Era la più bella, la più pura e la più degna architettura che avesse mai
visto. Il servo gli aprì varie altre stanze; trovò una biblioteca, una
raccolta di storia naturale, un gabinetto di fisica. Felice si era intanto
svegliato e gli era corso dietro; il pensiero di come e quando avrebbe ricevuto
la lettera di Teresa, gli dava pensiero, temeva d'incontrare Mignon e in certo
modo anche Natalia.
Natalia lo fece invitare a colazione. Entrò in una stanza in cui parecchie
ragazze ben vestite tutte, come pareva, sotto i dieci anni, preparavano una
tavola, mentre una persona d’età portava dentro bevande diverse.
Natalia entrò e le giovani avevano a poco a poco lasciato la stanza per
attendere alle loro piccole occupazioni. Wilhelm, ch’era restato solo con
Natalia, desiderò di rivedere Mignon; l'amica lo pregò di pazientare finché
fosse ritornato il medico che era stato chiamato dalle vicinanze.
Wilhelm, stava per aggiungere qualcosa, quando entrò il medico e, subito dopo i
primi saluti, cominciò a parlare dello stato di Mignon. Natalia che aveva preso
per mano Felice, disse che voleva condurlo da Mignon e preparare così la bimba
alla comparsa del suo amico.
Il medico, appena fu solo con Wilhelm, proseguì: - Ho da raccontarle strane
cose che Lei appena suppone. Natalia ci dà modo di poter parlare liberamente di
fatti che pur avendoli appresi da lei non si potrebbero discutere con tanta
libertà in sua presenza; la singolare natura della bimba, di cui
ore si parla, consiste esclusivamente in una profonda nostalgia. Il
desiderio di rivedere la sua patria e il desiderio di Lei, amico mio, sono,
potrei dire, la sola cosa terrena in lei; tutte e due queste cose si prospettano
alla fanciulla solo in un'infinita lontananza, tutti e due gli oggetti giacciono
irraggiungibili dinanzi a quest’anima singolare. Deve essere nata nelle
vicinanze di Milano e nella prima giovinezza, dev'esser stata rapita ai suoi
genitori da una compagnia di saltimbanchi. Di più non si può sapere da lei per
poter fissare con precisione il nome e il luogo perchè allora era troppo
piccina, e specialmente perché ella ha fatto giuramento di non indicare
precisamente a nessun uomo vivente né la sua patria né la sua origine. Poiché
proprio quella gente che la trovò smarrita ed alla quale così esattamente ella
descrisse la propria abitazione, e che con tanta insistenza, pregò di
ricondurla a casa, la portò via con sé tanto più in fretta; la notte poi
nell’albergo credendo che la bimba dormisse, si mise a scherzare sul buon
acquisto assicurando ch’ella non avrebbe ritrovato il cammino. Allora, un
terribile spavento prese la povera creatura e, alla fine, le apparve la Madre di
Dio che la rassicurò che si sarebbe presa cura di lei. Allora ella fece a se
stessa un santo giuramento, che per l’avvenire non si sarebbe mai confidata
con nessuno, non avrebbe confidato a nessuno la sua storia e che voleva vivere e
morire nella speranza di un diretto aiuto divino. Anche queste cose ch’io le
racconto, ella non le ha confidate espressamente a Natalia; la nostra degna
amica le ha messe insieme da singole espressioni, da canti e da distrazioni
infantili, che tradiscono proprio quel ch’ella vuol tacere.
Wilhelm poteva così spiegarsi qualche canto, qualche parola della enigmatica
fanciulla. Egli pregò insistentemente il suo amico di non celargli nulla di
quel che gli era noto degli strani canti e delle confessioni della strana
creatura.
- Oh! - rispose il medico - si prepari a una strana confessione, a una storia,
cui Lei, senza forse ricordarsene, ha preso tanta parte e che, come temo, è
stata decisiva per la morte e per la vita di questa straordinaria natura di
fanciulla.
- Racconti, racconti - rispose Wilhelm - sono tanto impaziente. -
Si ricorda, disse il medico, di una segreta e notturna visita femminile, dopo
una rappresentazione e la festa che ne segui? – Si, me ne ricordo bene! -
esclamò Wilhelm arrossendo - ma non credevo di dovermene ricordare in questo
momento. -
- Sa, Lei chi era? – No! Lei mi spaventa! Per amore del cielo, non era mica
Mignon? Chi era? Me lo dica! -
- Io stesso non lo so. - Allora non era Mignon? - No, certo no! Ma Mignon era
sul punto di apprestarsi pian piano a Lei, ma con terrore dovette vedere da un
angolo della stanza che una rivale l'aveva preceduta. -
- Una rivale? – esclamò Wilhelm – continui, Lei mi confonde interamente. -
- Sia lieto, disse il medico, di poter apprendere così rapidamente da me questi
risultati. Natalia ed io fummo tormentati abbastanza finché non potemmo
comprendere chiaramente lo stato di questa buona creatura cui desideravamo
portar aiuto. La sua attenzione era stata eccitata da frivoli discorsi di Filina
e di altre ragazze e da una certa canzoncina e, l’aveva molto sedotta il
pensiero di passare una notte presso l'amato, senza che in questo ella sapesse
immaginarsi nulla di più, che un dolce e felice riposo. L'affetto per Lei,
amico mio, era già potente e vivo nel suo cuore; nelle Sue braccia la buona
figliola si era già quietata da molti dolori, ormai desiderava in tutta la sua
pienezza questa felicità. Ora si proponeva di pregarLa cortesemente, ora ne era
trattenuta da un segreto timore. Alla fine, la lieta serata e il buon umore per
il vino ripetutamente gustato le dettero il coraggio di tentare l'impresa e di
introdursi da Lei in quella notte. La aveva preceduto correndo per celarsi nella
stanza aperta, solo che, salite le scale, aveva udito un fruscio, si era
nascosta e aveva visto una bianca figura femminile entrar quatta quatta nella
Sua stanza. Lei stesso arrivò di lì a poco e la bimba udì mettere il paletto.
Mignon provò tormenti inauditi, tutti i più vivi sentimenti di una gelosia
appassionata si mischiavano all’aspirazione ignota di un oscuro desiderio e
colpirono la sua natura non ancora sviluppata. Il suo cuore che sin allora aveva
battuto solo di nostalgico desiderio e d’attesa, cominciò d'un tratto ad
arrestarsi e come un peso di piombo, a premerle il petto; ella non poteva più
respirare né sapeva come aiutarsi, udì l’arpa del vecchio, andò in fretta
da lui nella soffitta e in terribili spasimi passò la notte ai suoi piedi.-
Il medico si fermò un momento e siccome Wilhelm taceva, proseguì: - Natalia mi
ha confidato che nulla in vita sua l'ha mai tanto spaventata come lo
stato della ragazza durante questo racconto: anzi
la nostra nobile amica si fece dei rimproveri per averle fatte fare queste
confessioni e per avere così crudelmente rinnovellati col ricordo i vivi dolori
della povera bimba. -
- La buona creatura, così mi raccontava Natalia, era appena arrivata a questo
punto del racconto, che d'un tratto mi cadde a terra dinanzi e con mano al petto
cominciò a lamentarsi perché le era ritornato lo stesso dolore come in quella
terribile notte. Si ravvoltolava per terra e io dovei radunare tutta la mia
fermezza d'animo per ricordarmi e applicare tutti i mezzi che, in simili casi,
sapevo utili per lo spirito e per il corpo.
- Lei mi mette in una penosissima situazione, esclamò Wilhelm, e proprio nel
momento in cui devo rivedere la cara creatura, mi fa sentire cosi vivamente
tutti i miei torti verso di lei. E posso confessarle che non comprendo che aiuto
può portare la mia presenza, se la fanciulla è in questo stato d'animo? Se lei
come medico è convinto che questa doppia passione abbia così profondamente
minato la sua natura da minacciarle la vita, perché debbo io con la mia
presenza, rinnovarle il dolore e forse affrettarle la fine? -
- Amico mio! - rispose il medico - quando non possiamo aiutare, abbiamo però
l’obbligo di confortare e so, perché ho visto importantissimi esempi, come la
presenza di un essere amato tolga alla fantasia la sua forza distruttrice e
cambi la passione in una quieta contemplazione. Tutto con misura e per uno
scopo! Perché proprio la presenza può riaccendere una passione che si
estingue, Veda la buona bimba, la tratti benevolmente e vedremo quel che ne
nascerà. -
Natalia rientrò e invitò Wilhelm a seguirla da Mignon. - Sembra che sia tutta
contenta con Felice e io spero che accoglierà bene l’amico. - Wilhelm la seguì
non senza un po' di ritrosia, profondamente commosso di quel che aveva appreso e
temendo una scena passionale. Quando entrò, avvenne proprio il contrario.
Mignon sedeva con una lunga veste bianca e coi folti capelli scuri parte
arricciati, parte sciolti, e teneva Felice in grembo e se lo stringeva al cuore,
ella aveva preso l'aria di uno spirito che si di disparte e il bambino pareva la
vita stessa; a vederli pareva che cielo e terra si abbracciassero. Sorridente
tese a Wilhelm la mano e disse: - Ti ringrazio, che mi hai portato il bimbo;
l'avevano portato via, Dio sa come, e da allora non potevo più vivere. Finchè
il mio cuore avrà, bisogno di qualcosa sulla terra, lui deve riempirne il
vuoto. - La calma con cui Mignon aveva accolto il suo amico, mise in gran
contentezza tutta la compagnia. Il medico espresse il desiderio che Wilhelm la
vedesse assai spesso e che procurassero di mantenerla in equilibrio sia
fisicamente che moralmente. Egli stesso si allontanò e promise di ritornare in
breve.
Wilhelm poté vedere allora Natalia nella sua cerchia e non avrebbe potuto
desiderare nulla di meglio che viverle vicino. La sua presenza aveva l'influenza
più pura sui giovani, fanciulle e ragazze di diversa età di cui parte
abitavano in casa sua parte venivano più o meno spesso a visitarla dalle
vicinanze.
- L'andamento della Sua vita, - le chiese una volta Wilhelm, - è stato sempre
molto uguale? Si capisce subito che Lei non ha mai deviato. Lei non fu mai
costretta a fare un passo indietro. - Questo lo devo a mio zio e all’abate -
rispose Natalia – che così bene seppero riconoscere le mie qualità. Sin
dalla mia giovinezza quasi, non mi ricordo di aver mai provato una più
forte impressione di quando vedevo ovunque il bisogno degli uomini e provavo
un invincibile desiderio di soddisfarli; la più lieta sensazione per me era, ed
è anche quando scorgo una mancanza, un bisogno nel mondo e posso tosto
ricercarne nello spirito un compenso,
un mezzo, un aiuto. Questo modo di vedere era in me del tutto naturale, senza la
minima riflessione, sì che io da bimba facevo le più strane figure e più di
una volta, con le mie singolari
proposte misi gli altri in imbarazzo. –
Mignon chiedeva spesso di essere della compagnia e tanto più volentieri glielo
concedevano perché pareva che a poco a poco ella si abituasse a Wilhelm, ad
aprirgli il suo cuore, e soprattutto ad essere più serena, e più vivace.
Passeggiando si appoggiava volentieri al suo braccio poiché si stancava
facilmente. - Ora, diceva, Mignon non si arrampica più e non salta più, e pure
sente sempre il desiderio di passeggiare lontano sulle cime dei monti, di
camminare da una casa a un'altra, da un albero a un altro. Come sono invidiabili
gli uccelli, specialmente quando costruiscono con tanta fiducia il loro nido!
–
Era ormai abitudine che Mignon invitasse spesso Wilhelm nel giardino. Se questi
era occupato o non lo poteva trovare, Felice doveva allora sostituirlo, e se in
alcuni momenti pareva che la ragazza fosse interamente disgiunta dalla terra, in
altri in altri invece era attaccata strettamente al padre o al figlio e sembrava
che temesse un distacco sopra ogni altra cosa.
Natalia si mostrava pensierosa. – Noi abbiamo desiderato - disse un giorno –
di dischiudere di nuovo, con la Sua presenza, quel dolce, povero cuore; se
abbiamo fatto bene, non lo sappiamo. - Tacque e parve attendere che Wilhelm
dicesse qualcosa. Gli venne in mente che la sua unione con Teresa, nelle
circostanze presenti, avrebbe straordinariamente afflitto Mignon; ma nella sua
incertezza non osò parlare di questo progetto, non supponendo che Natalia
potesse esserne informata.
Assai spesso avevano sino allora parlato della signorina Teresa, assai spesso
l’avevano nominata casualmente e quasi ogni volta Wilhelm era stato sul punto
di confidare alla sua nuova amica ch’egli aveva offerto a quell’eccellente
ragazza il suo cuore e la sua mano. Una certa sensazione che non si sarebbe
potuto spiegare lo trattenne; esitò tanto, sinché Natalia stessa, col dolce
sorriso, modesto e sereno che sempre le si vedeva, gli disse: - Così devo io
rompere alla fine il silenzio e conquistarmi a forza la Sua confidenza! Perché,
amico mio, mi tiene segreta una cosa che per Lei è tanto importante e che tocca
anche me tanto da vicino? Lei ha offerto la Sua mano alla mia amica… io non
mischio nelle cose senza incarico ecco qui la legittimazione! Ecco la lettera
che Teresa Le manda per mezzo mio.
- Una lettera di Teresa! – esclamò Wilhelm. - Si, signore! La Sua sorte è
decisa, Lei è felice. Lasci che io auguri felicità a Lei e alla Sua amica! -
Wilhelm tacque e guardò dinanzi a sé. Natalia lo guardò e si accorre che era
divenuto pallido. - La Sua gioia è grande, proseguì, essa prende l’aspetto
dello spavento, Le toglie la favella. La mia partecipazione non è meno
affettuosa, sebbene mi lasci ancora la parola. Spero che Lei mi sarà grato,
poiché posso dirle che la mia influenza su Teresa non fu piccola; ella mi
chiese consiglio e per caso Lei era proprio qui, e così potei felicemente
vincere i pochi dubbi che la mia amica ancora sollevava; i messaggi andarono e
vennero: qui è la decisione! Qui è lo scioglimento! E ora deve leggere tutte
le lettere, deve gettare un libero, puro sguardo nel cuore della Sua sposa! –
Wilhelm dispiegò il foglio ch’ella gli tese disuggellato; conteneva le liete
parole: “Sono Sua, come sono e come Lei mi conosce. Chiamo mio Lei, com’è e
come la conosco. Quello che cambierà il matrimonio in noi e nei nostri rapporti
sapremo sopportarlo con ragione con lieto animo e buon volere. Poiché non
passione ci ha unito, ma simpatia e fiducia, così arrischiamo meno che mille
altri. Lei mi perdonerà certo se io talora mi ricorderò affettuosamente del
mio vecchio amico, e per questo voglio stringere al petto Suo figlio, come una
madre. Se Lei vuol dividere subito con me la mia piccola casa, ne è padrone e
signore; frattanto si conchiuderà l’acquisto del possesso. Desidererei che
non
vi si facesse alcun cambiamento senza di me, per mostrar subito che
merito la fiducia che Lei mi concede. Stia bene, mio buono e caro amico! amato
sposo, venerato marito! Teresa la stringe al seno con speranza e con gioia! La
mia amica Le dirà di più, Le dirà tutto!”
Wilhelm, cui questo foglio aveva interamente ravvivato davanti l’immagine
della sua Teresa, era anche tornato completamente in sé. Alla lettura, i più
rapidi pensieri si scambiarono nella sua anima. Si rappresentò dinanzi Teresa
nella sua perfezione, rilesse la lettera e apparve sereno. Natalia gli offrì le
lettere scambiate da cui vogliamo scegliere qualche passo.
Teresa, dopo aver descritto a modo suo il suo sposo, continuava:
“Così io mi immagino l'uomo, che ora mi offre la sua mano. Come egli pensa di
sé, tu potrai poi vederlo dalle carte in cui egli apertamente si descrive a me;
sono convinta che sarò felice con lui.”
“Per quel che riguarda la diversità di casta, tu sai com’io ho sempre
pensato in proposito. Alcuni uomini sentono terribilmente le discordanze delle
condizioni esterne e non le possono sopportare. Io non voglio convincere
nessuno, ma agire secondo il mio convincimento. Non intendo di dare un esempio,
ma il mio modo d'agire non è senza esempio. A me fan paura solo le intime
discordanze, un recipiente che non si adatta a quel che deve contenere: molto
sfarzo e poco godimento, ricchezza e avarizia, nobiltà e rozzezza, gioventù e
pedanteria, bisogno e cerimonie, queste sarebbero le circostanze che potrebbero
annientarmi; il mondo poi può apprezzarle o disprezzarle a suo piacere.”
"Se spero che andremo d'accordo, fondo la mia speranza principalmente sul
fatto ch’egli è simile a te, mia cara Natalia, che infinitamente stimo e
venero.
"Sì, egli ha di te la nobile ricerca e l’aspirazione del meglio da cui
traiamo fuori il bene stesso che crediamo di trovare. Quante volte in silenzio
non ti ho biasimata perché trattavi questo o quell'uomo altrimenti ch’io non
avrei fatto, e ti comportavi diversamente in questo o quel caso eppure, alla
fine, si vedeva che tu avevi ragione. Se noi pigliamo gli uomini solo come sono,
dicevi tu, li rendiamo peggiori; se invece li trattiamo come se davvero fossero
quel che dovrebbero essere li portiamo allora là dove devono essere portati.
Voglio anche confessarti che prima di conoscerti, non conoscevo nulla di più
alto nel mondo che la chiarezza e l’intelligenza; solo la tua presenza mi ha
convinta, animata, soggiogata e alla tua bella e nobile anima cedo volentieri il
primo posto. Anche, nel mio amico venero le stesse qualità; la storia della sua
vita è un eterno cercare e non trovare. Ma non un cercare vano, bensì un
cercare meraviglioso e buono lo pervade; egli crede che gli si possa dare solo
quello che può venire da lui. Cosi, mia cara, anche questa volta la mia
chiarezza non mi nuoce, conosco il mio sposo meglio ch’egli stesso non si
conosca, e tanto più lo stimo.''
Se penso a Lotario? Vivamente e ogni giorno. Non posso fare a meno di lui
neppure un momento, nella compagnia che in ispirito mi circonda. Oh, come
rimpiango quest'uomo eccellente che mi è quasi parente per uno sbaglio di
gioventù e che la natura ha voluto così prossimo a te. Siamo per lui quel che
ci è possibile, finché non trovi una sposa degna e anche allora facciamo che
si sia insieme e insieme si rimanga!".
- Che diranno ora i nostri amici? – cominciò Natalia. – Suo fratello non sa
nulla di tutto ciò? – chiese Wilhelm – Niente, come tutti quelli di casa
sua. La cosa per ora è trattata solo da noi donne. Per quanto riguarda Lidia,
si era già prima accordata con mio fratello che si sarebbero scambievolmente
partecipati il loro matrimonio, ma che non si sarebbero consigliati prima. -
Natalia scrisse una lettera a Lotario, invitò Wilhelm ad aggiungerci qualche
parola: Teresa l'aveva pregata di ciò. Stavano per sigillare la lettera, quando
inaspettatamente si fece annunciare Jarno.
Fu accolto nel modo più cortese: pareva molto allegro e desideroso di
scherzare, e alla fine non poté fare a meno di dire: - Veramente vengo qui per
portarle una notizia molto strana, ma pur bella che riguarda la nostra Teresa.
Lei ci ha qualche volta biasimati bella Natalia, di occuparci di tante cose; ma
guardi ora, come è bene avere dovunque degli informatori. Indovini e ci mostri
ancora una volta la Sua sagacità. -
La compiacenza con cui pronunziò queste parole, l'aria maliziosa con cui
riguardò Wilhelm e Natalia, convinsero tutt'e due che il loro segreto era stato
già scoperto. Natalia rispose sorridendo: - Siamo molto più esperti che Lei
non pensi, abbiamo già messo in carta lo scioglimento della sciarada prima
ancora che ci fosse proposta. -
Con queste parole gli tese la lettera diretta a Lotario e fu lieta di sfuggire
in tal modo alla sorpresa e alla confusione che a loro eran state preparate.
Jarno prese il foglio con un certo stupore, lo scorse soltanto, restò sorpreso,
lo lasciò cadere di mano e con grandi occhi guardò tutti e due con
un'espressione di meraviglia, quasi di spavento che non si era usi a vedere sul
suo viso. Non disse parola.
Wilhelm e Natalia furono non poco colpiti. Jarno andava su e giù per la stanza.
- Che devo dire! o, meglio, lo devo proprio dire? – esclamò - Allora segreto
contro segreto! Sorpresa contro sorpresa: Teresa non è figlia di sua madre!
L'impedimento è tolto: io venivo per pregarli di preparare la nobile ragazza
alla sua unione con Lotario. –
Jarno scorse la costernazione dei due amici che abbassarono gli occhi a terra.
Egli disse: - Questo è uno di quei casi che peggio di ogni altro si sopportano
in compagnia. Quel che ognuno ha da pensare sull'accaduto, lo pensa meglio di
tutto in solitudine; io, per lo meno, domando un'ora di permesso. - Si affrettò
verso il giardino e Wilhelm lo seguì macchinalmente, ma a distanza.
Dopo un'ora si ritrovarono. Wilhelm prese la parola e disse: - Altre volte,
quando io vivevo sconsideratamente, senza piano né scopo, mi venivano incontro
a braccia aperte, quasi mi si affollavano intorno, amicizia, amore, simpatia,
fiducia; ora che prendo tutto con serietà, sembra che la sorte voglia prender
con me altri modi. La decisione di offrire a Teresa la mia mano è la prima che
interamente venga, da me stesso. Feci il mio piano riflettendo, la mia ragione
era pienamente d'accordo e coll’assentimento dell'impareggiabile ragazza si
adempirono tutte le mie speranze. Ora la sorte più strana butta giù la mano
tesa. Teresa mi porge da lontano la sua - come in sogno - e io non posso
afferrarla e la bella visione scompare per sempre! –
Tacque un momento, con lo sguardo assorto, e Jarno voleva parlare. - Mi lasci
dire ancora qualcosa, l'interruppe Wilhelm, poiché si tratta ora di tutta la
mia vita. In questo mi viene in aiuto l’impressione che la presenza di Lotario
mi fece la prima volta e che mi è restata invariata. Quest'uomo merita ogni
specie di affetto e amicizia, e senza sacrificio non è possibile nessuna
amicizia: per lui mi sarà possibile rinunziare alla sposa più degna. Vada, gli
racconti la strana storia e gli dica a che cosa io sono pronto. - Jarno rispose:
- In tali casi ritengo che tutto si risolva da sé a patto che non si agisca con
precipitazione. Non facciamo passo alcuno senza il consentimento di Lotario.
Voglio andare da lui, attenda calmo il mio ritorno o una sua lettera. –
Partì a cavallo e lasciò i due amici nella più grande tristezza. Ebbero tempo
di ripensare in più di una maniera all’avvenimento e di fare le loro
osservazioni. Ma il loro stupore crebbe al sommo quando il giorno di poi, venne
un messo di Teresa che recava a Natalia la seguente inattesa lettera:
"Per quanto strano possa parere, devo alla mia lettera precedente farne
seguire subito un'altra e pregarti di mandarmi in fretta il mio sposo. Egli deve
diventare mio marito, qualunque cosa facciano per rubarmelo. Dagli la lettera
qui acclusa! Ma che non ci sia nessun testimone, chiunque sia". La lettera
a Wilhelm diceva così:
"Che penserà della Sua Teresa, se essa ad un tratto appassionatamente
sollecita un'unione che parve iniziarsi solo con la ragione più calma. Non si
faccia trattenere da nulla e parta appena ricevuta questa lettera. Venga caro,
caro amico mio, ora tre volte amato, giacchè mi si vuol togliere a Lei, o per
lo meno si cerca di rendere difficile la nostra unione".
- Che si deve fare? - esclamò Wilhelm, dopo letta la lettera. - In nessun altro
caso il mio cuore e la mia ragione han tanto taciuto come in questo momento,
rispose Natalia dopo aver un po' riflettuto; non saprei che fare, come non so
cosa consigliare. - E aggiunse: - Solo un po’ di pazienza, solo un po' di
tempo per riflettere. In questo strano concatenamento, io so solo questo: che
non dobbiamo fare con precipitazione cose che poi non possiamo revocare. Se mio
fratello ha davvero qualche speranza di unirsi con Teresa, sarebbe allora
crudele strapparlo per sempre a una felicità. Aspettiamo soltanto per vedere se
egli sa qualcosa, se crede, se spera. - Ad appoggiare i motivi del suo
consiglio, venne fortunatamente una lettera di Lotario: “Non rimando Jarno;
una riga di mia mano ha più valore per te che le parole dettagliate di un
messo. Son certo che Teresa non è figlia di colei che si riteneva fosse sua
madre, e non posso quindi abbandonare la speranza di unirmi a lei sinché ella
non sia pure convinta di questo nuovo fatto, e allora, con calma riflessione,
decida fra me e l'amico. Non lo lasciare andar via da te, ti prego! Ne dipendono
la felicità, la vita di un fratello. Ti prometto che quest'incertezza non deve
durare a lungo". - Lei vede come sta la cosa – diss’ella amichevolmente
a Wilhelm: - mi dia la Sua parola d'onore di non uscire dalla casa. - Gliela do!
- esclamò dandole la mano: - non voglio lasciare questa casa contro il Suo
volere. Ringrazio Dio e il mio buon genio che questa volta sarò guidato proprio
da Lei. -
Natalia scrisse a Teresa come stavano le cose dichiarandole che non avrebbe
lasciato partire il comune amico e nello stesso tempo le mandò la lettera di
Lotario.
Teresa rispose:
"Sono sorpresa non poco che Lotario stesso si sia convinto, poiché
immagino che di fronte a sua sorella non vorrà simulare sino a questo punto.
Sono tuttavia irritata, molto irritata. È meglio che non dica altro. Meglio di
tutto è che io venga da te non appena avrò messo a posto la povera Lidia che
è stata trattata troppo crudelmente. Se il mio amico non si libera, vengo io
fra qualche giorno per cercarlo presso di te e per non lasciarlo mai più. Ti
meravigli che questa passione si sia impossessata della tua Teresa? Non è
passione, è convincimento che, non potendo esser mio Lotario, questo nuovo
amico farebbe la felicità della mia vita! Diglielo in nome di Teresa che ha
accolto la sua offerta con tanta affettuosa franchezza. Il mio primo sogno di
come avrei vissuto con Lotario, è lontano dalla mia anima; il sogno di come
penso di vivere col mio nuovo amico, mi è ancora presente. –
Io mi rimetto in Lei - disse Natalia a Wilhelm dandogli la lettera di Teresa;
spero che non mi sfuggirà. Pensi che lei ha in mano pure la felicità della mia
vita. La mia esistenza è così intimamente unita e radicata nell’esistenza di
mio fratello ch’egli non può provare dei dolori senza che anch'io li provi,
nessuna gioia che non sia anche la mia gioia. -
Si arrestò, Wilhelm le prese la mano esclamando: - Oh, prosegua questo è il
momento di una scambievole confidenza! non abbiamo avuto più di ora bisogno di
conoscerci più a fondo. -
Così parlando erano andati camminando su e giù per il giardino. Natalia aveva
colti vari fiori di strana forma ch’erano del tutto sconosciuti a Wilhelm e di
cui le chiese il nome. - Lei certo non s’immagina, disse Natalia, perché io
colgo questo mazzo? È per mio zio di cui ora vogliamo visitare la tomba. Il
sole splende adesso così vivamente verso la "Sala del Passato" che io
devo condurvela né io ci vado mai senza portare alcuni fiori che mio zio
particolarmente prediligeva.
Con queste parole erano arrivati all'edificio principale. Natalia lo condusse
attraverso un ampio corridoio sino a una porta, dinanzi a cui stavano due sfingi
di granito. La porta stessa, secondo l'architettura egiziana, era in cima un po'
più ristretta che alla base, e i suoi battenti di bronzo preparavano a una
vista severa. Ma come si era poi dolcemente sorpresi quando questa impressione
attesa si cambiava nella più pura letizia e si entrava in una sala in cui arte
e vita toglievano ogni ricordo della morte e della tomba. Di faccia alla porta,
su un magnifico sarcofago, si vedeva la statua di un uomo imponente, appoggiato
su un cuscino. Dinanzi a sé teneva un rotolo e pareva vi leggesse con profonda
attenzione. Natalia, togliendo un mazzo appassito, mise quello fresco alla
figura dello zio. - Qui abbiamo passato molte ore - disse Natalia - prima che
questa sala fosse finita. Nei suoi ultimi anni, mio zio aveva chiamato a sé
alcuni abili artisti e il suo più gradito passatempo era di aiutarli a
immaginare e a eseguire i disegni e i cartoni per queste pitture. -
Wilhelm non poteva saziarsi di ammirare gli oggetti che lo circondavano. -
Quanta vita è racchiusa in questa "Sala del Passato"! - esclamò - Si
potrebbe chiamarla ugualmente bene la sala del presente e dell'avvenire - Mentre
stavano per andarsene, Natalia disse: - Devo richiamare la Sua attenzione su una
cosa ancora. Osservi quelle aperture semicircolari su in alto, da tutt'e due le
parti! Là possono star nascosti i cori. Negli oratori e nei concerti, ci
disturba sempre la figura del musicista: la vera musica è solo per l'orecchio,
una bella voce è la cosa più vaga che si possa pensare, e se l'individuo da
cui essa emana, col suo corpo determinato, compare innanzi gli occhi, distrugge
il puro effetto di quella vaghezza.
Lasciarono la sala quando udirono i ragazzi che correvano con furia nel
corridoio, mentre Felice gridava: - No, io! no, io? - Mignon si gettò per prima
dentro la porta stretta. Era senza respiro e non poteva parlare. Felice, ancora
a una certa distanza, gridò: - Mamma Teresa è là! -
I ragazzi avevano fatto scommessa, pare, a chi portava prima la notizia. Mignon
giaceva nelle braccia di Natalia, il cuore le batteva fortemente. – Cattiva! -
diceva Natalia - non ti ho proibito ogni moto violento? guarda come batte il tuo
cuore! - Lascialo schiantare! - disse Mignon con un profondo sospiro - batte già
da troppo tempo.
Si erano appena riavuti da questa confusione, da questa specie di spavento, che
Teresa entrò. Volò verso Natalia, abbracciò lei e la cara Mignon. Poi si
rivolse a Wilhelm con occhi sereni e disse: - Così, amico mio, come va? Lei non
si è lasciato scuotere? - Egli fece un passo verso di lei; ella gli saltò al
collo. - Oh Teresa mia! - gridò - Amico mio, mio amato, mio sposo! Sì, in
eterno tua! - ella esclamò fra i baci.
Felice la tirava per la gonna, e diceva: - Mamma Teresa, ci sono anch'io. -
Natalia era lì ritta e guardava innanzi a sé. Mignon d’un tratto portò la
mano sinistra al cuore e stendendo con forza il braccio destro, cadde con un
grido ai piedi di Natalia, come morta.
Lo spavento fu grande: non c'era più traccia di moto né nel cuore né nel
polso. Wilhelm la prese in braccio e la portò presto su mentre il corpo gli
pendeva dalle spalle senza vita. La presenza del medico dette poco sollievo:
egli e il giovane chirurgo, si dettero invano ogni premura. Non si poteva
richiamare in vita in nessun modo la magnifica creatura.
Natalia fece cenno a Teresa. Questa prese il suo amico per mano e lo portò
fuori della stanza. Egli era annichilito e senza parola, e non aveva il coraggio
di alzare gli occhi. Così si sedette presso di lei sul canapè su cui la prima
volta aveva trovato Natalia. Ci sono momenti nella vita, in cui avvenimenti -
simili a spole alate - si muovon qua e là, dinanzi a noi e irresistibilmente
compiono un tessuto che noi stessi abbiamo più o meno filato e ordito.
- Amico mio, - disse Teresa rompendo il silenzio e prendendolo per mano –
questi sono gli avvenimenti a sopportare i quali bisogna essere due nel mondo.
Pensa, senti, che tu non sei solo, perché tu dividi con me i tuoi dolori! - Lo
abbracciò e se lo strinse dolcemente al seno; egli la prese nelle braccia e la
serrò fortemente a sé. Ma nel suo spirito c'era tristezza e vuoto e solo
l'immagine di Mignon fluttuava dinanzi alla sua fantasia. Natalia entrò.
Wilhelm si staccò dalle braccia di Teresa. - Dove vuole andare? - chiesero le
due donne. - Lasciatemi vedere la bimba che io ho uccisa! - esclamò. - Andiamo
a vedere quel povero angelo morto! Il suo aspetto sereno ci dirà ch’ella è
felice! - Poiché le due amiche non potevano trattenerlo, lo seguirono; ma il
buon medico, che venne loro incontro col chirurgo li trattenne d’avvicinarsi
alla defunta e disse: - Mi permettano, per quanto può la mia arte, di dare un
po' di durata alle spoglie di questo caro essere dandogli pure l'aspetto della
vita. Mi concedano ancora qualche giorno di tempo e non chiedano, per favore, di
rivedere la cara bimba sinché non l'avremo portata nella "Sala del
Passato". -
Gli amici non ebbero tempo sufficiente per dare più diffusi schiarimenti alla
signorina Teresa sulla bimba e sulla causa probabile della sua morte inattesa;
poiché furono annunciati degli stranieri che, non appena comparvero, si vide
che stranieri non erano.
Lotario, Jarno e l’Abate entrarono. Natalia andò incontro al fratello; fra
gli altri si fece momentaneo silenzio. Teresa disse sorridendo a Lotario: - Lei
non credeva certo di trovarmi qui; per lo meno non è opportuno che ci
avviciniamo in questo momento, ma intanto, dopo una così lunga assenza, La
saluto cordialmente. -
Lotario le tese la mano e disse: - Una volta che dobbiamo soffrire e rinunziare,
ciò può anche essere in presenza d'un bene amato e desiderato. Non domando di
avere nessuna influenza sulla Sua decisione e la mia fiducia nel Suo cuore,
nella Sua ragione e nel Suo puro intendimento è sempre tanto grande che io
posso deporle volentieri nelle mani la sorte mia e del mio amico. -
La compagnia si divise ben presto in singole coppie per andare a passeggiare.
Natalia andò con Lotario, Teresa con l'Abate, e Wilhelm rimase nel castello con
Jarno.
La sera l’Abate li invitò alle esequie di Mignon.
La compagnia si recò nella "Sala del Passato" e la trovò stranamente
ornata e illuminata. Le pareti erano coperte di tappeti azzurro-cielo dall'alto
fin quasi in basso, cosicché apparivano solo la base e il fregio.
Sui quattro candelabri negli angoli ardevano grandi candele di cera e, così in
proporzione, sui quattro più piccoli che circondavano il sarcofago centrale.
Vicino a questo stavano quattro ragazzi vestiti di celeste e d’argento, e
pareva che facessero aria con larghi ventagli di struzzo ad una figura che
giaceva.
La compagnia si sedette e due cori invisibili incominciarono a chiedere con voce
soave:
- Chi ci portate al tacito avello? - I quattro bimbi risposero con tenue voce: -
Una compagna dei nostri giuochi noi vi portiamo, fatela riposare tra voi, fino a
che il giubilo la desti delle coorti celesti. –
Coro
O primizia di gioventù, sii benvenuta nelle nostre accolte, benvenuta in
tristezza!
Non ti segua un bimbo, non ti segua nessuna fanciulla! Solo vecchiezza,
spontanea e pacata, si accosti al tacito portico e tra compagni austeri riposi
la cara, ammirevole fanciulla.
Fanciulli
Ah! con che tristezza noi la portiamo qua! Ah! e deve restarvi! Lasciate
restare anche noi, lasciateci piangere sulla sua tomba.
Coro
Vedete, vedete le ali possenti! Guardate la pura veste leggera! e splende
dal capo la benda d'oro! vedete il bello, il degno riposo!
Fanciulli
Ah! che non s’alzano l'ali, e in giuochi leggeri più non ondeggia la
veste; quando di rose adorneranno il suo capo, amica e benigna lei ci guardava.
Coro
Guardate con gli occhi dell'anima! in voi viva la forza che crea, la forza
che porta il più bello, il più alto, sopra le stelle: la vita.
Fanciulli
Ma ahimé noi qui la desideriamo invano; più non s'aggira pei giardini, più
non raccoglie nei prati i fiori. Lasciateci piangere, noi la lasciamo qui!
Lasciateci pianger, restare con lei!
Coro
Bimbi, tornate di nuovo alla vita! l'aria fresca vi asciughi le ciglia,
l’aria che gioca intorno all'acqua scorrente. Fuggite la notte! Il dì, la
gioia e la perpetuità sono la parte del vivente.
Fanciulli
Orsù, torniamo alla vita. Il giorno ci dia gioie e lavoro, sinché sera ci
rechi riposo e il sonno notturno ci ristori.
Coro
Bimbi! tornate alla vita! Nella pura veste della bellezza vi incontri
l’amore con lo sguardo celeste e la corona d’immortalità.
I ragazzi erano già lontani; l’Abate s’alzò dalla sua sedia e si mise
dietro la bara. - È ordine dell'uomo che ha preparato questo silente soggiorno,
egli disse, che ogni nuovo arrivato vi venga accolto con solennità. Dopo di
lui, costruttore di questa casa, fondatore di questi luoghi, noi abbiamo per
prima qui condotta una giovane straniera, e così questo piccolo spazio
rinchiude già due diversissime vittime della severa, capricciosa, inflessibile
dea della morte. Noi nella vita entriamo secondo leggi prescritte, sono contati
i giorni concessici a maturare fino a vedere lo splendore della luce, ma per la
durata della vita non c'è legge. Il più sottile filo di vita si protrae in
inaspettata lunghezza, ed il più forte è troncato a forza dalle forbici
d’una parca che pare si diletti di contraddizioni.
Della bimba che noi qui seppelliamo, sappiamo dire ben poco. Ancora ci è
sconosciuto donde veniva, non conosciamo i suoi genitori e possiamo solo
supporre il numero dei suoi anni. Il suo cuore profondo e rinchiuso ci ha
lasciato indovinare appena le sue condizioni più intime; nulla v'era di
comprensibile in lei, nulla di manifestato, se non l'amore per l'uomo che la
salvò dalle mani di un barbaro. Questo tenue affetto, questa viva gratitudine
fu quasi la fiamma che divorò l'olio della sua vita; l'abilità del medico non
poté conservare la sua bella vita, l'amicizia con le cure più amorevoli non
poté prolungarla. Ma se l'arte non poté incatenare lo spirito che si partiva,
ha per altro impiegato tutti i suoi mezzi al fine di conservare il corpo e
sottrarlo alla caducità. Una sostanza balsamica è penetrata attraverso tutte
le vene e colora adesso, invece del sangue, le guance così presto impallidite.
Avvicinatevi, amici miei, e guardate il miracolo dell'arte e dello zelo!
Levò il velo, e la bimba giaceva nelle sue vesti da angelo, come dormendo nella
posa più bella. Tutti s'appressarono e ammirarono quella parvenza di vita. Solo
Wilhelm restava a sedere e non poteva riaversi; non osava pensare a quel che
sentiva ed ogni pensiero pareva voler distruggere i suoi sentimenti.
L'Abate continuò: - Con santa fiducia, questo cuore così buono, così chiuso
verso gli uomini, fu costantemente rivolto a Dio. L’umiltà, quasi
un'inclinazione ad abbassarsi esternamente, parevano innate in lei. Con zelo si
teneva fedele alla religione cattolica, in cui era nata ed educata. Spesso ella
espresse il desiderio di riposare in terra consacrata e, secondo il rito della
chiesa, noi abbiamo consacrato questo involucro marmoreo, e la poca terra
nascosta nel suo origliere. Con che fervore ella baciò negli ultimi momenti
l'immagine del crocifisso che sta leggiadramente disegnata con mille punti, sul
suo tenero braccio! - E dicendo questo alzò la manica del braccio destro e si
vide un crocifisso azzurrognolo accompagnato da lettere e segni sulla pelle
bianca.
Premendo una molla l'Abate fece scendere lentamente il corpo nelle profondità
del marmo. Quattro giovani, vestiti come i ragazzi di prima, uscirono di dietro
il tappeto a tenda, sollevarono sulla bara il pesante coperchio bene adornato, e
incominciarono il loro canto.
I Giovani
Ben serbato è oramai il tesoro, la bella immagine del passato!
Qui nel marmo riposa incorrotto ed anche nei vostri cuori continua a vivere, a
operare. Tornate! tornate alla vita! prendete con voi la sacra austerità; poiché
la severità, soltanto, la sacra, tramuta la vita in eternità!
L'invisibile coro si unì nel canto alle ultime parole, ma nessuno nella
compagnia comprese le parole di conforto; ognuno era troppo occupato dei propri
sentimenti. E solo quando il canto fu interamente svanito ricominciarono con
nuova forza il dolore, le riflessioni, i pensieri; ed ognuno desiderava
ardentemente di ritornare in quell'atmosfera armoniosa.
J. Wolfgang von Goethe
(1749-1832)
36
- I sacrifici che valgono (Giovanni Ferreri (l884- ?)
L’umanità
è sempre stata considerata dagli spiriti svegli come una grande malata, non
solo per i mali di cui soffre perennemente ma anche per i rimedi che essa si dà
e dei quali, come si sa, non uno procura la guarigione, anzi neppure un
lenimento. L'amabile scetticismo di un poeta non disturbava nemmeno la
farmacopea per scegliere l’immagine sconsolata atta a scolpire ironicamente la
realtà. Per lui i rimedi che la umanità si somministra fanno assumere alla
grande ammalata soltanto la configurazione dell’infermo che si gira e si
rigira nel letto trovando un momentaneo sollievo nel mutar di posizione, e non
ha ancora goduto bene del sollievo, che già diventa urgente tornare a quella di
prima.
Si può fondare su tale concezione, se di vuole, tutta una filosofia, tutta una
scienza politica ed una sociologia, tutta una morale ed una pedagogia. Ma questo
porterebbe fuori del nostro terreno. E d'altra parte non vogliamo recare alcun
soccorso allo scetticismo che è anche troppo pronto ad avvelenare l'anima umana
paralizzandone la capacità d'azione, distruggendo ogni fede che è slancio
verso il meglio in cerca del bene, sempre implicito riconoscimento del Bene
eterno cui deve far capo la vita, fede della quale abbiamo assoluto bisogno, non
foss'altro in quel suo albore che chiamiamo la speranza.
Ma la nostra fede è fede che vuole essere illuminata ed una speranza che vuol
darci il più solido fondamento.
Com’è difficile trovare quell'assoluto di cui e la fede e la speranza hanno
bisogno per sentirsi ancorate a qualche cosa che non partecipi della labilità
universale. Più si avanza nell'esperienza e più si diventa umili ed esitanti
nel dogmatizzare, mentre si cerca sempre più verso l'assolutamente altro il
proprio punto d'appoggio. E voi sapete che oggi chi dogmatizza di più lo fa
lanciando strali contro il dogma.
Non neghiamo nessuno dei valori umani e niente che possieda, anche soltanto un
po' della loro polvere d'oro. Esaltiamo tutte le virtù. Ma dei valori umani
vediamo il caduco e delle virtù scorgiamo lucidamente i limiti oltre i quali
esse stesse diventano vizi o conducono al vizio, proprio come da tanti vizi (sol
che si muti l'orientamento spirituale), possono scaturire, tante virtù.
Ci sono delle virtù che possono rendere angusti e angustiare la vita degli
altri.
Vero è che il bene altrui può derivare proprio dall'angustiargli la vita. Le
medicine efficaci fanno sempre più o meno soffrire o recano qualche noia. Ma
posti su questo terreno, i virtuosi vanno spesso tormentando il prossimo senza
alcun costrutto, almeno per il prossimo.
Peggio ancora; perché l'inganno è più sottile: si può aduggiare il prossimo
e non giovargli punto anche tormentando soltanto se stessi, con la migliore
delle intenzioni; per esempio: quella di sacrificarsi per gli altri. Ci sono
creature che a furia di sacrificarsi per gli altri sono diventate cagione di
sacrificio per questi stessi altri in pro dei quali si sacrificavano.
C’è un veleno insidiosissimo il cui reperto è quanto mai difficile e che
rende malefiche tante cose buone. È il nostro egoismo che si dissimula nelle
maniere più impensabili.
Invero: anche nel sacrificarsi si può soltanto soddisfare una propria brama.
Nobile brama, dite voi. Non sempre. Come esiste un terribile egoismo nelle
persone che amano più intensamente ed è difficile salvarsi dall’egoismo di
chi ama di un amore che è soltanto natura, così è possibile nel sacrificio
seguire inconsciamente una falsa pista che è quella della soddisfazione di una
propria brama.
Amore e egoismo si fondono stranamente insieme. È difficile tracciarne i
confini. Per questo è così difficile delineare i contorni del sacrificio che
giova agli altri ad è provocato da una evidente loro necessità, per
distinguerlo da quello che muove soltanto dal bisogno proprio.
Inutile pensare che il cuore sia lui la guida infallibile. L'esperienza è già
stata fatta. Ad un certo punto il cuore si deve dare per vinto di fronte agli
inestricabili garbugli che crea, e chiamare in soccorso la ragione, tanto
disprezzata, per mettere un po' in sesto le faccende della propria esistenza;
finché la ragione stessa - mettendo troppo a sesto - crea le condizioni della
prossima rivolta del cuore.
E così...all'infinito? Dobbiamo proprio accontentarci di un equilibrio
instabile? E sarà sempre questo il prodotto di opposte esperienze? Nulla dunque
su cui appoggiarsi definitivamente?
Nulla. Fuorché Dio.
I sacrifici rituali perdevano nelle epoche di decadenza religiosa la loro
significazione e il loro valore, ed i profeti potevano dire che Dio non li
gradiva (…) Così i nostri sacrifici per gli altri possono subire la stessa
sorte quando venga ad esaurire il contenuto spirituale che non è dato solo
dall'amore, ma dall'amore che viene dal nostro essere ancorati in Dio per fede.
Qui è la speranza del mondo, perché senza quest'ancoraggio, tutto il
relativismo che è nella vita, tutto il contraddittorio che è nelle cose e
perfino quello della ragione, tutto il cumulo delle esperienze fallimentari del
vivere, trascinano al nichilismo più esasperato quanto assurdo, dato che la
vita mostra da sé di essere più forte di ogni fallimento e al di sopra di
tutto l'ondeggiare del vivere e più logica di tutto il nostro ragionare.
Mentre dunque noi scopriamo i limiti contro i quali anche le più alte virtù
cozzano, noi cerchiamo il nostro equilibrio sempre rinnovantesi, nel
senza-limiti: in Dio, Infinito e assoluto amore.
Giovanni Ferreri (l884- ?)
37
– L’Evangelo della ragione (Gotthold
Ephraim Lessing)
… la strada, sulla quale il genere umano perviene alla sua
perfezione, deve averla prima percorsa ciascun singolo uomo, chi prima, chi dopo
- Averla percorsa in una e medesima vita?
Può egli essere stato nella stessa vita un Giudeo sensista e un Cristiano
spirituale? Può averli riuniti entrambi in una medesima vita?
Questo no, senza dubbio! - Ma perché ciascun singolo uomo non potrebbe essere
stato più di una volta a questo mondo? –
Forse questa ipotesi è o così risibile perché è la più antica? E perché
l’intelletto umano, prima che la sofistica della scuola lo avesse disperso e
indebolito, subito si rivolse ad essa?
Perché non dovrei anche poter avere già fatto qui una volta tutti i passi per
il mio perfezionamento, cui possono arrecare solo le pene e le ricompense
temporali degli uomini?
E perché non un'altra volta tutti quelli, che ci aiutano così potentemente a
fare le previsioni di ricompense eterne?
Perché non dovrei ritornare tanto spesso, quanto sono destinato ad ottenere
nuove conoscenze, nuove capacità? Forse ch'io a bella prima ho così
progredito, che non valga la pena di ritornare?
Perché? - O forse, perché mi dimentico, che già sono esistito? Bene per me,
ch’io me ne dimentichi: la reminiscenza delle mie precedenti condizioni non mi
permetterebbe che di fare un cattivo uso della presente. E ciò che ora debbo
dimenticare l'ho poi dimenticato per sempre?
O forse, perché andrebbe perduto per me tanto tono? - Perduto? - E che cosa ho
da perdere? Non è mia tutta l'eternità?
Gotthold
Ephraim Lessing (1729-81)
38
- La vittoria sulla caducità (V. Solovev)
...Che la vita naturale carnale
non solamente nella forma grossolana di male, ma legata anche con le forme della
socialità umana sia una via cattiva e falsa, lo si sapeva prima del Cristo. Lo
sapevano i savi dell'India, i bramini ed i buddisti; lo sapevano i filosofi
greci, Platone ed i suoi seguaci. Ma è insufficiente conoscere e condannare
questa via perversa, che i filosofi platonici mostravano nel mondo ideale della
verità, bellezza e bene sussistente per sé; fa mestieri mostrare realmente che
questa vita esiste, fa mestieri portare questa vita nell'uomo e nella natura
rivelando in essi ciò che si nasconde in questa vera vita. E se questa è la
vera vita, essa non può divenire impotente e inattiva: essa, deve vincere la
falsa e perversa vita, e sottomettere la legge cattiva di essa con la sua
grazia.
Il fondamento della vita carnale è la malizia, la sua fine, la morte e la
corruzione. Il principio della vera vita, l'amore, vince la malizia e la sua
conclusione, la resurrezione, vince la morte. Se la morte e la corruzione sono
invincibili, ciò vuol dire che la legge della vita animale, la legge del
peccato e della schiavitù, è l'unica legge del mondo; ciò vuol dire che la
vita della carne è la vita reale e non vi è altra vita nella realtà: non solo
nell'immaginazione e nei pensieri umani; ciò vuol dire, che in Verità vi è
solamente il torrente della materia, e tutto il resto, sogni vuoti di senso; e
se così è, noi dobbiamo vivere al momento che scorre, dobbiamo gozzovigliare e
godere il giorno di oggi. Tutto quello che ieri avvenne è già trascorso e non
ritorna, e domani noi stessi morremo.
E se l'altra vita spirituale non è solamente un sogno, essa deve manifestarsi
nelle sole sensazioni e desideri, non nei soli pensieri e parole, ma in realtà,
nella vittoria reale dello spirito sovra la natura materiale. Ed una tale
vittoria della forza spirituale della materia deve avere totalmente un altro
carattere che la vittoria di una forza materiale sovra un'altra nella lotta
naturale per l'esistenza, nella quale il vinto è offerto in sacrificio, è
inghiottito e annientato. Il principio spirituale, specialmente nella sua
vittoria sulla natura ostile, deve mostrare la sua preminenza, nel non divorare
ed annientare questa natura vinta, ma nel ristabilirla in una nuova miglior
forma di essere. La risurrezione è l'interna conciliazione della materia con lo
spirito, col quale essa qui forma un solo essere come la sua reale espressione,
come il suo "corpo spirituale". La finale e distintiva verità, del
cristianesimo consiste nella spiritualizzazione e divinizzazione della carne.
Non vi è niente di più contrario, a questa verità che lo spiritualismo
unilaterale. L’incarnazione e la risurrezione del Logos è un triplice
trionfo: qui vi sono tre principi dell'essere: il divino, il materiale e
l’umano rivelano la loro importanza assoluta. Dio è glorificato nel mondo
perché si rivela come un essere attivo, sostegno di tutto l'infinito il quale
non solo limita la forza estranea della materia e non solo distingue da sé la
sua non verità ma anche penetra nel profondo del suo essere come in se stesso,
internamente sottomettendola e assimilandola a se stesso e attenuandosi in essa.
Ciò è un compimento e un trionfo della natura materiale. Perché prima
dell'apparizione dell’uomo spirituale la forza della natura in ogni essere, la
sua peculiare volontà vivente nella sua tendenza verso l'essere infinito, è
dominata dalla legge della specie, sotto il cui giogo perisce ogni individuo; e
quantunque l'uomo naturale può penetrare nel dominio dell’essere eterno, solo
per via di contemplazione, la sua vita personale resta soggetta alla legge
dell'essere materiale, al lavorio della morte e della corruzione come la vita
delle altre creature. Solamente nell'incarnazione e risurrezione del Dio-uomo,
l'essere naturale nella forma di organismo umano prima soddisfa la sua pretesa
limitata, conseguendo per sé la pienezza e l'integrità della vita divina. La
rovina di un individuo naturale non è la soluzione della contraddizione del
mondo fra il particolare e l'universale, ma la sua risurrezione e l'eterna vita.
Ed infine, questa soluzione è raggiunta mediante la ragionevole e libera azione
della volontà umana. La condizione della risurrezione è l'eroismo, quell'atto
della personalità divino-umana col quale il Cristo si strappò alla legge del
peccato e si sottomise all'assoluta volontà divina, facendo del suo principio
umano il canale della azione divina nella natura materiale. Quando in tal modo
la radice del male del mondo fu strappata, il suo frutto, la morte fu abolito
dalla risurrezione nella quale, per conseguenza, insieme con Dio e la materia,
trionfa il principio umano che li congiunge entrambi.
La perfetta incarnazione, del senso (ratio) divino nel Cristo libera il
principio umano per una nuova attività. Se l'antica umanità cercava solamente
Dio, e perciò non poteva vivere secondo Dio, per la nuova, umanità – per la
quale il vero Dio è rivelato nel Cristo - vi è l'obbligazione di vivere
secondo Dio, cioè attivamente assimilarsi e restituire i semi della vita divina
manifestati in essa. Ad essa non è più necessario cercare la verità, la verità
è data. Essa deve attuarla nella realtà: e poiché la verità data è
assoluta, infinita, essa deve essere realizzata i tutta la sua realtà, in tutta
la pienezza dell’essere naturale ed umano il quale non deve offrire nessun
limite a questa verità V affinché Dio sia tutto in tutti. Al mondo antico era
sufficiente contemplare la divinità come idea, il nuovo mondo, che ha la
visione della divinità come reale apparizione, non può limitarsi alla
contemplazione: esso deve vivere ed agire in virtù del principio divino che si
rivela in lui, trasformando se stesso ad immagine e somiglianza del Dio vivente.
L'umanità è tenuta non già a contemplare la divinità, ma rendere se stessa
divina. Conforme a ciò la nuova religione non può essere unicamente una
passiva venerazione di Dio e adorazione, ma deve realmente essere un’azione
riunita della divinità e dell'umanità per la trasformazione di quest'ultima,
da carnale e naturale, in spirituale e divina. Cioè non è una creazione dal
nulla, ma una trasformazione, una transustanziazione dalla materia nello
spirito, dalla vita della carne nella vita divina.
Vladimiro Solovev (1853-1900)
39
– Pestalozzi (Giovanni
Niederer)
L’attività esteriore della
vita di Pestalozzi (1746-1827), si svolse in un cerchio molto limitato. Il suo
viaggio più lungo fu da Zurigo a Lipsia, e persino nell'ambiente ristretto
della sua patria si dolse spesso di non essere riuscito a fare neppure un giro
nelle Alpi svizzere. In compenso seppe estendere la sua attività spirituale
nell’incommensurabile e, grazie ad una energia quasi senza confronto, riuscì
a vincere i limiti dello spazio e del tempo. Pari ad un vulcano portò la sua
luce a grande distanza suscitando l'attenzione dei curiosi, lo stupore degli
ammiratori, lo spirito investigatore degli osservatori e la partecipazione dei
filantropi di molti continenti.
Attirò a sé il mondo a cui egli non poteva giungere. Il mondo venne a lui e
dovunque penetrò la cultura, si divulgò se non la luce del suo spirito, la
fama del suo nome. Il carattere di questa creatura straordinaria, che io così
chiamo perché era ben più creatura umana che non solo virile riunendo in sé
le caratteristiche di ambedue i sessi in lineamenti inconfondibili, già per
questa ragione è più difficile da comprendere di quello che non si creda
generalmente, a meno che non si concepisca la semplicità come quella profondità
che è insieme base e compendio della molteplicità. Il suo modo d'agire, era
anch’esso straordinariamente ineguale e appariva necessaria un'assoluta
assenza di regole. Egli, infatti, sebbene con idee ben decise cercava sempre
qualcosa di nuovo e di diverso nei modi più molteplici, nel campo più vasto o
nelle direzioni più opposte. Le espressioni correnti e più comuni: animo
infantile, pia felicità, fervida dedizione non arrivano a spiegare quest'uomo.
La sua immagine, la struttura del suo corpo, il suo modo d'essere esteriore già
lo dimostrano: l'andatura ineguale, il modo d'apparire, di camminare, di
parlare, ora frettoloso, ora circospetto e come smarrito nel proprio pensiero,
ora precipitoso, ora ardito e imponente, il tono della sua voce modulato secondo
i vari sentimenti dell’anima; i tratti del viso composti di elementi
molteplici, contrastanti, mutevoli e mobili in tutte le direzioni; gli occhi
incavati ora luminosi come stelle e raggianti, ora ritirati in se stessi come se
si affissassero in una íncommensurabílità interiore, la fronte sfuggente
liscia e ardente, i capelli folti a ciuffi quasi irti sul cranio, le labbra
sottili eppur capaci di ingrossarsi, una bocca straordinariamente espressiva dal
punto di vista fisionomico ad attraente, per così dire assorbente ed
espellente, capace di esprimere ardore, giocondità, bontà, scherzo, scherno e
derisione a seconda dell'oggetto o dell'impulso; il complesso dei tratti del
volto esprimenti ora la più tenera mitezza, ora dolore lacerante e profonda
malinconia, ora spaventosa serietà, ora un paradiso di amore e di delizia che
poteva giungere fino a trasfigurarlo, il petto largo e prominente, il dorso
grosso incurvato, la vigorosa e diritta muscolatura: in breve, ciò che colpiva
in lui nei più piccoli come nei più grandi particolari, specialmente però la
quantità e la varietà di ciò che colpiva, annunciavano un individuo in cui
vibravano o avevano vibrato tutte la corde della natura umana. Candido e
fiducioso come un bambino; mite e cortese, delicato e sensibile come una donna,
fermo e volitivo, virile nell'osare e nell'imporsi, sempre pronto alla ripresa e
al sacrificio, superando gli ostacoli come un'eroe, e tutto questo partendo dai
più tenui moti e dalle minime risonanze nelle diverse situazioni della vita,
attraverso tutte le gradazioni fino al più sublime entusiasmo e al rapimento;
per contro mostrando nello stesso grado le debolezze e gli errori del lato
opposto di questa natura fino al dolore più lacerante, fino all'espressione più
furiosa della passione violenta: ecco cos’era personalmente Pestalozzi. Così
lo hanno visto i testimoni e collaboratori della sua opera educativa a Burgdorf,
a Münchenbuchsee e a Yverdon. Così lo abbiamo imparato a conoscere noi forse
meglio che nessun altro e vogliamo credere con futuro vero vantaggio
dell'educazione umana, neppure esperienze di questa sorta permettono di scrutare
sicuramente i germi del bene e del male della natura umana, condizione
indispensabile per rinvigorire i primi e soffocare i secondi, il che costituisce
la meta dell'educazione.
Il tratto fondamentale dell'individualità di Pestalozzi, l'essenza quasi della
personalità che penetrava, determinava, dominava tutte le sue altre doti era
l'originalità nel vero senso della parola. Il suo modo di essere e di agire era
proprio assolutamente suo e solamente suo. Pieno d'infinita eccitabilità, e
ricettività per quello che lo circondava, egli trasformava tutto ciò che
vedeva, udiva, toccava, trattava in quanto assorbiva tutto nella sua indole.
Tutto quello che diceva e faceva, scriveva e tentava non si appoggiava su niente
di quello che la società aveva accettato; le idee, le rappresentazioni altrui
non coincidevano con le sue, in realtà esistenti e generalmente valide. Tutto
ciò si riferiva a una totalità che viveva originariamente in lui, derivava dal
suo modo speciale di vedere il mondo e l'umanità e ogni sua singola espressione
o imprese, ora come un lampo di quella visione che irradiava in tutte le
direzioni: spesso sembrava lampeggiare come dalla notte e dalle nubi e aveva la
sua coerenza e il suo vero significato solo in essa e da essa separato appariva
in stridente contrasto col resto. Da questa originalità che è in sé il
marchio del genio, la testimonianza divina della forza creatrice, della
somiglianza di Dio nella natura umana, la quale se agisca pura nell'intimo e
indisturbata all'esterno produce le opere dal vero, del buono e del bello,
esaltatrice dell'uomo, derivò la bontà e la grandezza personale dal Pestalozzi;
essa fu però anche la sorgente di incassanti malintesi e sbagli e dei relativi
conflitti che derivarono nella sua esistenza. Questa originalità si rivelava in
lui come energia dello spirito e dell'animo separata dalla sua dedizione ed in
contrasto con essa. Nel Pestalozzi scrittore si mostrò l'impressionante effetto
della disarmonia, per esempio nel fatto che, malgrado tutta l’intima pienezza
poetica e malgrado tutti gli sforzi, egli con suo rammarico non poté mai esser
poeta; fece tutti gli sforzi per giungere alla forma poetica, senza poter
produrre una poesia. L'influsso di questa duplicità sulla sua opera e sul suo
destino fu ben più infelice. Dagli altri egli non accoglieva se non quanto già
in lui viveva, e per la stessa ragione, riusciva a essere e dare agli altri solo
ciò che esisteva esclusivamente nelle sua personalità, e individualità. Egli
capiva gli altri a suo modo e gli altri lo capivano nel loro, involontariamente
egli ingannava loro ed essi ingannavano lui. Così la sua originalità fin
dall'infanzia, divenne, per lui come per gli altri, insieme con una sorgente di
luce e di entusiasmo anche una fonte di sbagli e di traviamenti, di
contraddizione con se stesso e di lotta colla vita …
A questo si unì la sfortuna della sorte nella sua situazione esteriore. Quello
che la natura concede in pura e perfetta pienezza ad ogni epoca della vita
umana, quello che essa conferisce a ciascuno, in modo particolare egli lo gode
dal principio alla fine della vita solo frammentariamente e in disarmonia. Già
da bambino non trovò nessun saldo punto d’appoggio, di acquietamento
dell'animo; da giovanetto nessuna soddisfazione spirituale interiore. Il suo
agire fu quindi sempre tensione, un incessante scambiare e rifiutare un soggetto
per un altro, perché non riuscì a trovare in nessuno quell'infinito verso cui
la sua natura lo spingeva. Così gli accadde di cercare la soddisfazione di sé
nella quantità delle cose finite, la certezza della meta in una realtà non
definita e solo presagita. La sua posizione come uomo non era naturale e quindi
il suo sforzo dovette essere violento. Gli fu negata la soddisfazione
dell'impulso irresistibile che lo dominava in quel tempo di partecipare colle
suo idee e colle suo forze alla vita del popolo, alla società e al governo del
suo costume, cose a cui egli legittimamente aspirava sia per nascita che per
condizione sociale, l'impetuosa fiumana respinta cercava degli sbocchi come
poteva e scavava nel profondo. Ma non essendo preparato né spiritualmente né
eticamente all'interno, né civilmente né socialmente all'esterno, né infine
in ambedue i riguardi, non avendo avuto una cultura completa, né scientifica né
artistica, non fu capace né di dominare se stesso, né di scavarsi un letto
sicuro per il proprio corso. Per quanto producesse in ogni campo cose
eccellenti, non aveva però nessun punto d'appoggio, nessuna connessione con la
realtà. Egli si smarrì nella sua propria dispersione e in quella del suo
tempo. Questa cattiva sorte continuò fin nella sua vecchiaia e lo rese
irrequieto ed esageratamente eccitato. Per quanto alto salisse e per quanto
giovanilmente si riprendesse, le manchevolezz J. Wolfgang von Goethe
(1749-1832)a dei vari periodi precedenti della sua vita non poterono più
essere risanate e gli fu impossibile liberarsi dal loro peso...
Da questa eccentricità e dalle sue conseguenze derivò il compito che la sua
personalità dovette assolvere per tutta la vita, ogniqualvolta quell'eccentricità
veniva ad apparire. Fu cioè obbligato, per poter affermare la sua originalità,
a cercare incessantemente in sé il punto di gravità del suo stato personale e
dei movimenti del suo spirito e del suo animo e fuori di sé i punti di
collegamento con la condizione e coi movimenti della vita civile e sociale.
L'originalità, cioè l'energia di un'individualità è già di per sé
unilaterale. Ogni grande sforzo dell'individuo, come ogni suo decisivo
progresso, distrugge il suo equilibrio interno ed esterno ed esige che sia
ristabilito. Lo stesso sviluppo della natura umana consiste in un continuo
spostamento e ristabilimento del suo equilibrio. Ma per la sua eccentricità il
Pestalozzi non poteva trovare questo equilibrio né in sé né nella società,
come essa realmente era. Doveva conquistarselo in qualcosa, al di fuori e al
disopra di entrambi oppure rinunciarvi, cioè rinunciare, a se stesso. Da questo
bisogno derivò per psicologica necessità, la scelta dei soggetti ai quali egli
diresse il suo spirito e la sua attività. La società non gli offriva nessun
riconoscimento positivo in cui egli potesse compiacersi e soddisfare il suo
cuore; perciò egli fece di questa società l'oggetto delle sue osservazioni e
delle sue ricerche. Le professioni e i campi di attività allora esistenti non
gli offrivano uno sbocco libero, non ostacolato che desse un adeguato campo
d'azione alla pienezza della sua forza, un campo in cui egli potesse servire con
gioia il mondo e l'umanità e in cui valesse la pena d’impegnarsi secondo il
suo sentimento. Egli quindi s’abbandonò a tentativi, ossia, detto con altre
parole, creò nuovi campi d'attività. Respinto su se stesso egli si abbandonò
a un'instancabile introspezione, cercando la chiave del mistero del mondo e del
cammino dell’umanità negli abissi del suo essere intimo...
Nondimeno, data la singolarità delle sue attitudini a delle sue doti, proprio
queste difficoltà, e questi errori furono per lui il mezzo per cui egli tese
tutta le molle della sua natura, e fu guidato ad assolvere il suo destino nel
tempo e nel mondo, a portare una rivoluzione spirituale in mezzo al popolo e
agli uomini, riconducendo il processo di sviluppo e di educazione alla vera
natura umana, dando nella sua persona un esempio unico nel suo genere,
inesauribilmente istruttivo, sublime e tremendo nello stesso tempo, delle
condizioni da cui dipende il bene e il male della nostra stirpe e dei suoi
individui.
Giovanni Niederer (1779-….)
40
– Fondamenti per prolungare la vita (Giovanni
Amos Comenius)
1. Quanto alla brevità dalla
vita Aristotele insieme con Ippocrate si lamenta e se la prende con la natura,
perché ai cervi, ai corvi e ad altri animali concede di vivere parecchi anni, e
assegna alla vita dell'uomo, nato a cose importanti, termini tanto brevi. Ma
Seneca sapientemente risponde: “La vita non la riceviamo breve ma la rendiamo
breve noi: e non ne abbiamo meno del bisogno, ma ne facciamo un grande sciupio.
Se ne sai fare buon uso, la vita è lunga”. E lo stesso aggiunge: “ C'è
concessa una vita lunga abbastanza, e c'è data con larghezza sufficiente, per
condurre a fine le cose più importanti, se s'impiega tutta bene”.
2. E se questo è vero com'è di fatti, è dunque colpa nostra se la vita non ci
basta nemmeno per sbrigare le cose della massima importanza; e non c'è da far
la meraviglia perché noi stessi facciamo un grande sciupio della vita, parte
gettandoci alla violenza in modo che necessariamente la vita si deve estinguere
prima del naturale termine; parte spendendo i ritagli di tempo in cose da nulla.
3. Uno scrittore, di certo non ignobile, dice e prova, con argomenti che anche
l’uomo del più delicato temperamento, se viene alla luce senza mancamenti, ha
in sé tanta forza vitale, che gli basta naturalmente fino a sessant'anni e a
chi di temperamento fortissimo, fino a centoventi anni. Se alcuni muoiono prima
di questi termini (e chi non sa che si muore nell'infanzia, nella giovinezza e
nella virilità?) è colpa degli uomini che commettendo vari eccessi e non
tenendo conto della vita, mandan tanto male sia la salute loro propria, sia la
salute dei figlioli che possono generare, e affrettano la morte.
4. Che poi nella breve durata della vita (per esempio, di 50, 40, 30 anni) si
possa arrivare a eseguire, la parte più importante delle cose, purché si
sappia far buon uso del tempo, ce lo prova l'esempio di quelli che prima
d’aver compiuto gli anni della virilità, arrivarono dove altri non tentarono
nemmeno d’arrivare, benché avessero vita lunghissima.
Alessandro Magno se ne andò all'altro mondo di trentatre anni e aveva non solo
una meravigliosa cultura, ma aveva vinto tutto il mondo, soggiogando non tanto
con la forza delle armi, quanto con la sapienza dei suoi disegni e la sua
meravigliosa rapidità nel compiere le imprese (non rimandando mai nulla al
giorno dopo). Giovanni Pico della Mirandola, non arrivò nemmeno all'età di
Alessandro, ma per l'amore della sapienza s'innalzò sopra tutti i punti dove può
salire l'ingegno umano, che nel suo secolo era stimato un miracolo d’uomo.
5. E per non citare altri esempi, lo stesso signor nostro Gesù Cristo, benché
non stesse sulla terra altro che 34 anni, compì la grande opera della
redenzione pensando senza dubbio, di mostrare col suo esempio (poiché tutta la
sua vita è allegorica) che qualunque numero d'anni tocchi di vivere all'uomo,
gli bastano per prepararsi e molto bene, all'eternità.
6. A questo punto non posso fare a meno di riferire le parole auree dette da
Seneca a questo proposito (dalla lettera 93): “Ho trovato molti giusti
recalcitranti agli uomini, nessuno recalcitrante a Dio. Rimproveriamo ogni
giorno il fato ecc… Che male c'è a uscir presto di dove prima o poi bisogna
uscire? La vita è lunga, se arriva alla sua pienezza, e arriva alla sua
pienezza, quando l'animo si è procacciato il bene suo proprio ed è diventato
padrone di se stesso”. Ed aggiunge: “Ti scongiuro, o mio Lucillo, facciamo
in modo che, come una cosa preziosa, così la nostra vita non abbia grande
ampiezza, ma grande valore. Misuriamola dai fatti, non dal tempo”. E poco
dopo: “Lodiamo dunque e mettiamo nel numero dei fortunati colui che ha
impiegato bene quel pochino di tempo che gli è toccato perché ha veduta la
vera luce e non è stato uno dei tanti che ci sono; ed è vissuto davvero e in
pieno vigore.” E di nuovo: “Come un uomo può essere perfetto anche se è di
piccola statura, così la vita può essere perfetta, anche se è di breve
durata. La durata della vita è una delle tante cose esteriori. Vuoi sapere
quanto, al massimo, si dovrebbe vivere? Fino a quando non siamo arrivati alla
sapienza. Chi ci arriva, tocca non la meta più lontana, ma la meta più
ragguardevole”.
7. Adunque contro i lamenti sulla brevità della vita ci sono per noi e per i
nostri figlioli (e anche per le scuole) questi due rimedi: provvedere quanto è
possibile I) a difendere il corpo dalle malattie e dalla morte, II) a disporre
la mente a far tutto con assennatezza.
8. Siamo obbligati a tenere il corpo al sicuro dalle malattie e dalle cadute;
primo perché è l'abitazione, anzi l'unica abitazione dell'anima; e perciò se
si rovina il corpo l'anima è costretta a emigrare subito da questo mondo; e se
anche si rovina a poco a poco facendogli una rottura ora da una parte ora da
un’altra, l’ospite sua, l'anima sta scomoda nella propria abitazione. Se
dunque nel palazzo del mondo, dove siamo stati messi per benignità di Dio, è
piacevole starci quanto più e quanto meglio si può, si deve aver provvida
cura, di questo padiglione formato dal corpo. Secondo, lo stesso corpo è stato
fatto non solo per abitazione dell’anima razionale, ma anche per suo organo e
senza questo non può sentire, né vedere, né far nulla, anzi non può nemmeno
pensare. Infatti, siccome non può essere oggetto del senso,
la mente non riceve la materia di tutti i suoi pensieri altro che dal senso
e non può compiere l'atto di pensare se non per mezzo della sensazione interna
ossia contemplando le immagini astratte delle cose. Di qui nasce che,
danneggiando il cervello, si danneggia la facoltà immaginativa e se le membra
del corpo stanno male, sta male anche l'anima.
9. Il nostro corpo poi si mantiene vigoroso con una dieta moderata; ma di questa
parlano di proposito i medici: noi accenniamo soltanto poche cose servendoci
dell'esempio d'una pianta. Una pianta per natura ha bisogno di tre cose: 1)
l’umidità continua, 2) di traspirazione frequente, 3) di riposo alternato. Ha
bisogno di umidità perché questa si guasta e secca; ma bisogna, che l'umidità
sia moderata perché se è troppa fa marcire le barbe.
Così il corpo ha bisogno d'alimenti perché senza questi diventa secco,
stecchito dalla fame e dalla sete; ma gli alimenti non devono essere troppi
affinché le forze digestive non ne restino aggravate e oppresse. Con quanta più
moderazione tu somministri gli alimenti allo stomaco e tanto più certa e
perfetta sarà la digestione: e siccome in generale a questo non ci si bada,
parecchi si rovinano le forze e la vita col soverchio alimento. E invero la
morte viene dalle malattie, le malattie dai cattivi umori, i cattivi umori dalla
cattiva digestione, la cattiva digestione dalla sovrabbondanza d'alimento perché
se ne ficca tanto dentro le stomaco che non è capace a digerirlo e, per
conseguenza, deve diffondere per le membra umori poco o punto digeriti dai quali
è impossibile che non provengano malattie: “Molti son morti per voracità.
(dice l'Ecclesiaste), ma chi pensa ai casi suoi, prolungherà la vita.
10. Ma per mantenere il vigore della salute non c'è bisogno soltanto di
prendere alimenti misurati, ma anche alimenti semplici. Il giardiniere non
annaffia la pianta, sia pur delicata quanto vuoi, col vino o col latte, ma col
liquido richiesto da tutti i vegetali, cioè con l'acqua. Bisogna dunque che i
genitori guardino di non avvezzare i giovanetti alle sostanze che irritano la
gola e principalmente, i giovanotti destinati o da destinarsi agli studi, perché
fu scritto non a caso, che Daniele e i suoi compagni, giovanetti di sangue
reale, consacrati agli studi, benché si nutrissero con legumi e acqua, furono
trovati più agili e grassi e quel che è più, più intelligenti di tutti gli
altri che mangiavano le delizie della tavola del re.
11. Una pianta ha bisogno anche di traspirare e d'invigorirsi spesso mediante i
venti, le piogge e il freddo ché altrimenti si intristisce e si guasta. Così
il corpo umano ha proprio bisogno di moto e di ginnastica e d'esercizi seri e
scherzevoli (come pure d'esser allenato alle intemperie, al freddo e al caldo).
12. Infine la pianta di tanto in tanto ha bisogno di riposo. E naturalmente non
è necessario che mandi sempre fuori germogli, fiori e frutti, ma ogni tanto
deve lavorare nel suo interno, digerire i succhi e in questo modo rafforzare sé
medesima. E Dio volle che al caldo succedesse il freddo, appunto per dare riposo
a tutti gli esseri che crescono sulla terra e così anche alla terra stessa: e a
questo effetto comandò per legge che ogni sette anni si desse riposo alla
terra, (Levitico, 25/3-4). Similmente ordinò per gli uomini (e per tutti gli
altri animali), la notte perché sia col sonno, sia col tener anche le membra in
riposo, ricuperassero le forze perdute con le occupazioni del giorno. Ma tanto
al corpo quanto alla mente ad intervalli bisogna dar sollievo con qualche
ricreazione minore di un'ora per evitare il pericolo che lavorino costretti
dalla violenza la quale è nemica della natura. Perciò è bene interrompere
anche i lavori diurni concedendo un po' di respiro e di fare un po’ di
conversazione, scherzi e giuochi, musica e di simili altre cose che ricreano i
sensi interiori ad esteriori.
13. Se uno osserva queste tre regole (di nutrirsi misuratamente, d'esercitare il
corpo e di dar man forte alla natura) è impossibile che non conservi
lunghissimamente la salute e la vita, eccettuato il solo caso di forza maggiore.
14. Bisogna ora parlare del modo di dispensare prudentemente il tempo che resta
e che deve essere consacrato al lavoro.
Par cosa da poco e facile a dirsi: trent’anni; ma trent'anni sono un bel
numero di mesi e più di giorni e ore. È certo che in così grande tratto di
tempo può far molto viaggio chi viaggi, anche se viaggia lemme lemme. Ne è
prova evidentemente, il modo in cui crescono le piante, le quali nemmeno con la
vista più acuta non ci si può accorgere che crescono perché è un fatto che,
avviene a poco a poco e insensibilmente; ma pure si vede che ogni mese crescono
un po' e dopo trent'anni tu osservi che son cresciute tanto da essere già
piante grandissime. Il nostro corpo nel crescere di statura tiene la stessa
regola: non lo vediamo crescere, ma vediamo che è cresciuto. E che la regola
tenuta dalla mente che cerca d’acquistare conoscenza delle cose, non sia
diversa, ce lo provano questi versucci proverbiali:
Se a un monticino, senza smetter
mai,
un pochino di roba aggiungerai,
in poco tempo, come per incanto,
diverrà il monticino un monte tanto.
15. Chi conosce la forza del
progresso, lo avverte subito perché mentre da ogni gemma spunta soltanto un
germoglio o un pollone l'anno, dopo trent’anni una pianta avrà mille rami, più
grossi e più piccoli e foglie e fiori e frutti innumerevoli. E deve parere
impossibile, che l'energia dell'uomo in venti o trent’anni, arrivi a qualunque
altezza e a qualunque distanza? Guardiamo un po' se è impossibile.
16. Il giorno civile è di 24 ore che, divise in tre parti per i bisogni della
vita, otto si danno al sonno, altrettante alle faccende secondarie (per esempio,
alla salute, al mangiare, al vestirsi, allo spogliarsi, alle ricreazioni oneste,
a conversazioni con gli amici, ecc.), e così ce ne restano altre otto per
sbrigare le faccende serie con ardore e senza noia.
Ogni settimana perciò (lasciato il settimo giorno tutto al riposo) si hanno 48
ore da destinare al lavoro; ogni anno 2.490; e in dieci, venti, trent'anni?
17. Ebbene, se ogni ora tu impari o un teorema di qualche scienza o una regola
di arte pratica o una bella storia o una bella massima (e queste è manifesto
che si può fare senza nessuna fatica), di grazia che tesoro d istruzione
riuscirai tu ad acquistarti?
18. Perciò disse bene Seneca: “Se della vita ne sappiamo far buon uso, essa
è lunga abbastanza ed è sufficiente a condurre a fine le cose più importanti,
se si impiega tutta bene”. Ma tutto sta qui, nel saper l'arte d'impiegarla
bene tutta, cosa che oramai dev'essere l'oggetto delle nostre ricerche.
Giovanni Amos Comenius (1592-1670)
41
- Il fenomeno puro
(J.
W. von Goethe)
I fenomeni, che noialtri siamo anche soliti chiamare
fatti, sono certi e determinati quanto alla loro natura, e invece spesso
indeterminati e oscillanti in quanto appaiono. Il naturalista cerca di capire e
di fissare ciò che nei fenomeni è determinato; in singoli casi non fa
attenzione soltanto a come i fenomeni appaiono, bensì anche a come essi
dovrebbero apparire. Come spesso ho potuto osservare specialmente nel campo nel
quale lavoro, vi sono molte frazioni empiriche che bisogna eliminare per
conservare un fenomeno costante e puro, ma appena, mi permetto ciò stabilisco
già una specie di ideale.
Tuttavia, vi è una grande differenza se, come fanno i teorici, si sacrificano
ad una ipotesi dai numeri interi oppure se si sacrifica all'idea del fenomeno
puro una frazione empirica.
Poiché l'osservatore non vede mai con gli occhi il fenomeno puro ma molto
dipende dal suo stato d'animo, da come si trova l’organo in quel momento,
dalla luce dall'aria, dalla temperatura, dai corpi, dal trattamento e da
migliaia di altre circostanze; è come voler bere il mare, quando ci si vuole
attenere all'individualità del fenomeno e la si vuole osservare, misurare,
ponderare e descrivere.
Nella mia osservazione e considerazione della natura, specialmente, negli ultimi
tempi, mi sono attenuto, per quanto era possibile, al seguente metodo.
Se ho sperimentato la costanza e la coerenza dei fenomeni fino ad un certo
grado, ne deduco un legge empirica, e la prescrivo agli altri fenomeni. Se la
legge e i fenomeni si adattano completamente a tale successione, ho vinto, se
non vi si adattano interamente, rivolgo la mia attenzione alle circostanze dei
singoli casi e sono costretto a cercare nuove condizioni nelle quali io possa
rappresentare in modo più puro gli esperimenti contradditori; ma se talvolta,
nelle stesse circostanze si verifica un caso che contraddice la mia legge, mi
accorgo che debbo andare avanti con tutto il mio lavoro e cercarmi un punto di
vista superiore. Secondo la mia esperienza dunque, sarebbe quello il punto in
cui lo spirito umano può meglio approssimarsi agli oggetti nella loro
universalità, avvicinarseli, in un certo senso, amalgamarsi razionalmente con
essi, come del resto facciamo nella comune empiria.
A proposito del nostro lavoro avremo da indicare i punti seguenti:
Il fenomeno empirico che ogni uomo percepisce nella natura, che quindi viene
elevato
a fenomeno scientifico mediante esperimenti, in quanto lo si rappresenta in
circostanze e condizioni diverse da quelle in cui l’abbiamo conosciuto a tutta
prima, ed in una successione più o meno felice.
Il fenomeno puro, infine, si presenta come risultato di tutte le esperienze e di
tutti gli esperimenti. Non può mai essere isolato, ma si mostra in una
successione costante di fenomeni. Per rappresentarlo lo spirito umano determina
ciò che è incerto, escludendo ciò che è intricato, anzi scopre ciò che non
è noto.
Qui, se l'uomo sapesse contentarsi, sarebbe forse l'ultimo fine delle nostre
energie. Giacché qui non si chiedono le cause, bensì le condizioni nelle quali
i fenomeni appaiono; si contempla e si accetta la loro successione coerente, il
loro eterno ritornare in mille circostanze diverse, la loro unitarietà e
mutevolezza, si riconosce la loro determinatezza e la si determina di nuovo
mediante lo spirito umano.
A dire il vero questo lavoro non dovrebbe essere definito speculativo giacché,
mi pare, alla fine si tratta soltanto di operazioni pratiche - che rettificano
se stesse - del comune intelletto umano, il quale osa cimentarsi in una sfera
superiore.
J.
Wolfgang von Goethe (1749-1832)
42 - Materia ed etere (Günther Wachsmuth)
La moderna scienza della natura
si forma un immagine del mondo riconducendo la infinita molteplicità dei
fenomeni della natura a due concetti, cioè a due immagini fondamentali: materia
ad etere. Ma le rappresentazioni, che di queste due estreme fondamentali unità
ci danno i ricercatori più avanzati, sono così differenti che, in questo
momento, tutto l'edificio scientifico, costruito su questi due concetti
fondamentali, tanto discussi, vacilla.
Il famoso studioso dell'etere, P. Lenard, nel suo discorso ben noto "Su
l'etere, e la materia" tenuto dinanzi all'accademia di scienze di
Heidelberg, diceva che uno studioso moderno della natura a chi gli domandasse
come, adunque, gli si rappresenti il mondo, risponderebbe in questa guisa:
"Per parlare di questo argomento, deve innanzi tutto constatare che le sue
asserzioni si riferiscono solo a quella parte del mondo che è accessibile alla
ricerca quantitativa, con l'aiuto degli organi dei sensi. Il quantitativo
appunto, la possibilità cioè di confrontare sempre per mezzo del calcolo,
tutti i risultati colla realtà e controllarla con essa, distingue la scienza
della natura dalla scienza dello spirito che si occupa sopra tutto dell'altra
parte del mondo. Possiamo anche chiamare mondo materiale quantitativo la parte
di esso accessibile alla indagine quantitativa per mezzo dei sensi, e solo di
questa si occupa lo studioso della natura e di questa sola egli si è formata
un'immagine.
Dobbiamo sottoporre a un esame critico questa tendenza fondamentale del modo di
rappresentazione della scienza naturalistica dell'ultimo secolo per giungere a
una concezione feconda dell’essenza dell'etere e della materia e per
comprendere perché non si può giungere a una conoscenza soddisfacente
dell'etere sulla base di tale tendenza della scienza naturalista che si
costringe solo: 1) al quantitativo, 2) a ciò che è percepibile con gli organi
dei sensi. L'etere: 1) non ha solo proprietà quantitativa, ma anche proprietà
qualitative inscindibili da quelle, 2) non è percepibile ai nostri organi
fisici dei sensi. Quindi chi vuole limitarsi al solo quantitativo e a ciò che
è percepibile ai sensi, non giungerà mai a una giusta visione di ciò che è
l'essenza e l’attività dell'etere.
Lenard dice che le immagini dello studioso moderno della natura sono di due
specie: "Sempre sono quantitative, ma possono esaurirsi completamente - e
questa è la prima specie - nei rapporti quantitativi tra le grandezze
osservabili: e allora sono rappresentabili perfettamente nella forma di formule
matematiche specialmente con equazioni differenziali. Questa è la via preferita
da Kirchhoff e Helmoltz, è detta descrizione matematica della natura. Esempi di
tali immagini sono: la legge di gravitazione di Newton o le equazioni
dell'elettrodinamica, di Maxwell. Le conseguenze logicamente necessarie delle
immagini, nello sviluppo delle quali consiste e la utilizzazione e la riprova
delle immagini, non sono altro che conseguenze matematiche di quelle equazioni.
Ma si può procedere oltre - e questa è la seconda specie - : lasciarsi guidare
da un'idea, senza di che certamente la ricerca della natura - di quella
inanimata almeno - siano meri processi di movimento consistano solo in
cambiamento di posto di una materia, data una volta per sempre. Si tratterebbe
allora in ogni caso di meccanismi, e le equazioni, che abbiamo formato come
immagini della prima specie, dovrebbero essere equazioni di meccanica,
dovrebbero corrispondere a ben determinati meccanismi; e allora noi possiamo
considerare questi meccanismi come immagini che noi ci siamo fatti del processi
della natura. Allora abbiamo modelli meccanici, modelli dinamici delle cose come
immagini loro nel nostro spirito. E Lenard riassumendo conclude: “Tutto ciò
che accade nel mondo è movimento, cambiamento di posto di materia data, una
volta per sempre. In nessuna parte si ha il più piccolo segno di un nuovo
sorgere o di uno svanire della materia. Si tratterà quindi soltanto di indicare
di quale specie sono i movimenti. Dobbiamo quindi fare innanzi tutto questa
affermazione fondamentale, la sostanza, ciò che è mosso, di cui consta
l'insieme del mondo materiale, è di due specie: materia ed etere”. E dopo
avere inserito in questa immagine del mondo le ricerche più moderne su la
radioattività egli indica come l’immagine del mondo non etere e materia, ma
etere ed elettricità. Anche il Lenard deve però dire: “La questione, è
soltanto questa: riusciamo noi a riprodurre, esattamente, per questa via,
l’immagine della realtà? È lo spirito umano in grado di riprodurre in sé
esattamente in questo modo il complesso della natura - quella inanimata,
diciamo? Proprio oggi sorgono su questo i dubbi più recisi…” E conclude:
“Io credo che le difficoltà non debbano trattenerci dal coltivare e
sviluppare l’immagine che ora abbiamo, perché altrimenti dovremmo rinunziare
a qualsiasi immagine di tale specie e, in genere, alla possibilità di una
concezione meccanica della natura. Io non credo che ciò possa accadere, neppure
se, per chiarire la meccanica dell'etere, dovessimo ammettere, accanto o dietro
all'etere e alle sue parti, un altro etere”.
In queste parole l’"ignorabimus" Franco di Du Boie Reymond appena
velato dalla speranza di una via d'uscita. Ma questa speranza non si può
realizzare finché si cerca di salvare la ipotesi meccanica, ricorrendo a sempre
nuove più ipotetiche specie di etere. Lenard, combattendo la teoria di Einstein,
che spoglia l’etere di ogni proprietà meccanica, ha introdotto, per salvare
la sua immagine del mondo, un etere primo accanto all'etere finora ammesso; ma
questo è un procede per una via che col tempo si dimostrerà sempre più un
vicolo cieco.
Già Carlo C. Planck, forte pensatore e ricercatore, prese, suo tempo, una
posizione molto aperta e coraggiosa di fronte alla spiegazione meramente
meccanica di entità quali il calore, la luce, la gravità. Egli, lottando
contro la separazione degli attributi qualitativi e quantitativi, fatta per il
metodo di osservazione adottato dalla scienza della natura nell'ultimo secolo,
tentava di mostrare, che con tale arbitraria scissione la scienza della natura,
ha foggiato un’immagine del mondo per cui l'azione dello spirito non si può
chiarire nel mondo detto materiale e il sorgere, la genesi del mondo della
sostanza da ciò che era prima della “nebulosa primordiale”, è
assolutamente inintelleggibile. Planck nel suo “Testamento di un tedesco”
dice: “Con tale spiegazione meccanica anche il rapporto del corporeo con la
luce e il calore vedrà, alla fine, come il rapporto della gravità,
sovvertito... Gli atomi materiali secondo tale concezione, in sé non hanno
nulla a che fare né con la luce, né col calore; essi sono pensati, secondo la
loro propria essenza, come parti stanti per sé, e producono calore e luce solo
per i loro rapporti meccanici di movimento con altri atomi. E così il vero
primordiale fondamentale rapporto della natura e della sua legge universale di
evoluzione viene totalmente rovesciato; poiché il primordiale non sarebbero più
quelle forme che, secondo la reale apparizione, sono ancora prive di
individualità e universali - la concentrazione, la gravità e le loro
controforme immediate calore e luce, ma vengono presupposti per la gravità,
calore, luce, gli atomi materiali individuali, differenziati per sé stanti.
Mentre anche la stessa moderna visione scientifica deve ammettere che lo stato
dei corpi cosmici si è sviluppato primamente da uno stato caldo e luminoso
ancora uniforme differenziato a uno stato di molteplicità separate e
individuali, nell'ultimo atteggiamento invece viene dato il primo posto non a
quelle forze dell'unità non individualizzata, uniforme del tutto (calore, ecc.)
ma, al contrario, alle singole parti separate individuali (atomi). Viene del
tutto capovolta la legge della evoluzione che dovrebbe valere per tutta la
natura e massimamente per la evoluzione di tutto ciò che è organico; e appunto
perché si vuole porre al principio, come primordiale la esteriorità meccanica
degli atomi separati, queste parti consistenti per sé, è resa impossibile,
come vedremo, ogni spiegazione dello organico, dello psichico, dell’universale
spirituale".
Planck ammoniva, così di non mettere geneticamente, il mondo degli atomi prima
del mondo delle entità calore, luce, ecc, e di non porre pregiudizialmente a
base dello studio della natura un concetto che può solo imporre limitazioni più
ristrette alla conoscenza della natura.
Poiché sono sorti tra i più grandi studiosi della natura tanti dubbi su la
loro stessa moderna concezione del mondo, non si capisce perché non sia ancora
stato accolto l’indirizzo dell'indagine, iniziato dal dr. Rudolf Steiner nei
suoi scritti su la natura che dà modo di uscire da un tale dilemma. Già nel
1891 indicava nei suoi scritti la falsità della via che segue quella concezione
del mondo la quale come Du Bois Roymond, risolve i processi della natura solo
nella “meccanica degli atomi” o come Ostwald, in “estrinsecazioni
d’energia”. Steiner ha mostrato come la scissione dell'immagine del mondo,
qual si è fatta finora, in una parte oggettiva (che si può comprendere solo
matematico-meccanicamente), e una parte soggettiva, ha condotto a uno
sfiguramento e a una falsificazione appunto di questa immagine del mondo. Le
considerazioni più recenti di filosofi e scienziati della natura hanno
“portato a credere che i processi esterni che provocano il suono
nell'orecchio, la luce nell'occhio, il calore nell'organo di senso del calore
ecc. non abbiano nulla in comune con la sensazione del suono, della luce, del
calore e così via. Questi processi esterni sarebbero movimenti determinati
dalla materia. E allora, lo studioso della natura ricerca quale specie di
processo esterno di movimento faccia sorgere nell'anima umana il suono, la luce,
il calore. E giunge alla conclusione che in nessuna parte dello spazio cosmico,
fuori dello organismo umano esiste il rosso, il giallo, l'azzurro, ma vi è
soltanto un movimento di onde di una materia sottile, elastica, l'etere, che,
percepito dall'occhio, viene rappresentato come rosso, giallo, azzurro. Se non
vi fosse l’occhio percipiente non vi sarebbe colore, ma soltanto etere mosso:
così pensa, il moderno scienziato della natura. L’etere è oggettivo, il
colore è soltanto qualcosa di soggettivo, formato nel corpo umano.” E oppone:
“Chi non abbia fondamentalmente alterata da Descartes, Locke, Kant e dalla
fisiologia moderna la facoltà di rappresentazione, non riuscirà mai a
comprendere come si possano ritenere quali stati meramente soggettivi
dell'organismo umano luce, calore, suono, colore e affermare insieme la presenza
reale di un mondo oggettivo di processi fuori dall'organismo umano. Chi fa
l'organismo umano generatore degli accadimenti suono, calore, colore ecc., deve
farlo anche produttore della estensione, della grandezza, posizione, movimento,
della forza, ecc. Poiché queste qualità matematiche e meccaniche sono
inscindibilmente connesse con tutto l'altro contenuto del mondo dell'esperienza.
Separare i rapporti di spazio, numero, movimento, la manifestazione della forza
del calore, suono, colore dalle altre qualità sensibili è soltanto atto del
pensiero astratto”. “Ma questa è una considerazione parziale: si tira una
linea attraverso a ciò che è percepibile coi sensi e si dichiara una parte
oggettiva, l'altra soggettiva. Solo questo è conseguente: se vi sono atomi,
essi sono parte di materia, con le proprietà della materia, non percepibili per
la loro piccolezza che sfugge ai nostri sensi. Svanisce però la possibilità di
trovare nel movimento degli atomi qualcosa che si possa opporre come oggettivo
alla qualità soggettiva del suono, colore, ecc. Cessa anche la possibilità di
trovare nella connessione tra il movimento e la sensazione del rosso, per
esempio, qualcosa di più che tra due processi che appartengono pienamente al
mondo sensibile. È chiaro: movimento dell'etere, posizione degli atomi ecc.,
appartengono allo stesso piano di sensazioni. Dichiarare queste soggettive è
solo il risultato di una riflessione non chiara. Se si dichiarano meramente
soggettive le qualità sensibili, si deve farlo anche per il movimento
dell'etere. Noi non percepiamo il movimento dell'etere non per ragione di
essenza, ma soltanto perché gli organi dei sensi non sono abbastanza finemente
organizzati. Ma questo è soltanto una circostanza accidentale. Può darsi che,
per un progressivo affinamento degli organi di senso, l'uomo possa un giorno
percepire direttamente anche il movimento dell'etere. E l'uomo di questo lontano
avvenire, se accogliesse la teoria della soggettività delle sensazioni,
dovrebbe anche dichiarare soggettivo questo movimento dell’etere come noi oggi
dichiariamo il colore, il suono, ecc.”
Poiché lo studioso della natura non può pensare il movimento senza qualcosa
che si muova, egli assume la materia, spogliata di ogni proprietà sensibile,
come il veicolo dei movimenti. Ma chi non sia preso da questo pregiudizio dei
fisici, deve scorgere che i processi di movimento sono degli stati legati alle
qualità che cadono sotto i sensi. Il contenuto del movimento a onde, che
corrisponde ai fenomeni del suono, sono le qualità stesse del suono. Lo stesso
vale egualmente per le altre qualità sensibili. Noi conosciamo il contenuto
delle oscillazioni del mondo fenomenico per mezzo di un divenire interno
immediato, non per introduzione di una materia astratta, per mezzo del pensiero
nei fenomeni. Quando io pongo dinanzi al mio occhio una superficie rossa, sorge
nella mia coscienza la sensazione del rosso. Ora in questa sensazione dobbiamo
distinguere il principio, la durata, la fine. Di fronte alla sensazione
transeunte deve stare un processo duraturo oggettivo il quale di nuovo, come
tale, è obbiettivamente limitato nel tempo, ha cioè principio, durata e fine.
Ma questo processo deve prodursi in una materia senza principio e fine,
indistruttibile, eterna. Questa, è ciò che propriamente permane nel
cambiamento dei processi (così pensa lo scienziato moderno della natura).
Mentre ancora Wundt dice che la materia è il substrato che “non diviene mai
visibile a noi per se stessa, ma solamente sempre nei suoi effetti”, e che
soltanto ammettendo tale substrato, possiamo giungere a una spiegazione sicura.
Steiner viene a questa conclusione: “L’immagine sensibile del mondo è la
somma delle percezioni che si metamorfizzano”. Le proprietà che dovrebbe
avere la materia ipotetica, assunta dai fisici e dai filosofi e dai loro
sostenitori, sono un non senso. Queste proprietà ricavate dal mondo sensibile,
dovrebbero però appartenere a un substrato che non appartiene al mondo
sensibile.
Ora importa a noi dichiarare che quando parliamo dell’etere, non si deve mai
intendere, per principio, un processo di movimento meccanico, spogliato di ogni
proprietà qualitativa, ma sempre sotto questo etere ci si deve rappresentare
qualcosa non soltanto oggettivamente quantitativo ma qualcosa, nella sua
struttura e attività, oggettivamente qualitatativo: appunto per esser fedeli
alla realtà della natura. Potremo mostrarlo concretamente in molti campi dello
studio della natura.
La prima limitazione del Lenard, allo studio scientifico della natura di una
immagine del mondo solamente meccanico-quantitativa non può per le nostre
considerazioni essere accettata perché contraddice fondamentalmente alla realtà
del mondo. E non possiamo neanche ammettere la seconda richiesta del Lenard: la
restrizione a quello soltanto che è accessibile agli organi fisici del senso.
L’immagine del mondo allo stesso studioso moderno della natura contraddice in
tutti i punti fondamentali a tale richiesta. Poiché nessun organo dei sensi ha
mai finora percepito gli elettroni, il nucleo degli atomi, le vibrazioni ed
altri fattori ipotetici dell'immagine del mondo che si forma la scienza della
natura, appunto perché ora gli organi fisici dei sensi non sono organizzati in
modo da percepire i movimenti dell'etere ecc.
Quando il prof. König nel suo scritto “La materia” dice: “Noi, ritenendo
come propriamente reali gli atomi e l’etere e riguardando come semplici esseri
fenomenici i corpi che cadono sotto i sensi, siamo già per metà nella
metafisica”, egli rileva giustamente che la scienza coi suoi concetti
fondamentali e con le sue ipotesi, cade sempre nell'errore di uscire fuori del
percettibile, il che pure vorrebbe evitare.
Ma bisogna chiarire quale specie di ipotesi sia giustificata, quale no.
Ipotesi è assunzione di ciò di cui noi non possiamo renderci conto
direttamente, ma soltanto per mezzo dei suoi effetti. L'ipotesi (giustificata)
può assumere soltanto ciò che io certo non percepisco, ma percepirei
senz'altro se eliminassi gli impedimenti esterni. La ipotesi può presupporre il
non percepito, ma deve presupporre il percepibile. Quindi ogni ipotesi è
giustificata nel caso che il suo contenuto possa essere direttamente confermato
dall'esperienza futura. Soltanto le ipotesi che possano cessare di essere
ipotesi, sono giustificate. L'ipotesi dell'etere che la scienza moderna della
natura assume è ingiustificata, perché né l’etere penetrabile discontinuo
che si muove nello spazio né la materia spogliata di tutte le proprietà
sensibili, sono percepibili per gli organi di senso.
Günther Wachsmuth (1923- ?)
43
- Il pensiero al servizio della comprensione del Mondo (Rudolf
Steiner)
Quando
osservo come una palla di bigliardo trasmette ad un'altra la spinta che ha
ricevuta, io resto senza alcuna influenza sullo svolgersi del fenomeno che
osservo. La direzione e la velocità del moto della seconda palla sono
determinate dalla direzione e dalla velocità del moto della prima. Finché io
rimango semplice osservatore, non posso dir nulla sul moto della seconda palla
se non quando tale moto è già avvenuto. Diverso è il caso se io comincio a
riflettere sul contenuto della mia osservazione. La mia riflessione ha lo scopo
di formare dei concetti su quel che avviene: mette in rapporto il concetto di
una palla elastica con certi altri concetti della meccanica tenendo conto delle
speciali circostanze che accompagnano il fenomeno.
Io cerco adunque di aggiungere al processo che ha luogo senza il mio intervento
un secondo processo che si compie nella sfera dell’ideazione. Quest’ultimo
dipende da me: e ciò è dimostrato dal fatto ch'io posso accontentarmi della
semplice osservazione e rinunziare a qualsiasi ricerca di concetti, se non ne
sento il bisogno. (...) Com'è sicuro che il processo oggettivo si svolge
indipendentemente da me, così è sicuro che il processo concettuale non può
svolgersi senza il mio intervento (...)
Noi sappiamo benissimo che insieme con gli oggetti non ci vengono dati
senz'altro anche i relativi concetti: l'osservazione immediata ci dice che tale
attività viene da noi. La questione per ora è questa: “Che cosa ci
guadagnamo noi a scoprire per ogni processo un parallelo concettuale?”.
Vi è una differenza profondissima fra i mutui rapporti che hanno per me i vari
elementi di un dato processo prima che io abbia scoperti i corrispondenti
concetti, e dopo. La mera osservazione può seguire gli elementi di un dato
processo nel suo svolgimento; ma il loro nesso rimane oscuro finché non vengono
in aiuto i concetti. Io vedo la prima palla di bigliardo muoversi con una data
velocità verso la seconda: per sapere quel che avverrà dopo seguito l'urto,
devo aspettare che l’urto sia avvenuto e seguire di nuovo con gli occhi i
fatti. Se, ad esempio, qualcuno mi copre, al momento dell'urto, il campo su cui
si svolge il processo, io resto – come semplice osservatore - completamente
all'oscuro di quel che dopo avviene. Ben diverso è il caso, se io mi ero già
formato, prima che mi si coprisse il campo, dei concetti corrispondenti alle
condizioni del fenomeno, allora io posso prevedere quel che avviene anche se mi
si toglie la possibilità dell'osservazione diretta. Un processo od oggetto
semplicemente osservato non fornisce da sé solo alcun dato riguardo al suo
nesso con altri processi od oggetti: questo nesso appartiene soltanto quando
all'osservazione si congiunge il pensiero.
Osservazione e Pensiero sono i due punti di partenza di tutta l'attività
spirituale cosciente dell'uomo. (...)
Il nostro pensiero di un cavallo e l'oggetto cavallo sono due cose che si
presentano a noi separate: e l'oggetto cavallo non ci è accessibile che
attraverso l'osservazione. Come pel semplice rimirare un cavallo noi non
possiamo formarci un concetto del medesimo, così non possiamo per semplice
pensare attorno a un cavallo produrre l'oggetto.
Cronologicamente, l'osservazione precede perfino il pensiero in quanto il
pensiero non impariamo a conoscerlo se non attraverso l'osservazione. In fondo
non abbiamo fatto che descrivere un'osservazione quando, al principio, abbiamo
visto come il pensiero si accende in presenza di un fenomeno e va al di là di
ciò che senza. il proprio intervento avviene. Di tutto ciò che entra nella
cerchia delle nostre esperienze, diveniamo consapevoli solo attraverso
l'osservazione. Il contenuto delle sensazioni e delle percezioni, i sentimenti,
gli atti di volizione, le immagini del sogno e della fantasia, le
rappresentazioni, i concetti, le idee, persino le illusioni e le allucinazioni
ci vengono date attraverso l’osservazione.
Però il pensiero, come oggetto dell'osservazione, si differenzia essenzialmente
da tutte le altre cose. L'osservazione di una tavola, di un albero, ecc.,
comincia per me appena questi oggetti appariscono sull'orizzonte della mia
esperienza, ma il pensiero attorno a questi oggetti non lo osservo
contemporaneamente. La tavola osservo io; il pensiero attorno alla tavola lo
eseguisco, ma non l'osservo nello stesso momento. Bisogna prima ch’io mi
collochi in un punto di vista esterno alla mia propria attività. (...)
Mentre osservare oggetti e processi e il pensare attorno ad essi sono condizioni
quotidiane che riempiono continuamente la mia vita, l'osservare il mio pensiero
è una specie di condizione eccezionale. Di questo fatto bisogna tenere
adeguatamente conto, quando si tratta di stabilire il rapporto fra il pensiero e
tutti gli altri oggetti dell'osservazione. (...)
La speciale natura del pensiero è in ciò che il pensante dimentica il suo
pensare nel tempo che lo eseguisce. Non è il pensare che occupa il pensante, ma
l’oggetto osservato su cui pensa.
La prima osservazione che facciamo attorno al pensiero, è quindi questa:
ch’esso è l'elemento inosservato della vita ordinaria del nostro spirito. E
la ragione per cui non osserviamo il nostro pensiero nella vita quotidiana dello
spirito, non è altra se non quella che il pensiero è un prodotto della nostra
propria attività. (…)
Non posso mai osservare il mio pensiero presente; ( ... ) dovrei scindermi in
due personalità - in una che pensa e in una che si guarda pensare - se volessi
osservare il mio pensiero presente. Ma non posso far ciò. Posso compier solo ciò
in due atti distinti. Il pensiero che deve essere osservato, non è mai quello
presentemente attivo ma un altro.
Due cose non sono conciliabili, una produzione attiva e una contrapposizione
riflessiva. Questo apparisce già dal primo libro di Mosè. Nei primi sei giorni
della creazione Dio fa sorgere il mondo e soltanto quando questo è sorto, sorge
la possibilità di rimirarlo. Così succede anche col nostro pensiero. Deve
esistere, prima che si possa osservarlo.
La ragione che ci rende impossibile l'osservare il nostro pensiero nel suo
svolgimento attuale d’ogni istante, è la stessa che ce lo fa riconoscere come più immediato e più intimo di ogni
altro processo nel mondo. Appunto perché noi stessi lo produciamo, conosciamo
ciò che è caratteristico del suo svolgimento e il modo in cui si compie il suo
divenire. Ciò che negli altri campi dell'osservazione può essere scoperto solo
per via indiretta - cioè il nesso causale e il mutuo rapporto dei singoli
oggetti - pel pensiero noi lo sappiamo in modo immediato e diretto. Dalla
semplice osservazione io non so perché al lampo segue il tuono; ma perché il
mio pensiero collega il concetto di tuono con quello di lampo, io lo so
immediatamente dal contenuto dei due concetti. Naturalmente non ha in ciò
alcuna importanza che i miei concetti di lampo e di tuono siano giusti: il nesso
dei due concetti quali li ho, mi è chiaro per se stesso ( ... ).
Quando si fa del pensiero l'oggetto dell'osservazione, si aggiunge al restante
contenuto osservato del mondo un qualcosa che sfugge altrimenti all'attenzione,
ma non si altera con ciò il genere di rapporto che l'uomo ha con le altre cose.
Si allarga il numero degli oggetti dell'osservazione, ma non il metodo
dell’osservare.
Quando osserviamo le altre cose, si mescola nel divenire del mondo un processo
che viene trascurato, un qualche diverso di ogni altro divenire, che non si
mette in linea di conto. Ma quando io considero il mio pensiero, allora non c'è
nessun elemento trascurato: ché quel che rimane nello sfondo, è esso stesso di
nuovo soltanto pensiero. In questo caso l'oggetto osservato è qualitativamente
uguale all’attività che su lui si dirige. E questa è un'altra proprietà
caratteristica del pensiero. Quando facciamo del pensiero un oggetto
dell'osservazione, non ci vediamo obbligati a ricorrere all'aiuto di qualche
cosa di qualitativamente diverso, ma possiamo rimanere nel medesimo elemento.
(…)
Quello che con la natura è impossibile: creare prima di conoscere, col pensiero
noi lo compiamo. Se noi volessimo aspettare di conoscere un pensiero prima di
pensarlo, non arriveremo mai a pensare. Dobbiamo risolutamente pensare per poter
poi per mezzo dell'osservazione di ciò che noi stessi abbiamo fatto, arrivare
alla conoscenza. Per l'osservazione del pensiero dobbiamo noi stessi fabbricare
prima un oggetto: mentre tutti gli altri oggetti sono invece provveduti senza
nostra cooperazione. (...)
È dunque indubitato che col pensiero noi reggiamo il divenire del mondo per un
lembo, dove senza la nostra partecipazione nulla si produce. E questo è proprio
il punto importante. (…) Io studio invero tutto il resto del mondo per mezzo
del pensiero; come potrei fare un'eccezione, pel mio pensiero?
Fino a tanto che la filosofia accetterà tutti i possibili principi - come
atomo, moto, materia, volontà, incosciente, ecc. - resterà campata in aria.
Solo quando il filosofo considererà l’assolutamente ultimo come suo primo,
potrà arrivare alla meta. E l'assolutamente ultimo cui è pervenuta
l'evoluzione del mondo, è il pensiero.
Rudolf Steiner (1861-1925)
44 - L'idea della libertà (Rudolf Steiner)
Il concetto dell'albero è, per
la conoscenza, condizionato dalla percezione dell’albero (…).
Il nesso fra concetto e percezione viene determinato indirettamente e
obiettivamente per mezzo dal pensiero applicato alla data percezione.
Il problema si presenta diverso, quando si considera la conoscenza e il rapporto
che sorge con essa, fra l'uomo e il mondo. (...).
Chi osserva il pensiero, vive, durante l'osservazione, direttamente in un
contesto di essenza spirituale che si sorregge di per sé. (...) .
Nella visione del pensiero, coincidono quelli che altrimenti debbono essere
sempre scissi, il concetto e la percezione. (...) E questo sorgere dal pensiero
è un fatto che s'impone al punto che solamente chi abbia riconosciuto come in
nulla l'organismo umano influisca sulla natura del pensiero, è in grado di
intenderne il vero significato. A costui però non può neppure sfuggire, quanto
sia peculiare il rapporto fra organismo umano e pensiero. (...)
Le orme di chi cammina sopra un terreno soffice, si imprimono su questo terreno
e nessuno sarà tentato di dire che le forme delle orme siano state determinate
da forze del terreno, operanti dal basso in alto; non si attribuirà a queste
forze nessun concorso alla formazione delle orme. Altrettanto poco, chi abbia
osservato obiettivamente le entità del pensiero, attribuirà alle orme lasciate
sull'organismo fisico di aver avuto parte alla determinazione di quella; poichè
quelle orme sono provenute dal fatto che il pensiero prepara la propria comparsa
per il tramite del corpo.
Qui però sorge una domanda quanto mai significativa. Se l'organismo umano non
ha parte alcuna nel determinare l’entità del pensiero, quale significato ha
quest’organismo entro il complesso dell’essere umano? Orbene, quanto succede
in quest’organismo per opera del pensiero non ha certo nulla a che fare con la
entità del pensiero stesso, ma bensì col sorgere da questo pensiero della
coscienza dell’IO. Nell’essere proprio del pensiero risiede, sì, il vero
“IO”, ma non la coscienza dall'Io.
Questo vede, chiunque obiettivamente osserva il pensiero! L’io si trova entro
il pensiero; la “coscienza dell'IO” affiora per il fatto che nella coscienza
generale s’imprimono nel senso sopraindicato le orme dell'attività del
pensiero. (La coscienza dell'Io nasce dunque per virtù dell’organismo
corporeo. Non si creda però, per questo, che la coscienza dell’io, dopo che
è sorta, continui a dipendere dall'organismo fisico; dopo che è sorta, viene
accolta dal pensiero, di cui condivide da allora in poi la essenza spirituale).
La “coscienza dell'Io” è costruita sull'organismo umano, dal quale
defluiscono gli atti della volontà. Una visione del rapporto fra pensiero, Io
cosciente e attività della volontà, la si potrà avere soltanto, dopo che si
sia osservato come l’atto volitivo proceda dall’organismo umano.
Per il singolo atto volitivo c'è da considerare il motivo e la molla spingente.
Il motivo è il fattore concettuale o rappresentativo; la molla spingente è il
fattore del volere, direttamente condizionato all'organismo umano. Il fattore
concettuale o motivo è la causa determinante momentanea del volere; la molla
spingente è la causa determinante permanente dell'individuo. Motivo del volere
può essere solo un concetto puro od un concetto in un determinato rapporto con
la percezione, cioè una rappresentazione.
Concetti generali e individuali (o rappresentazioni) divengono motivi del volere
in quanto agiscono sull'individuo umano e lo determinano all'azione in una certa
direzione. Un medesimo concetto (o una medesima rappresentazione) agisce però
diversamente su individui diversi. Muove uomini diversi ed azioni diverse, il
volere non è quindi un mero risultato del concetto (o della rappresentazione)
ma anche della indole individuale dell’uomo. Questa indole individuale la
chiameremo la disposizione caratterologica,. Il modo in cui concetto e
rappresentazione agiscono sulla disposizione caratterologica dell'uomo, dà alla
sua vita, una determinata impronta morale o etica.
La disposizione caratterologica, vien formata dal contenuto intrinseco più o
meno permanente del nostro soggetto, cioè dal contenuto delle nostre
rappresentazioni, e dei nostri sentimenti. (…) La rappresentazione di fare una
passeggiata nella prossima mezz'ora determina lo scopo del mio agire; ma questa
rappresentazione diviene motivo del volere solo se coincide con una appropriata
disposizione caratterologica, cioè solo se attraverso precedenti esperienze si
sono formate in me le rappresentazioni della convenienza del passeggiare e
inoltre se si accoppia in me anche il sentimento del piacere.
Dobbiamo quindi distinguere: l.) le possibili disposizioni soggettive che sono
atte ad elevare a motivi certi concetti e rappresentazioni; 2.) i possibili
concetti e rappresentazioni che sono capaci di influenzare la mia disposizione
caratterologica in modo tale da provocare un atto volitivo. Quelle costituiscono
le molle, questi gli scopi della moralità.
Le molle della moralità possiamo ritrovarle cercando di quali elementi si
compone la vita individuale: il primo gradino della vita individuale è la
percezione, e precisamente la percezione sensoria. Noi siamo qui in quella
regione della nostra vita individuale, in cui la percezione si trasforma
immediatamente in volontà, senza intervento di sentimenti e di concetti. La
molla dell'uomo, in questo caso, si può senz'altro chiamare impulso. La
soddisfazione dei nostri bisogni inferiori (fame, rapporti sessuali istintivi,
ecc.) si compie in tal guisa. La caratteristica della vita d'impulso consiste
nell'immediatezza, con cui la singola percezione provoca l'atto volitivo. Questo
modo di determinazione della volontà che originariamente è proprio solo della
Vita dei sensi inferiori, può però venire esteso anche alle percezioni dei
sensi superiori. Alla percezione di un qualche accadimento nel mondo esterno
(senza oltre pensare e senza che in noi si unisca un particolare sentimento),
facciamo seguire un'azione; (...)
La seconda sfera della vita umana è il sentimento. Alle percezioni del mondo
esterno si connettono determinati sentimenti. Questi sentimenti possono
divenire: molle d’azione. Quando vedo un uomo affamato, la compassione può
divenir molla al mio agire (…)
Il terzo gradino della vita è finalmente quella del pensiero e della
rappresentazione. Per mera riflessione può una rappresentazione o un concetto
divenire motivo di azione. Le rappresentazioni diventano motivi pel fatto che
nel corso della vita noi connettiamo continuamente certi scopi del volere con
percezioni che, in forma più o meno modificata, ritornano sempre. Queste
rappresentazioni ondeggiano dinanzi gli uomini come modelli determinanti per
tutte le successive risoluzioni; divengono parte della loro disposizione
caratterologica. Tale molla del volere possiamo chiamarla esperienza pratica;
(...)
Il gradino più alto della vita individuale è il pensiero puramente
concettuale, senza riguardo a un determinato contenuto percettivo. Noi
determiniamo il contenuto di un concetto per pura intuizione fuori della sfera
ideale. Un simile concetto non contiene nulla che si riferisca a determinate
percezioni. Quando noi arriviamo al volere sotto l'influenza di un concetto che
implica una percezione cioè di una rappresentazione, allora, è questa
percezione che ci determina attraverso il pensiero concettuale. Ma quando noi
agiamo sotto l'influenza di mere intuizioni, la molla del nostro agire è il
pensiero puro. Poiché in filosofia si è abituati a chiamare ragione la facoltà
del pensiero puro, così è giustificato di chiamare ragione pratica la molla
morale caratteristica di questo gradino. È chiaro che una simile spinta non si
può più, nel senso stretto della parola, considerare come appartenente al
campo delle disposizioni caratterologiche. Ché ciò che qui agisce come molla,
non è più un qualche di meramente individuale in me, ma è il contenuto ideale
e, conseguentemente, universale della mia intuizione. Appena io considero la
legittimità di questo contenuto come base e punto di partenza di un'azione, io
entro nel campo della volontà e non importa se il concetto esisteva già da
tempo in me o è giunto alla mia coscienza solo immediatamente prima
dell'azione, cioè non importa se era già presente in me come disposizione
oppure no. (…)
I motivi della moralità sono rappresentazioni e concetti. Vi sono dei moralisti
che vedono anche nel sentimento un motivo della moralità e, per es., ritengono
che scopo dell'azione morale sia la produzione della massima quantità possibile
di piacere nell'individuo agente. Ma non è così: il piacere in sé non può
diventare un motivo, ma solo lo può un piacere rappresentato. La
rappresentazione di un futuro sentimento, ma non il sentimento stesso, può
agire sulla mia disposizione caratterologica. Ché il sentimento, nel momento
dell’azione, non esiste ancora ma deve essere provocato appunto dall'azione.
La rappresentazione del proprio o dell'altrui bene si può però giustamente
considerare come un motivo della volontà. Il principio di ottenere con le
proprie azioni la massima quantità possibile di piacere proprio, cioè di
raggiungere la felicità individuale, si chiama egoismo. Questa felicità
individuale si cerca di raggiungere o col pensare solo al proprio benessere,
senza riguardo alcuno magari a prezzo della felicità di altri individui
(egoismo puro), oppure col procacciare il bene altrui per la ragione che dalla
felicità altrui si attende indirettamente una influenza benefica sulla propria
persona o che dal danno altrui si teme vengano minacciati gli interessi propri
(morale prudenziale). Il contenuto particolare dei principi morali egoistici
dipenderà poi dalla rappresentazione che l'uomo si farà della felicità
propria o dell'altrui. A seconda di quel ch’egli considererà come un bene
della vita (agiatezza, speranza, di felicità, liberazione da diversi mali,
ecc.), egli determinerà il contenuto della sua aspirazione egoistica.
Un ulteriore motivo è da vedersi nel contenuto puramente concettuale di una
azione. Questo contenuto non riguarda (come la rappresentazione del proprio
piacere) soltanto la singola azione, ma la giustificazione di un'azione per
mezzo di un sistena di principi morali. Questi principi possono regolare la vita
morale in forma di concetti astratti, senza che il singolo si preoccupi
dell'origine dei concetti. Allora noi sentiamo semplicemente la sottomissione al
concetto morale, che ondeggia come comandamento, come necessità morale al di
sopra delle nostre azioni. La giustificazione di tale necessità la lasciamo a
chi richiede la sottomissione morale, cioè all'autorità morale che noi
riconosciamo (capo di famiglia, Stato, costume sociale, autorità ecclesiastica,
rivelazione divina). Una speciale forma di questi principi morali è quella in
cui il comandamento non vien proclamato da un'autorità esterna, ma dal proprio
interno (autonomia morale). Crediamo di sentire allora nel nostro proprio
interno la voce, alla quale dobbiamo sottometterci. Il nome di questa voce è la
coscienza.
Si ha però un progresso morale quando l'uomo non eleva a motivo del suo agire
semplicemente il comandamento di una autorità esterna o di quella interna, ma
quando si sforza di riconoscere la ragione per cui una data massima deve valere
come motivo. Questo progresso è quello che distingue dalla morale autoritaria
l'azione basata su giudizio morale. L’uomo giunto a questo gradino studierà
la necessità della vita morale e dalla conoscenza delle medesime si lascerà
determinare alle sue azioni.
Tali necessità sono:
il massimo bene possibile della collettività umana, puramente per esso medesimo
bene;
il progresso della civiltà ossia l'evoluzione morale dell'umanità verso una
sempre maggior perfezione;
la realizzazione di fini morali individuali concepiti per pura intuizione. (…)
Gli uomini sono diversi fra loro per potere intuitivo. In uno le idee ribollono,
un altro le acquista solo a gran fatica. Le situazioni in cui gli uomini vivono
e che formano la scena delle loro azioni, non sono meno diverse. Il modo di
operare di un uomo dipenderà quindi dal modo in cui il suo potere intuitivo
reagirà di fronte a una determinata situazione. La quantità delle idee attive
in noi, il contenuto reale delle nostre intuizioni, è costituito da ciò che di
tutta l'universalità del mondo delle idee ha preso in ciascun uomo una forma
individuale. In quanto questo contenuto intuitivo agisce sulle azioni, esso
costituisce la potenzialità morale dell’individuo.
Lasciare svolgere tale potenzialità è la molla morale più alta e nello stesso
tempo il più alto motivo di coloro che intendono come tutti gli altri principi
morali si fondano alla fine in questa potenzialità. (...)
Un'azione viene sentita come libera in quanto la sua causa stia nella parte
ideale del mio essere individuale; ogni altra parte di un'azione, che venga
eseguita per forza di natura che per costrizione di una norma morale viene
sentita come non libera. Libero è solo l’uomo che in ogni momento della sua
vita, è in grado di obbedire a se stesso. Un'azione morale è una mia azione
soltanto se può in questo senso dirsi libera. L'azione libera non esclude ma
include, le leggi morali solo si distingue per stare più in alto della azioni
dettate unicamente da tali leggi. Perché la mia azione dovrebbe servire meno al
bene comune se io la compio per amore, che se io la compio soltanto perché il
servire al bene comune è un dovere? Il mero concetto del dovere esclude la
libertà, perché non vuole riconoscere l'individualità, ma non reclama la
sottomissione a una norma generale. La libertà dell'azione è solo concepibile
dal punto di vista di colui che lascia svolgere la sua potenzialità morale.
“Ma come è possibile la convivenza degli uomini se ciascuno si sforza
soltanto di affermare la propria individualità?” Ecco un'altra obiezione del
moralismo malinteso. Esso crede che una convivenza degli uomini sia possibile
solo quando questi siano riuniti da un ordine morale comune per tutti. Questo
moralismo non comprende la unicità del mondo delle idee. Non comprende che il
mondo delle idee che è attivo in me, è quello medesimo che è attivo nel mio
simile. (...) L'individualità è possibile soltanto là dove ogni essere
individuale sa dell’altro per osservazione individuale. La differenza fra me e
il mio simile non consiste menomamente nel fatto di vivere in due mondi
spirituali completamente diversi, ma nel fatto che da un mondo d’idee comune
egli riceve altre intuizioni di me. Egli vuole svolgere le sue intuizioni, io le
mie. Se entrambi veramente crediamo dall'idea, senza seguire alcun impulso
esterno (fisico o spirituale), non possiamo non incontrarci negli stessi sforzi,
nelle stesse intenzioni. Un malinteso, un urto morale escluso fra uomini
moralmente liberi. Solo l'uomo moralmente non libero che segue l’impulso
naturale il comandamento del dovere, urta contro il suo prossimo quando questi
non segue lo stesso istinto o lo stesso comandamento. Vivere nell'amore per
l’azione e lasciar vivere nella comprensione della volontà altrui è la
massima fondamentale dell’uomo libero. Egli non conosce alcun dovere
all'infuori di quello con cui il suo volere si mette in intuitivo accordo; quel
ch’egli sarà per volere in un determinato caso, glielo dirà il suo
patrimonio d’idee. (…)
Chi di noi può dire che in tutte le sue azioni egli è veramente libero? Ma in
ciascuno di noi alberga un’entità più profonda in cui l’uomo libero trova
espressione. La nostra vita si compone di azioni libere e non libere. Ma noi non
possiamo arrivare al fondo del concetto dell'uomo, senza arrivare allo spirito
libero come espressione più pura della natura umana. Noi siamo veri uomini solo
in quanto siamo liberi. (…)
Quando Kant dice del dovere: “Dovere! tu alto e gran nome che non contieni in
te nulla di quel che di caro porta con sé la lusinga, ma reclami sottomissione,
che stabilisci una legge… davanti alla quale tutte le inclinazioni tacciono,
seppur in segreto ad esse si oppongono”; lo spirito libero risponde: “Oh
libertà! tu dolce e umano nome, che contieni in te tutto ciò che di moralmente
caro massimamente mi lusinga come uomo, che non mi fai servo di alcuno, che non
stabilisci alcuna legge, ma attendi ciò che il mio amore morale riconoscerà da
sé come legge, perché di fronte a qualsiasi legge impostagli esso non si sente
libero!”
Questo è il contrasto fra la moralità legale e moralità libera. (...)
Non bisogna coniare la formula che l’uomo esista soltanto per fondare un
ordinamento morale del mondo separato da lui. Chi pensasse così starebbe -
riguardo alla scienza dell'uomo - allo stesso punto a cui stava quella scienza
naturale che diceva: “Il toro ha le corna, per poter dar cornate”.
Fortunatamente la scienza naturale ha abbandonato questi concetti di finalità
oggettiva. L'etica riesce più difficilmente a sbarazzarsene; ma come non ci
sono la corna allo scopo di poter dare cornate, ma ci sono le cornate per via
delle corna, così non c’è l’uomo allo scopo di far della moralità, ma
c’è la moralità per mezzo dell'uomo. L'uomo libero agisce moralmente perchè
ha un'idea morale, ma non agisce allo scopo di generare moralità. Gli individui
umani con le loro idee morali appartenenti al loro essere, sono il presupposto
dell'ordinamento morale del mondo.
Rudolf Steiner (1891)
45
- Goethe e Hegel
(Rudolf Steiner)
La considerazione goethiana del mondo arriva
soltanto fino a un certo limite. Egli osserva i fenomeni della luce e dei colori
e s’inoltra fino al fenomeno primordiale; cerca di orientarsi in mezzo alle
forme molteplici dell’ente vegetale e perviene alla “Urpflanze”
sovrasensibile. Dal fenomeno primordiale alla pianta primordiale non ascende a
principi esplicativi superiori. Lascia questo ai filosofi. Per suo conto è
soddisfatto di trovarsi su quella vetta empirica, da cui all'indietro può
dominare l'esperienza in tutti i suoi gradi e in avanti può, se non entrare,
almeno guardare nel regno della teoria.
Nella considerazione del reale Goethe va innanzi fino a che gli si fanno
incontro le idee. In quale connessione stanno le idee fra loro, come nella
cerchia ideale una cosa sorga dall'altra, questi sono problemi che cominciano
appena sulla vetta empirica su cui Goethe riman fermo. “L'idea è eterna ed
unica - egli pensa - non è ben fatto che si adoperi anche il plurale. Tutto ciò
che noi scorgiamo, e di cui possiamo discorrere, sono solo manifestazioni
dell’idea”. Ma poichè nelle manifestazioni l'idea si presenta come una
pluralità di idee singole (idea pianta, idea dell'animale, ecc.) queste idee
singole devono lasciarsi ricondurre a una forma fondamentale così come la
pianta si lascia ricondurre alla foglia. Anche le idee singole sono diverse solo
nella manifestazione; nella loro vera essenza sono identiche.
Quindi è nello spirito della concezione goethiana del mondo tanto il parlar di
una metamorfosi delle idee quanto il parlare di una metamorfosi delle piante. Il
filosofo che ha cercato di rappresentare questa metamorfosi delle idee è Hegel.
Quindi egli è il filosofo della concezione goethiana del mondo. Egli parte
dalla idea più semplice, da puro “essere”. Nel puro essere il vero aspetto
dei fenomeni del mondo si nasconde completamente. Il loro ricco contenuto
diventa un'astrazione anemica. Si è rinfacciato a Hegel di dedurre tutto il
ricco contenuto del mondo delle idee dal puro essere. Ma il puro essere contiene
“in idea” l'intero mondo delle idee, così come la foglia contiene in idea
l’intera pianta. Hegel segue la metamorfosi dell'idea del puro essere astratto
fino allo stadio in cui l’idea diviene direttamente un apparire reale. Egli
vede questo stadio ultimo nell'apparire della filosofia, in quanto nella
filosofia le idee che agiscono nel mondo vengono intuite nel loro aspetto
originale. Esprimendo ciò in linguaggio goethiano si potrebbe dire: la
filosofia è l’idea nella sua massima espansione; il puro essere è l’idea
nella sua estrema concentrazione. Il fatto che Hegel vede nella filosofia la
metamorfosi più perfetta dell'idea, dimostra ch’egli è altrettanto lontano
quanto Goethe dall’auto osservazione. Una cosa, raggiunge la sua più alta
metamorfosi quando estrinseca il suo pieno contenuto nella percezione, nella
vita immediata. La filosofia invece contiene il contenuto ideale del mondo non
in forma di vita, ma in forma di pensieri. L’idea vivente, l’idea come
percezione, è data soltanto dall'auto-osservazione umana. La filosofia di Hegel
non è una concezione mondiale della libertà in quanto non cerca il contenuto
del mondo nella sua forma più alta sul terreno della personalità umana. Su
questo terreno ogni terreno diviene affatto individuale. Hegel non cerca questo
individuale, ma il generale, la specie. E quindi egli pone l'origine della
morale non nell'individuo umano ma in un ordinamento del mondo, posto al di
fuori dell'uomo e contenente le idee morali. L’uomo non si dà da se stesso
uno scopo morale, ma deve inserirsi entro l'ordinamento morale del mondo. Il
singolo, l'individuale rappresenta per Hegel proprio il cattivo, quando rimane
nel suo isolamento. Solo entro l'intero acquista il suo valore. Questa è
l'opinione della borghesia, dice Max Stirner, “e il suo poeta Goethe come il
suo filosofo Hegel, hanno saputo glorificare la dipendenza del soggetto
dall’oggetto, la sommissione al mondo oggettivo, ecc.” Qui abbiamo a che
fare a sua volta con un altro modo di vedere unilaterale. Tanto a Hegel quanto a
Goethe manca l’intuizione della libertà perché ad entrambi manca
l’intuizione dell'intima essenza del mondo del pensiero. Hegel si sente
assolutamente il filosofo della concezione goethiana del mondo.
Il 20 febbraio 1821 scrive a Goethe: “Ella mette in cima a tutto il semplice e
l'astratto, che chiama appropriatamente fenomeno primordiale, mostra poi come le
manifestazioni più concrete risultino dal sopravvenire di ulteriori influenze e
circostanze, e regola l'intero processo in modo che l'ordine di successione vada
dalle condizioni semplici alle più complesse e fa in guisa che così ordinato e
decomposto l’intricato apparisca, finalmente chiaro. Rintracciare il fenomeno
primordiale, liberarlo dalle circostante accidentali, afferrarlo astrattamente,
come noi diciamo: ecco, a mio avviso, il compito di chi ha un senso profondo e
spirituale della natura, ecco il metodo per giungere ad una conoscenza veramente
scientifica in questo campo (…).
Ma farò ancora accenno a V.S. del particolare interesse che ha per noi filosofi
il fenomeno primordiale così come è stato messo in evidenza: in quanto
possiamo adesso adoperare un simile preparato direttamente in servigio della
filosofia.
Poi che abbiamo spinto il nostro assoluto, originariamente, informe, grigio, o
affatto oscuro, verso l'aria e la luce, fino a fargli venire il desiderio delle
medesime, abbiamo ora bisogno di finestre ove metterlo fuori alla piena luce del
giorno.
Ma i nostri schemi se ne andrebbero in fumo, se volessimo esporli così
senz'altro alla confusione variopinta dell'avverso mondo. È qui che i fenomeni
primordiali di V.S. giungono molto a proposito; costituiscono una specie di
penombra spirituale e comprensibile, per la sua semplicità, visibile e
palpabile per la sua materialità, in cui si abbracciano fra loro i due mondi:
il nostro mondo astruso e l'esistenza manifesta”.
Anche se la concezione goethiana del mondo e la filosofia hegeliana si
corrispondono completamente, errerebbe chi volesse riconoscere uno stesso valore
ai pensieri cui è giunto Goethe e a quelli a cui è giunto Hegel. In entrambi
vive la stessa maniera di veder le cose. Entrambi vogliono scansare l'autopercezione.
Ma Goethe ha fatto le sue riflessioni su campi in cui la deficienza della
percezione non ha effetto nocivo. Se anche non ha mai visto il mondo delle idee
come percezione, egli ha però vissuto nel mondo delle idee e imbevuto di esse
le sue osservazioni. Hegel non ha più di Goethe riguardato il mondo delle idee
come percezione, come esistenza individuale dello spirito, ma ha fatto le sue
riflessioni proprio sul mondo delle idee e quindi in molte direzioni tali
riflessioni riescono storte e mendaci.
Se Hegel avesse fatto osservazioni sopra la natura, esse sarebbero divenute
altrettanto preziose quanto quelle di Goethe. Viceversa se Goethe avesse voluto
innalzare un edificio di pensieri filosofici, sarebbe stato abbandonato da
quella sicura intuizione della realtà vera, che lo ha guidato nelle sue
considerazioni sulla natura.
Rudolf Steiner (1897)
46 - Friedrich Nietzsche e la psicopatologia (Rudolf Steiner)
“Come i processi psichici
vanno paralleli agli eccitamenti del cervello, così la psicologia fisiologica
va parallela alla fisiologia del cervello. Dove questa ultima non le offre
conoscenza sufficiente, la psicologia fisiologica dovrà investigare le
manifestazioni psichiche come tali in modo del tutto provvisorio, accompagnata
però sempre dal pensiero che anche per queste manifestazioni psichiche si deve
dimostrare la possibilità di un parallelismo coi processi cerebrali”.
Anche se non si sottoscrive incondizionatamente a questa affermazione di Theodor
Ziehen, si dovrà concedere che si è mostrata feconda per il metodo della
psicologia. Sotto l'influsso di questo criterio, questa scienza è giunta a
vedere conoscenze scientifiche. Ma bisognerà anche aver ben chiaro quale luce
getti su la connessione delle manifestazioni psichiche con i corrispondenti
processi fisiologici la osservazione delle manifestazioni patologiche
dell’anima. I fatti anormali della vita dell'anima ci chiariscono quelli
normali. E specialmente importante appare il perseguire le manifestazioni
anormli dell'anima, fin nei campi in cui l'attività della medesima raggiunge le
più alte produzioni spirituali.
Una personalità come quella di Nietzsche, offre speciali condizioni per una
tale osservazione: un nucleo morboso nella sua personalità diede a lui perenne
opportunità di riandare alla base profonda fisiologica delle sue
rappresentazioni. Egli ha toccato tutti i toni, dalla lingua poetica fino alle
più alte vette della astrazione concettuale; e precisamente dice egli stesso
come il mondo delle sue rappresentazioni si connetta con le sue condizioni
corporali: “Nel 1879 io rinunziai all'insegnamento in Basilea e come un'ombra
vissi l'estate a S. Moritz e, l'inverno seguente, il più povero di sole di
tutta la mia vita, come un’ombra a Naumburg. Questo fu il mio minimum;
nell’anno trentesimo sesto della mia vita, toccai il punto più basso della
mia vitalità: vivevo ancora, senza vedere tre passi dinanzi a me. In questo
tempo sorse “Il viandante e la sua ombra”. Certo di ombre mi intendevo io
allora... Nell'inverno che seguì, il mio primo inverno genovese, sbocciò quel
raddolcimento e spiritualizzazione, che è condizionato a estrema povertà di
sangue e muscoli, la “Aurora”. La piena chiarità e serenità, esuberanza
anche di spirito che quest'opera rispecchia, si unì in me non solo con la più
profonda debolezza fisiologica, ma anche appunto con un eccesso del senso del
dolore. In mezzo ai tormenti di un dolore nel cervello, per tre giorni
ininterrotti con penosa espettorazione di catarro, io avevo una chiarezza
dialettica per eccellenza e riflettevo con molto sangue freddo a cose alle quali
in condizioni sane non mi arrampico perché non abbastanza raffinato e freddo. I
miei lettori sanno quanto io consideri la dialettica sintomo di decadenza, come
nel caso più famoso di Socrate”.
Nietzsche considera il cambiamento del modo delle sue rappresentazioni come
prodotto appunto di un mutamento delle sue condizioni corporali: “Un filosofo
che ha fatto il suo cammino, e sempre ancora lo fa, attraverso a varie
condizioni di salute, è passato anche per diverso filosofie; egli infatti non
può che trasportare ogni volta il suo stato nelle fome e lontananze più
spirituali; questa arte della trasfigurazione è la sua filosofia”. Nelle
memorie della sua vita scritte nel 1888, “Ecce homo”, dice come dalla
malattia egli abbia avuto l’impulso a foggiarsi una visione ottimistica del
mondo. “Poiché si badi a questo, gli anni della mia più bassa vitalità
furono quelli in cui cessai di essere pessimista: l'istinto del ristabilirmi mi
proibiva una filosofia di povertà e scoramento”.
La grande contraddizione nel mondo delle idee di Nietzsche appare da questo
punto di vista comprensibile. Nelle contraddizioni si muove la sua natura
fisica. “Si è presupposto che si è una persona e quindi necessariamente si
ha anche la filosofia della propria persona; ma v'è una grande differenza: in
un filosofo le sue deficienze, in un altro le sue ricchezze e forze”. E in
Nietzsche si riaccendono ora l’uno ora l’altro. Finché fu nel benessere
delle forze giovanili che egli accolse il “pessimismo del sec. XIX come segno
della più alta forza del pensiero e di una vittoriosa pienezza di vita; ritenne
la conoscenza tragica, che trovava in Schopenhauer come “il più bel lusso
della nostra civiltà, come la forma della sua prodigalità più preziosa,
squisita e rischiosa, ma sempre, su la base della sua straricchezza, come, un
lusso permesso”. Ma non poteva vedere permesso tale lusso quando quel che era
morboso in lui, prese il sopravvento. E si crea perciò una filosofia che nella
vita faccia la affermazione più alta possibile. Aveva bisogno ora d’una
visione universale della “affermazione di sé”, della “elevazione di sé”,
di una morale di signori; aveva bisogno della filosofia dell’”eterno
ritorno”. “Io ritorno, con questo sole, con questa terra, con questa aquila,
con questo serpente - non a una vita nuova o a una vita migliore o a una vita
simile -: io ritorno eternamente, a questa mia stessa uguale vita nel più
grande e nel più piccolo”. “Poiché una mensa di Dei è la terra e fremente
di nuove opere creatrici, divine”… Oh, come potrei io essere non ardente per
l'eternità, per il nuziale anello tra gli anelli, l'anello del ritorno?”
Per i dati poco sicuri che abbiamo sugli antenati di Nietzsche, non possiamo
purtroppo formarci un giudizio soddisfacente su quanto delle qualità spirituali
di Nietzsche sia da riportare all’ereditarietà. Non giustamente si è spesso
accennato, questo proposito, che suo padre morì di malattia cerebrale; perché
questi fu colpito dalla malattia per una disgrazia dopo la nascita di Nietzsche.
Non pare però senza importanza il cenno che Nietzsche stesso fa a un elemento
morboso in suo padre: “Mio padre morì a trentasei anni; egli era delicato,
amorevole, morboso, come un essere destinato solo a trapassare...” Quando
Nietzsche dice che in lui vive qualcosa di decadente accanto a qualcosa di sano,
egli pensa che quello gli deriva dal padre, questo dalla madre che era una donna
sanissima.
Nella vita dell'anima di Nietzsche incontriamo molti tratti che confinano col
patologico e richiamano Heine e Leopardi, che hanno con lui molto di simile.
Heine fin dalla giovinezza fu travagliato dalla più cupa malinconia, soffrì
incubi e più tardi seppe anch’egli, dalla più miseranda condizione del
corpo, dal deperimento progrediente, attingere idee non lontane da quelle di
Nietzsche.
Sì, in Heine abbiamo quasi un precursore di Nietzsche per la contrapposizione
della comprensione della vita apollinea o tranquillamente contemplante e la
dionisiaca ditirambica affermazione della vita.
E anche la vita spirituale di Heine rimane inesplicabile dal punto di vista
psicologico se non si tiene conto del nucleo patologico della sua natura che
egli ereditò dal padre, che era una personalità degenerata, quasi un'ombra
scivolante attraverso la vita.
Specialmente sorprendenti sono le rassomiglianze dei caratteri fisiologici di
Leopardi e Nietzsche. In entrambi la stessa fine sensibilità ai temporali e
alle stagioni, ai luoghi e ambienti. Leopardi sente la più lieve mutazione
“termometrica e barometrica”. Poteva produrre solo nell'estate e andava
errando sempre in cerca di un luogo di sosta adatto al suo creare.
Nietzsche su questa proprietà della sua natura così si esprime: “Ora, che
per un lungo esercizio, leggo su me, come su un delicato e sicuro strumento, gli
effetti di origine climatica e meteorologica, e in un breve tragitto, da Torino
a Milano, calcolo fisiologicamente in me il cambiamento dei gradi di umidità
dell'aria, penso con sgomento al fatto inquietante che la mia vita fino agli
ultimi dieci anni, gli anni pericolosi della vita, si è svolta in luoghi falsi
e a me quasi proibiti. Naumburg, Schulpforta, Thüringen specialmente, Bonn,
Lipsia, Basilea, Venezia, altrettanti luoghi di infelicità per la mia
fisiologia...”
Con questa inconsueta sensibilità, si unisce in Leopardi come in Nietzsche un
dispregio di ogni senso altruistico: per entrambi sopportare gli uomini è un
superamento di sé. Dalle parole stesse di Nietzsche, sappiamo che in lui il suo
brivido per impressioni forti, per attrattive troppo sollecitanti la sua
sensibilità, instilla la diffidenza contro le tendenze non egoistiche. Egli
dice: “Ai compassionevoli io oppongo che per essi la vergogna, la riverenza,
la tenerezza, facilmente dinanzi alle distanze si perdono”. Il Leopardi
afferma che un uomo sopportabile solo di rado si trova e con ironia e amarezza
considerava la miseria; Nietzsche faceva suo principio: “I deboli e malformati
debbono perire: primo precetto del nostro amore degli uomini. E si deve aiutarli
in questo”.
Nietzsche dice che la vita è essenzialmente violazione, sopraffazione
dell'estraneo e dei deboli, oppressione, durezza, costrizione al proprio modo,
incorporamento o almeno sfruttamento”. Ugualmente per Leopardi la vita è una
incessante paurosa battaglia in cui gli uni calpestano gli altri.
Questi pensieri cadono entrambi nel patologico perché sorgono in essi in modo
del tutto irrazionale. Non per un esame logico, come l'economista Malthus o il
filosofo Hobbes, o per diligenti osservazioni come Darwin, furono portati al
concetto della lotta per la esistenza, ma dalla acuta sensibilità, per cui ad
ogni stimolo esterno corrispondevano con violento senso di difesa, come ad un
assalto ostile.
Questo si vede ben chiaro in Nietzsche. Egli trova in Darwin l’idea della
lotta per l’esistenza, non la respinge, ma la interpreta conformemente alla
tesa sua sensibilità. “Posto che vi sia questa lotta - e in fatto essa vi è
- si svolge però al rovescio, purtroppo di quel che la scuola di Darwin
desidererebbe e che forse si dovrebbe desiderare come essa; non favorevolmente
cioè ai forti, ai privilegiati, alle fortunate eccezioni. - le specie non
crescono in perfezione, ma i deboli si fanno signori dei forti - perché essi
sono il numero, e sono anche i più accorti... Darwin ha dimenticato lo spirito
- (questo è inglese!), i deboli hanno più spirito... Chi ha forze, si sbarazza
dello spirito.”
Senza dubbio fino a un certo grado la sensibilità tesa e l'impulso a
indirizzare le proprie osservazioni prevalentemente su la propria personalità
si condizionano. Ma le nature sane ed armoniose in ogni parte, come per es.
Goethe, vedono nella troppo intensa osservazione di sé qualche cosa che deve
far pensare.
Il modo di vedere di Goethe è in piena contraddizione con la rappresentazione
di Nietzsche: “Prendiamo la parola: conosci te stesso! Non dobbiamo intenderla
in senso ascetico. Non intende affatto la autoscienza dei nostri moderni
ipocondriaci umoristi e autopaladini, ma dice semplicemente: “dà in certa
misura attenzione a te stesso, prendi notizia di te, perché tu sappia come ti
trovi coi tuoi simili e col mondo.”
Non occorre per questo nessun tormento psicologico; ogni uomo sano sa e
sperimenta, quel che essa vuole dire: è un buon consiglio che apporta
praticamente ad ognuno il più grande vantaggio... Come si impara a conoscerci?
Non già con le meditazioni, ma sì con l’attenzione. Cerca di adempiere il
compito tuo e tu sei senz'altro quel che è in te”.
Noi sappiamo che anche Goethe aveva una sensibilità fine; ma egli aveva anche
il necessario contrappeso, la capacità che egli parlando di altri ha benissimo
descritto in un colloquio con Eckermann nel 20 dicembre 1829: “Lo
straordinario - quel che fanno uomini squisitamente dotati - presuppone una
organizzazione assai delicata che sia capace delle più fini sensazioni. E
questa organizzazione è nel conflitto col mondo e con gli elementi facilmente
turbata e offesa; e chi come Voltaire, non unisce straordinaria tenacia, a una
grande sensibilità è facilmente soggetto a una morbosità cronica”. Questa
tenacia manca a nature come Nietzsche e Leopardi.
Esse si perderebbero del tutto sotto le impressioni, gli stimoli che subiscono,
se non si chiudessero artificiosamente al mondo esterno, non gli si ponessero
ostilmente contro. Si paragoni con la vilenza di Nietzsche nel commercio con gli
uomini, la piacevolezza di Goethe, che egli così descrive: “La socievolezza
è nella mia natura; perciò in tutte le mie svariate imprese mi guadagnavo
collaboratori e mi facevo collaboratore ad essi e così raggiungevo la buona
ventura di vedere me continuare a vivere in essi, essi in me.”
Una manifestazione altamente sorprendente nella vita opirituale ai Nietzsche è
lo sdoppiamento della coscienza di sé, sempre presente in modo latente, ma
emergente a volte in modo notevole.
Il “due anime abitano, ah!, nel mio petto” (Faust), confina in lui col
patologico: ed egli non dare l'equilibrio tra le “due anime”. Le sue
polemiche a stento si possono comprendere altrimenti che da questo punto di
vista. Egli non colpisce coi suoi giudizi quasi mai l'avversario.
Quel che vuole assalire egli se lo pone di fronte in modo veramente degno di
nota e poi combatte contro un fantasma che sta ben lungi dalla realta. E questo
si comprende solo se si considera che egli, in fondo, non combatte contro un
nemico esterno, ma contro se stesso. E combatte tanto più ardentemente quando
egli in altro tempo si è trovato nello stato che egli riguarda come avverso, o
quando questo stato gioca almeno una parte nella vita della sua anima.
La sua battaglia contro Wagner è solo una battaglia contro se stesso. In un
tempo in cui egli veniva sbattuto di qua e di là in campi di idee contrastanti,
si unì, in parte involontariemente, a Wagner. Fu accolto come amico e Wagner
crebbe smisuratamente ai suoi occhi. Lo chiama il suo “Giove” cui egli
aspira “Una vita feconda ricca, che scuote, del tutto diversa, inaudita tra la
media dei mortali! Per questo anch’egli vi sta saldamente radicato, con la
propria forza, con lo sguardo via da ogni effimero, fuori del suo tempo nel più
bel senso”.
Nietzsche si foggiava ora una filosofia della quale egli si poteva dire che
coincideva, con la direzione dell'arte e la comprensione delle vita di Wagner.
Egli si identifica con Wagner. Lo considera come il primo grande rinnovatore
della civiltà tragica, che solo nella antica Grecia aveva avuto un inizio degno
di nota, ma che poi, per la raffinata sapienza intellettuale di Socrate e per la
unilateralità di Platone, dovette indietreggiare, e solo nel Rinascimento aveva
ancora un ravvivamento di breve durata.
Nietzsche fa contenuto della sua propria opera quel che egli crede di aver
riconosciuto come missione di Wagner. Ora nei suoi “Scritti postumi” si può
vedere come egli sotto l’influsso di Wagner respinse indietro il suo secondo
io. Tra questi scritti si trovano parole del tempo prima, e durante il suo
entusiasmo wagneriano, che si muovono in direzione di sentire e pensare del
tutto opposta. Pure egli si foggia una immagine ideale di Wagner che vive, non
nella realtà, ma solo nella fantasia di lui. E in questa immagine il suo io si
immerge pienamente. Più tardi sorgono in questo io campi di rappresentazione in
contrasto col modo di vedere wagneriano.
Ed egli diviene nel vero senso della parola il più violento avversario del suo
proprio mondo di pensieri. Poiché egli combatte non il Wagner della realtà, ma
la immagine che egli prima si era fatta di Wagner. La sua appassionata
ingiustizia si comprende soltanto se si vede che egli diviene così violento
solo perché egli combatte qualcosa che, secondo la sua opinione, lo ha
danneggiato traviandolo dal suo cammino. Se si fosse trovato di fronte a Wagner
obbiettivamente come un qualunque altro suo contemporaneo forse sarebbe divenuto
più tardi un suo avversario, ma in tutta la faccenda assai più ponderatamente
calmo e freddo. Ed egli sa che vuole allontanarsi non da Wagner, ma dal suo
proprio io quale si è formato in un certo momento.
Egli dice: “Voltare le spalle a Wagner era un destino per me e quindi, ancora
voler bene a qualcosa, una vittoria.” Nessuno si era forse immerso più
pericolosamente nel wagnerismo, nessuno se ne era più duramente difeso, nessuno
si è rallegrato di più di essersene liberato.
Una storia lunga! Come definirla con una parola? Forse superamento di sé? Che,
come prima e ultima cosa un filosofo attende da sè? Superare in sé il suo
tempo, “liberarsi dal tempo”. Con quello appunto, per cui è figlio del suo
tempo. “Bene! Io sono come Wagner, il figlio di questo tempo: un decatente! Ma
questo io ho compreso, me ne sono difeso: il filosofo in me si difendeva contro
questo”.
E ancora più chiaramente egli dice come sentisse la divisione del suo io e la
irrimediabile contraddizione del mondo dei suoi pensieri, nella sua coscienza:
“Chi assale il suo tempo, può soltanto assalire sé: che altro può vedere
altro che sé? Così “In un altro sé soltanto, si può venerare.
Annientamento di sé, divinizzazione di sé, spregio di sé - questo è il
nostro giudicare, amare, odiare”.
Nietzsche, quando combatte, quasi sempre combatte contro se stesso. Quando egli
nel primo tempo della sua opera di scrittore scese violentemente in campo contro
la filologia, combatteva in sé il filologo, il notevole filologo, che prima
ancora dell'esame di dottorato era stato nominato professore all'università.
Quando nel 1876 cominciò la sua battaglia contro gli ideali, aveva dinanzi al
suo occhio il suo proprio idealismo. E quando al termine della sua carriera
scrisse con violenza senza esempio il suo “Anticristo”, nient’altro ancora
lo provocava che l'intimo “cristiano” che sentiva in sé; egli senza lotta
in sé si era allontanato dal cristianesimo, ma se ne era allontanato solo con
la mente, con una sola parte del suo essere: col suo cuore, nel mondo del suo
sentire, nella condotta pratica della sua vita, rimase fedele alle
rappresentazioni cristiane. Insorse come appassionato avversario di una parte
del suo proprio essere. “Bisogna aver visto da presso il suo destino, averlo
anzi vissuto in sé; per esso essersi quasi affondati per non poter ammettere più
scherzo alcuno.
Il libero pensiero dei nostri signori ricercatori della natura e fisiologi è ai
miei occhi uno scherzo: manca in loro in queste cose la passione, il soffrire di
esse”. Come Nietzsche si sentisse diviso in sé e si sapesse impotente a
equilibrare in unità di coscienza le diverse potenze del suo interno, è
mostrato nella chiusa di una poesia dell'estate 1888, del tempo cioè che di
poco procede la catastrofe: “Ora - tra due nulla rattrappito, un
interrogativo, un enigma stracco - un enigma per uccelli da rapina... - oramai
ti scioglieranno, hanno fame del tuo scioglimento; svolazzano già intorno a te,
loro enigma, a te impiccato!... O Zarathustra!... conoscitore di te!… di te
giustiziere”.
Questa incertezza di sé si esprime anche nel fatto che alla fine della sua
carriera dà una quasi interamente nuova interpretazione alla sua evoluzione. La
sua visione del mondo ha una delle sue sorgenti nella antichità greca. Si può
in quasi tutti i suoi scritti rintracciare quale grande influsso abbiano avuto
su lui i greci: non si stanca di riaffermare l'altezza della civiltà greca.
Nel 1875 egli scrive: “I greci, l’unico popolo geniale del mondo: anche come
discepoli lo sono e lo comprendono nel modo migliore e sanno di quel che hanno
appreso fare non solo ornamento e fregio, come fanno i Romani. Il genio fa
tributari tutti i mediocri: così anche i persiani mandano le loro ambascerie
agli oracoli greci. Come diversi i Romani con la loro arida serietà, dai Greci
geniali!”
E quali belle parole trovò nel 1873 per i primi filosofi greci: l'ogni popolo
arrossisce quando si guarda ad una società di filosofi così mirabilmente
idealizzata come quella degli antichi greci Talete, Anassimandro, Eraclito,
Parmenide, Anassagora, Empedocle, Democrito e Socrate. Tutti questi uomini sono
tagliati da una stessa unica, roccia. Stretta necessitá domina tra il loro
pensare ed il loro carattere... E così essi formano insieme, quella che
Schopenhauer ha detto, in contrapposizione alla repubblica dei dotti, la
repubblica dei geniali: un gigante dice all'altro, attraverso ai deserti spazi
dei tempi; e, indisturbato dai petulanti schiamazzanti nani che via strisciano
sotto di loro, prosegue l'alto colloquio degli spiriti... Proprio come prima
esperienza, della filosofia su terreno greco, la sanzione dei sette sapienti è
una mirabile ed indimenticabile linea per la immagine dell'ellenismo.
Altri popoli hanno santi, i greci hanno sapienti... il giudizio di quei filosofi
sulla vita e sulla esistenza dice assai più che un giudizio moderno, perché
essi avevano dinanzi la vita in una rigogliosa pienezza e perché in essi il
senso del pensatore non si smarriva come presso di noi, tra il desiderio di
libertà, bellezza, grandezza della vita e l'impulso della verità che solo
chiede: quale valore veramente ha la vita?”
Nietzsche sempre è dinanzi a questa sapienza greca come dinanzi a un ideale:
cercava con una parte del suo essere di uguagliarlo, ma con l'altro lo
rinnegava. Nel “Tramonto degli idoli”, dopo aver detto quello di cui vuole
esser grato ai Romani, aggiunge: “Ai greci io assolutamente non debbo nessuna
forte impressione intima e, per dire con precisione, essi non possono per noi
quello che sono i romani. Dai greci non si impara - il loro modo è troppo
estraneo e anche troppo fluido per agire imperialmente, “classicamente”. Chi
avrebbe imparato da un greco a scrivere? Chi lo avrebbe imparato senza i
romani?... La magnifica agile corporeità, l'ardito realismo e immoralismo
propri dei greci furono un bisogno, non un natura. Seguirono poi, non furono fin
dal principio. E anche con feste e arti niente altro si voleva che sentirsi in
alto; mezzi per esaltare sé, per portare, nel caso, paura dinanzi a sé… I
greci, secondo il modo tedesco, giudicano secondo i loro filosofi, utilizzano la
bonarietà, per così dire della scuola socratica, per decidere che cosa in
fondo sia ellenico… I filosofi sono, sí, la decadenza dell'ellenismo…”
Si comprenderanno chiaramente molte manifestazioni di Nietzsche, quando si
connetta il fatto che i suoi pensieri filosofici poggiano su la osservazione di
sé, con l'altro che questo “sé” era non un quid in sé armonico, ma
scheggiato.
Questo “scheggiamento” egli portava, anche nella sua spiegazione del mondo.
Guardando in sé egli poteva dire: “Non dobbiamo noi artisti confessare che è
in noi una perturbante diversità, che il nostro gusto e d'altra parte la nostra
forza creatrice stanno in strano modo per sé, restano per sé e crescono per sé,
ciascuno - voglio dire, hanno gradi e tempi del tutto diversi di vecchiaia,
giovinezza, maturità, frollezza, fracidezza? Così che un musico, per es.,
potrebbe durante la sua vita creare cose che contraddicono a quello che il suo
orecchio di uditore prega, gusta, preferisce; e neppure occorreva che egli
sapesse di questa contraddizione!”
Questa è la spiegazione della natura dell'artista, formata secondo la essenza
di Nietzsche. Qualcosa di simile in tutti i suoi scritti.
Certo si va in parecchi casi troppo in là nel connettere manifestazioni della
vita dell'anima con concetti patologici; ma per una personalità come quella di
Nietzsche si vede che la sua visione del mondo trova piena spiegazione con
questa connessione. Come può essere utile per molti rispetti tenersi alla
parola di Dilthey: “Il genio non è una manifestazione patologica, ma l'uomo
sano, perfetto”; sarebbe però difettoso interdirsi, per un tale dogma, ogni
trattazione come quella che abbiamo fatta qui su Nietzsche.
Rudolf Steiner (1900)
47 – Le concezioni radicali del mondo (Rudolf Steiner)
Al principio del decennio 1840-50 un uomo scuote con
energia la concezione hegeliana del mondo che egli prima aveva conosciuto a
fondo ed intimamente.
È Ludovico Feuerbach (1804-‘72). La dichiarazione di guerra ch’egli mosse
alla concezione del mondo ch’egli aveva superata, è data in una forma
radicale nei suoi scritti: “Tesi preliminare per la riforma della filosofia”
(1842), “Principi della filosofia del futuro” (1843). Possiamo seguire lo
svolgimento ulteriore dei suoi pensieri negli altri scritti: “L’essenza del
cristianesimo” (1841), “L’essenza della religione” (1845) e
“Teogonia” (1857). Con l’attività di Ludovico Feuerbach si rinnovava sul
terreno della scienza dello spirito, un processo che già cent'anni prima si era
svolto sul terreno delle scienze naturali (1759) coll'intervento di G. Fr. Wolff.
L'azione di Wolff aveva significato una riforma dell'idea dell’evoluzione nel
campo della scienza degli esseri viventi. In quale maniera Wolff intendesse
l’evoluzione, risulta più chiaramente dalle visuali dell'uomo che ha opposto
alla trasformazione di questa raffigurazione, la resistenza più violenta:
Alberto von Haller. Quest’uomo, in cui i fisiologi venerano a buon diritto uno
degli spiriti più forti della loro scienza, non sapeva raffigurarsi lo sviluppo
di un essere vivo diversamente dal modo del germe che contiene già in
proporzioni esigue tutte le parti che appariscono nel decorso della vita. Lo
sviluppo è dunque sviluppo di qualche cosa che era già presente, ma che, sia
per la sua esiguità sia per altre ragioni, sfuggiva alla percezione. Se questa
concezione viene mantenuta logicamente, nulla di nuovo sorge nel decorso
dell’evoluzione, ma qualche cosa di nascosto, di racchiuso viene del continuo
messo alla luce. Il von Haller ha rappresentato queste visuali con molta rigidità
(...) Nella madre primordiale, Eva, era già latente, tenuissimo, tutto il
genere umano. Questi semi umani si sono sviluppati nel decorso della storia dal
mondo. Vediamo il filosofo Leibniz (1646-1716) esprimere la stessa opinione:
“Credere che le anime che debbono un giorno diventare anime umane sono già
state presenti, in forma seminale, come quelle delle altre specie, e che esse
hanno esistito nei nostri proavi fino ad Adamo, cioè all'inizio delle cose,
sempre in forma di oggetti organizzati”. Ora, a questa idea dell'evoluzione,
il Wolff nella sua “Theoria generationis” pubblicata nel 1759, aveva opposto
un’altra idea, partendo dal presupposto che le membra che appaiono nel decorso
della vita di un organismo, non esistevano prima in nessuna maniera, ma nascono
come tante creazioni nuove. Il Wolff aveva mostrato che nell’uovo non si trova
in nessun modo la forma dell'organismo evoluto, ma che il suo sviluppo ha una
concatenazione di creazioni nuove. Questa teoria sola spiega come può nascere
qualche cosa che non era presente ancora, che veramente “diventa”.
La concezione del von Haller nega il divenire, giacchè essa ammette che ciò
che esisteva già, diventa visibile. Questo osservatore della natura all’idea
del Wolff oppose la parola d’ordine: “Non vi è divenire” (Nulla est
epigenesis). La parola d'ordine ha per decenni fatto sì che la concezione del
Wolff rimanesse del tutto trascurata. Goethe attribuisce a tale teoria la
resistenza incontrata dai suoi sforzi per spiegare gli esseri vivi. Egli ha
tentato di capire le formazioni che si vedono nella natura organica mercè il
divenire di essa, proprio nel significato di una autentica teoria
dell'evoluzione secondo la quale ciò che appare in un essere vivo non è stato
latente finora, ma nasce veramente solo nel momento in cui appare. Egli scrive
nel 1817 che questo tentativo su cui riposava il suo scritto del 1790 sulla
metamorfosi delle piante, abbia incontrato “una accoglienza fredda, quasi
ostile. Questa riluttanza era del tutto naturale; la teoria dell'incapsulamento,
il concetto della preformazione, dello sviluppo progressivo di ciò che esisteva
fin dai tempi di Adamo, dominava in generale perfino i migliori cervelli”.
Anche nella concezione hegeliana del mondo possiamo trovare un resto della
vecchia teoria. Il pensiero puro che appare nello spirito umano, doveva essere
contenuto in tutti i fenomeni, prima ch’esso giungesse nell'uomo all'esistenza
sensibile. Lo Hegel pone questo pensiero puro prima della natura e dello spirito
individuale; esso deve essere nello stesso tempo rappresentazione di Dio, come
egli era per la sua essenza eterna prima della “creazione” del mondo.
L'evoluzione del mondo si presenta dunque come una evoluzione del pensiero
puro”.
Tale è l’atteggiamento del Feuerbach di fronte a Hegel. La protesta di
Feuerbach contro la concezione del mondo di Hegel riposa sul fatto ch’egli era
disposto ad ammettere l'esistenza dello spirito prima della sua apparizione
reale nell’uomo, come il Wolff lo era a concedere che le parti
dell’organismo vivente si trovassero già nell’uovo. Come il Wolff vedeva
negli organi dell’essere vivo creazioni nuove, il Feuerbach ne vedeva nello
spirito umano individuale. Questo non è presente in nessuna maniera prima della
sua apparizione sensibile. Esso nasce solo nel momento in cui appare nella realtà.
Non avrebbe senso per il Feuerbach il parlare di uno spirito universale di un
essere, da cui lo spirito particolare tragga l'origine. Non esiste l'essere
razionale prima della sua apparizione positiva nel mondo, dove esso plasma la
materia e il mondo sensibile in un modo tale che il suo riflesso apparisce
infine nell’essere umano. Prima dell'apparizione dello spirito umano non vi
sono che materie ed energie irrazionali, che si costituiscono in un sistema
nervoso che si concentra nel cervello. In questo nasce come creatura nuova e
perfetta, qualcosa che non esisteva ancora, l’anima umana, dotata di ragione.
In una tale concezione del mondo, non vi è possibilità di fare derivare i
fenomeni e gli oggetti da un’essenza primitiva e spirituale. Un essere
spirituale è una creazione nuova che risulta dall’organizzazione del
cervello. E quando l'uomo trasporta cose spirituali nel mondo esterno, egli si
rappresenta arbitrariamente che una essenza simile a quella che ispira le sue
proprie azioni, esiste al di fuori di lui e domina il mondo. L'uomo deve creare
ogni essenza spirituale dalla propria fantasia; le cose e i fenomeni del mondo
non danno nessuna occasione di ammettere una tale essenza. Non l'essenza
spirituale e primordiale in cui gli oggetti giacciono racchiusi ha creato l'uomo
nella propria sembianza, ma l'uomo secondo la propria essenza ha formato
l'immagine fantastica di un tale essere primordiale. È il convincimento del
Feuerbach: “La conoscenza che l'uomo ha di Dio è conoscenza ch’egli ha di
se stesso, della propria essenza. Sola l'unità dell'essere e della coscienza è
verità. Dove vi è coscienza di Dio, vi è anche l'essenza di Dio - dunque
nell'uomo”.
L'uomo non si sentiva abbastanza forte per appoggiarsi completamente su di se
stesso; perciò egli secondo la propria immagine si è creato un essere infinito
ch’egli venera ed adora. La concezione hegeliana del mondo ha, è vero,
allontanato tutte le altre qualità dell'essere primordiale, e non ha serbato
per esso che la razionalità. Il Feuerbach toglie perfino questa; e così egli
mette da parte l'essenza primordiale. Al posto della saggezza divina egli
colloca recisamente la saggezza mondiale. Egli segna, come un momento critico e
necessario nell'evoluzione della concezione del mondo, “la confessione e il
riconoscimento che la coscienza di Dio non sia altra che la coscienza
dell'umanità, che l'uomo non può pensare, presentire, rappresentare, sentire,
credere, volere, amare e venerare in questo Assoluto, in quanto Divino, altro
essere che l’essere umano”. Vi è una concezione della natura ed un'altra
dello spirito umano, ma nessuna concezione v’è dell'essenza divina. Nulla è
reale se non il positivo. “Il reale nella sua realtà o in quanto reale è il
reale come oggetto dei sensi, il sensibile. Verità, realtà, sensibilità sono
termini identici. Solo un essere sensibile, è un essere vero, reale. Solo
attravero i sensi un oggetto ci è veramente dato, non attraverso il pensiero in
sé stesso. L’oggetto dato dal pensiero o identico ad esso è solo
pensiero”.
Questo non significa altro che questo: il pensiero si presenta nell'organismo
umano come una creazione nuova e non è consentito raffigurarselo, prima della
sua apparizione, come latente sotto qualsiasi forma nel mondo. Non è lecito
voler spiegare ciò che si presenta a noi positivamente, facendolo derivare da
qualche cosa che già esisteva. Vero e divino è solo positivo “ciò che è
immediatamente certo, si esprime immediatamente e convince, ciò che trae
immediatamente dietro a sé l'affermazione della esistenza – il decisivo,
l'indubitabile, chiaro come il sole. Ma chiaro quanto il sole è solo il
sensibile; dove comincia il regno del sensibile finiscono dubbi e conflitti. Il
segreto della conoscenza immediata è la sensibilità”. La confessione di
Feuerbach culmina in queste parole: “Fare della filosofia il retaggio
dell'umanità, fu il mio primo conato. Ma chi una volta ha preso questa via,
giunge necessariamente infine a fare dell'uomo il retaggio della filosofia”.
“La nuova filosofia fa dell’uomo, includendo la natura come la sua base,
l'oggetto unico, universale e supremo della filosofia - l'antropologia dunque
congiunta alla filosofia diventa la scienza universale.”
Il Feuerbach esige che la ragione non venga collocata, come punto di partenza, a
capo della concezione del mondo, secondo il sistema di Hegel, ma ch’essa,
venga osservata come prodotto dell'evoluzione, come creazione nuova
dell'organismo umano cui essa difatti si ricollega. Perciò egli respinge ogni
separazione tra l'elemento spirituale e il corporale e materiale, perché lo
spirituale non può essere che un prodotto dell'evoluzione dell'elemento
corporale. “Quando lo psicologo dice: “Mi distinguo dal mio corpo - egli
dice pressapoco ciò che dice il filosofo nella logica o nella metafisica dei
costumi: “faccio astrazione dalla natura umana”. È ciò possibile? È
possibile fare astrazione dalla propria essenza? Non fai l'astrazione perché
sei uomo? Puoi pensare senza testa? I pensieri sono anime isolate. Va bene: ma
l'anima isolata non è essa una immagine fedele dell'uomo corporale? Non si
trasformano perfino i concetti metafisici più generali dell'essere e
dell'essenza, come l'essere e l'essenza dell'uomo si trasformano? Che cosa
significa dunque fare astrazione dall'uomo? Niente altro che facciamo astrazione
dall’uomo in quanto egli è oggetto della mia coscienza e del mio pensiero, ma
dall'uomo che giace dietro alla mia consapevolezza, cioè dalla mia natura cui
“nolens, volens” la mia astrazione rimane collegata. Così come psicologo
puoi nel tuo pensiero fare astrazione dal corpo tuo, ma rimani pure,
nell'essenza tua, collegato strettamente ad esso, cioè tu ti pensi distinto da
esso, ma non sei perciò veramente distinto... Non ha ragione il Lichtenberg
quando egli afferma che non si dovrebbe dire “penso” ma “pensa in me”.
Se dunque l'”io penso” si distingue dal corpo, ne segue forse che anche
“pensa in me” separa dal corpo ciò che è involontario nel nostro pensiero,
la radice e la base dell’“io penso”? Donde proviene dunque che non
possiamo pensare ad ogni momento che i pensieri non stanno sempre sottomessi
alla nostra volontà, che spesso in un lavoro intellettuale, malgrado gli sforzi
più energici della volontà, non progrediamo finché una circostanza esterna,
forse un cambiamento di tempo, non ridà elasticità ai nostri pensieri? Donde
appare che anche l'attività del pensiero, è un'attività organica. Perché
dobbiamo spesso portare nell’anima per anni pensieri finché essi divengano
chiari e lucidi? Perché anche i pensieri sono sottoposti ad una evoluzione
organica, che i concetti debbono anche essi maturare e svolgersi come i frutti
nei campi e le creature nel seno materno!”
Il Feuerbach accenna a Giorgio Cristoforo Lichtenberg, il pensatore morto nel
1799, che può essere, per molte delle sue idee, annoverato tra i precursori
della concezione del mondo, che si esprime negli spiriti del tipo di Feuerbach e
le cui rappresentazioni sono state tanto feconde per il secolo decimonono, perché
le imponenti costruzioni del pensiero di Fichte, Schelling, Hegel posero tutto
in ombra e dominarono l'evoluzione spirituale, tanto che sprazzi d'idee
aforistiche perfino così rilucenti come quelli del Lichtenberg, rimasero
ignoti. Non abbiamo che da ricordare qualche detto di questo uomo eminente, per
mostrare come il suo spirito rivivesse nella corrente aperta da Feuerbach.
“Dio creò l'uomo secondo l’immagine sua; questo significa probabilmente che
l'uomo creò Dio secondo la sua”. “Il nostro mondo diventerà così
raffinato che sarà così ridicolo credere in Dio come lo è oggi credere ai
fantasmi”. “Il nostro concetto di Dio è qualcosa di diverso
dall'inconcepibile personificato?” “La raffigurazione che ci facciamo
dell'anima presenta molta affinità con quella nostra di una calamita nella
terra. È solo una immagine. È un’invenzione innata nell’uomo pensare tutto
sotto questa forma”. “Invece di dire che il mondo si rispecchia in noi,
dovremmo piuttosto dire che la nostra ragione si rispecchia nel mondo. Non
possiamo fare diversamente: siamo costretti a riconoscere nel cosmo un ordine e
un governo saggio: questo risulta dalla disposizione del nostro pensiero. Non ne
consegue necessariamente che qualche cosa, che noi dobbiamo per forza pensare,
sia realmente, come la pensiamo... e per questo non si può provare l'esistenza
di nessuna divinità. Dio non si lascia provare”. “Siamo consapevoli di
certe raffigurazioni che non dipendono da noi; altre, almeno lo crediamo,
dipendono da noi; dov'è il limite? Non conosciamo che l'esistenza delle nostre
impressioni, raffigurazioni e pensieri. Dovremmo dire: “qualche cosa pensa”,
come diciamo: “lampeggia”.
Se il Lichtenberg avesse avuto oltre a questi slanci di pensiero la capacità di
fonderli in una concezione armoniosa del mondo, egli non sarebbe stato negletto
come lo è stato. Per costruire un concetto del mondo ci vuole non solo la
superiorità dello spirito ch’egli possedeva, ma anche il potere di foggiare
idee connesse in modi molteplici e di dare a loro una forma plastica. Questa
possibilità gli difettò. La sua superiorità si esprime in un giudizio
notevole sui rapporti di Kant coi suoi contemporanei. “Credo che come i
discepoli di Kant rimproverano sempre ai loro avversari che non li capiscono,
molti anche credono che il signor Kant abbia ragione, giacché, essi lo
capiscono. La sua raffigurazione filosofica è nuova e si stacca molto dalle
solite visuali, e quando si riesce ad intuirla, si è molto disposti a tenerla
per vera, giacché Kant ha tanti seguaci. Ma si dovrebbe pure riflettere che
questa comprensione non è un motivo per tenere questo sistema vero. Credo che
la maggioranza nella gioia d'intendere un sistema molto astratto e oscuro, abbia
creduto con ciò ch’esso fosse dimostrato.”
Quanto Feuerbach dovesse sentirsi affine a Lichtenberg, risulta soprattutto
quando si confronta da quale punto di vista i due pensatori consideravano i
rapporti della loro concezione del mondo con la vita pratica. Le conferenze che
il Feuerbach pronunciò nell'inverno del 1848 davanti ad un gruppo di studenti
sull’essenza della religione, si concludevano con queste parole: “Mi auguro
solo di non aver fallito al compito che ho tracciato in una delle prime lezioni,
il compito cioè di fare degli amici di Dio degli amici degli uomini, di
credenti, pensatori; di oranti, lavoratori; di candidati all'al-di-là, studiosi
di questo mondo; di cristiani, che secondo la loro propria confessione, sono
“metà animali, metà angeli”, uomini: uomini completi”.
Chi come Feuerbach fa riposare ogni concetto del mondo sul fondamento della
conoscenza della natura e dell'uomo, deve anche nel regno della morale eliminare
tutti i compiti, tutte le obbligazioni che nascono da un dominio diverso dalle
disposizioni naturali degli uomini, o che hanno uno scopo diverso da quello che
si riferisce tutto al mondo sensibile. “Il mio diritto è la tendenza alla
felicità quale me la concede la legge; il mio dovere è l'istinto di felicità
degli altri che mi costringe a riconoscerlo”. “Non guardando l'al di là
imparerò ciò che debbo fare, bensì osservando questo mondo. Tutta la forza
ch'io spendo ad assolvere qualsiasi dovere che si riferisce al mondo di là è
sottratta alle mie capacità di questo mondo cui solo sono destinato”.
“Concentrazione sul mondo presente” ecco ciò che richiede Feuerbach.
Possiamo leggere parole simili negli scritti del Lichtenberg. Ma proprio queste
sono mescolate con parti che mostrano quanto poco un pensatore che non ha la
possibilità di escogitare armoniosamente le sue idee riesca a seguire una idea
fino alle sue conseguenze più estreme. Il Lichtenberg richiede sì la
concentrazione sul mondo presente, ma egli introduce ancora in questa essenza
considerazioni che si riferiscono ad un al di là: “Credo, che molti uomini
dimenticano nella loro vocazione per il cielo, quella della terra. Penso che
l'uomo sarebbe più saggio, se egli lasciasse l'educazione celestiale dove sta.
Se noi siamo stati messi da un essere saggio a questo posto, ciò che non è da
dubitare, facciamo del nostro meglio in questa situazione e non ci lasciamo
accecare da certe rivelazioni. Ciò che l'uomo deve sapere per essere felice
egli lo sa, senz’altra rivelazione che quella posta dalla natura a sua
disposizione”. Confronti, come quello che si può stabilire tra il Lichtenberg
e il Feuerbach, sono istruttivi per la storia della evoluzione del concetto del
mondo. Ci fanno scorgere il progresso degli spiriti, permettono di misurare
quanto l'intervallo di tempo che li separa abbia accentuato questo processo.
Feuerbach è passato attraverso la concezione hegeliana del mondo, e da essa ha
attinto il vigore per plasmare da tutti i lati il suo sistema, opposto a quello
di Hegel. Egli non è più turbato dal problema kantiano, abbiamo veramente il
diritto di attribuire la realtà al mondo che percepiamo o esiste questo mondo
soltanto nella nostra immaginazione? Chi afferma questo ultimo termine può
collocare nel mondo reale che giace al di là delle rappresentazioni, tutte le
energie possibili all'uomo. Egli può, accanto all’ordine naturale del mondo,
ammettere un ordine soprannaturale, come fece Kant. Chi, nel senso di Feuerbach,
dichiara che il sensibile è reale, deve eliminare ogni ordine soprannaturale.
Per lui non c'è imperativo categorico, nato nell’al di là, dovunque sia; per
lui vi sono solo doveri che risultano dagli impulsi e dagli scopi naturali
dell'essere umano.
Per foggiare una concezione del mondo tanto aliena da quella di Hegel, come fece
Feuerbach ci voleva una personalità tanto diversa dallo Hegel, quanto la sua.
Lo Hegel si sentiva a suo agio nel movimento della vita attuale. Dominare
l’attività immediata del mondo col suo spirito filosofico era per lui un
compito bello. Quando egli fu liberato dalla sua attività d’insegnante a
Heidelberg per recarsi in Prussia, egli fece intendere chiaramente nel suo
discorso d’addio che la prospettiva di trovare un campo d'attività che non
consistesse solo nell'insegnamento, ma gli consentisse anche un'attività
pratica, lo seduceva. “Sarebbe stata per lui di grande importanza la
prospettiva di una possibilità, nell'età più matura, di passare dalla
funzione precaria di docente di filosofia in una università, ad un'altra
attività e ad altro impiego”. Chi è in una tale disposizione di pensiero,
deve vivere in pace con le forme della vita pratica che la vita del suo tempo ha
assunto. Egli deve giudicare ragionevoli le idee che pervadono la sua epoca.
Solo da questo sentimento egli può attingere l’entusiasmo con cui lavorare
alla loro costruzione. Feuerbach non provava grande simpatia per la vita del suo
tempo. Preferiva la calma di un luogo appartato all'agitazione della vita
moderna di allora. Egli si esprime chiaramente in proposito: “Del resto io non
mi riconcilierò mai con la vita della città. Giudico buono anzi mio dovere,
recarmici ogni tanto per studio, secondo le impressioni che ho già esposte; ma
io devo tornare alla solitudine campestre per studiare e riposarmi in seno alla
natura. Il mio dovere più urgente è di preparare le mie conferenze, secondo il
desiderio dei miei ascoltatori o di preparare per la stampa le carte di mio
padre”.
Dalla sua solitudine, Feuerbach credeva di potere meglio giudicare ciò che non
è naturale nella forma assunta dalla vita reale, ciò che l'illusione umana vi
ha mescolato, la purificazione della vita dalle illusioni, questo egli riteneva
fosse il suo dovere. Perciò egli doveva starsene lontano dalla vita tuffata in
queste illusioni. Egli cercava la vita vera; e non poteva trovarla, nella forma
ch’essa ha preso nella civiltà contemporanea. Quanto egli fosse sincero nella
sua concentrazione su di questa vita, lo prova un giudizio suo sulla rivoluzione
di marzo. Essa gli appariva sterile perché nelle idee su cui era basata
sopravviveva ancora la vecchia fede nell'al di là. “La rivoluzione di marzo
era ancora figlia, sebbene illegittima, della fede cristiana. I fautori della
costituzione credevano che il Signore non avesse a che dire: il diritto sia! la
libertà, sia! per creare il diritto e la libertà; e i repubblicani credevano
che bastasse volere la repubblica per chiamarla alla vita: credevano dunque alla
creazione ‘ex nihilo’ di una repubblica.” Gli uni trasportavano i miracoli
cosmici cristiani; gli altri i miracoli sensibili cristiani, sul terreno della
politica. Sola una personalità che pensa di portare in se stessa l'armonia del
mondo di cui l'uomo ha bisogno, può anche nella profonda insoddisfazione in cui
il Feuerbach si trovava, di fronte alla realtà, cantare l'inno alla realtà
ch’egli ha cantato. Noi lo sentiamo in parole come queste: “Nella mancanza
di una prospettiva dell'al di là, io posso in questo mondo, nella valle
d'afflizioni che è la politica tedesca ed europea, mantenermi in vita e
sanamente, solo facendo del presente l'oggetto della mia aristofanesca. Solo una
tale personalità poteva cercare nell'uomo la forza che altri vanno ad attingere
da una potenza esteriore.
La nascita del pensiero aveva influito sulla concezione greca del mondo, così
che l'uomo non si sentiva più immedesimato nel cosmo, come l'antica
raffigurazione immaginativa glielo concedeva. Era il primo stacco di un distacco
abissale tra l'uomo e il mondo. Uno stadio ulteriore fu dato con lo sviluppo
della nuova mentalità scientifica. Questa evoluzione separò completamente la
natura e l'anima umana. Doveva nascere da una parte una immagine della natura in
cui l'uomo, secondo la sua natura spirituale e psichica non si trova, e
dall’altra parte una idea dell’anima umana che non aveva collegamento colla
natura. Nella natura si trovava la necessità conforme alle leggi, ma
nell'ambito di questa nessun posto per ciò che si trova nell'anima umana:
tendenza alla libertà, senso di una vita radicata in un mondo spirituale e che
non si esauriscono nell'esistenza sensibile. Spiriti come quello di Kant,
trovarono uno sbocco nella separazione assoluta delle due sfere; trovavano
nell’una la conoscenza della natura, nell'altra la fede. Goethe, Schiller,
Fichte, Schelling, Hegel pensavano l'idea dell'anima consapevole di sé, così
ch’essa sembrava a loro radicata in una natura spirituale più alta, che
domina la natura e l'anima umana. Col Feuerbach appare uno spirito, che mercé
l'immagine del mondo che la nuova raffigurazione scientifica può dare, si crede
obbligato a negare all'anima umana ciò che è in contrasto con l'immagine della
natura. Egli può fare questo solo perché egli elimina da quest'anima umana ciò
che impedisce di riconoscere in essa un membro della natura. Fichte, Schelling,
Hegel presero l'anima consapevole per ciò che essa è. Feuerbach fa di essa ciò
di cui egli ha bisogno per il suo concetto del mondo. Egli è l'iniziatore di
una raffigurazione che si sente dominata dall'immaginazione della natura. Essa
non sa conciliare i due elementi dell'immagine del mondo, l'immagine della
natura, e quella dell'uomo; perciò essa trascura del tutto l'immagine
dell'anima. L’idea wolffiana delle nuove creazioni porta all'immagine della
natura un contributo fecondo d’impulsi. Il Feuerbach utilizza questi impulsi
per creare una conoscenza dello spirito che può solo sussistere in quanto non
se ne occupa. Egli determina una corrente di pensiero che rimane impotente
dinanzi ad una delle esigenze più forti della vita psichica moderna, dinanzi
alla consapevolezza di sé. Nel concetto suddetto del mondo questo impulso si
rivela in un modo tale che non solo esso viene ammesso come inconcepibile, ma
che - perché esso appaia inconcepibile - la sua vera forma viene fraintesa ed
esso è trattato come un fattore della natura, cioè che non appare vero ad un
osservatore disinteressato.
“Dio fu il mio primo pensiero, la ragione il secondo, l'uomo il terzo ed
ultimo”. Così Feuerbach descrive la via ch’egli aveva seguita da credente e
discepolo dello Hegel, e da questo stadio al suo proprio pensiero. Avrebbe
potuto dire le stesse parole il pensatore che l'anno 1834 scrisse uno dei libri
più efficaci del secolo. “La vita di Gesù”. Era Davide Federico Strauss
(1808/'74). Feuerbach prendeva le mosse da uno studio dell'anima umana e vi
trovava la tendenza a proiettare nel mondo la propria essenza e a venerarla come
essenza originale e divina. Egli cercava una spiegazione psicologica della
nascita del concetto di Dio. Le visuali dello Strauss miravano allo stesso
scopo, ma egli non seguiva come il Feuerbach la via dello psicologo bensì
quella dello storico. Ed egli non poneva al centro delle sue riflessioni il
concetto di Dio in generale, nel senso universale adottato da Feuerbach, bensì
la nozione cristiana dell'uomo: Dio, Gesù. Egli voleva fare scorgere come
l'umanità, nel decorso della storia, fosse giunta a questa raffigurazione. Che
l'essenza divina primordiale si riveli nello spirito umano, era la fede della
concezione hegeliana del mondo. Anche lo Strauss condivideva questo
convincimento. Ma in un individuo umano, secondo la sua opinione, l'idea divina
non può realizzarsi in tutta la sua realtà. L'individuo è sempre una
espressione incompleta dello spirito divino. Ciò che manca ad un essere umano
perch’esso sia perfetto, lo possiede un altro. Quando si considera tutto il
genere umano, vi si trovano, ripartite fra individui innumerevoli, tutte le
perfezioni che sono particolari alla divinità. Il genere umano nel suo
complesso è il Dio incarnato, l’Uomo-Dio. Ecco, secondo l’opinione dello
Strauss, il concetto di Gesù che si fa il pensatore. Da questo punto di vista,
lo Strauss si accinge alla critica della nozione cristiana dell’uomo-Dio. Ciò
che il pensiero distribuisce fra tutto il genere umano, il cristianesimo lo
riassume in una personalità esistita effettivamente una volta nella storia.
“All’idea di un uomo-Dio contraddicono le qualità e le mansioni attribuite
dalla dottrina ecclesiastica a Gesù. Nell'idea della specie umana esse invece
concorrono”. Con l’appoggio di indagini accurate, delle basi storiche dei
Vangeli, lo Strauss cerca di dimostrare che le raffigurazioni del Vangelo sono i
risultati della fantasia religiosa. Questa avrebbe presentito oscuramente il
fatto che il genere umano sia l'uomo-Dio, ma non l’avrebbe espresso in
concetti chiari, bensì in una forma poetica, in un mito. La storia del figlio
di Dio diventa per lo Strauss un mito in cui le idee dell'umanità furono
espresse poeticamente, molto prima di essere conosciute dai pensatori nelle
forme del pensiero puro. Da questo punto di vista, si spiega tutto il miracolo
della storia evangelica, senza ricorrere alla spiegazione volgare, spesso
invocata prima, che vedeva nei miracoli illusioni volontarie ed ingenue,
praticati dal fondatore della nuova religione per rendere la sua dottrina più
impressionante o inventate dagli apostoli a questo scopo. I miracoli erano la
veste poetica di verità reali. Nell’immagine del Salvatore morente e
resuscitato, il mito raffigura l'umanità che dai suoi interessi finiti, dalla
vita quotidiana, si innalza alla conoscenza della verità e della razionalità
divina. Il finito muore per rinascere come infinito.
Nel mito degli antichi popoli si può vedere la sconfitta della raffigurazione
immaginativa dei tempi primitivi da cui si sviluppa la vita concettuale. Un
sentimento di questo fatto sopravvive nel secolo decimonono in una personalità
come quella di Strauss. Egli vuole orientarsi nel processo e nel significato
della vita concettuale: egli si addentra nel rapporto della concezione del mondo
col pensiero mitico nella epoca storica. Egli vuole sapere come la
raffigurazione plasmatrice dei miti può ancora operare nella concezione moderna
del mondo. E nello stesso tempo egli vuole radicare la coscienza umana di sé in
una essenza che giaccia fuori della personalità individuale, rappresentandosi
l'umanità intera come una incarnazione dell’essenza divina. Con questo egli
acquista per le singole anime una base della psiche del genere umano totale, che
si esplica nel divenire storico.
Lo Strauss fa opera più radicale ancora nel suo libro pubblicato negli anni
1840/41: “La dottrina cristiana, nella sua evoluzione storica e nel conflitto
colla scienza moderna”. Qui si tratta per lui, di ridurre i dogmi cristiani
dalla loro forma poetica alle nozioni vere dei concetti su cui essi poggiano.
Egli insiste sull’incompatibilità della coscienza moderna con quella che
rimane fedele alle antiche rappresentazioni immaginative e mitiche della verità.
“Lasci dunque il credente che lo scienziato segua il suo cammino e viceversa;
lasciamo a loro la fede, che ci lascino dunque la filosofia e se i bigotti
riescono ad escluderci dalle loro chiese, considereremo questo come un guadagno.
Vi sono stati fino adesso abbastanza tentativi falsi di conciliazioni; solo la
separazione degli estremi, può approdare a qualche cosa. Le visuali dello
Strauss avevano suscitato un'immensa agitazione negli spiriti. Con amarezza si
constatava che il concetto moderno del mondo non si contentava di colpire le
raffigurazioni religiose in generale, ma ch’esso, con una ricerca storica
fornita di tutti i mezzi scientifici, cercava di eliminare l'inconseguenza che
secondo le parole dette una volta dal Lichtenberg, “aveva consistito nel
sottoporre la natura umana al giogo di un libro”. “Non si può, egli
continua, immaginare qualche cosa di più abominevole e questo solo esempio
prova che misera creatura sia l'uomo in concreto, voglio dire rinchiuso in
questo fiasco a due gambe fatto di terra, di acqua e di sale. Se fosse possibile
che una volta la ragione si erigesse un trono di despota, l'uomo che volesse
confutare, seriamente, in base all'autorità di un libro, il sistema di
Copernico, dovrebbe essere impiccato. Che un libro si dica proviene da Dio, non
è ancora certo che esso sia da Dio; che la nostra ragione derivi da Dio è
certo, si può intendere la parola Dio come si vuole. La ragione dove regna,
punisce, sia con le conseguenze naturali della colpa, sia con ammonimento, se
l'ammonimento può essere chiamato punizione”. Lo Strauss fu destituito dalla
sua carica di docente all'università di Tubinga, in seguito alla pubblicazione
della ‘Vita di Gesù’ e quando egli fu nominato professore di teologia
all'università di Zurigo, i contadini vennero con vanghe a protestare contro il
dissolvitore dei miti ed a esigere il suo licenziamento.
Un altro pensatore andò molto più lontano di quanto si proponeva lo Strauss
nella critica dell'antico concetto del mondo, dal punto di vista del nuovo. Fu Bruno Bauer. Troviamo ancora presso di lui l'opinione patrocinata dal Feuerbach che
l'essenza dell'uomo sia l'essenza sua più nobile e che ogni essenza più alta
non sia che una illusione, che l'uomo crei secondo il proprio modello e collochi
se stesso al di sopra di sé, ma questa teoria assume una forma ridicola. Bruno
Bauer descrive il modo in cui l'io umano giunge a crearsi un duplicato di sé in
espressioni dettate, non dal bisogno di una comprensione simpatica della
religione, ma dalla gioia di distruggere. Egli dice: “l'io che abbraccia tutto
ebbe paura di se stesso, esso non osò concepirsi come tutto e come forza più
generale che esista, cioè esso rimase spirito religioso e diventò
completamente estraneo a se stesso, ponendo di fronte a sé la sua forza
generale, come estranea e lavorando in timore e tremore per la propria
conservazione e la propria felicità”. Bruno Bauer è una personalità che si
afferma criticando ogni dato, col suo pensiero sovvertitore. Egli dalla
concezione hegeliana del mondo ha ricordato la convinzione che il pensiero abbia
il compito di penetrare fino all'essenza delle cose. Ma egli non è, come Hegel,
disposto a lasciare al suo pensiero produrre una risultante o una costruzione
concettuale. Il suo pensiero non è produttivo, è critico. Un pensiero
definito, una idea positiva, gli avrebbero dato il senso di una limitazione.
Egli non vuole fissare la forza critica del pensiero partendo da un concetto,
come da un punto di vista determinato, come ha fatto lo Hegel. “La critica è
da una parte l'ultima azione di un determinato pensiero filosofico, che si deve
con questo liberare da una determinazione positiva, che restringe ancora la sua
generalità, e d’altra parte è anche il presupposto senza il quale la
filosofia non può innalzarsi all'ultima generalità della coscienza di sé”.
Ecco la professione di fede della critica della concezione del mondo adottata da
Bruno Bauer. La critica non crede alle idee, ai concetti, ma solo al pensiero.
“L'uomo è solo stato scoperto adesso” dice il Bauer con trionfo. L'uomo
oramai non è più legato che dal suo pensiero. Non è umano il dedicarsi a
qualche cosa di sovraumano: ma lo è il rielaborare tutto nel crogiuolo del
pensiero. L'uomo non deve essere il riflesso di un altro essere, ma prima di
tutto, l'”uomo”, ed egli può esserlo solo attraverso il suo pensiero.
L'uomo che pensa è l'uomo vero. Nulla cosa esterna, né la religione, né il
diritto, né lo Stato, né la legge possono fare dell’essere umano un uomo,
solo il suo pensiero. Nel Bauer appare l'impotenza del pensiero che vorrebbe
raggiungere la consapevolezza di sé ma non vi riesce.
Ciò che il Feuerbach ha riconosciuto come l’essenza più alta dell'uomo, ciò
che Bruno Bauer affermava essere stato scoperto dalla critica, come concetto del
mondo, l'uomo considerato senza pregiudizi e senza presupposti, è il compito
che si propone Max Stirner, nel suo libro apparso nel 1845 “L’Unico e la sua
proprietà”. Lo Stirner esprime questo giudizio: “Con l'energia della
disperazione il Feuerbach afferra il contenuto complessivo del cristianesimo,
non per rigettarlo bensì per afferrarlo, per staccare dal cielo con uno sforzo
supremo questa religione lungamente desiderata, rimasta sempre lontana e per
tenerla sempre vicino a sé. Non è questa la stretta dell'ultima disperazione,
una stretta per la vita e la morte e non è nello stesso tempo la nostalgia e il
desiderio cristiano dell'al di là? L’eroe non vuole penetrare nell'al di là,
ma trarre a sé l'al di là e costringerlo a diventare questo mondo”. E da
questo momento non grida il mondo intero con più o meno consapevolezza che
“si tratta del mondo presente, che il cielo deve venire sulla terra ed essere
vissuto qui?” Alla teoria del Feurbach lo Stirner oppone una contraddizione
violenta: “L’essenza più eccelsa è in ogni caso l'essenza dell'uomo, ma
perché è la sua essenza, non l'uomo stesso, rimane per noi indifferente che
noi vediamo questa essenza fuori dell'uomo in quanto Dio o che lo troviamo
nell'uomo e la chiamiamo “essenza dell'uomo” o “essere umano”. “Non
sono né Dio né l'essere umano né l'essenza più alta, né la mia essenza, e
in fondo non importa che noi pensiamo l’essenza fuori di noi o in noi. In
realtà noi pensiamo sempre l'essenza più alta in un doppio al di là, sia
interno, sia esterno nello stesso tempo, giacché lo spirito di Cristo è
secondo il nostro concetto cristiano “spirito nostro” e “vive in noi”:
Esso vive nel cielo e in noi. Noi povere creature siamo la sua dimora e quando
il Feuarbach distrugge la dimora celestiale, ed obbliga lo spirito a venire in
noi con tutta la sua suppellettile, noi, la sua dimora terrena, siamo anche
molto in disagio”.
Per quanto il singolo io umano supponga ancora una forza qualsiasi da cui esso
dipende, esso vede se stesso non dal proprio punto ai vista, ma da quello di
questa potenza estranea. Egli non possiede se stesso, è posseduto da questa
forza. L'uomo religioso dice: “Vi è una essenza originale e divina di cui
l'uomo è il riflesso”. Egli è posseduto dall'archetipo divino. Il seguace
dello Hegel dice: vi è una essenza umana in ogni individuo, è un riflesso
particolare di questa essenza. Ogni essere umano singolo è dunque posseduto
dall'”essenza dell’umanità”. Ma in realtà, esiste solo l'uomo individuo,
non il concetto generico dell’umanità, che il Feuerbach sostituisce
all'essenza divina. Quando l'essere umano mette al di sopra di se stesso il
“genere umano”, egli si abbandona di certo ad una illusione, come quando
egli si sente dipendente da un Dio personale. Per il Feuerbach, le leggi che il
Cristo vede istituite da Dio e ritiene perciò, normative, sono leggi che
permangono perché corrispondono all'idea generale dell'umanità. L'uomo si
giudica moralmente, sì da chiedersi: le mie azioni individuali corrispondono a
ciò che conviene alla essenza generale dell’umanità? Il Feuerbach dice: se
l'essenza dell'uomo è la sua essenza più alta nella pratica, il primo e il più
alto comando, sarà l'amore dell’uomo per l'uomo. “Homo
homini deus est. L’etica
è in sé e per sé una potenza divina”. I rapporti morali sono in sé veri
rapporti religiosi. La vita è nei suoi rapporti essenziali e sostanziali di
natura divina. Tutto ciò che è retto, vero, buono ha in se stesso il suo
motivo di santità, nelle sue proprietà. L'amicizia è e deve essere sacra. La
proprietà è sacra, il matrimonio è sacro, il bene di ogni essere umano è
sacro, ma sacro in sé e per se stesso. Esistono dunque energie generali ed
umane; l’etica è tale. Essa è sacra in sé e per se stessa; l'individuo deve
ubbidirle. L'individuo non deve volere ciò ch’egli vuole da se stesso, ma ciò
che è nel senso dell'etica sacra. Egli è posseduto dall'etica. Lo Stirner
caratterizza nel modo seguente questa concezione: “Invece del Dio di tutti,
cioè “l’UOMO” ed è per noi l’ideale più alto essere uomini. Giacché
nessuno può essere mai pienamente ciò che implica la parola “essere
umano”, l'essere umano rimane per l’individuo un al di là eccelso, un
essere supremo, ancora non raggiunto, un Dio”. Una tale sublime essenza è
anche il pensiero, di cui la concezione critica del mondo ha fatto un Dio.
Stirner non si lascia fermare da esso. “Il critico teme di diventare dogmatico
o di stabilire dogmi. Per forza, ché diventerebbe altrimenti l’antitesi di un
critico, un dogmatico; egli invece di essere buono, in quanto critico,
diventerebbe cattivo etc.” “Via coi dogmi” ecco il suo dogma. Pure il
critico rimane sullo stesso terreno del dogmatico, sul terreno del pensiero, ma
poi egli ne diverge nel rinunciare e ritenere il pensiero che gli serva di
principio, nel processo di escogitazione; non gli lascia dunque acquistare
stabilità. Egli fa ora, il processo del pensiero contro la credibilità, egli
fa valere il progresso del pensiero, contro il pensiero statico. Nessun pensiero
si salva dalla sua critica, giacché essa è il pensiero o lo spirito che pensa.
“Non sono un avversario della critica, cioè non sono un dogmatico, e non mi
sento leso dal dente del critico quando egli lacera un dogmatico. Se fossi un
dogmatico, io stabilirei un dogma, cioè un pensiero, una idea, un principio e
li porterei alla perfezione, come un sistematico, facendone la base di un
sistema, cioè di un edificio concettuale. Se invece fossi un critico, nemico
della dogmatica, io battaglierei contro il pensiero schiavo, difenderei il
pensiero contro ciò che è pensato. Ma non sono il difensore né di un concetto
né del pensiero”. Ogni pensiero nasce dall’io individuale, anche se fosse
il concetto della propria essenzialità. E quando l'uomo crede di riconoscere il
proprio io, vuole descriverlo secondo la sua essenzialità, egli si rende
dipendente da questa essenzialità. Posso pensare ciò che voglio: appena
ricorro a certi concetti, appena definisco, divento schiavo dei dati del
concetto, della definizione. Lo Hegel faceva dell'io la manifestazione della
ragione, lo rendeva dipendente da essa. Ma tutte queste dipendenze non potevano
avere valore di fronte all'io poiché esse tutte derivano dall'io. Esse riposano
dunque su di un'illusione dell'io. In realtà esso non è dipendente. Tutto ciò
da cui esso deve dipendere, esso stesso deve crearlo. Esso deve prendere qualche
cosa in se stesso, per metterlo al di sopra di se stesso come un fantasma.
“Uomo, il tuo cervello è spiritato, tu sei matto. Tu sogni cose grandi e ti
raffiguri un mondo intero di Dei che esistono per te, un regno degli spiriti cui
sei chiamato, un ideale che ti attrae. Hai insomma una fissazione!” “In
realtà, nessun pensiero può avvicinarsi a ciò che vive in me. Il mio pensiero
può giungere a tutto, solo di fronte al mio io debbo fermarmi. Non posso
pensarlo, ma sentirlo soltanto. Non sono volontà, non sono idea, come non sono
il riflesso di una divinità. Tutte le altre cose le concepisco mercé il
pensiero. L’io lo vivo. Non ho bisogno di definirmi, di descrivermi di più,
mi sento vivo in ogni momento. Ho bisogno di descrivere solo ciò che non vivo
immediatamente, ciò che è fuori di me. Mi appare un controsenso volermi
concepire come pensiero, come idea, quando io mi posseggo come oggetto. Se ho di
fronte a me una pietra, cerco di spiegarmi col pensiero che cosa sia questa
pietra. Ciò che sono, non ho bisogno di spiegarmelo, lo vivo già.” Lo
Stirner replica ad un attacco diretto contro il suo libro: “L’individuo è
una parola, e per una parola si dovrebbe poter pensare qualche cosa, una parola
deve avere un contenuto concettuale. Ma l'individuo è una parola senza nozione,
essa non ha contenuto concettuale. Che cosa può dunque essere il suo contenuto,
se non è il pensiero? Un oggetto che non può presentarsi due volte, che non può
essere espresso, giacché se potesse veramente e completamente essere espresso,
esso si presenterebbe per la seconda volta, sarebbe presente nella espressione.
Poiché il contenuto dell’individuo non è contenuto concettuale, perciò esso
è impensabile e indicibile, ma giacché è indicibile, egli è questa frase
intera, e oppure nessuna frase. Solo quando non si dice nulla di te e tu sei
solo nominato, sei tu riconosciuto in quanto "tu". Appena si dice di
te qualche cosa, sei conosciuto come questa cosa (uomo, spirito, cristiano e così
via). Il singolo non dice altro, perché esso è un mero nome, esso dice solo
che tu sei tu e nient'altro, che sei un "tu" unico e tu stesso. Perciò
sei senza predicati e nello stesso tempo senza destinazione, senza vocazione,
senza legge”.
Già nel 1842 in uno studio sulla “Rheinische Zeitung” sul principio irreale
della nostra educazione o sull'umanismo ed il realismo, lo Stirner aveva
espresso l'idea che il pensiero, il sapere non può penetrare fino al nucleo
della personalità. Egli considera dunque come un principio d'educazione
erroneo, che in un modo unilaterale il sapere sia messo al centro
dell'educazione, al posto di questo nucleo personale. “Un sapere che non ci
purifica e si concentra per trascinare poi la volontà che solo mi aggrava come
un avere ed una possessione, invece di essere parte di me stesso, così che l'io
mobile e libero, non ingannato da un avere che trascina dietro di sé, possa
percorrere il mondo, con un senso di freschezza, un sapere quindi, che non
diviene personale, è una misera preparazione per la vita. Se è la tendenza
dell'epoca nostra, dopo di avere conquistato la libertà di pensiero di portarla
alla perfezione includendovi la libertà della volontà, per realizzare con
questa il principio di una nuova epoca, lo scopo ultimo dell'educazione non può
più essere il sapere, ma la volontà nata dal sapere e l’espressione parlante
di ciò che essa deve raggiungere è “L’uomo personale e libero”. Come in
certe altre sfere, nella sfera pedagogica la libertà non riesce ad affermarsi;
la forza dell'opposizione non può esprimersi; si esige la sottomissione. Una
istruzione formale e materiale viene solo ricercata, e solo scienziati escono
dai serragli degli umanisti, solo “cittadini utili” escono da quelli dei
realisti, ed entrambi le categorie non sono che esseri sottomessi. Il sapere
deve morire per risuscitare come volontà, e crearsi quotidianamente come nuova
persona. ”Nella persona del singolo può solo giacere la fonte di ciò
ch’egli fa. I doveri morali non possono essere comandi che vengono imposti
all’uomo da qualsiasi parte, ma scopi che egli propone a se stesso. È
un'illusione quando l’uomo crede di fare qualche cosa per seguire il comando
di una etica santa e generale. Egli lo fa perché la vita del suo io lo spinge a
farlo. Non amo il mio prossimo, perché ubbidisco a un comando sacro dell'amore
del prossimo. Devo, voglio, amarlo. Gli uomini hanno eretto in leggi al di sopra
di loro, ciò che essi hanno voluto. In questo punto è facilissimo fraintendere
lo Stirner. Egli non nega l'azione morale. Egli nega l’imperativo morale. Il
modo in cui l'uomo agisce, quando egli capisce realmente se stesso, crea già un
ordine morale del mondo. Precetti morali sono per Stirner un fantasma, una
fissazione. Essi individuano qualche cosa che l’uomo raggiunge da sé, quando
egli si abbandona tutto alla sua natura. I pensatori astratti faranno questa
obbiezione: non vi sono delinquenti? non possono questi agire secondo l'impulso
della loro natura? Questi pensatori astratti prevedono il caos se i precetti
morali non sono più santi per gli uomini. Lo Stirner poteva ad essi rispondere:
“non vi sono anche malattie nella natura? E quelle non sono causate da leggi
eterne e ferree come la salute? Ma non si può distinguere l'ammalato da chi sta
bene? Mai un uomo di senno terrà un ammalato per sano, perché la malattia e la
salute sono causate da leggi naturali”.
Né lo Stirner ritiene l’immoralità per moralità, perché entrambi possono
manifestarsi quando l'individuo è lasciato a se stesso. Ciò che distingue lo
Stirner dai pensatori astratti, è il suo convincimento che nella vita umana, se
gli individui sono abbandonati a se stessi, la moralità sarà prevalente, come
nella natura prevale la salute. Egli crede alla nobiltà morale della natura
umana, allo sviluppo libero dell'individuo; i pensatori astratti non gli
sembrano credere a questa nobiltà; perciò egli crede ch’essi diminuiscono la
natura dell'individuo facendola schiava di doveri generali, mediatori della
condotta umana. Debbono avere molta malvagità e molta perversità nell'anima,
questi “uomini morali”, pensa lo Stirner, per richiedere tante prescrizioni
morali; essi debbono essere affatto privi di amore, per volere che l'amore, che
dovrebbe nascere in loro da un impulso libero, sia a loro imposto mercé un
comando. Se venti anni fa, in un libro serio, si poteva dire con rimprovero che
il libro dello Stirner "L'unico" annientò lo spirito e l'umanità, il
diritto e lo stato, la verità e la virtù come tanti idoli della servitù del
pensiero (Treitschke), questo ci prova quanto facilmente poteva essere frainteso
Stirner, per le sue dichiarazioni radicali, sebbene l'individuo umano stesse
sempre dinanzi agli occhi suoi come qualche cosa di nobile, di eccelso, di unico
e di libero che nemmeno il volo alto del pensiero poteva raggiungere. Durante la
seconda parte del sec. XIX, Max Stirner fu presso a poco dimenticato. Siamo
debitori agli sforzi di John Mackay, se oggi abbiamo un'immagine della sua vita
e del suo carattere. Nel suo libro “Max Stirner, la sua vita e la sua opera”
(Berlino, 1898), il Mackay ha elaborato tutto il materiale accumulato in
ricerche di molti anni per caratterizzare il pensatore “più ardito e più
conseguente”, secondo il suo giudizio.
Lo Stirner, come altri pensatori moderni, sta di fronte al fatto dell’io
consapevole, da afferrare”. Altri cercano mezzi per concepire questo io. Ma il
concetto incontra difficoltà perché fra l'immagine della natura e quella della
vita dello spirito, un abisso si è aperto. Lo Stirner non si preoccupa di
questo. Egli si pone di fronte al fatto dell'io consapevole ed adopera tutto
quanto egli può esprimere, a mettere in luce questo fatto. Egli vuole parlare
dell'io in un modo tale che ognuno consideri l’io a sé e che nessuno si
sottragga a questo esame dicendo l’io è questo o quello. Lo Stirner non vuole
accennare ad una idea, ad un concetto dell'Io, ma all'io stesso vivo, che trova
in sé la personalità.
Il sistema dello Stirner, come al polo opposto i sistemi di Goethe, Schiller,
Fichte, Schelling, Hegel è una apparizione che doveva, con una certa necessità,
sorgere nell'evoluzione moderna del concetto del mondo. Il fatto dell'io
consapevole si presenta allo spirito suo con cruda vividezza. Ogni creazione
concettuale gli appariva nella luce in cui poteva apparire ad un pensatore, che
vuole afferrare il mondo con soli concetti, il mondo mitico immaginativo. Di
fronte a questo fatto spariva per lui ogni altro contenuto del mondo, in quanto
questo ci mostra un rapporto con l'io consapevole. Egli isolava completamente
l'io cosciente.
Che vi fossero difficoltà nel porre l’io in questo modo, lo Stirner non lo
avverte nemmeno. I decenni seguenti non poterono entrare in rapporto con questa
posizione isolata dell’io. Poiché questi decenni sono prima di tutto
preoccupati di scoprire l'immagine della natura, sotto l'influenza della
mentalità scientifica. Dopo che lo Stirner ebbe presentato un lato della
coscienza moderna, il fatto dell'io consapevole, l'epoca rimosse lo sguardo da
questo io e lo fissò laddove “l'io” non si trova, sull'immagine della
natura.
La prima metà del secolo decimonono ha attinto le sue concezioni del mondo
dall'idealismo. Se un ponte viene gettato là alle scienze naturali, come presso
Schelling, Lorenzo Oken (1779-1851), Enrico Steffens (1773-1845), questo avviene
dal punto di vista della concezione idealistica del mondo e nell’interesse di
questa concezione. Il tempo è così poco preparato a rendere fecondi pensieri
scientifici in vista di una concezione del mondo, che le visuali geniali di
Giovanni Lamarck intorno all'evoluzione dagli organismi più semplici ai più
perfetti, che apparvero nel 1809, rimasero ignorate e che quando Geoffroy de St.
Hilaire, nel 1830, in opposizione al Cuvier, patrocinò l'idea di una parentela
generale e naturale di tutte le forme organiche ci volle il genio di Goethe per
intuire la portata di questa idea. I numerosi risultati della scienza naturale
che anche la prima metà del secolo ci ha portati condussero nell’evoluzione
della concezione del mondo a nuovi enigmi dal mondo, soprattutto quando Carlo
Darwin, nel 1859, aprì alla concezione della natura nuovi orizzonti per quanto
riguarda la conoscenza del mondo dei viventi.
Rudolf Steiner (1914)
48 - Scienze naturali e vita dello spirito (Rudolf Steiner)
Il pensiero scientifico ha avuto
una profonda influenza sui concetti moderni. Il toccare le aspirazioni dello
spirito, la "vita dell’anima" senza rendersi conto dei concetti e
risultati della scienza, diventa cosa sempre più impossibile.
Vero è che ci sono ancora molti i quali soddisfano a queste aspirazioni
impedendo alle correnti scientifiche di perturbare la loro sfera di idee; coloro
però che sentono il palpito dell'ora presente non possono essere di questo
numero.
I concetti scientifici accaparrano sempre più le menti e i cuori, benché meno
docili e spesso incerti e scoraggiati, seguono anch’essi. Quel che più
inquieta non è il numero delle menti conquistate, ma il veder che il pensiero
scientifico moderno racchiude in sé una forza che fa dire all'osservatore:
l'avvenire è suo.
In un'epoca nella quale le diverse classi sociali propendono sempre più verso
questo modo di pensare, sentendosene attratte come da una forza magica, non è
più permesso negare e dileggiare la scienza materialista. E sebbene alcuni,
mantenendosi in perfetta riservatezza intellettuale, dichiarino che il tempo
della piatta dottrina di forza e materia è passato da lungo tempo, ciò non
riesce a mutare menomamente la cosa. Bisognerebbe piuttosto ascoltare coloro che
dichiarano apertamente come appunto sulle concezioni scientifiche abbia ad
essere fondata una nuova religione. È ad essi che si rivolge l'attenzione del
momento, e vi è motivo di credere ch’essi l'accaparreranno sempre più. Anche
colui che conosce le profonde aspirazioni dell'umanità non può fare a meno
d'ascoltarle, nonostante le riconosca superficiali e meschine.
Ma c’è un'altra classe di menti che ci sollecita ancora; sono quelli che non
sono ancora riusciti a metter d'accordo il cuore e il cervello; non sono capaci
di liberare il ragionamento dai concetti delle scienze naturali; il peso delle
prove li opprime; ma questi concetti non soddisfano le aspirazioni religiose
dell'anima loro; la prospettiva che queste offrono li scoraggia. L'anima umana
atta ad innalzarsi sino alle cime della Bellezza, della Verità, e della Bontà
dovrà poi, in ogni singolo caso, dileguarsi nel nulla come una bolla di
schiuma?
È un sentimento che pesa su molti come un incubo; e anche i concetti
scientifici li opprimono. Tali persone chiudono gli occhi fin che possono su
questo contrasto che sorge nell'anima loro, anzi cercano di consolarsene dicendo
che l'anima umana non riuscirà mai a scrutare certi misteri. Esse pensano
scientificamente fin dove giunge l'esperienza dei sensi e la logica del
ragionamento, ma conservano i sentimenti religiosi che sono stati loro inculcati
mantenendosi su queste cose in un'oscura nebulosità di raziocinio.
Non c'è dubbio, il pensiero scientifico è la forza più potente della vita
intellettuale contemporanea, e non si può non occuparsene per quanto il modo
con cui cerca di soddisfare le aspirazioni dello spirito sia superficiale e
scoraggiante.
Ben triste davvero se ciò bastasse! Che sconforto sarebbe se si dovesse annuire
a chi dice: “Il pensiero è una forma della forza; noi camminiamo per via
della medesima forza colla quale pensiamo”.
“L'uomo è un organismo che trasmuta le diverse forme della forza in forza di
pensiero, un organismo che manteniamo in azione per mezzo del così detto
‘nutrimento’ col quale produciamo ciò che chiamiamo ‘il pensiero’”.
Oh il meraviglioso processo chimico che cambia una certa quantità di cibo nella
divina tragedia di Amleto!” Questo si legge in un opuscolo di Roberto G.
Ingersoll intitolato “Moderno crepuscolo degli dei”. Che un gruppo di
pensatori approvi questo credo dettato da alcuni, poco importa; il grave è che
molti si credono forzati a pensare così per la sacrosanta autorità della
scienza.
Tale stato di cose sarebbe veramente sconfortante se la scienza stessa ci
forzasse ad accettare quel credo proclamato dai suoi profeti più recenti. (…)
Ma le esigenze delle scienze naturali sono proprio quelle di cui ci parlano i
loro rappresentanti? Il loro contegno dimostra appunto il contrario; nel loro
campo essi non si comportano come molti dicono e come richiedono dagli altri.
Darwin e Haeckel, avrebbero potuto forse fare quelle grandi scoperte biologiche,
se invece di osservare la vita e la struttura degli esseri viventi, si fossero
rinchiusi in un laboratorio a far esperimenti chimici su un pezzo di tessuto
preso dall'organismo di un animale?
Lyell avrebbe forse potuto descrivere l'evoluzione della crosta terrestre se,
invece di far delle ricerche sugli strati della terra e ciò che contengono si
fosse messo a esaminare le qualità chimiche d'innumerevoli sassi?
Si imitino dunque questi scienziati che si presentano come figure monumentali
nell'evoluzione della scienza moderna. Nelle regioni superiori della vita
intellettuale succederà allora quel che succede nel campo della scienza
naturale. Non si pretenderà più d'aver compreso l'essenza della “divina”
tragedia d'Amleto, dicendo che un meraviglioso processo chimico ha trasformato
in tragedia una certa quantità di cibo. Non lo si crederà più di quanto uno
scienziato potrebbe credere d'aver veramente compreso la parte che ha il calore
nella evoluzione della terra, osservando nella ritorta l'effetto di questo sullo
zolfo. E non dirà nemmeno di aver compreso la struttura del cervello dopo aver
esaminato l'effetto di un acido su una parte della testa ma seguendo nei secoli
il corso dell'evoluzione, vedrà come dagli organi di animali inferiori questo
cervello si sia formato.
Il fatto è incontestabile: colui che prenda a esaminare la natura dello
spirito, non può che imparare dalla scienza naturale e fare precisamente come
fa questa senza farsi dettar leggi da certi suoi rappresentanti; e si segue
questo metodo osservando senza pregiudizi il processo d'evoluzione dello spirito
umano come lo scienziato osserva il mondo esteriore.
Proseguendo così, si giunge a un metodo d'osservazione che si distingue da
quello puramente scientifico, come la geologia, si eleva al di sopra della
semplice fisica e la biologia al disopra della chimica. Si raggiungono così
metodi superiori che non sono quelli seguiti dalla scienza naturale, ma che ne
hanno il carattere.
È soltanto con tali metodi che si riesce a penetrare veramente un'evoluzione
spirituale come quella del cristianesimo o di altre forme religiose. Chi li
applica incontrerà l'opposizione di chi crede pensare scientificamente; ma se
ne consolerà sentendosi in armonia colla scienza universale. Un tale scrutatore
della vita dello spirito dovrà superare anche l'indagine storica dei documenti.
È obbligato a farlo pel senso della genesi delle cose datogli dalla storia
naturale. La descrizione delle ritorte, dei vasi, delle pinzette che hanno
servito alla scoperta di una legge chimica, non è di importanza per
l'esposizione di detta legge; né lo stabilire le fonti storiche del
cristianesimo da cui attinse l'evangelista Luca o quelle da cui è stata
combinata la rivelazione di S. Giovanni ha più valore. La “storia” non può
essere, in questo caso, che un'introduzione alle vere ricerche.
Lo studio delle origini storiche dei documenti non dilucida le idee contenute
nei libri di Mosè, né le tradizioni dei miti greci. I concetti di cui ivi si
tratta non hanno trovato in esse che una espressione esteriore.
Lo scienziato che voglia scrutare l'essere umano, non va a cercare come si sia
formata la parola “uomo” nell'evoluzione della lingua. Si attiene alla cosa,
non alla parola che l'esprime. Così nella vita spirituale dovremo attenerci
allo spirito e non ai documenti esteriori.
Rudolf
Steiner (1908)
49 - Premesse ad una “Conoscenza soprasensibile del mondo e dell’uomo” (Rudolf Steiner)
In questo saggio si vuole dare
una descrizione di alcune parti del mondo soprasensibile. Chi voglia ammettere
soltanto quello sensibile, riterrà tale descrizione un vacuo prodotto della
fantasia. Ma chi voglia cercar le vie che conducono fuori dal mondo dei sensi,
arriverà presto a comprendere che la vita umana acquista valore e significato
soltanto se si penetri con lo sguardo in un altro mondo. Questa penetrazione non
distoglie l'uomo, come molti temono, dalla vita “reale”. Poiché solo per
tale via egli impara a star saldo e sicuro nella vita. Impara a conoscerne le
cause, mentre, se le ignora, muove a tastoni, come un cieco, attraverso gli
effetti. Solo dalla conoscenza del mondo soprasensibile la “realtà”
sensibile acquista significato. Perciò questa conoscenza accresce, non
diminuisce, la nostra capacità di vita. Può diventare un uomo realmente
“pratico” soltanto chi comprenda la vita.
L'autore del presente saggio non descrive nulla di cui non possa testimoniare
per esperienza propria, per quella specie di esperienza che può esser fatta in
questo campo. Perciò egli esporrà unicamente cose che, in questo senso, ha
sperimentate lui stesso.
Il modo come generalmente si usa leggere nei nostri tempi, non vale per questo
libro. In un certo senso, ogni pagina, spesso anche pochi periodi, dovranno
essere conquistati con sforzo. A questo si è teso coscientemente. Poiché solo
così il libro può diventare per il lettore quel che ha da essere per lui. Chi
si limiti a scorrerlo, non lo avrà affatto letto. Le verità in esso contenute
devono venir sperimentate. La scienza dello spirito ha un'efficacia solo in
questo senso.
Lo scritto non può essere giudicato secondo i criteri della scienza ordinaria,
se il punto di vista per un tale giudizio non si desume dal libro stesso. Se però
il critico adotta questo punto di vista, vedrà che questa esposizione non è
mai in contrasto con i veri metodi scientifici. L'autore sa di non aver voluto,
nemmeno con una sola parola, entrare in conflitto con la sua coscienziosità
scientifica.
Chi voglia cercare anche per altra via le verità qui esposte, le troverà nella
mia “Filosofia della libertà”. Per strade diverse i due libri tendono al
medesimo fine. Alla comprensione dell’uno, l'altro non è necessario benché,
naturalmente, possa riuscire utile.
Chi cerchi in questo libro le “verità ultime”, lo metterà forse da parte,
insoddisfatto. Del complessivo dominio della scienza dello spirito, l’autore
si è proposto di esporre, anzitutto, le verità fondamentali.
È certo insito nella natura dell'uomo chiedere subito risposta alle domande sul
principio e sulla fine del mondo, sullo scopo dell'esistenza e sull'essenza di
Dio. Ma chi non voglia dar parole e concetti per l'intelletto bensì vere
conoscenze per la vita, sa che in un libro che contenga i primi elementi della
conoscenza spirituale non gli è lecito dir cose che appartengono ai gradini
superiori della saggezza. Solo dopo aver compreso questi primi elementi si è in
grado di vedere come vadano poste le domande di ordine superiore. (…)
Chi ai giorni nostri pubblica un'esposizione di fatti soprasensibili, dovrebbe
aver chiare due cose. Anzitutto, che la nostra epoca ha bisogno di coltivare
conoscenze soprasensibili; secondariamente, che oggi la vita spirituale è piena
di rappresentazioni e di sentimenti che possono far apparire a molti una simile
descrizione addirittura come fantasticheria sregolata e sogno. La nostra epoca
ha bisogno di conoscenze soprasensibili, poiché tutto quanto l'uomo apprende
nel modo ordinario intorno al mondo e alla vita suscita in lui una quantità di
domande a cui possono dar risposta solo le verità soprasensibili. Non c'è però
da illudersi: quel che, nell’ambito delle attuali correnti culturali, può
essere appreso intorno ai fondamenti dell'esistenza, non è, per l'anima che
senta profondamente, una risposta, ma rappresenta anzi una serie di domande sui
grandi enigmi del mondo e della vita. Per un certo tempo, qualcuno può aver
l'impressione di possedere una soluzione degli enigmi della vita nei
“risultati di fatti rigorosamente scientifici” e nelle deduzioni di qualcuno
dei pensatori moderni. Se però l'anima discende fino a quelle profondità a cui
deve arrivare, se comprende davvero se stessa, quel che da principio le sarà
sembrato una soluzione, le apparirà soltanto come sprone alla vera domanda. Ed
una risposta a tale domanda non dev'essere soltanto diretta ad appagare una
curiosità umana, ma da essa dipende la calma interiore e l'armonia della vita
dell'anima. La conquista di una tale risposta, non soddisfa soltanto la sete di
sapere, ma rende l'uomo più valido al suo lavoro e lo porta all'altezza dei
compiti della vita, mentre la mancanza di una soluzione di quel problemi lo
paralizza nell’anima e, in ultimo, anche nel corpo. La conoscenza
soprasensibile non è solo qualcosa per i nostri bisogni teoretici, ma lo è
pure per la vera prassi della vita. Appunto per il carattere della vita
spirituale moderna, la conoscenza spirituale è un campo conoscitivo
indispensabile alla nostra epoca.
D’altra parte, è un fatto, che oggi molti respingono con la massima energia
quello di cui più hanno bisogno. Il potere di molte opinioni fondato su
“sicure esperienze scientifiche” è per taluni così grande ch’essi non
possono se non considerare come pazzia il contenuto di un saggio come questo.
Chi espone conoscenze soprasensibili può mettersi di fronte a queste cose
senz'alcuna illusione.
Si sarà certo facilmente tentati di esigere da lui prove irrefragabili. Ma non
si riflette che con tale richiesta, si cade in un errore. Poiché, certo senza
rendersene conto, si esigono non le prove inerenti alle cose, ma quelle che si
vogliono e si possono riconoscere. L'autore di questo libro sa ch’esso non
racchiude nulla d'inammissibile per chi stia sul terreno della moderna scienza
naturale. Sa pure che si può consentire con tutte le esigenze di questa scienza
e appunto perciò trovar ben fondata la rappresentazione del mondo
soprasensibile, quale è esposta qui. Anzi, proprio un modo di pensare
strettamente scientifico dovrebbe sentirsi a suo agio in questa
rappresentazione. E chi pensa così, avrà di fronte a certe discussioni un
sentimento che può essere caratterizzato da queste parole profondamente vere di
Goethe: “Una dottrina falsa non si può confutare perché poggia sul
convincimento che il falso sia vero”. Le discussioni sono inutili di fronte a
chi voglia ammettere solo quelle prove che sono conformi al suo proprio modo di
pensare. Chi conosca la vera natura di ciò che è “dimostrare” si rende
chiaramente conto, che l’anima umana trova la verità per altre vie che non
quelle della discussione.
Quando, nell'autunno dell'anno 1813, Johann Gottlieb Fichte espose la sua
“Dottrina” quale frutto maturo di una vita tutta dedita al servizio della
verità disse subito in principio le seguenti parole: “Questa dottrina
presuppone un senso interiore affatto nuovo, per cui si apre un nuovo mondo che,
per l'uomo ordinario, non esiste”. E poi ricorse ad una similitudine per
mostrare quanto la sua dottrina dovesse rimanere inafferrabile per chi volesse
giudicarla con le rappresentazioni dei sensi ordinari. “Immaginatevi un mondo
di ciechi nati, ai quali perciò le cose e i loro rapporti siano noti soltanto
per quel che ne rivela il tatto. Andate a parlar loro dei colori e delle altre
condizioni che esistono soltanto in virtù della luce e per la vista. Parlerete
a vuoto, e sarà una fortuna se ve lo dicono perché allora, non tarderete a
riconoscere il vostro errore e, a meno che possiate aprir loro gli occhi,
smettere l'inutile discorso”.
Ora, chi parla agli uomini di quelle cose alle quali Fichte allude qui, si trova
troppo spesso in una condizione analoga a quella del veggente in mezzo ai ciechi
nati. Ma queste sono le cose che si riferiscono alla vera natura e alle mete
supreme dell'uomo. E chi credesse necessario “smettere l'inutile discorso”
dovrebbe disperare dell'umanità. Non bisogna, al contrario, dubitare nemmeno un
istante della possibilità di “aprire gli occhi” a chiunque vi cooperi con
la sua buona volontà.
Fondandosi su questa premessa, hanno parlato e scritto tutti coloro che hanno
sentito di aver sviluppato nell’organo di percezione interiore capace di
riconoscere la vera natura dell'uomo, celata ai sensi esteriori. Perciò fin dai
tempi più remoti, si è sempre parlato di una “saggezza occulta”.
Chi ne abbia afferrato qualcosa, sente di possederlo con la stessa sicurezza che
ha riguardo alla rappresentazione dei colori, l'uomo dotato di vista sana. Perciò
questa saggezza occulta non abbisogna di “prove” per lui. Ed egli sa anche
che, per chi come lui, abbia un “organo di percezione superiore” aperto,
essa non può abbisognare di prove. Uomini dotati di questo senso superiore
possono parlare fra loro come chi abbia visitato l'America può parlarne a chi,
pur senza esserci stato, sia in grado di farsene un’idea, poiché, quando ne
avesse l'occasione, vedrebbe da sé le cose descritte dall'altro.
Ma chi osserva il mondo soprasensibile non deve parlar solo a chi, come lui,
indaghi nel mondo spirituale. Deve indirizzare le sue parole a tutti gli uomini.
Poiché deve riferire intorno a cose che riguardano ognuno; anzi egli sa che
senza la conoscenza di esse, nessuno può essere “uomo” nel vero senso della
parola. E parla a tutti gli uomini, perché sa che esistono diversi gradi di
comprensione per quanto egli ha da dire. Sa che anche uomini ancora lontani dal
momento in cui si aprirà loro la possibilità di indagini spirituali proprie,
lo possono comprendere. Il sentimento e la comprensione della verità sono
infatti in ogni uomo. Ed a questa comprensione che può accendersi in ogni anima
sana egli a tutta prima si volge. Sa pure che in questa comprensione è
racchiusa una forza che a poco a poco deve condurre ai gradini superiori dalla
conoscenza. Quel sentimento che forse da principio non vede nulla di quanto gli
viene esposto è di per sé il mago che aprirà “l’occhio spirituale”.
Esso germoglia nelle tenebre. L'anima non vede; ma, attraverso questo sentimento
è afferrata dalla “potenza della verità”; e allora, a poco a poco, la
verità, si avvicina all'anima e le apre il “senso superiore”. Per qualcuno
ci vorrà più tempo, per qualcun'altro meno; chi però ha pazienza e costanza
raggiunge la meta. Se non ogni cieco nato può essere operato, ogni occhio
spirituale può essere aperto: è solo questione di tempo.
L’erudizione e la cultura scientifica non sono condizioni necessarie al
dischiudersi di questo “senso superiore”. Esso può aprirsi tanto nell'uomo
semplice quanto nel dotto. Anzi, ciò che ai nostri tempi per lo più si
considera come la “sola” scienza può spesso essere piuttosto d'intralcio
che di aiuto. Poiché, per sua natura, questa scienza ammette come “realtà”
unicamente quel che cade sotto i sensi ordinari. E per quanto grandi siano i
suoi meriti riguardo al riconoscimento di questa verità, essa crea, quando
dichiara valido per ogni sapere umano quel che è necessario e salutare pel suo
proprio dominio una quantità di preconcetti che precludono l'accesso alle verità
superiori.
A quel ch’è detto qui, spesso si obietta che alla conoscenza umana si
frappongono barriere insormontabili e che perciò, va respinto ogni sapere che
non ne tenga conto. E si considera, forse, immodesto chi voglia far delle
asserzioni intorno a cose che, secondo la convinzione di molti, esorbitano dal
campo delle facoltà conoscitive umane. Tale obiezione trascura il fatto che la
conoscenza superiore, dev’essere preceduta da uno sviluppo delle forze
conoscitive umane. Ciò che, prima di questo sviluppo, sta oltre i limiti della
conoscenza, rientra, dopo il risveglio di certe facoltà latenti in ogni uomo,
senz'altro nel dominio della conoscenza.
C’è, però, una cosa da tener presente. Si potrebbe dire: “A che serve
parlare agli uomini di cose per cui le loro forze conoscitive non sono deste e
che, perciò, rimangon loro precluse?” Ma sarebbe un'osservazione erronea. Per
scoprire le cose di cui si tratta qui, occorrono certe facoltà; ma se, dopo che
sono state scoperte, queste cose vengono comunicate, chiunque voglia applicarvi
una logica scevra di preconcetti e un sano senso della verità la può capire.
In questo libro non si comunicano cose che, a chiunque lasci agire in sé un
pensiero non unilaterale, non offuscato da pregiudizi, e un libero, aperto senso
della verità, possono far l'impressione di rispondere in modo soddisfacente
agli interrogativi della vita umana e dei fenomeni del mondo. Ci si chieda:
“Se le cose qui affermate sono vere, ne risulta o no una soddisfacente
spiegazione della vita?” E si troverà che la “vita” di ogni singolo uomo
risponde affermativamente.
Per essere “maestro” in questi campi superiori dell'esistenza, non basta però
che in un uomo si siano aperti i sensi capaci di percepirli. Anche qui occorre
coscienza come per essere maestri nel campo della realtà comune. La vista
superiore non fa dell'uomo un “dotto” in materia spirituale, come i sensi
sani non fanno di noi dei “dotti” nel mondo della realtà sensibile. Ma
poiché la realtà sottostante a quella spirituale non è, in ultima analisi,
che l'uno dei due aspetti della stessa ed unica essenza fondamentale, chi è
ignorante nel campo delle conoscenze sensibili, rimarrà per lo più tale anche
nel campo di quelle savrasensibili. Questo fatto genera in chi, per vocazione
spirituale, si sente chiamato a pronunciarsi intorno ai domini spirituali
dell'esistenza, il sentimento di una responsabilità illimitata. Esso gli impone
modestia e riserva. Il sentimento di questa responsabilità non dovrebbe però
trattenere nessuno dall’occuparsi delle verità superiori; nemmeno chi, per le
condizioni quotidiane della sua vita, non ha l’agio di dedicarsi alle scienze
ordinarie. Si può, infatti, assolvere il proprio compito umano anche ignorando
la botanica, la zoologia, la matematica e le altre scienze; ma non si può
essere "uomini" nel pieno senso della parola senza, essersi in qualche
modo accostati alle conoscenze della natura e del destino dell'uomo, rivelati
dalla conoscenza sovrasensibile.
L'autore di questo libro non vuol esporre nulla che non sia per lui un fatto,
come un’esperienza del mondo esteriore è un fatto per gli occhi, gli orecchi,
e l'intelletto ordinario.
Si tratta di esperienze accessibili a chiunque sia deciso a seguire il
“sentiero della conoscenza” descritto alla fine di questo libro. Si assume
un giusto atteggiamento di fronte alle cose del mondo soprasensibile quando si
premetta che un sano pensare e sentire sono in grado di comprendere tutto quanto
di vere cognizioni può fluire dai mondi superiori e che, muovendo da questo
intendimento e facendo di esso la propria solida base, si è compiuto un passo
importante verso la visione diretta, sebbene per conseguirla occorra anche
altro. Ci si sbarrano, invece, le porte della vera conoscenza superiore, se si
disprezza questa via e si vuol penetrare nei mondi superiori soltanto in altro
modo. La massima di voler ammettere i mondi superiori solo dopo averli veduti è
di impedimento alla veggenza. La volontà di comprendere attraverso il sano
pensiero quel che più tardi potrà essere veduto evoca forze importanti
dell’anima, le quali appunto conducono a questa veggenza.
Le seguenti parole di Goethe contrassegnano il punto di partenza di una delle
vie, che conducono a conoscere la natura dell’uomo: “Non appena si accorge
degli oggetti intorno a lui, l'uomo li considera in rapporto a sé stesso; e con
ragione, il fatto ch’essi gli piacciano o no, lo attraggano o lo respingano,
gli giovino o gli nuocciano. Questo modo del tutto naturale di guardare e
giudicare le cose sembra essere altrettanto facile quanto è necessario, eppure
espone l’uomo a mille errori, che spesso lo umiliano e gli amareggiano la
vita. Un compito ben più difficile si assumono quelli che, mossi da un vivace
impulso di conoscenza, aspirano ad osservare gli oggetti della natura in sé e
nei loro reciproci rapporti; poiché ben presto lamentano la mancanza della
norma, che è loro di aiuto quando, come uomini, osservano le cose in rapporto a
se stessi. Manca loro la norma del piacere e dispiacere, dell'attrazione e
repulsione, dell’utile e dannoso. A tutto ciò devono interamente rinunciare;
devono, quali essere indifferenti e, per così dire, divini, cercare e
investigare quel che è, e non quel che piace. Così, né la bellezza né
l'utilità delle piante debbono commuovere il vero botanico; egli ha da
investigare la loro struttura, il loro rapporto col restante regno vegetale e,
come il sole le ha fatte spuntare e le illumina tutte, così egli con sguardo
equanime e tranquillo, le deve guardare e abbracciar tutte, traendo la norma
delle sue cognizioni, i dati del suo giudizio non da se stesso, ma dalla cerchia
delle cose osservate”.
Questo pensiero di Goethe richiama l'attenzione dell'uomo su tre cose. Anzitutto
sugli oggetti dei quali gli perviene continuamente notizia pel tramite dei sensi
e ch’egli tocca, odora, gusta, ode e vede. Secondariamente, sulle impressioni
che gli oggetti fanno sopra di lui, sul piacere e dispiacere, il desiderio o
l'avversione che gli suscitano e pei quali egli giudica gli uni simpatici e gli
altri antipatici, gli uni utili e gli altri dannosi. E, in terzo luogo, sulle
cognizioni ch’egli, quale “essere per così dire, divino”, acquista
intorno alle cose, ai segreti della loro natura e della loro attività che si
rivelano a lui.
Nella vita umana questi tre campi si distinguono nettamente. E l'uomo si avvede
perciò di essere congiunto al mondo in triplice modo. Il primo è prestabilito,
ed egli lo accetta come un fatto. Col secondo egli fa del mondo una cosa che lo
concerne, che ha importanza per lui. Il terzo, egli lo considera come una meta
verso la quale deve tendere incessantemente.
Perché il mondo appare all'uomo in questo triplice modo? La semplice
osservazione può mostrarlo. Cammino sopra un prato fiorito. Attraverso i miei
occhi i fiori mi rivelano i loro colori. Questo è il fatto ch'io accetto come
dato. Godo dello splendore delle tinte. Così trasformo il dato in vicenda mia
propria. Congiungo, attraverso i miei sentimenti, i fiori con la mia propria
esistenza. Un anno dopo, torno sul medesimo prato. Ci sono altri fiori. Mi
suscitano un nuovo compiacimento. La mia gioia dell'anno precedente risorgerà
come ricordo. Essa è in me; l’oggetto che l'aveva destata non c'è più. Ma i
fiori che vedo adesso sono della medesima specie di quelli dell'anno precedente;
sono cresciuti secondo le medesime leggi. Se mi sono chiarito quelle specie,
quelle leggi, io le ritrovo nei fiori di quest'anno quali le ho riconosciute in
quelli dell'anno prima. E forse rifletterò: “I fiori dell’anno scorso sono
scomparsi; la gioia che mi hanno data è rimasta unicamente nel mio ricordo. È
congiunta solo col mio essere. Ma ciò che l'anno scorso ho riconosciuto in
rapporto ai fiori e torno a riconoscere quest'anno, durerà finché ne
cresceranno di simili. È qualcosa che mi si è rivelato, ma che non dipende
dalla mia esistenza come, invece, ne dipende la mia gioia. I miei sentimenti di
gioia restano in me; le leggi, l’essenza delle piante, rimangono fuori di me,
nel mondo”.
L'uomo si congiunge continuamente in questo triplice modo con le cose del mondo.
Non s'introduca a tutta prima nulla in questo fatto, ma lo si accolga
semplicemente quale si offre. Ne risulta che l'uomo ha tre aspetti nella sua
natura. Questo, e null'altro, vogliamo per ora indicare con la tre parole corpo,
anima e spirito. Chi a queste parole unisca una qualsiasi opinione preconcetta
o, peggio, qualche ipotesi, dovrà necessariamente fraintendere quanto andremo
esponendo. Con la parola corpo s’intende ciò mediante cui si palesano
all’uomo le cose che l'attorniano, come, nell'esempio precedente, i fiori del
prato. Con la parola anima si vuole indicare ciò mediante cui egli congiunge le
cose con la sua esistenza, sente in rapporto ad esse piacere e dispiacere,
letizia e disgusto, gioia e dolore. Per spirito s'intende ciò che nell'uomo si
rivela quando, secondo l’espressione di Goethe, egli guarda le cose quale
“essere, per così dire, divino”.
In questo senso l'uomo consiste di corpo, anima e spirito.
Mediante il suo corpo egli può mettersi in rapporto momentaneo con le cose.
Mediante la sua anima conserva in sé le impressioni che queste fanno su di lui;
e mediante il suo spirito gli si rivela ciò che le cose custodiscono in se
stesse. Solo osservando l'uomo sotto questi tre aspetti, si può sperare di
arrivare a comprenderne la natura. Poiché questi tre aspetti lo mostrano
imparentato in tre modi diversi col restante mondo.
Attraverso il suo corpo egli è imparentato con le cose che si offrono ai suoi
sensi da fuori. Le materie del mondo esterno compongono questo suo corpo; le
forze del mondo esterno agiscono anche in esso. E come, per mezzo dei suoi
sensi, egli contempla le cose del mondo esterno, così può anche contemplare la
propria esistenza corporea. Ma è impossibile contemplare alla stessa maniera
l’esistenza dell’anima. Tutto quello che in me è processo corporeo, può
essere percepito dai sensi corporei. Il mio piacere e dispiacere, la mia gioia e
il dolore non possono essere percepiti né da me né da altri mediante sensi
corporei. Il campo dell’anima è inaccessibile alla percezione corporea.
L’esistenza corporea dell’uomo è manifesta agli occhi di tutti; quella
animica, egli la porta in sé come suo proprio mondo. Attraverso lo spirito, però,
il mondo esterno gli si rivela in un modo superiore. I segreti del mondo esterno
si rivelano bensì nel suo intimo; ma egli esce spiritualmente fuori di se
stesso e lascia la cose parlar di sé, di quel che ha importanza per esse, non
per lui. L'uomo leva lo sguardo al cielo stellato: il rapimento che la sua anima
prova gli appartiene; le leggi eterne stellari ch’egli afferra nel pensiero,
nello spirito, non appartengono a lui, ma alle stelle.
L'uomo è in tal modo cittadino di tre mondi. Mediante il suo corpo, egli
appartiene al mondo che può anche percepire col corpo; mediante la sua anima,
egli si edifica il suo proprio mondo; mediante il suo spirito, gli si rivela un
mondo più elevato degli altri due.
Appare evidente che, per la differenza essenziale di questi tre mondi, si potrà
far luce intorno ad essi e alla parte che vi ha l'uomo solo attraverso tre modi
diversi di osservazione.
Rudolf
Steiner (1922)
50 – Introduzione al tema: “Pensiero umano e pensiero cosmico” (Rudolf Steiner)
Vorrei parlarvi del “rapporto
dell'uomo con l'universo” da un determinato punto di vista. (…)
L’uomo sperimenta in sé ciò che noi possiamo chiamare il “pensiero”, e
nel pensiero l'uomo può sentirsi come alcunché di direttamente attivo, che può
esplicare la propria attività. Se noi consideriamo un qualsiasi oggetto
esteriore, per es. una rosa o una pietra, e ci rappresentiamo questo oggetto
esteriore, può venirci fatta, e con ragione, la seguente osservazione: “Tu
non puoi mai sapere proprio, mentre te la rappresenti, quanto tu abbia veramente
della pietra e della rosa. Tu vedi la rosa, il suo colore roseo esteriore, la
sua forma; vedi come si spartisce in singoli petali; tu vedi la pietra con il
suo colore, con i suoi vari spigoli, ma devi pur sempre dire a te stesso: può
tuttavia esservi qualcosa ancora che non mi si palesa esteriormente. Tu non sai
quanto nella tua rappresentazione tu abbia veramente della pietra, della
rosa”.
Ma se qualcuno ha un pensiero, è egli stesso che crea questo pensiero. Si
potrebbe dire: egli sta dentro ogni fibra di questo pensiero, perciò partecipa
dell'attività dell'intiero pensiero. Egli sa: ciò che vi ha in questo
pensiero, l’ho immesso così, io stesso nel pensiero; e ciò che io non ho
pensato nel pensiero, non può difatti essere in esso. Io abbraccio tutto questo
pensiero. Nessuno potrebbe sostenere che, quando mi rappresento un pensiero,
possa in esso esservi dell'altro, come nel caso della rosa e della pietra, poiché
io stesso ho creato il pensiero; sono presente in esso e so perciò quello che
contiene.
In verità, il pensiero è quanto v’ha di più originalmente nostro. Se
troviamo il rapporto del pensiero col cosmo, con l'universo, troviamo il
rapporto col cosmo, con l'universo di quanto v'ha di più originalmente nostro.
Il che ci assicura che quando si osserva il rapporto dell'uomo con l’universo,
prendendo le mosse dal pensiero, questo punto di vista è veramente fecondo. Ora
vogliamo iniziare questo esame: esso ci condurrà a importanti ed elevate
considerazioni scientifico-spirituali. Ora occorrerà costruire delle fondazioni
che ad alcuno di voi potranno sembrare forse alquanto astratte. (…)
Quello dunque che appunto abbiamo detto ci assicura che l'uomo, se si attiene a
ciò che egli ha nel pensiero, può trovare un intimo rapporto del suo essere
con l’universo, con il cosmo. Però se ci vogliamo porre da questo punto di
vista, ci si presenta una difficoltà, una grande difficoltà. Intendo dire che
questa grande difficoltà non concerne l’esame che ci proponiamo, ma la
condizione obiettiva delle cose. Si presenta una difficoltà, in quanto è vero
che si vive entro ogni fibra del pensiero e che perciò il pensiero, quando lo
si ha, lo si deve conoscere più intimamente di qualsiasi altra
rappresentazione; ma certo la maggior parte delle persone non ha pensieri! E a
questo fatto, che la maggior parte degli uomini non ha pensieri, non si riflette
ordinariamente con vera profondità. Né ci si riflette con sufficiente
profondità, perché per riflettervi occorrono appunto “dei pensieri”.
Anzitutto dovremo notare, che ciò che impedisce alle persone, generalmente
nella nostra vita, di avere dei pensieri si è che gli uomini - per le necessità
ordinarie della vita - non hanno affatto sempre bisogno di spingersi veramente
fino al pensiero, ma che, invece del "pensiero", si contentano della
parola. La maggior parte di ciò che nella vita ordinaria si chiama pensare, si
svolge in parole, si pensa in parole. Molto di più di quanto non si creda si
pensa in parole. E molti, quando chiedono spiegazione, di questo o di quello, si
accontentano che si dica loro una parola qualsiasi di cui sia loro noto il suono
e che desti in essi qualche ricordo; prendono allora per spiegazione ciò che
essi sentono con una tale parola e credono di avere il “pensiero”.
Veramente quello che appunto ho detto, ha condotto - in una determinata epoca,
durante l'evoluzione della vita spirituale dell’uomo - a far sorgere
un'opinione, condivisa ancora oggidì da molti che si chiamano “pensatori”.
(…)
Altrove ho cercato di dimostrare come il "pensiero" nasca soltanto -
si potrebbe dire - a un dipresso fra il sesto e l'ottavo secolo prima di Cristo.
Anteriormente a quel tempo la anime umane non sperimentavano affatto ciò che
nel giusto senso della parola si può chiamare pensiero. Che cosa sperimentavano
prima la anime umane? Esse sperimentavano delle immagini; ogni sperimentare del
mondo esteriore avveniva per immagini. Ho già detto questo spesso da diversi
punti di vista. Questo sperimentare per immagini è l'ultima fase dell’antico
sperimentare chiaroveggente; poi, per l'anima umana, “l’immagine” si fa
“pensiero”. (...) Ho cercato poi di mostrare, come questo pensiero
progredisca in Socrate, in Platone, in Aristotele; come esso assuma determinate
forme, e si evolva ulteriormente nel Medioevo a quanto starò ora per esporvi.
L'evoluzione del pensiero conduce a dubitare addirittura che possano esservi nel
mondo quelli che si chiamano pensieri “universali”, concetti universali:
conduce al cosidetto nominalismo, alla concezione filosofica, che i concetti
universali possono essere dei meri “nomi”, dunque semplici parole. Su questi
pensieri universali vi era dunque, una concezione filosofica (a oggidì molti
l'hanno ancora), secondo la quale tali pensieri non siano altro che parole.
Per meglio chiarire quanto per l'appunto si è detto, prendiamo un concetto
facile da afferrare e perfino universale; prendiamo il concetto
"triangolo" come concetto universale. Ora chi si mette dal punto di
vista del nominalismo e non può staccarsi da ciò che si è andato formando a
questo riguardo come “nominalismo” nell’epoca dall’XI fino al XIII
secolo, dirà a un dipresso così: “Disegnami un triangolo!” Ebbene, gli
disegnerò un triangolo, per es., come questo:
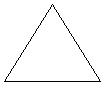 |
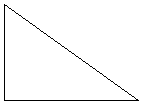
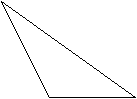
Il nominalista aggiunge allora: sta bene, vi è un triangolo acuto, retto e
ottuso. Ma tutto ciò non è il triangolo. Il triangolo universale deve
contenere tutto ciò che un triangolo può contenere. Nel pensiero
“universale” del triangolo deve rientrare tanto il primo quanto il secondo e
il terzo triangolo. Ma un triangolo acuto non può essere al contempo retto e
ottuso. Un triangolo acuto è un triangolo speciale, non è un triangolo
universale; così del pari un triangolo retto o uno ottuso: un triangolo
universale non vi può essere. Il triangolo “universale” è dunque una
parola che comprende i triangoli speciali, e il concetto universale del
triangolo non esiste. È una "parola" che abbraccia i casi singoli.
Questo ragionamento (nominalistico), può naturalmente continuare. Supponiamo
che qualcuno pronunzi la parola "leone". Colui che si attiene al punto
di vista del nominalismo, dice: “Nello zoo di Berlino vi è un leone, in
quello di Hannover vi è pure un leone e ve ne è anche uno nel giardino
zoologico di Monaco. Vi sono i singoli leoni; ma un leone universale, che abbia
a che fare con i leoni di Berlino, di Hannover o di Monaco, non esiste. È una
semplice parola quella che comprende i singoli leoni”. Esistono soltanto cose
singole e oltre le singole cose - dice il nominalista - non vi sono che parole
che abbracciano le singole cose.
Questo modo di vedere, come già si è detto, è sorto in una data epoca della
storia dal pensiero e lo rappresentano ancora oggi delle menti logiche e
acutissime. E chi esamina un poco la questione appunto esposta, dovrà in fondo
ammettere: “si presenta qui alcunché di peculiare, per cui non posso
senz'altro decidere se vi sia veramente questo 'leone universale' e il
'triangolo universale', perché non ci vedo chiaro. So ora venisse uno che mi
dicesse: “Vedi, caro amico, non posso ammettere che tu mi mostri il leone di
Monaco, o quello di Hannover oppure di Berlino. Se tu ritieni che vi sia il
‘leone universale’ devi condurmi in quel posto qualsiasi dove si trovano dei
‘leoni universali’; se tu però mi mostri soltanto i leoni di Monaco, di
Hannover e di Berlino, non mi hai dimostrato che esistono dei 'leoni universali'…
Se dunque venisse qualcuno che la pensasse in tal modo e occorresse mostrargli
il leone “universale”, ci si troverebbe alquanto imbarazzati. Non è tanto
facile rispondere al quesito: dove si deve condurre colui al quale si deve
mostrare il leone universale”. Ora non vogliamo subito considerare ciò che ci
vien dato dalla scienza dello Spirito, lo faremo in seguito. Vogliamo ora
fermarci al pensiero, fermarci a quello che può venir raggiunto col pensiero e
dovremo dire a noi stessi: - se vogliamo rimanere su questo terreno non riesce
facile condurre in porto chi dubita del leone universale. Anzi non ci riesce
affatto. “Ecco una delle difficoltà alla quale bisogna semplicemente
consentire. Perché se nel campo del comune pensiero non si vuole ammettere
questa difficoltà, è segno che non si apprezzano le difficoltà della
conoscenza umana in generale. Fermiamoci al triangolo poiché in fondo é
indifferente per la questione in generale che si arrivi a spiegarla a mezzo del
triangolo, del leone o di altro.
A tutta prima sembra impossibile disegnare un triangolo “universale” che
contenga tutte le proprietà, tutti i triangoli. È cosa che sembra
completamente impossibile. E poiché non solo sembra impossibile, ma lo è
veramente per il pensiero umano comune, ogni filosofia esteriore si trova qui
proprio dinanzi a una barriera; e sarebbe suo dovere di ammettere una buona
volta che, come filosofia esteriore, si trova dinanzi a una barriera. Ma questa
barriera, appunto, non é che quella della stessa filosofia esteriore. Vi è
tuttavia una possibilità di superare questa barriera e di questa possibilità
vogliamo ora occuparci.
Immaginiamoci di disegnare il triangolo, non semplicemente nel senso di uno che
dica: - Ora ti ho disegnato un triangolo, eccolo qua:
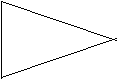 |
A questo si può sempre
obbiettare che non è un triangolo universale. Si può cioè disegnare il
triangolo altrimenti. Veramente non lo si può, ma vedremo subito quale sia il
rapporto fra questo potere e non potere. Supponiamo che questo triangolo che
abbiamo dinanzi a noi lo si disegni a questo modo - e che si permetta ai singoli
lati di esso di muoversi a loro piacimento in ogni direzione; e che si permetta
loro anzi di muoversi con velocità diverse, di guisa che i lati, p. es.
assumano nel momento successivo, quest'altra posizione:
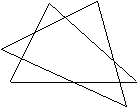 |
Insomma noi ci assumiamo un modo
incomodo di rappresentarci il triangolo, per cui diciamo: - Non voglio soltanto
disegnare un triangolo per poi lasciarlo stare, ma pretendo che la tua capacità
di rappresentazione soddisfa determinate esigenze. Tu devi immaginarti che i
lati del triangolo siano in continuo moto. Se sono in moto, dalla forma dei
movimenti possono contemporaneamente scaturire un triangolo rettangolo, o un
ottusangolo, o qualsiasi altro -.
Due cose si possono fare e anche esigere in questo campo. Anzitutto si può
esigere la massima comodità; se qualcuno ci disegna un triangolo, tutto è
finito e se ne conosce l’aspetto: ora si può riposare tranquillamente nei
propri pensieri perché si ha ciò che si vuole. Si può però fare anche
nell’altro modo e si può considerare il triangolo come punto di partenza, e
permettere al contempo a ogni lato di volgersi con velocità diverse verso
diverse direzioni. Questo caso però riesce meno comodo, poiché si devono
compiere dei movimenti nei propri pensieri. Però così si ottiene realmente il
pensiero universale del triangolo; mentre non lo si raggiunge se ci si ferma a
un solo triangolo. Il pensiero universale "triangolo" vi è quando si
tiene il pensiero in continuo movimento, quando è versatile.
I filosofi, non avendo fatto ciò che appunto ho detto, non avendo cioè messo
il pensiero in moto, si trovano ora necessariamente dinanzi ad una barriera e
fondano il nominalismo.
Vogliamo ora tradurre quanto abbiamo qui argomentato in un linguaggio a noi già
noto. Si richiede da noi, quando vogliamo elevarci dal pensiero particolare a
quello universale, che si metta il pensiero particolare in movimento di guisa
che il “pensiero mosso” è il “pensiero universale”, il quale scivola da
una forma all’altra. Io dico “forma”, ma a rigore si tratta che il tutto
si muove e ogni singolo caso che scaturisce da questo moto è una forma in sé
circoscritta. Prima non ho disegnato che singole forme: un triangolo acutangolo,
uno rettangolo e uno ottusangolo. Ora disegno qualcosa - veramente non lo
disegno, come ho già fatto, ma ci si può rappresentare quel che la
rappresentazione deve suscitare, cioè che il pensiero universale è in
movimento e crea col suo fermarsi la singole forme. “Forme” ho detto. Così
vediamo che i filosofi del nominalismo, i quali necessariamente si trovano
dinanzi a una barriera, si muovono in un determinato regno, nel regno degli
Spiriti della Forma. Entro il regno degli spiriti della “forma” che sta
intorno a noi, dominano le forme e poiché le dominano vi sono in questo regno
le singole cose strettamente in sé circoscritte. Da ciò vedete che i filosofi
a cui accenno, non hanno mai preso la decisione di uscire dal regno della forma,
e perciò non hanno potuto nei pensieri universali avere altro che parole mere,
semplici parole. Se essi uscissero dal regno delle singole cose, cioè, dalle
forme, giungerebbero a un genere di rappresentazioni in continuo movimento; vale
a dire che nel loro pensare acquisterebbero una realizzazione del regno degli
Spiriti del Moto, della gerarchia immediatamente superiore. Ma questo non
consentono i suddetti filosofi. E quando negli ultimi tempi del pensiero
occidentale ve ne fu una volta uno che si decise a pensare veramente in questo
senso, fu poco compreso benché sul conto di lui molto si sia parlato e
fantasticato.
Cercate ciò che Goethe, ha scritto nella sua ”Metamorfosi delle piante”,
quello che egli chiama la “proto-pianta”; cercate poi ciò che egli chiama
il “proto-animale” e troverete che non ci si può orientare con questi
concetti di “proto-pianta” e di “proto-animale” se non pensandoli in
movimento. Se si accoglie questa mobilità di cui parla lo stesso Goethe, non si
ottiene un concetto astratto, circoscritto nelle sue forme. Si ha invece ciò
che vive nelle sue forme, ciò che procede attraverso tutta l’evoluzione del
regno animale, o del regno vegetale, ciò che in questo suo processo si
trasforma così come il triangolo si trasforma in acutangolo o in ottusangolo,
ciò che può essere ora lupo o leone, o insetto a seconda che la mobilità sia
disposta in modo da modificarsi durante il suo passaggio attraverso i singoli
casi. Goethe ha dato movimento ai rigidi concetti delle forme; questa è stata
la sua opera grande, centrale. Questo è quanto d’importante egli ha
introdotto nello studio della natura della sua epoca.
Vedete qui da un esempio come ciò che chiamiamo la “scienza dello Spirito”
sia effettivamente atto a tra gli uomini fuori da quello a cui oggi
necessariamente devono stare attaccati, perfino quando sono filosofi. Poiché
senza i concetti che si acquistano per mezzo dalla “scienza dello Spirito”
non è affatto possibile, se si è onesti, di ammettere altro se non che i
pensieri universali sono “mere parole”. Questa è la ragione per cui ho
detto, che la maggior parte delle persone non ha affatto pensieri. Se ad essi si
parla di pensieri, li respingono.
Quando si parla agli uomini di “pensieri”? Quando si dice, per es., che gli
animali e le piante hanno delle “anime collettive”. Che si dica “pensieri
universali” e “anime collettive” (vedremo in seguito il rapporto che v'ha
fra questi due concetti), per il pensiero è tutt'uno. Ma l'anima collettiva non
può essere compresa se non pensandola in movimento, in continuo movimento
esteriore e interiore, altrimenti non si arriva all’anima collettiva”. Ma,
nella generalità, gli uomini si rifiutano di far questo, perciò respingono
anche l’anima collettiva, respingono dunque il pensiero universale. Ma per
imparare a conoscere il mondo manifesto non occorrono pensieri: occorre soltanto
il ricordo di ciò che si è veduto nel regno della forma. E lì i pensieri
universali rimangono allora mere parole. E se fra i vari spiriti delle Gerarchie
superiori non vi fosse anche il Genio del linguaggio, il quale forma le parole
universali per i concetti universali, gli uomini stessi non lo farebbero. Gli
uomini dunque traggono anzitutto proprio dal linguaggio i loro pensieri
universali e oltre ai pensieri universali conservati nel linguaggio, non
possiedono gran che di più.
Da questo possiamo vedere che il pensare dei veri pensieri deve pur essere
qualcosa di speciale. Nel pensare dei veri pensieri v'ha da essere qualcosa di
affatto peculiare. E che si tratti di qualcosa di affatto peculiare possiamo
comprenderlo dalla difficoltà che gli uomini trovano a conseguire chiarezza nel
campo del pensiero. Nella vita esteriore abituale, capita forse spesso per un
po’ di millanteria di affermare che il pensare sia facile; ma non è facile.
Perché il vero pensare esige sempre di ricevere un afflato sottilissimo, sotto
un certo riguardo incosciente, dal regno degli Spiriti del moto. Se il pensare
fosse così facile, non si farebbero tanti errori madornali nel campo del
pensiero. Ci si tormenta ora difatti, da più di un secolo, per un pensiero che
già spesso ho citato e che è stato espresso da Kant.
Kant voleva togliere di mezzo la cosidetta prova ontologica dell’esistenza di
Dio. Questa prova ontologica dell’esistenza di Dio, deriva pure dall’epoca
in cui sorse il nominalismo, allora quando si diceva che vi fossero soltanto
parole, per i concetti universali, e che non esistesse nulla di universale che
potesse corrispondere ai singoli pensieri, come i singoli pensieri corrispondono
alle rappresentazioni.
Esporrò questa prova ontologica dell'esistenza di Dio come esempio del modo
come si usa pensare. Essa dice a un dipresso così: - se si ammette un Dio,
questo dovrà essere l'Essere più perfetto. Se egli è l'Essere più perfetto,
non deve mancargli “sussistenza”, perché altrimenti vi sarebbe un essere più
perfetto di lui, dotato di quelle qualità che si pensano, e per di più dotato
di esistenza reale. Si deve dunque pensare l’essere più perfetto come
esistente. Non si può dunque pensare a Dio se non esistente, quando lo si pensi
come l’essere più perfetto. Vale a dire, dal concetto stesso si può dedurre
che, secondo la prova ontologica, il Dio deve esistere. - Kant ha cercato di
confutare questa prova in quanto voleva mostrare che da un "concetto"
non è possibile dedurre l’esistenza di una cosa; e sul proposito ha perfino
coniato quel famoso detto, a cui già spesso ho accennato: che cento talleri
veri non sarebbero né più né meno di cento talleri possibili. Cioè: se un
tallero ha trecento pfennige, occorre per cento talleri possibili calcolare
trecento pfennige (per cento), e parimenti per cento talleri reali (...). Cento
talleri possibili contengono dunque altrettanto quanto cento talleri veri; vale
a dire che non vi è differenza se io penso cento talleri reali o cento talleri
possibili. Dal semplice pensiero di un essere sommamente perfetto, non è
consentito dedurre la esistenza del medesimo solo perché il mero pensiero di un
Dio possibile avrebbe le stesse qualità del pensiero di un Dio reale.
Questo sembra molto ragionevole. E da cento anni gli uomini si tormentano sulla
questione dei cento tolleri possibili e dei cento talleri reali. Pensiamo però
un punto di vista che ci sia vicino: quello, cioè, della vita pratica. Può da
questo punto di vista dirsi che cento talleri possibili contengano cento talleri
reali? Si può dire che cento talleri reali contengono precisamente cento
talleri in più di cento talleri possibili. È pur ben chiaro: da una parte il
pensiero di cento talleri possibili e, dall’altra, cento talleri reali: è una
bella differenza! Vi sono da quest'ultima parte per l’appunto cento talleri di
più. E sono proprio i cento talleri reali che hanno importanza nei maggiori
casi della vita.
Ma la questione ha un aspetto ancora più profondo. Si può cioè porre il
quesito: - in che cosa consiste la differenza fra cento talleri possibili e
cento talleri reali? - Ritengo che tutti ammettano che per chi può avere i
cento tolleri, v'ha indubbiamente una seria differenza fra le due eventualità.
Immaginatevi infatti che abbiate bisogno di cento talleri e che qualcuno vi
offra la scelta fra cento talleri possibili e cento talleri reali. Se vi é
veramente possibile averli, la differenza sembra avere importanza. Ma supponete
invece di trovarvi nel caso di non poter realmente avere i cento talleri, allora
può darsi che sia per voi assolutamente indifferente se qualcuno non vi dà
cento talleri possibili o cento talleri reali. Se non vi è dato di poterli
avere, cento talleri reali valgono proprio quanto cento talleri possibili.
Ma tutto ciò ha un significato. E il significato è questo: che nel modo come
Kant ha parlato di Dio, era possibile parlare soltanto in un'epoca in cui, per
mezzo dell'esperienza animica umana, “non si poteva più avere il Dio”.
Quando Dio non era accessibile come una realtà, il concetto del Dio possibile o
il concetto del Dio reale si equivalevano, così come si equivalgono cento
talleri reali o cento talleri possibili quando non si possono avere. Se per
l’anima non vi è via che conduca al Dio reale, non condurrà ad esso
certamente neppur alcun ragionamento svolto nello stile di Kant. Da questo
vedete che la questione ha tuttavia un aspetto più profondo. Ne parlo soltanto
per chiarirvi per mezzo di essa che quando si tratta del "pensare"
occorre spingere l'indagine alquanto più profondamente. Errori di pensiero
s'insinuano infatti e si propagano attraverso le menti più illuminate e per
lungo tempo non si scorge in che consiste la falla del pensiero. (…) Occorre
sempre per il pensiero che si tenga conto della situazione in cui esso venne
concepito.
Dalla natura del pensiero universale prima, e poi dall'esistenza di un errore di
pensiero come in particolar modo quello di Kant, ho cercato di mostrarvi che le
vie del pensiero non si possono esaminare così semplicemente senza un
approfondimento delle cose. Mi avvicinerò ora all'argomento anche da un terzo
lato.
Supponiamo che vi sia qui una montagna o una collina e accanto ad essa un pendio
scosceso: da questo pendio scosceso scaturisce una sorgente; questa si precipita
giù perpendicolarmente per il pendio come una vera cascata. Nelle medesime
condizioni supponiamo di vedere più in alto anche una sorgente la quale
tenderebbe pure a far proprio come la prima, ma non lo fa. Essa non può cioè
precipitare verso il basso come una cascata, ma scorre giù tranquillamente in
forma di ruscello o di un corno d’acqua. Ha l'acqua nella seconda sorgente
forze diverse dalla prima? No, evidentemente. Perché la seconda sorgente
agirebbe proprio come la prima se la montagna non glielo impedisse spiegando le
proprie forze verso l'alto. Se non vi fossero le forze che la montagna spinge
all'insù, le forze che la trattengono, la sorgente precipiterebbe giù come la
prima. Due forze dunque devono essere considerate; la forza di gravità della
terra, mercé la quale una delle due sorgenti precipita in basso. Questa esiste
però ugualmente anche per l'altra sorgente; perché si può proprio dire che
essa è lì e la si vede attrarre la sorgente verso il basso. Se qualcuno però
fosse scettico, potrebbe negare questo particolare nel caso della seconda
sorgente e dire: in questa non si vede niente, mentre nella prima sorgente ogni
pulviscolo d'acqua, viene tratto in giù. In ogni punto della seconda sorgente
occorre dunque aggiungere la forza che si frappone alla forza di gravità della
terra; la forza trattenitrice della montagna. Supponiamo ora che venga qualcuno
e dica: - a quanto tu mi dici della forza di gravità, credo poco; e neppure
credo a quello che tu mi dici della forza trattenitrice. È forse per causa del
monte che la sorgente segue quella direzione? Io non lo credo. -
A questo tale si potrebbe chiedere allora: “Che cosa credi dunque?” Ed egli
risponderebbe: - Io credo che laggiù vi sia dell'acqua, che subito sopra vi sia
parimenti dell'acqua, e più sopra ancora ve ne sia pure e così di seguito. Io
credo che l'acqua che sta sotto venga spinta in giù da quella che sta sopra, e
quest'ultima, a sua volta venga spinta in giù da quella immediatamente
soprastante! Ogni strato d'acqua spinge sempre giù quella che gli sta sotto!
Questa è una differenza importante. Il primo uomo ritiene che la forza di
gravità tiri giù le masse d'acqua; il secondo invece dice che vi sono tanti
strati d'acqua e che quelli superiori spingono giù quelli sottostanti, di guisa
che sopra ogni strato di acqua scorre giù quello immediatamente superiore.
Sarebbe ben sciocco, non è vero, un uomo che parlasse di un simile sistema a
“spinte”. Ma ammettiamo che non si tratti di un ruscello o di un corso
d'acqua, ma della storia dell'umanità e che un uomo come quello suddescritto
dicesse: “L’unica cosa che credo è che viviamo ora nel ventesimo secolo in
cui si sono svolti certi dati avvenimenti; questi sono stati determinati da
altri simili dell’ultimo terzo del secolo decimonono; questi, alla loro volta,
sono determinati da quelli del secondo terzo del secolo decimonono e questi
ultimi da quelli del primo terzo di quel secolo.” Questa si chiama “storia
pragmatista”, in cui si parla sempre nel senso di “cause ed effetti”,
cosicché dagli eventi precedenti si spiegano quelli che susseguono. Come
qualcuno può negare la forza di gravità e dire che i diversi strati di acqua
si spingono a vicenda, così succede pure quando qualcuno coltiva la storia in
senso pragmatico e spiega le condizioni del secolo decimonono come una
conseguenza della rivoluzione francese.
Noi certamente diciamo: - No, vi sono anche altre forze oltre quelle che
spingono dietro, le quali ultime del resto non agiscono nemmeno nel senso che si
crede; perché proprio come le forze del fiume non “spingono” da dietro, così
neppure gli eventi che stanno dietro spingono nella storia dell’umanità.
Vengono sempre nuove influenze dal mondo spirituale (così come nella sorgente
l'azione della forza di gravità è costante), e si incrociano con altre forze
come la forza di gravità nel fiume si incrocia con la forza trattenitrice della
montagna. Se non ci fosse che una forza sola vedresti la storia prendere un
corso completamente diverso. Ma in essa tu non vedi le singole forze che vi
agiscono, non vedi ciò che è stato descritto come conseguenza delle evoluzioni
di Saturno, del Sole e della Luna nell'evoluzione della Terra. E non vedi ciò
che succede continuamente con le anime umane, che traversano il mondo spirituale
e tornano quaggiù. Tutto questo, tu semplicemente lo neghi.-
Ma un'interpretazione della storia che si comporta come se ci si presentasse con
la concezioni or ora caratterizzate noi l'abbiamo, e non è neppure
particolarmente rara! Nel secolo decimonono è stata anzi considerata
straordinariamente geniale. Che cosa però potremmo dire al riguardo dal punto
di vista ora acquisito? Se qualcuno pensasse del torrente come pensa della
storia, penserebbe una vera sciocchezza. Quale è la ragione per la quale egli
pensa siffatta sciocchezza anche in ordine alla “storia”? Questa sola, che
egli non se ne avvede! E la storia è tanto complicata che viene esposta quasi
dappertutto come “storia pragmatica”, ma non ci se ne accorge.
Da questo vediamo che indubbiamente la scienza dello spirito, che deve
conseguire dei principi sani per la comprensione della vita, trova da fare nei
più diversi campi della vita; che effettivamente vi è una certa necessità
d'imparare anzitutto a pensare, di conoscere prima di tutto le leggi e gli
impulsi interiori del pensare. Potranno altrimenti succedere i casi più
grotteschi. Così, per es., v’ha oggi qualcuno che inciampica, intoppa,
zoppica nel problema “pensiero e linguaggio”: è il famoso glossografo Fritz
Mauthner, il quale ha scritto anche un grande vocabolario filosofico. Il grosso
volume del Mauthner sulla “Critica del linguaggio” è già ora alla sua
terza edizione; è dunque diventato un libro celebre per i nostri contemporanei.
In questo libro v’ha molto di geniale, ma vi sono anche cose tremende. Vi si
può trovare, per es., uno strano errore di pensiero (e ci si imbatte quasi ogni
5 righe in un errore di quel genere): il buon Mauthner mette in dubbio l'utilità
della logica perché per lui "pensare" altro non è che “parlare”,
e allora non v’ha senso di coltivare la logica, basta la grammatica. Inoltre
egli dice: “Poiché dunque non vi può legittimamente essere una logica, i
logici sono stati degli imbecilli”. E poi dice: “Nella vita ordinaria dalle
"conclusioni" nascono i "giudizi", è dai giudizi che
nascono poi le rappresentazioni. Così fanno gli uomini! A che serve dunque una
logica se gli uomini stessi dicono che essi fanno nascere i giudizi dalle
conclusioni, e dai giudizi le rappresentazioni? Questo è altrettanto geniale
come se si dicesse: “a che giova la botanica? L’anno scorso e l'anno prima
le piante hanno pur continuato a crescere!” Ma questa è logica che si trova
presso colui che bandisce la logica. Ed è comprensibile che egli la bandisca.
Si trovano ancora ben altre stramberie in questo strano libro, che in fatto di
rapporto fra pensiero e parola non porta a chiarezza, bensì a confusione.
Ho detto che occorrevano delle fondazioni per rilievi che dovranno indubbiamente
condurci alle vette della contemplazione spirituale. Delle fondazioni come
quelle che oggi sono state proposte potranno a taluno sembrare piuttosto
astratte, ci riusciranno però utili.
E ritengo di aver cercato di rendere la cosa tanto facile da aver reso
trasparente ciò che ho detto. Vorrei soprattutto far rilevare che per mezzo di
tali semplici osservazioni si può già acquistare un'idea di dove giaccia il
limite fra il regno degli Spiriti della forma e il regno degli Spiriti del moto.
La possibilità tuttavia di conseguire tale idea dipende intimamente dal fatto
di poter consentire dei pensieri “universali”, o di poter consentire
soltanto rappresentazioni o concetti di cose singole; dico semplicemente: poter
consentire.
Rudolf Steiner (1914)
51 - Della questione sociale (1919) (Rudolf Steiner)
Non è egli vero che il moderno movimento operaio si
manifesta dalla catastrofe della guerra mondiale con tali fatti che dimostrano
come fossero insufficienti le idee per le quali per lunghi decenni si credette
di capire che cosa vive nella volontà proletaria? A farci questa domanda ci
muove ciò che dalle esigenze del proletariato, finora compresse, e da tutto ciò
che vi si connette, viene ora spinto alla superficie della vita. Le forze che le
comprimevano sono ora in parte, già annientate, e soltanto chi ignora come
siano indelebili certi impulsi della natura umana può pensare di conservare la
condizione imposta da quelle forze agli stimoli sociali di una gran parte
dell'umanità.
Riguardo a questi impulsi sociali si abbandonavano alle più grandi illusioni
alcuni personaggi, ai quali la posizione sociale permetteva di influire, con la
parola e col consiglio - arrestandone o favorendone l'azione - sulle forze della
vita europea che nel 1914 spinsero alla catastrofe della guerra. Potevano
credere che una vittoria del loro paese avrebbe calmato gli attacchi sociali.
Ora dovrebbero riconoscere che si deve alla loro condotta, se gli impeti sociali
si sono manifestati in tutta la loro efficienza. Si può dire anzi che la
presente catastrofe dell’umanità, apparsa come quell'avvenimento storico per
cui quegli impeti ricevettero tutta la loro forza propulsiva. Quei personaggi e
le classi dirigenti, dovettero uniformare continuamente, negli ultimi
avventurosi anni, la loro condotta a ciò che si agitava nella vita degli
ambienti socialisti. Avrebbero agito, spesso e volentieri, diversamente, se non
si fossero curati di quella tendenza che ora, nei suoi effetti, continua nella
forma che hanno preso gli odierni avvenimenti.
Ed ora che è entrato nella fase decisiva ciò che per anni si è preparato
nella evoluzione della vita dell'umanità; ora è tragicamente fatale che ai
fatti compiuti non corrispondano le idee che sorsero nel divenire di tali fatti.
Può perciò sembrare ben giustificato il porre la questione nei seguenti
termini: Che cosa vuole veramente il movimento proletario moderno? Corrisponde
cotesto suo volere a ciò che comunemente si è pensato? È il vero aspetto
della questione sociale quello che si manifesta nel pensiero dei molti che su
tale questione hanno riflettuto? O è invece necessario seguire una direttiva di
pensiero del tutto diversa? A tale questione non si potrà accostarsi con
imparzialità, se non si è stati posti dalle vicende della vita, in condizione
di vivere la vita spirituale del proletariato moderno o, meglio, di quella parte
del proletariato che ha concorso maggiormente a determinare l'inizio
dell'odierno movimento operaio.
Si è parlato molto dello sviluppo della tecnica moderna e del moderno
capitalismo; del come questo sviluppo ha dato origine al proletariato attuale,
anche del come esso è pervenuto alle presenti esigenze con lo svolgersi della
nuova vita economica. In tutto ciò che si è detto su questi argomenti c'è
molto di esatto. Che non si è pervenuti però a qualcosa di decisivo può
intenderlo soltanto chi non si lascia ipnotizzare dalla massima che soltanto
“le circostanze esteriori danno all’uomo l’impronta della sua vita”, ma
è capace di farsi un'idea spregiudicata degli impulsi che operano nell'intimo
profondo dell'anima.
È un fatto incontestabile che le esigenze del proletariato si sono sviluppate
di pari passo con la tecnica moderna e col moderno capitalismo. Ma il
riconoscere questo fatto non dà ancora alcun decisivo chiarimento su ciò che
vive in quelle esigenze, particolarmente come impulso puramente umano. E finché
non si penetra nella vita di questo impulso, non si può pervenire al vero
aspetto della “questione sociale”.
Un’espressione che ricorre spesso nel mondo proletario, può fare una
significativa impressione in chi è capace di penetrare nelle latenti e profonde
forze della volontà umana. Voglio dire questa: “il proletariato moderno ha
acquistato la coscienza di classe”. Esso non segue più in certo modo,
istintivamente, inconsciamente le classi a lui estranee. Sa di appartenere ad
una classe speciale e vuol far valere il rapporto di questa sua classe con le
altre nella vita pubblica, in un modo corrispondente ai suoi interessi. Per chi
ha la capacità di intendere le sottocorrenti dell’anima, l'espressione
“coscienza di classe” - come la usa il moderno proletariato - sarà
rivelatrice di fatti essenziali della concezione della vita sociale di quelle
classi lavoratrici che si trovano prese nella vita della tecnica moderna e del
moderno capitalismo.
Egli ha da porre mente, innanzi tutto, al modo con cui le dottrine scientifiche
relative alla vita economica e ai rapporti col destino umano abbiano, a guisa di
fulmine, colpita l'anima proletaria infiammandola. Si troverà di fronte a un
fatto su cui molti di quelli che si limitano a pensare sul proletariato, ma non
con esso, avventano giudizi del tutto confusi, e per conseguenza dannosi, data
la gravità degli odierni avvenimenti. Con l'opinione che al proletariato
“incolto”, abbia dato di volta il cervello per colpa del marxismo e dello
svolgimento che a questo dettero gli scrittori del movimento operaio, e da
quanto si sente dire spesso in argomento non si arriva alla comprensione, oggi
necessaria, in questo campo del momento storico mondiale. Giacché quando si
esprime una tale opinione, si dimostra, soltanto che non si vuole prendere in
considerazione il lato essenziale del movimento sociale odierno. E questo lato
essenziale è che la coscienza proletaria di classe è tutta riempita di
concetti che hanno assunto il loro carattere dallo sviluppo della scienza
odierna. (...) Queste cose possono sembrare prive d’importanza a chi si
ritiene un “uomo pratico”. Ma chi vuol farsi un’idea veramente feconda del
moderno movimento operaio, deve rivolgere a queste cose tutta la sua attenzione.
Poiché in ciò che oggi esigono i proletari socialisti - moderni e
rivoluzionari - non vive già la vita economica trasformata in impulso umano,
così come pensano alcuni, ma la scienza dell’economia, dalla quale è stata
afferrata la coscienza proletaria. Ciò risulta tanto chiaramente dalla
letteratura scientifica del movimento proletario e da quella divulgata dal
giornalismo che il negarlo significa chiudere gli occhi davanti alla realtà dei
fatti. Ed è un fatto terminante lo stato attuale della società, questo, che il
moderno proletariato fissa il contenuto della propria coscienza di classe in
concetti d'indole scientifica.
Tutte le discussioni sulla nuova vita economica, sul secolo delle macchine, sul
capitalismo, possono, sì, illuminare sulle basi effettive del moderno movimento
operaio, ma ciò che chiarisce in modo preciso il presente stato sociale non
deriva immediatamente dal fatto che l'operaio è stato applicato alle macchine e
attratto perciò nell'orbita della vita capitalistica, bensì dalla circostanza
che egli si è formato pensieri ben determinati sulla sua “coscienza di
classe” in rapporto alle macchine e in dipendenza dell'ordine economico
capitalistico. (…) Chi vuol comprendere il movimento proletario, deve
conoscere prima di tutto come p e n s a il proletariato. Giacché il movimento
operaio, dalle sue più ragionevoli tendenze alla riforma fino a quelle
distruttive, non è conseguenza di forze “extra-umane”, di “impulsi
economici”; ma è prodotto da “uomini”, dalle loro rappresentazioni e dai
loro sforzi di volontà. (…) Dal momento che né le macchine né il
capitalismo non potevano offrire al proletario (in quanto uomo) nulla che
valesse a riempirgli l’anima di un contenuto degno dell'uomo, quel movimento
ha ricercato le sue origini di pensiero nelle nuove direttive della scienza. Nel
medioevo un tale contenuto era offerto dal lavoratore dal suo stesso mestiere
manuale. Nella maniera con cui questi si sentiva umanamente legato al suo stesso
lavoro, si trovava qualche cosa che, dinanzi alla sua coscienza, faceva apparire
la vita - entro l'intera società umana - degna di essere vissuta. Gli era dato
di riguardare il suo lavoro in guisa da poter credere realmente di avverare per
suo mezzo ciò che egli voleva essere come “uomo”. Nell'ordinamento della
vita capitalistica, l'uomo fu indotto a rivolgersi su se medesimo, sul proprio
essere interiore, in cerca di una base su cui fondare un’opinione cosciente di
che cosa si è come uomo. Per formarsi un siffatto concetto, nulla gli veniva
dalla tecnica e dal capitalismo. Così è accaduto che la coscienza proletaria,
avendo perduto ogni contatto umano con la immediatezza della vita, si è
orientato verso il pensiero scientifico. Ma ciò avvenne quando le classi
dirigenti si sforzavano di acquistare un modo di pensiero scientifico che non
aveva più neppure esso la forza propulsiva spirituale necessaria a condurre la
coscienza umana ad un contenuto per ogni parte soddisfacente dei suoi bisogni.
(…)
Comunque si voglia giudicare del rapporto tra gli impulsi religiosi (e ciò che
vi si connette) e il pensiero scientifico moderno, se si considera senza
preconcetti, l'evoluzione storica, si dovrà convenire che l’ideazione
scientifica si è sviluppata da quella religiosa. Le vecchie concezioni del
mondo però, che si basavano sopra sostrati religiosi, non hanno potuto
comunicare il loro impulso sostenitore dell'anima alla nuova forma scientifica
del pensiero. Esse rimasero estranee a questa e continuarono a vivere con un
contenuto di coscienza a cui non poterono rivolgersi le anime del proletariato.
Per le classi dirigenti quel contenuto di coscienza poté avere ancora un certo
valore. In un modo o in un altro, esso si connetteva con ciò che umanamente le
legava con la loro posizione sociale. Esse non cercarono dunque un nuovo
contenuto di coscienza, perché la tradizione della vita stessa permetteva loro
di conservare il vecchio. Il proletariato moderno fu avulso da tutte le vecchie
concezioni della vita. La sua vita è stata posta su di una base del tutto
nuova. Per esso, col distacco delle vecchie basi, venne meno al tempo stesso
anche la possibilità di attingere alle vecchie sorgenti spirituali che
permanevano nel campo da cui si era allontanato. Con la tecnica moderna e col
moderno capitalismo si sviluppò simultaneamente - in quanto si possa parlare di
simultaneità riguardo alle grandi correnti storiche del mondo - il carattere
della coscienza moderna. A questa si rivolse con fiducia, con fede, il moderno
proletariato e vi cercò il nuovo contenuto di coscienza di cui sentiva bisogno.
Ma di fronte a questo carattere scientifico il proletariato si trovava in ben
altro rapporto da quello delle classi dirigenti. Queste non sentivano il bisogno
di fare delle loro concezioni scientifiche il sostegno della propria anima.
Sebbene esse potessero comprendere, con tale maniera di pensare, che nell'ordine
naturale vi è una connessione diretta dall'animale più basso fino all'uomo,
pur tuttavia questa concezione rimaneva per esse allo stato di nozione teorica,
senza generare l'impulso a prendere la vita, anche nei riguardi del sentimento,
nel modo interamente corrispondente a siffatta persuasione. (...) Alcuni delle
classi dirigenti si sentono “emancipati”, affrancati dalla religione. Certo
nelle loro rappresentazioni vive la convinzione scientifica; nei loro sentimenti
però pulsano, a loro insaputa, i residui di una fede tradizionale di vita.
(…)
Le classi dominanti non riconoscono di essere la causa di quel sentimento della
vita che presentemente nel proletariato muove loro incontro preparato alla
lotta. Eppure ne sono state esse la cagione per il fatto che della loro vita
spirituale hanno saputo trasmettere in eredità al proletariato solo qualche
cosa che gli deve dare l'impressione di semplice “ideologia”. (...)
Le classi borghesi incontrano oggi tanta difficoltà a penetrare nell'anima del
proletario, riescono così poco a capire come nell’intelligenza non ancora
adusata del proletario, può trovare accesso una ideazione che tanto esiga dal
pensiero quale è quella di Carlo Marx. (...) Un movimento con intenti pratici,
un puro movimento delle più comuni esigenze della vita umana, non si è mai
trovato così - quasi esclusivamente su di una base ideativa - come accade
dell'attuale movimento proletario. Si può dire anzi che tra le agitazioni
congeneri sia questa la prima che si è collocata puramente su di una base
scientifica. (...) Non si può comprendere il concetto proletario della vita e
la sua realizzazione mediante le azioni dei suoi rappresentanti, se non
ravvisando questo fatto in tutta la sua portata per entro lo sviluppo della
nuova umanità. (…)
Al proletario moderno, per il suo modo di pensare, orientato scientificamente,
non solo la stessa scienza ma anche l'arte, la religione, la morale e il
diritto, appaiono ormai elementi della umana ideologia. In questi elementi della
vita spirituale, esso non scorge nulla di reale che irrompa nella sua esistenza
e valga ad aggiungere nulla alla vita materiale. (...) Seppure quegli elementi
tornino ad agire in questa vita materiale, quando per via indiretta penetrano
nel concetto della vita e negli impulsi della volontà, tuttavia originariamente
non sono che immagini ideologiche che si innalzano da questa vita. Non possono
di per sé offrire nulla che valga a superare le difficoltà sociali. Soltanto
per entro i fatti materiali può nascere qualcosa che mena allo scopo.
La vita dello spirito è passata dalle classi dirigenti alla popolazione
proletaria, sotto forma che la distrugge per la sua coscienza, quando si tratta
di arrivare alle forze che dovrebbero portare alla soluzione dei conflitti
sociali. Se dovessero permanere ancora queste condizioni, si dovrebbe veder
condannata all’impotenza la vita spirituale dell’umanità, di fronte alle
esigenze sociali del presente e dell’avvenire. E di questa impotenza, è in
realtà persuasa una gran parte del moderno proletariato. Una tale persuasione
si sente esprimere nelle stesse confessioni marxiste. Si dice: la vita economica
moderna ha sviluppato dalle sue vecchie forme quelle attuali del capitalismo;
questo sviluppo, che ha posto il proletario in una posizione insopportabile di
fronte al capitale, andrà ancora più avanti. Ucciderà il capitalismo mediante
le forze stesse che in esso operano e da questa morte del capitalismo si avrà
la liberazione del proletariato. (…) Il proletariato ha bisogno di una vita
spirituale da cui emani una forza che dia all’anima il sentimento della sua
dignità umana. Giacché quando egli fu attratto nell’orbita economica del
capitalismo dei nuovi tempi, fu indirizzato ad una tale vita spirituale coi più
intimi bisogni dell’anima. Invece quella vita spirituale che gli fu trasmessa
dalle classi dirigenti, come ideologia, vuotò l'anima sua.
Ciò che imprime la forza direttiva al movimento sociale presente è il fatto
che nelle esigenze del proletariato moderno opera l'aspirazione ad una
connessione con la vita dello spirito, diversa da quella che può dargli
l'attuale ordinamento sociale. (…) Dalla giusta comprensione di questo fatto,
dipende la visione di una via che sola può far uscire dalla confusione delle
presenti condizioni sociali dell'umanità. Ora, l'accesso a questa via è stato
precluso dall'ordinamento sociale che è risultato, sotto l'influenza delle
classi dirigenti, dalla nuova forma economica.
Si dovrà acquistare la forza per aprirne l'accesso. (...)
Si tratta ora di questo che, in ultima analisi, il moderno ordinamento economico
capitalistico non vede nel suo ambito, che delle merci e la loro valorizzazione
nell'organismo economico. E in seno all'organismo capitalistico è divenuta
merce anche una cosa rispetto alla quale il proletariato sente che non può
essere merce. Quando si arrivi a conoscere con quanta forza un tale sentimento
opera, come uno dei fondamentali impulsi di tutto quanto il moderno movimento
sociale proletario, si comprenderà che negli istinti, nei sentimenti
subcoscienti del proletariato c’è un’avversione a che la sua energia di
lavoro debba essere venduta al padrone nel modo stesso che si vendono le merci
sul mercato. Esso sente orrore a che sul mercato della mano d'opera, la sua
energia di lavoro rappresenti la medesima parte delle merci sul mercato a
seconda della domanda e dell'offerta. Quando si arriverà a conoscere quale
importanza abbia questa avversione per l'energia del lavoro fatta merce, nel
movimento sociale moderno; quando, senza preconcetti, si volgerà lo sguardo a
considerare che ciò che qui opera non è ancora proclamato (…) allora, al
primo impulso - cioè alla vita spirituale sentita come ideologia - si troverà
da aggiungere il secondo impulso il quale, bisogna dirlo, rende oggi la
questione sociale imperiosa, anzi scottante. (...)
Il capitalismo è divenuto la forza che ancora imprime il carattere di merce ad
una parte dell'essere umano: all'energia di lavoro. (...)
La questione del lavoro non si presenterà nel suo vero aspetto, finché non si
comprenderà che nella vita economica la produzione, lo scambio e il consumo
delle merci, soggiacciono a leggi che corrispondono ad interessi il cui dominio
non deve essere esteso alla energia umana di lavoro.
Rudolf Steiner
52 - Brano de “La mia vita” di Rudolf Steiner (Rudolf Steiner)
E in questo stato d’animo
venni anche a conoscere per la prima volta le opere di Nietzsche. Il primo libro
che lessi fu "Al di là del bene e del male". Anche questo studio mi
attrasse e nello stesso tempo mi respinse.
Mi riuscì difficile spiegarmi Nietzsche: amavo il suo stile, amavo il suo
ardimento; ma non mi piaceva il modo com’egli trattava i problemi più
profondi senza elevarsi a un grado di esperienza spirituale, pel quale la sua
anima potesse immergersi in essi coscientemente. Sentivo tuttavia che molte
delle cose ch’egli dice mi erano immensamente famigliari. Mi sentivo vicino a
lui nelle sue lotte e sentivo anche di dover trovare un'espressione a questo
senso d'affinità.
Nietzsche era per me una delle più tragiche figure contemporanee; e la sua
tragedia mi pareva risultare necessariamente, per le anime capaci
d'approfondimento interiore, dal carattere della struttura spirituale
dell’epoca delle scienze naturali. In questi sentimenti trascorsi gli ultimi
anni a Vienna.
Prima che si chiudesse questo primo periodo della mia vita, ebbi l’occasione
di visitare Budapest e la Transilvania, del quale ho parlato e che per anni mi
era rimasto congiunto con rara fedeltà, mi aveva fatto conoscere parecchi dei
suoi compatrioti residenti a Vienna. Perciò, oltre alle altre mie relazioni
sociali, già molto estese, frequentavo ora anche diversa gente della
Transilvania, fra cui i coniugi Breitenstein che mi divennero allora e mi sono
rimasti amici cordiali. I miei rapporti con queste persone mi diedero
l’occasione d'un viaggio a Budapest. Grande fu l'impressione che ricevetti
dalla capitale ungherese il cui carattere è così fondamentalmente diverso da
quello di Vienna. Si attraversa, venendo da Vienna, un paesaggio incantevole; è
un viaggio brillante, tra gente piena di temperamento e di vivacità musicale.
Guardando dal finestrino del treno si ha l'impressione che la natura stessa si
colorisca d’una speciale nota poetica e che gli abitanti, senza prestar molta
attenzione alla poesia della natura, ch’è loro abituale, si abbandonino ai
giochi d'una loro musica del cuore, spesso profondamente intima. E quando si
mette il piede a Budapest, ecco tutto un mondo che si rivela, un mondo che può
essere contemplato col più vivo interesse, ma non mai interamente compreso dai
visitatori appartenenti ad altri popoli europei; come uno sfondo scuro, sul
quale risplenda una scintillante luminosità di colori. Quando mi trovai davanti
al monumento di Franz Deak, l'essenza di questo mondo mi balzò allo sguardo
come concentrata in un’unica figura, il creatore di quell'Ungheria che durò
dal 1867 al 1918. Ha una testa in cui vive una volontà rude e superba, una
volontà che dà di piglio risolutamente alle cose e arriva al suo risultato
senza astuzie, con impeto elementare, senza riguardo a nulla. Sentii quanto
fosse soggettivamente vera, per ogni ungherese autentico quella frase che spesso
avevo sentito ripetere: “Fuori dell’Ungheria non c'è vita; e se c’é non
è vita”.
Da bambino, vivendo sul confine occidentale dell’Ungheria, avevo potuto
constatare come i Tedeschi dovessero sentire l’urto contro questa rude volontà
superba. Ora nel cuore stesso dell’Ungheria, imparai a conoscere come questa
volontà, conduca il magiaro ad un isolamento umano; isolamento che con una
certa ingenuità egli riveste d’uno splendore a lui naturale e che, se pur si
mostra volentieri all’occhio segreto della Natura, non sopporta facilmente
l'occhio aperto degli uomini.
Sei mesi dopo questa visita, gli amici della Transilvania organizzarono per me
una conferenza a Hermannstadt. Era l'epoca natalizia. Attraversai le vaste
pianure, nel cui centro giace Arad; le nostalgiche poesie di Lenau mi
risuonavano in cuore mentre lasciavo spaziare lo sguardo su quelle amplissime
distese, su quelle vastità dove l'occhio non incontra limiti. Dovetti
pernottare in un paesuccio di confine fra l'Ungheria e la Transilvania e passai
metà della notte seduto in un'osteria. Oltre a me, c'era solo un gruppo di
giocatori di carte, riunito attorno a una tavola: gente di ogni nazionalità,
com'era possibile trovarne allora nell'Ungheria e nella Transilvania. E già
dopo una mezz'ora di gioco, la veemenza, la passione con la quale quegli uomini
giocavano, traboccava e si espandeva in nuvolaglie animiche, che si elevavano al
di sopra della tavola, si combattevano come demoni ed avvolgevano e
inghiottivano infine completamente gli uomini. Quali differenze di passionalità
si rivelano lì nelle diverse nazioni!
Arrivai a Hermannstadt il giorno di Natale e venni introdotto nella colonia
sassone di Transilvania che viveva lì fra i Rumeni e i Magiari. Nobile stirpe
la quale, nella decadenza che non voleva ammettere, si sforzava a rimanere
valorosa: spirito tedesco esiliato in oriente, quasi a ricordo della sua vita di
secoli addietro e deciso a mantener fedeltà alla propria origine; e però, in
quest’atteggiamento, rivelava un tratto di allontanamento dalla vita, e lo
manifestava in un’allegria fittizia inculcata dall’educazione. Trascorsi
belle giornate tra i pastori tedeschi della Chiesa evangelica, i maestri delle
scuole tedesche ed altri Tedeschi della Transilvania. E il cuore mi si
riscaldava in mezzo a quegli uomini che, nella loro sollecitazione per lo
spirito della stirpe e nella cura che ad esso dedicavano, sviluppavano una
cultura del cuore la quale, a sua volta, parlava in primo luogo al cuore.
Quest'intimo calore mi ardeva nell'anima durante una gita in slitta, con gli
amici vecchi e nuovi, tutti avvolti in pesanti pellicce, con un freddo da lupi,
sulla neve crepitante, verso il sud, verso i Carpazi; da lontano, una muraglia
di monti coperti di nere foreste; da vicino, una selvaggia e raccapricciante
regione montuosa frastagliata da orridi e precipizi.
Contro di tutte le mie esperienze era il mio amico che non si stancava di
escogitare nuovi mezzi per farmi conoscere più a fondo l'elemento sassone della
Transilvania. Egli trascorreva ancora sempre parte del suo tempo a Vienna, parte
a Hermannstadt; aveva allora fondato una rivista settimanale allo scopo di
promuovere la cultura sassone nella Transilvania; impresa fatta esclusivamente
di idealismo, senza un milligrammo di spirito pratico, alla quale però
collaboravano quasi tutti i rappresentanti della cultura sassone in
Transilvania. Cessò di esistere poche settimane dopo la sua fondazione.
Simili esperienze, come quella di questi viaggi, mi sono state offerte dal
destino; e mi diedero l'occasione di educare lo sguardo per il mondo esterno la
cui visione non mi è stata facile, mentre nell’elemento spirituale vivevo,
per cosi dire, spontaneamente.
Con l'anima piena di ricordi nostalgici feci il mio viaggio di ritorno a Vienna.
Qualche tempo dopo mi capitò nelle mani un libro: “Rembrandt educatore”,
della cui “ricchezza di contenuto spirituale” tutti parlavano allora. Lo si
considerava come l’avvento d'uno spirito nuovo. A questo sintomo, dovetti
rendermi conto di quanto, con la costituzione della mia anima io fossi solo
nella vita spirituale dell’epoca. La mia impressione, di fronte a questo libro
che tutti esaltavano era la seguente: come se qualcuno avesse passato per mesi e
mesi le sue serate al tavolino di un caffè ben frequentato, ascoltando le
“spiritose” sentenze degli assidui, e le avesse poi annotate in forma
aforistica; e infine, compiuto questo "lavoro preliminare", avesse
riuniti tutti i foglietti contenenti tali annotazioni, li avesse mescolati ben
bene, tirati fuori, e attaccato l'uno all'altro, facendone un libro. Questa
critica è naturalmente esagerata. Ma la mia concezione della vita mi portava
appunto a respingere l'opera che invece era ammirata come un capolavoro dallo
“spirito dell’epoca”; per me quel libro rimaneva, alla superficie di
pensieri che, pur spacciandosi per spirituali, non scendevano però, nemmeno in
un'unica frase, a congiungersi con le vere profondità dell’anima umana. Mi
addolorava che i miei contemporanei vedessero in un tale libro l’espressione
d'una profonda personalità, mentre io dovevo ritenere che quel diguazzar di
pensieri nelle acque basse dello spirito illanguidisse nelle anime ciò ch’era
in loro di umanamente profondo.
A quattordici anni avevo dovuto cominciare a dar lezioni private e per altri
quindici, fino all’inizio del secondo periodo della mia vita, che si svolse a
Weimar, il destino mi aveva mantenuto in quell'attività. Con lo sbocciare di
molte anime nel corso della loro infanzia e della loro gioventù si è collegato
col mio proprio sviluppo e ho potuto osservare quanto sia differente nei due
sessi l’ingresso nella vita perché, oltre all'istruzione di ragazzi e di
adolescenti, mi fu affidata anche quella di alcune giovinette. E persino la
madre del giovane di cui, dato il suo stato patologico, avevo assunto
interamente l'educazione, fu per un certo tempo mia allieva nella geometria; e
sia a lei sia a sua sorella tenni più tardi anche lezioni di estetica.
In questa famiglia dimorai per parecchi anni come in una casa mia, pur
dedicandomi anche altrove ai miei compiti d'insegnante e di precettore.
L’amicizia che mi univa alla madre del ragazzo, mi portava a prender parte a
tutte le gioie e a tutte le pene della famiglia. In questa donna avevo dinanzi a
me un'anima di singolare bellezza; ella viveva in piena dedizione allo sviluppo
del destino dei suoi quattro ragazzi; in lei si poteva studiare l'amor materno
in grande stile; era bello e interessante occuparci insieme di problemi
pedagogici. Aveva una buona disposizione musicale e vivo entusiasmo per quest’arte
e, finché furono piccoli, fu lei che si occupò, almeno in parte, degli
esercizi musicali dei ragazzi. Con me s'intratteneva sui più svariati problemi
della vita addentrandosi in essi con viva comprensione e interesse profondo;
seguiva anche con la medesima attenzione i miei lavori scientifici ed altri. Era
un tempo in cui sentivo profondo il bisogno di parlar con lei su ogni cosa che
mi stesse a cuore. Quando le raccontavo le mie esperienze spirituali, ella mi
ascoltava con un'attitudine singolare: il suo intelletto aveva simpatia per
esse, eppure manteneva un lieve tono di riserva; l’anima invece le accoglieva
pienamente. Il suo atteggiamento di fronte all'essere umano si manteneva
naturalistico: nel suo pensiero ella metteva sempre in rapporto la struttura
morale dell’anima con lo stato più o meno sano della costituzione fisica. In
un certo suo modo istintivo, ella pensava, “medicalmente” sull'essere umano;
persino con una speciale nota naturalistica. Era interessantissimo intrattenersi
con lei su quest’argomento. Insieme a ciò aveva di fronte alla vita esterna
l'attitudine d'una donna che compie col più scrupoloso senso del dovere quanto
le viene affidato, mentre però nell'intimo lo considera in gran parte
esorbitante dalla propria sfera. Sotto molti rapporti, riteneva il proprio
destino come un peso; ma non esigeva nulla dalla vita, la prendeva così come si
presentava, fuorché quando si trattava dei figli. Tutto quanto riguardava
questi ultimi, lo sentiva, invece con la più intensa emozione dell’anima.
A tutto ciò: vita animica d'una donna, la sua così bella dedizione ai figli,
vita di famiglia, entro una vasta cerchia di parenti e di conoscenti, io
partecipavo vivamente. La situazione non era però esente da difficoltà. La
famiglia era israelita, assolutamente libera nelle sue concezioni da ogni
limitazione di confessione o di razza; ma nel padre, al quale ero molto
attaccato, c'era una certa suscettibilità di fronte ad ogni osservazione che un
non ebreo facesse sugli Ebrei; suscettibilità provocata dall’antisemitismo,
allora in ripresa.
Se non che, in quel tempo, prendendo io parte viva alla lotta che i Tedeschi
avevano da sostenere in Austria per la loro esistenza nazionale, fui condotto
anche a occuparmi della situazione, storica e sociale del giudaismo, specie
quando uscì l’”Homunculus” di Hamerling. Gran parte della stampa
giornalistica prese occasione da quest'opera per caratterizzare quale
antisemita, questo poeta eminentemente tedesco; gli stessi nazionalisti tedeschi
antisemiti lo pretesero come uno di loro. Tutto ciò mi toccava assai poco; ma,
in un articolo ch’io scrissi sull’”Homunculus”, mi espressi, o così mi
sembrava, in modo del tutto oggettivo sulla situazione del Giudaismo. L’uomo,
nella cui casa io vivevo e con cui ero in rapporti di vera amicizia, lo prese
come una speciale forma di antisemitismo. La sua amicizia per me non venne
minimamente alterata; però l'articolo gli arrecò un profondo dolore. Lo vedo
ancora davanti a me, appena ebbe letto l'articolo, sconvolto dalla pena più
intensa: “Non è possibile interpretare in senso amichevole ciò che Lei ha
scritto qui sugli ebrei, - mi disse - eppure non è tanto questo che mi ferisce,
quanto il fatto che, dati l’intimo rapporto che ha con noi e coi nostri amici,
soltanto con noi può aver fatto le esperienze che l’hanno indotta a scrivere
così”.
S'ingannava: ché il mio giudizio procedeva esclusivamente dalla visione
complessiva storico-spirituale; nulla di personale vi era fluito. Ma egli non
poteva vederlo. Alle mie dichiarazioni rispose soltanto: “No, l'uomo che educa
i miei figli non è - a giudicare da questo articolo - un amico degli ebrei. E
non fu possibile distoglierlo da questa convinzione. Però non pensò nemmeno
per un attimo che il mio rapporto con la famiglia dovesse minimamente mutare;
questo per lui era una necessità. Ancora meno potevo io considerare questo
fatto come il motivo d'un cambiamento perché l’educazione di suo figlio era
per me un compito assegnatomi dal destino. In tutti e due però rimase nella
coscienza il senso che qualcosa di tragico si fosse venuto a frapporre nei
nostri rapporti.
Ad aggravare la situazione si aggiunse un altro fatto. In seguito alle lotte
nazionali di quel tempo, molti dei miei amici avevano assunto un colore
antisemitico nella loro visione del Giudaismo e non vedevano quindi con simpatia
la mia posizione in una casa israelita. D'altra parte il capo di casa vedeva nei
miei rapporti amichevoli con tali persone una conferma dell'impressione ricevuta
dal mio articolo.
Apparteneva alla parentela della famiglia, di cui facevo intimamente parte, il
compositore della “Croce d'oro”, Ignatz Bruell, fine personalità alla quale
volevo un gran bene. Viveva quasi perduto in se stesso, lontano dalle cose del
mondo. Il suo interesse per la musica non era però esclusivo, ma si rivolgeva a
molti altri lati della vita spirituale; egli poteva dedicarsi a questi suoi
interessi solo perché era un “favorito dalla sorte” e viveva, si può dire,
sullo sfondo d'una vita di famiglia che allontanava da lui ogni cura
dell'esistenza quotidiana permettendo che la sua attività creativa si svolgesse
in un ambiente di agiatezza.
Cosi egli si sviluppò penetrando non nella vita, ma solo nella musica. Non
occorre qui classificare il valore o meno della sua produzione musicale, ma era
incantevole incontrarlo per strada e vederlo risvegliarsi dal suo mondo di suoni
nel momento in cui gli si rivolgeva la parola. Persino i bottoni del suo
panciotto non erano quasi mai abbottonati nell'occhiello giusto; egli luceva
nello sguardo una soavità meditativa, il passo non era del tutto sicuro, ma
pieno d'espressione. Conversando con lui si poteva parlare di molte cose per le
quali manifestava una comprensione fine e delicata; ma si poteva scorgere in lui
come il contenuto d'ogni discorso s'insinuasse subito nel regno della musica.
Nella famiglia in cui vivevo, conobbi anche l'insigne medico Dr. Breuer che,
insieme col Dr. Freud, partecipò - per cosi dire - alla nascita della
psicanalisi. Egli però collaborò soltanto agli inizi di questa concezione e
non fu più d'accordo con lo sviluppo datole in seguito dal Dr. Freud. Il Dr.
Breuer era per me una personalità piena di attrattiva di cui ammiravo molto il
contegno nel campo professionale; ma anche in altri campi egli era uno spirito
eclettico. Parlava di Shakespeare in modo che se ne potevano ricevere vigorosi
impulsi: era interessante ascoltarlo anche quando parlava di Ibsen, o della
“Sonata a Kreutzer” di Tolstoi, dal suo punto di vista genuinamente medico.
Quando trattava simili argomenti con la mia amica, la madre dei giovinetti che
educavo, assistevo spesso col più vivo interesse alla conversazione. In quel
tempo la psicanalisi non era ancora nata; ma i problemi che tendevano in quella
direzione erano già nell’aria. I fenomeni ipnotici avevano dato una
colorazione speciale al pensiero della medicina. La mia amica era legata
d’amicizia al Dr. Breuer fin dalla gioventù; e a me si presentava qui un
fatto che mi ha dato molto da riflettere: questa donna pensava in un certo
senso, ancor più “medicalmente” dell'insigne medico stesso. Trattandosi una
volta d’un morfinomane, curato dal Dr. Breuer, ella mi disse: “Pensi che
cosa ha fatto il Dr. Breuer! Si è fatto dare da quel morfinomane la parola
d’onore che non avrebbe più preso morfina. Credeva con ciò d'arrivare a
qualche risultato, e rimase indignato quando il paziente gli mancò di parola:
indignato al punto da esclamare: - Come posso curare una persona che non tiene
la parola data? - È incredibile, essa aggiunse, che un medico così eccellente
possa essere tanto ingenuo! Come si può volere guarire attraverso una promessa,
una cosa radicata così profondamente nella natura?”
Non importa qui che la signora avesse ragione o no. Le vedute del medico sulla
terapia suggestiva possono aver cooperato al suo tentativo di cura. Ma non si può
negare che tali parole della mia amica testimonino della straordinaria energia
con la quale ella parlava allora in modo così singolarmente consono allo
spirito che viveva nella scuola viennese di medicina, appunto al tempo in cui
quella scuola fioriva.
Era davvero, nel suo genere, una donna superiore e sta come una figura
importante nella mia vita. Ora è morta da lungo tempo. Fra le cose che mi
resero penoso il distacco da Vienna ci fu anche il fatto di dovermi separare da
lei. Se guardo indietro alla prima parte della mia vita, cercando di
caratterizzarla come da fuori, si afferma in me questa sensazione: il destino mi
aveva guidato in modo che, raggiunti i trent'anni, non mi vedevo ancora legato
da nessuna “professione” esterna. Nemmeno nell'Archivio di Goethe e Schiller
a Weimar entrai come impiegato fisso, ma quale libero collaboratore
all’edizione goethiana che l’Archivio pubblicava per incarico della
Granduchessa Sofia. Nel resoconto stampato dal direttore dell’Archivio, nel 12°
volume degli Annuari goethiani è scritto, infatti: “Dall'autunno del 1890 si
è aggiunto, ai collaboratori fissi, il Dr. Rudolf Steiner, da Vienna. Ad
eccezione della parte osteologica, gli è stato assegnato tutto il campo della
“Morfologia”, circa cinque o sei volumi della “seconda sezione” ai quali
affluisce dal lascito dei manoscritti, un materiale d'alta importanza.
Rudolf Steiner (1924)
53 - Altro stralcio da un’”Autobiografia” (Collingwood)
Fino all'età di tredici anni vissi in casa e mio
padre curò egli stesso la mia istruzione. Le lezioni occupavano soltanto due o
tre ore ogni mattina; per il resto egli mi lasciava in libertà, aiutandomi
talvolta in quello che sceglievo di fare, ma più spesso lasciando che me la
cavassi da solo.
Fu opera sua che io incominciassi lo studio del latino a quattro anni e del
greco a sei; ma fu opera mia l’incominciare, circa allo stesso tempo, a
leggere tutto quello che potevo trovare, specialmente di geologia, di astronomia
e di fisica; a riconoscere le rocce e le stelle, ed a capire il funzionamento
delle pompe, delle serrature e di altri strumenti meccanici che si trovavano per
la casa.
Fu mio padre a darmi lezioni di storia antica e moderna, illustrandola su carte
geografiche in rilievo fatte con carta macerata, ottenuta facendo bollire dei
giornali in un tegame; ma la mia prima lezione su ciò che ora considero il mio
campo specifico, la storia del pensiero, fu la scoperta, nella casa di un amico
che stava a poche miglia lontano, di un libro sgualcito del Seicento, privo di
copertina e di frontespizio, e pieno di strane dottrine sulla meteorologia, la
geologia ed il moto dei pianeti. Doveva essere un compendio dei
"Principia" di Cartesio, a quel che mi è dato giudicare dal ricordo
di ciò che diceva sui vortici; avevo circa nove anni quando lo trovai e già ne
sapevo abbastanza sulle corrispondenti teorie moderne per valutare il contrasto
che offriva.
Esso mi mise a parte del segreto dal quale i libri moderni mi avevano fino
allora escluso, e cioè che le scienze naturali hanno una loro storia e che le
dottrine che esse insegnano in ogni campo e in ogni periodo, sono state
raggiunte non da qualche scopritore che colga la verità dopo secoli di errori,
ma dalla graduale modificazione di dottrine fino a quel momento tenute per vere;
e che esse stesse saranno modificate in un giorno futuro, a meno che il pensiero
non si arresti. Non dirò che tutto questo mi sia parso chiaro a quell'acerba età
ma dalla lettura di questo libro acquistai almeno la consapevolezza che la
scienza è un organismo che nel corso della sua storia si modifica più o meno
in continuità in ogni sua parte, piuttosto che un magazzino di verità
conquistate una dopo l'altra. Negli stessi anni osservavo sempre il lavoro di
mio padre, di mia madre e degli altri pittori di professione che frequentavano
la nostra casa, e mi provavo sempre ad imitarli; così imparai a pensare un
quadro non come un prodotto finito, esposto all'ammirazione dei conoscitori, ma
come il documento visibile del punto raggiunto nel tentativo di risolvere un
problema pittorico. Imparai quello che alcuni critici e scrittori di estetica
non sanno mai, neppure alla fine della loro vita: e cioè che nessuna opera
d'arte è mai finita (…). Si cessa di lavorare a un dipinto o a un manoscritto
non perché essi siano finiti, ma perché è giunto il giorno della consegna o
perché l'editore ne richiede insistentemente una copia, o perché “sono stufo
di lavorarci” o “non so proprio che cosa ci si possa fare di più”.
Trovavo in me stesso minore attitudine alla pittura che alla letteratura; fin da
piccolo scrivevo continuamente, in versi e in prosa, liriche e frammenti di
epica, novelle avventurose e romanzesche, descrizioni di paesi immaginari,
assurdi trattati scientifici e archeologici. Un'abitudine prolifica a questo
riguardo era incoraggiata, anzi richiesta, dalla consuetudine familiare di
produrre una rivista mensile manoscritta, che si faceva poi circolare tra
parenti e amici.
Mia madre conosceva bene il pianoforte ed era solita suonare per un’ora ogni
mattina prima di colazione; qualche volta, anche di sera, davanti a un pubblico
formato da fanciulli del vicinato seduti per le scale al buio. In questo modo
venni a conoscere tutte le sonate di Beethoven e quasi tutto Chopin, perché
questi erano i suoi compositori favoriti, benché non fossero anche i miei. In
quanto a me non sono mai stato capace di suonare bene il pianoforte.
Mio padre aveva molti libri e mi permetteva di leggerli liberamente. Tra gli
altri aveva conservato i libri di studi classici, di storia antica e di
filosofia che aveva usato ad Oxford. Di regola questi li lasciavo stare, ma un
giorno, quando ebbi otto anni, fui attratto dalla curiosità a tirar giù un
piccolo libro nero sul cui dorso stava scritto: “Kant's Theory of Ethics”.
Era la traduzione di Abbot del "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”; e
come lo cominciai a leggere, mi incastrai tra la libreria e il tavolo, e fui
preso da una strana successione di emozioni. Da principio fu un’intensa
eccitazione. Sentivo che si dicevano cose della più alta importanza, e su
questioni di urgenza imprescindibile; cose che ad ogni costo dovevo capire. Ma a
questo punto con ondata di indignazione, mi accorsi che non potevo capire. Cosa
umiliante a confessare, quello era un libro le cui parole erano inglesi e i cui
periodi grammaticalmente tornavano: ma il significato di essi mi sfuggiva.
Quindi, terza ed ultima, venne la strana sensazione che il contenuto di quel
libro, anche se non lo potevo capire, era in qualche modo affar mio, una
questione mia personale o, meglio, qualcosa che mi sarebbe personalmente
appartenuto in futuro. Non si trattava della puerile intenzione di “diventare
un guidatore di locomotive quando sarò grande” perché non c'era desiderio in
ciò: io non volevo, in nessun senso della parola, esser padrone dell'etica
kantiana quando fossi stato abbastanza adulto, ma sentivo come se si fosse
alzato un velo, rivelandomi il mio destino. Ecco che dopo di ciò fui preso
dall'impressione di essere investito di un compito la cui natura non potevo
definire se non dicendo: io devo pensare. Ciò a cui dovevo pensare non lo
sapevo; e quando ubbidendo a questo imperativo, mi facevo muto e mi astraevo
dalla compagnia o cercavo la solitudine per pensare senza essere interrotto, non
avrei potuto dire, e tuttora non lo potrei, che cosa fosse quello a cui
realmente pensavo.
Non c'erano particolari problemi che mi ponessi né c’erano specifici
argomenti cui dirigessi la mente: c’era soltanto un’informe agitazione
mentale senza un fine preciso, come se stessi lottando contro una nebbia. So
adesso che questo è ciò che sempre mi capita quando sono ai primi stadi nella
elaborazione di un problema. Finché il problema non si è avviato decisamente
alla soluzione, non so che cosa sia: tutto quello di cui ho coscienza è questa
vaga irrequietezza mentale, questa sensazione di essere preoccupato da qualche
cosa che non conosco. Capisco adesso che i problemi del lavoro della mia vita
stavano prendendo nel profondo di me stesso la loro prima forma embrionale. Ma
tutti quelli che mi osservavano debbono aver pensato, come infatti fecero i miei
parenti, che io mi fossi abituato all'ozio, perdendo quella vivacità, e quella
prontezza di mente che erano state così evidenti nella mia prima fanciullezza.
La mia unica difesa contro questa opinione - dato che non sapevo che cosa mi
stesse succedendo, e perciò non avrei potuto spiegarlo - era il coprire questi
attacchi di astrazione con qualche attività fisica, gingillandomi per quel
tanto che mi permettesse di non distrarre l'attenzione dal mio travaglio
interiore.
Ero un ragazzo ingegnoso, capace di fare un mucchio di cose: veloce nel
camminare, nell'andare in bicicletta o nel canottaggio, ed espertissimo nel
manovrare una barca a vela. Così, quando mi prendevano questi attacchi, mi
mettevo a fare qualche bazzecola, come un reggimento di omini di carta, o a
vagare senza meta nei boschi o per i monti, o a veleggiare tutto il giorno in
una calma assoluta. Era penoso esser preso in giro perché giocavo con omini di
carta; ma l'alternativa, a tutto questo, lo spiegare cioè perché lo facessi,
era impossibile. Non sono sicuro se fosse questa mia progressiva tendenza a non
fare niente a far decidere mio padre di mandarmi a scuola. Comunque egli era
troppo povero per pagarne lui stesso le spese, ed esse (e più tardi anche
quelle di Oxford) furono sostenute dalla generosità di un ricco amico. Così a
tredici anni fui messo ad una scuola preparatoria al fine di concorrere ad una
borsa di studio, e conobbi la dura ‘routine’ colla quale i ragazzi della
classe media inglese si guadagnano la vita con concorsi, cominciando ad una età
in cui ai loro coetanei della classe lavoratrice è ancora proibito per legge,
di scendere sul mercato del lavoro. L’amico di mio padre, ne sono sicuro,
avrebbe pagato per me con la stessa benevolenza tanto duecento sterline
all’anno quanto una; ma per me almeno era un punto d'onore vincere le borse di
studio, se non altro per giustificare la spesa di tanti soldi per me; e anche se
tale spesa non fosse stata giustificata, lo specialismo, che è uno dei
principali vizi dell'educazione inglese non mi avrebbe risparmiato. Lo spettro
di una sciocca disputa secentesca, abita ancora le nostre aule, infettando
maestri e scolari con la pazza idea che gli studi devono essere o “classici”
o “moderni”. Io ero adatto a specializzarmi in greco e latino, quanto in
storia e lingue moderne, (parlavo e leggevo il francese e il tedesco con la
stessa facilità dell'inglese), o le scienze naturali, e nulla avrebbe potuto
offrire alla mia mente il nutrimento adatto, se non lo studio di tutte e tre le
cose; ma l’insegnamento di mio padre mi aveva impartito una buona dose di
latino e greco in più di quella che la maggioranza dei ragazzi della mia età
avesse ricevuto e poiché dovevo specializzarmi in qualcosa, mi specializzai in
questo e divenni uno studente “classico”.
Oltre al “rapprochement” tra filosofia e storia, stavo anche lavorando ad un
“rapprochement” tra teoria e pratica. I miei primi sforzi in questa
direzione, furono tentativi di obbedire a ciò che sentivo come una vocazione a
resistere alla corruzione morale propagata dal dogma "realista" che
cioè la filosofia morale non faccia altro che studiare, con uno spirito
puramente teoretico, un campo che quella ricerca lascerebbe inalterato.
L’opposto di questo dogma mi sembrava non solo una verità, ma una verità
che, e per la sua integrità e per la sua efficacia, come agente morale nel
senso più largo del termine, dovrebbe essere familiare ad ogni essere umano:
cioè, che nella sua qualità di agente morale, politico, economico, egli non
viva in un mondo di “crudi fatti”, a cui i pensieri non facciano né caldo né
freddo, ma in un mondo di pensieri; che se si cambiano le “teorie” morali,
politiche ed economiche generalmente, accettate dalla società in cui egli vive,
si cambia il carattere del suo mondo; e che se si mutano le sue “teorie”, si
muta il suo rapporto con quel mondo; così che in entrambi i casi si cambia il
suo modo d'agire.
Il tentativo "realista" di negare ciò poteva senza dubbio esser
difeso con qualche ragione plausibile finché era possibile fare un taglio netto
tra pensiero filosofico e pensiero storico. Si poteva ammettere che il modo in
cui un uomo agisce, in quanto egli è un agente morale, politico, economico, non
è indipendente dal suo modo di pensare sulla situazione in cui si trova. Se la
conoscenza circa i fatti della propria situazione si chiama conoscenza storica,
la conoscenza storica è necessaria all'azione. Ma si potrebbe ancora obiettare
che il pensiero filosofico, che avrebbe a che fare con “universali”
all'infuori del tempo, non sia necessario. Argomenti di questa specie, non
valeva più la pena di confutarli sapendo ormai come sapevo, che il
"realismo" era completamente fuori strada sulla natura della storia, e
che di conseguenza ogni argomento "realista" basato sulla distinzione
tra storia e filosofia, - o tra fatti e teorie, o tra “l’individuale” (che
alcuni realisti mal chiamavano “il particolare”) e “l’universale” –
deve considerasi sospetto. Subito dopo la guerra, perciò, incominciai a
riconsiderare nei loro particolari tutti i punti ed i problemi della filosofia
morale, includendo sotto questo titolo tanto la teoria dell'economia che quella
della politica e quella della morale in senso stretto, alla luce dei principi
che già a quel tempo informavano tutto il mio lavoro.
In primo luogo sottoposi quei punti e quei problemi a ciò che io chiamavo un
trattamento storico, insistendo sul fatto che ognuno di essi aveva la sua
storia, ed era incomprensibile senza avere una qualche conoscenza di quella
storia. In secondo luogo tentai di trattarli con un altro procedimento che
chiamai analitico. La mia idea era che una stessa azione (che come azione pura e
semplice era un'azione “morale”) era anche un'azione “politica”, in
quanto azione relativa ad una norma e nello stesso tempo un'azione
“economica” in quanto mezzo per un fine. I problemi della teoria morale, nel
più largo senso della parola 'morale', potevano così dividersi nel modo
seguente: a) problemi della teoria morale in senso stretto, cioè problemi che
trattano dell'azione in quanto tale; b) problemi della teoria politica, cioè i
problemi che trattano dell'azione in quanto formazione, obbedienza o
trasgressione di norme; c) problemi della teoria economica, o problemi che hanno
per oggetto l'azione in quanto produttrice o non produttrice di beni al di là
di sé stessa.
Non c’erano, ritenevo, azioni soltanto morali né soltanto politiche; ogni
azione era morale, politica ed economica. Ma sebbene le azioni non dovessero
dividersi in tre classi separate - le morali, le politiche e le economiche -
queste tre caratteristiche, la loro moralità, la loro politicità e la loro
economicità, dovevano essere distinte, e non confuse come lo sono, per es.
nell’utilitarismo che dà ragione dell'economicità, quando professa di dar
ragione della moralità.
Queste erano le direttive in base alle quali svolsi il problema, nelle mie
lezioni del 1919. Continuai a far lezione su questo argomento per quasi tutto il
resto della mia permanenza nel Pembroke College, rivedendolo continuamente. Lo
schema che ho appena descritto rappresenta, ovviamente, uno stadio del mio
pensiero in cui il “rapprochement” tra storia e filosofia era ancora molto
incompleto. Qualunque lettore che abbia compreso i capitoli precedenti di questo
libro può comprendere da sé come le modificai col passar del tempo.
Il “rapprochement” tra teoria e pratica era parimenti incompleto. Non le
pensavo più come reciprocamente indipendenti; vedevo che la relazione tra loro
era di intima e reciproca dipendenza, il pensiero dipendendo da ciò che colui
che pensa ha imparato dall'esperienza nell’azione, l'azione dipendendo da ciò
che egli pensava di sé e del mondo; sapevo molto bene, anche, che il pensiero
scientifico, storico e filosofico dipendeva tanto dalle qualità “morali”
come da quelle “intellettuali”, e che le difficoltà “morali” dovevano
essere superate non dalla sola forza “morale”, ma dal pensare con chiarezza.
Questo era però soltanto un “rapprochement” teoretico di teoria e pratica,
non “rapprochement” pratico: io conducevo ancora la mia vita di tutti i
giorni, come se pensassi che il compito di quella vita fosse teoretico e non
pratico. Non vedevo che la mia tentata ricostruzione della filosofia morale
sarebbe rimasta incompleta finché le mie abitudini si fossero basate sulla
banale distinzione tra pensatori e uomini d’azione.
Questa divisione, come molte cose che oggi noi consideriamo naturali, era una
sopravvivenza del Medioevo. Io vivevo e lavoravo in una università, e una
università è una istituzione basata su idee medioevali, la cui vita e la cui
opera sono ancora impacciate dalla medievale interpretazione della distinzione
greca fra vita contemplativa e vita pratica come campi riservati a due classi di
specialisti.
Posso vedere adesso, che avevo tre diverse posizioni verso questa sopravvivenza.
C'era un primo R.G. Collingwood che sapeva teoricamente che la divisione era
falsa, e che la “teoria” e la “pratica”, essendo interdipendenti,
dovevano entrambe essere ugualmente frustrate, se segregate nelle specifiche
funzioni di classi diverse.
C'era un secondo R.G. Collingwood che nelle abitudini della sua vita ordinaria
si comportava come se essa fosse stata concreta, vivendo egli come un pensatore
di professione per il quale i cancelli del college erano il simbolo del suo
essere appartato degli affari della vita pratica. Le mie abitudini e la mia
filosofia erano così in conflitto: vivevo come se non credessi nella mia stessa
filosofia, e filosofavo come se non fossi stato il pensatore di professione che
ero di fatto. Mia moglie soleva dirmelo; ed io solevo seccarmene alquanto.
Ma al disotto di questo conflitto c'era un terzo R.G. Collingwood per il quale
la toga del pensatore di professione era un travestimento di volta in volta
comico e odioso nella sua incongruenza. Questo terzo R.G. C. era un uomo
d'azione, o piuttosto era un qualcosa in cui la differenza tra pensatore e uomo
d'azione scompariva. Egli non mi lasciava mai solo molto a lungo. Si rigirava
nel sonno ed il tessuto della mia vita abituale incominciava a incrinarsi.
Sognava, ed i suoi sogni si cristallizzavano nella mia filosofia. Quando non
voleva giacersene quieto e lasciarmi giocare a fare il professore, solevo
pacificarlo mettendo da parte le mie associazioni accademiche, e tornando dalle
mie parti a tenere conferenze alla società antiquaria locale. Può sembrare una
strana forma di “sfogo” per un uomo d'azione compresso ma aveva molto
effetto. L'entusiasmo verso gli studi storici e verso di me quale loro guida in
quegli studi, che io non mancavo mai di suscitare in coloro che mi ascoltavano,
non era diverso in sostanza dall'entusiasmo che un oratore suscita per la sua
persona e la sua politica. E qualche volta questo terzo R.G. C. si svegliava,
balzando su: per esempio un giorno, poco dopo il principio d'agosto 1914, quando
una folla di minatori del Northumberland, piena di fervore patriottico, vide
quel che essa immaginò fosse una spia tedesca nel “vecchio campo romano” su
per la collina ed agì in modo conforme.
Il terzo R.G. C. soleva alzarsi e ravvivarsi con voce sonnolenta, tutte le volte
che incominciavo a leggere Marx. Non fui mai affatto convinto né dalla
metafisica di Marx, né dalla sua teoria economica: ma l'uomo era un
combattente, e un grande combattente; e non soltanto un combattente, ma un
combattente filosofo. La sua filosofia poteva non essere convincente, ma per chi
non era tale? Qualsiasi filosofia - lo sapevo - sarebbe, non solo non
convincente ma insensata per uno che traviasse il problema ch’essa intende
risolvere. Quella di Marx intendeva risolvere un problema “pratico”: il
compito, come egli stesso diceva, era di “rendere migliore il mondo”. La
filosofia di Marx sarebbe perciò apparsa di necessità senza senso, eccetto che
per uno che, non dirò condividesse il suo desiderio di rendere migliore il
mondo per mezzo della filosofia, ma almeno considerasse tale desiderio come
ragionevole. Secondo i miei principi di critica filosofica era inevitabile che
la filosofia di Marx dovesse sembrare senza senso a filosofi con i guanti come i
“neorealisti”, con la loro netta divisione tra teoria e pratica, o per i
“liberali” quali John Stuart Mill, che sostenevano che si dovrebbe lasciar
pensare alla genteciò che vuole, perché quel che essa pensa non ha in fondo
importanza. Al fine di criticare una filosofia senza guanti come quella di Carlo
Marx, si deve essere filosofo senza guanti almeno per quel tanto che permetta di
considerare legittimo il filosofare senza guanti.
Il primo ed il terzo R.G. C., erano d’accordo nel volere una filosofia senza
guanti. Essi non volevano una filosofia che fosse un giocattolo scientifico
garantito come divertente per i filosofi di professione, sicuri dietro i
cancelli del loro “college”. Essi volevano una filosofia che fosse
un’arma. Fin qui io ero con Marx. Forse tutto quello che ostava sulla via di
un più stretto accordo era il secondo R.G. C. il pensatore accademico o di
professione.
La mia posizione verso la politica è sempre stata quella che in Inghilterra è
chiamata democratica, e sul continente, liberale. Mi consideravo come una unità
in un sistema politico in cui ogni cittadino che possedesse il diritto di voto
aveva il diritto di votare per un rappresentante del Parlamento. Pensavo che il
governo del mio paese, grazie ad un diritto di voto molto esteso, a una libera
stampa e a un diritto di libera parola universalmente riconosciuto, fosse tale
da rendere impossibile che una considerevole parte del paese potesse essere
oppressa dall’azione del governo o che le sue rimostranze dovessero essere
soffocate, anche se non ci si poteva trovare rimedio. Pensavo che il sistema
democratico non era soltanto una forma di governo, ma una scuola di esperienza
politica, estesa a tutta la nazione e pensavo che nessun governo autoritario,
per quanto forte, potesse essere tanto forte come quello che poggiava su di una
opinione pubblica politicamente educata.
Come forma di governo pensavo che la sua essenza stesse nel fatto che essa era
un vivaio in cui le direttive politiche erano portate a maturazione alla luce
del sole, non un ufficio postale che le distribuisce belle e fatte ad un paese
passivamente ricettivo.
Questi li consideravo meriti grandissimi: più grandi di quelli di ogni altro
sistema politico fino allora escogitato, e degno di essere difeso a tutti i
costi contro coloro i quali, volendo ingannare il cittadino ed imporre delle
direttive belle e fatte, preparate da qualche cricca senza responsabilità,
slealmente lo accusavano di essere “impacciante” e “inefficiente”.
Sapevo naturalmente che aveva denunciato questo sistema come una frode avente la
funzione di gettare una sembianza di legalità sull'oppressione dei lavoratori
da parte dei capitalisti, ma sebbene sapesse che tale oppressione esisteva ed
era in larga misura legalizzata, pensavo che fosse compito di un governo
democratico lo sradicarla.
Non pensavo che la nostra costituzione fosse priva di errori. Ma la scoperta e
la correzione di questi errori era compito dei governi, non dei singoli
elettori. Perché il sistema si correggeva da sé, essendo capace mediante la
legislazione, di emendare i propri errori.
Esso era anche tale da alimentarsi da sé. I membri del Parlamento erano scelti
dagli elettori nella loro stessa cerchia: i gradi più alti del sistema erano
occupati da persone prese tra i membri del Parlamento; e così, finché i
singoli elettori compivano i loro doveri politici, tenendosi adeguatamente
informati sulle questioni pubbliche e votando secondo quanto in ogni data
occasione giudicavano fosse il bene della nazione nel suo complesso, c'era poco
pericolo che i suoi rappresentanti fossero insufficientemente informati, o
insufficientemente dotati di spirito pubblico per fare con onore il loro lavoro.
E, grazie al voto di maggioranza, non importava molto se alcuni, in qualsiasi
momento, non fossero informati o fossero sviati. Finché la maggioranza era
abbastanza bene informata e sufficientemente dotata di spirito pubblico per quel
che essa aveva da fare, gli sciocchi ed i disonesti sarebbero stati battuti ai
voti.
L'intero sistema comunque si sarebbe sfasciato, se una maggioranza
dell’elettorato fosse divenuta o male informata sulle questioni pubbliche, o
corrotta nel suo atteggiamento verso di esse; cioè capace di adottare nei loro
confronti una politica diretta non al bene della nazione come un tutto, ma al
bene della propria classe e del proprio ceto, o dei suoi stessi componenti.
Per quanto riguarda il primo periodo mi accorsi di un cambiamento in peggio
durante gli anni dal 1890 al 1900. I giornali dell'età vittoriana si facevano
un dovere, consideravano anzi il loro primo dovere, di dare ai loro lettori una
piena e accurata informazione sulle cose di pubblico interesse. Poi venne il
“Daily Mail”, il primo grande giornale inglese per il quale la parola
“notizia” perdette il suo vecchio significato di fatti che il lettore doveva
sapere se voleva votare intelligentemente ed acquistò il nuovo significato di
fatti, o fantasia, che potrebbero rendergliene divertente la lettura. Leggendo
un tale giornale il lettore non imparava più a votare. Imparava a non votare;
perché gli si insegnava a pensare le “notizie” non come la situazione in
cui egli doveva agire, ma come un puro spettacolo per i momenti d'ozio.
Per quanto riguarda il secondo periodo, mi accorsi piuttosto tardi di influenze
corruttrici. La sistemazione del Sud Africa del ministero Campbell-Bannerman fu
una bella dimostrazione dei principi in cui credevo, ed una prova che non avevo
torto a considerare i principi della politica inglese. La legislazione sociale
del suo successore, il primo ministro Asquith, fu tale che non potevo fare altro
che approvarla. Ma il modo con cui essa venne propagandata promettendo agli
elettori “nove soldi in cambio di quattro”, era la negazione di quei
principi. Lloyd George divenne per me una caratteristica, secondo solo al Daily
Mail, della corruzione dell'elettorato. Durante il primo quarto di questo
secolo, ciascuna di queste influenze corruttrici ebbe un enorme sviluppo.
Dopo la guerra il sistema democratico era minacciato da due potenti rivali.
C’erano due elementi in questo sistema, ognuno dei quali era figlio del
proprio rivale. Su di una base lockiana di proprietà privata la tradizione
democratica aveva eretto un sistema di istituzioni rappresentative designate a
promuovere il bene della nazione nella sua totalità. Ma esisteva, sulla carta
da che Marx la formulò, ed in termini di realtà politica dalla rivoluzione
russa, un sistema avente lo stesso fine, ma un diverso punto di partenza. I
socialisti (uso il termine nel senso di “socialismo marxista”), erano
d'accordo con la tradizione democratica nel mirare al miglioramento sociale ed
economico di tutto il popolo, ma proponevano di raggiungere questo fine
attraverso la proprietà pubblica dei “mezzi di produzione”. Poi vennero il
fascismo in Italia, ed il nazionalsocialismo in Germania, che erano d'accordo
con la tradizione democratica nel fare della proprietà privata il loro primo
principio ma, allo scopo di conservarla, essi non soltanto abbandonarono le
istituzioni politiche del governo democratico, ma anche il fine del
miglioramento sociale ed economico a cui quelle Istituzioni erano dirette.
La vera rottura tra la tradizione democratica ed i socialisti non era su un
principio politico, ma su un principio di fatto. Nessuno, penso, negherebbe che
la società europea moderna sia divisa tra persone le cui energie sono
incentrate nel possedere beni, e persone le cui energie sono incentrate nel
produrne.
Chiamiamoli capitalisti e lavoratori rispettivamente. Tutti i capitalisti
producono delle cose, e tutti i lavoratori ne posseggono; ma questo non annulla
la distinzione. Se ciò che è vitale per un uomo è il suo possesso di certe
cose, mentre il suo impegnarsi in certe attività è relativamente poco
importante, per molto che egli faccia è un capitalista. Se avviene il
contrario, per molto che possieda, egli è lavoratore.
Fra queste due “classi” nella società europea moderna, i socialisti
ritenevano che esistesse una “guerra di classe” e che le istituzioni
parlamentari non superassero questa guerra, ma la dissimulassero soltanto. La
tradizione democratica sosteneva che le istituzioni parlamentari agivano in modo
tale da dissipare ogni tendenza alla guerra di classe per mezzo della libertà
di parola e della libera discussione. Il fascismo su questo punto era d'accordo
col socialismo: sebbene i suoi portavoce, perseguendo la loro evidente politica
di inganno, lo negassero. Ma mentre il socialismo sperava di porre fine alla
lotta di classe con una vittoria dei lavoratori che avrebbe portato
all’abolizione delle differenze di classe, il fascismo aspirava di perpetuarla
con una vittoria capitalista che avrebbe portato alla permanente soggezione dei
lavoratori. Il nazionalsocialismo è soltanto la varietà locale tedesca del
fascismo.
Il fascismo potrebbe meglio definirsi come un socialismo capitalista: un
ordinamento in cui il sistema socialista sia stato rovesciato, al fine di
connetterlo con un altro primo motore, cioè col desiderio dei capitalisti di
rimanere tali. Allo scopo di soddisfare questo desiderio essi erano felici di
farsi ricattare dal governo fascista al di là di ogni tassazione e controllo
che mai fosse stato escogitato da governo parlamentare. Nel socialismo il
movente primo era il desiderio del benessere sociale ed economico dell’intera
nazione. Paragonati ad esso, lo scopo e la forza del fascismo non erano
rispettabili, e dovevano essere mascherati. Essi erano perciò celati sotto una
coltre di odio e di gelosia internazionale.
Di fatto il fascismo non era compatibile con l’odio internazionale. Non si
basava sull'idea di nazione, ma su quello di classe e se fosso stato onesto,
esso avrebbe risposto al “Manifesto dei comunisti” con il grido:
“Capitalisti di tutto il mondo unitevi!”
Ma il fascismo non era capace di onestà. Essenzialmente un tentativo di
combattere il socialismo con le sue stesse armi, esso fu sempre incoerente con
se stesso. Ci fu un tempo un noto e intelligente filosofo che fu convertito al
fascismo. Come filosofo quella fu la sua fine. Nessuno poteva abbracciare un
credo così fondamentalmente sballato e rimaner capace di pensare chiaramente. I
grandi esponenti del fascismo sono degli specialisti nel destare le passioni
della massa; i suoi appartenenti minori, degli opportunisti e dei maneggioni.
Sapendo tutto questo e pensando che, nonostante qualche influenza corruttrice,
la vera tradizione democratica esisteva ancora nel mio paese, respinsi il
socialismo perché il sistema parlamentare funzionava ancora abbastanza bene
nell'assolvere la sua funzione di antisettico contro la guerra di classe;
respinsi il fascismo come una incoerente caricatura delle peggiori
caratteristiche del socialismo e rimasi fedele alla tradizione democratica.
“Fu l’ulcera spagnola” - disse Napoleone – “a distruggermi”. Avevo
viaggiato per gran parte della Spagna nel 1930 e nel l931, e nel secondo anno
avevo visto in atto un po’ dovunque dei movimenti rivoluzionari. Essi erano
condotti nel modo più ordinato. I miei amici ed io non vedemmo mai un solo atto
di violenza, né mai ne sentimmo parlare od avemmo la prova che tali atti
fossero avvenuti. In una città osservammo quello che noi prendemmo per una
festa religiosa, in cui dei fanciulli vestiti di bianco cantavano, mentre gli
adulti stavano a guardare con interesse e rispetto, e perfettamente calmi. Più
tardi, in una osteria dove la radio ritrasmetteva il vespro dalla cattedrale di
Canterbury, chiedemmo a quelli che ci erano vicini di che festa si trattasse:
“Festa? - risposero - era la rivoluzione!”
I nostri amici solevano scrivere dall'Inghilterra esprimendo timori per la
nostra incolumità in mezzo alle atrocità dalle quali - così i giornali
dicevano loro – era accompagnata la rivoluzione; alla mercé dei
“comunisti” sitibondi di sangue nella loro guerra contro la religione. Ma
non c’erano atrocità né si vedeva o si sentiva parlare di “comunisti”.
Erano soltanto uomini di mentalità democratica, al lavoro per stabilire un
governo parlamentare; nessuna guerra contro la religione, ma soltanto una decisa
eliminazione della potenza politica di capoccia ecclesiastici e militari, mentre
la Chiesa stessa, come si poteva vedere in ogni città, continuava indisturbata
le sue funzioni religiose, senza che il clero o gli edifici addetti al culto
fossero minimamente toccati.
Allora pensai che era proprio comico che i giornali inglesi fossero così male
informati su ciò che accadeva in Spagna. Non mi passò per la testa che fosse
possibile un'altra spiegazione. Non so quale sia quella giusta: o era una mera
coincidenza che questa epidemia di ignoranza preparasse la via alla politica con
la quale, più tardi, la maggior parte della stampa inglese (agendo, non si può
fare a meno di sospettarlo, su istruzione del governo) deliberatamente ingannò
i suoi lettori sul carattere della repubblica spagnola; o altrimenti quella
politica era già in atto, e quelle istruzioni presumibilmente erano già date
nel 1931.
Alcuni anni più tardi cominciò la guerra civile spagnola. Era una ribellione
dei papaveri militari deposti contro il regime democratico che li aveva
soppiantati: la ribellione dell'esercito di una nazione contro il popolo di una
nazione ed il suo governo legalmente costituito; legalmente costituito, cioè,
secondo le idee inglesi. Ogni inglese che avesse un po’ di fede nella
tradizione politica britannica, conoscendo la verità, avrebbe voluto aiutare il
governo spagnolo contro i ribelli. E si richiedeva un aiuto molto piccolo:
soltanto una situazione militare di parità. Se il governo avesse soltanto
potuto improvvisare ed equipaggiare un esercito, il destino dei ribelli sarebbe
stato segnato.
Il governo “nazionale” britannico impedì che questo avvenisse. Esso adottò
ed impose a certe altre nazioni una politica di “non intervento”, ciò che
voleva dire, proibire l’introduzione in Spagna di uomini che combattessero, e
di munizioni con cui combattere. Ora, se in un certo paese l'esercito è in
rivolta contro un governo disarmato che sta tentando di armarsi a propria
difesa, non ci vuole una grande perspicacia per vedere che un embargo contro
l'importazione di armi in quel paese è un atto di aiuto ai ribelli. In
Inghilterra la gente vedeva che il suo governo, sotto la maschera del “non
intervento” stava intervenendo, e molto energicamente, al fianco dei ribelli;
così, per tenerla tranquilla, ebbe inizio una campagna di stampa che ripeteva
le solite storie sul “comunismo” e sulle “atrocità” della cui falsità
alcuni anni prima io stesso potevo essere testimone. Ebbe successo. Persone che
credono nella tradizione politica inglese non amano i comunisti e non approvano
le atrocità. La simpatia per il governo spagnolo appassì sensibilmente. Non c'è
dubbio - si diceva - che é soltanto il nostro imbroglio del “non
intervento” a rendere possibile ai ribelli di far progressi contro il governo;
ma si voleva veramente la vittoria del governo? Ognuno sapeva che il capo dei
ribelli era un fantoccio dei dittatori italiano e tedesco e che questi, quali
fossero le loro dichiarazioni di “non intervento”, gli fornivano
costantemente uomini e munizioni. Ognuno sapeva che facendo così essi avevano
alterato la situazione strategica dal Mediterraneo, peggiorandola molto dal
punto di vista britannico. Ma se qualcuno faceva illusioni a questo argomento il
governo “nazionale” inglese rispondeva: “Fidatevi di noi, sappiamo quel
che facciamo. Vi abbiamo dato la pace”. Questo, ancora una volta, ebbe
successo. L'elettorato era pronto a passar sopra quasi ad ogni cosa, purché si
evitasse la guerra. Ma non diede alcuna prova, né allora né poi, che essa
fosse stata evitata. Non venne data alcuna prova che uno od entrambi i dittatori
imponessero al governo britannico, di adottare la politica del “non
intervento” con minacce di guerra. Non si diede alcuna prova che al loro
notorio rifiuto a mantener fede a quella politica siano state contrapposte
minacce della stessa natura. Non si diede alcuna prova che il governo britannico
avrebbe messo in pericolo la pace col solo astenersi da quelle azioni con cui,
legalmente o illegalmente, esso proibiva ai suoi cittadini di arruolarsi al
servizio del governo spagnolo.
Non si diede alcuna prova di tutto ciò; ed erano cose che certamente nessuno
avrebbe creduto a quel tempo, e nessuno crederà mai, senza prove a prove
conclusive che le dimostrino. Ma così densa era l'atmosfera di sotterfugio in
cui il governo “nazionale” da molti anni avvolgeva la sua politica (a
cominciare dalle vuote spacconate di Ramsey MacDonald che sembrava dir molto e
non disse mai nulla affatto; e continuando con i metodi dell’”uomo di
fiducia” di Baldwin, che parlava quasi esclusivamente per dire quale uomo
onesto egli fosse e quale completa fiducia tutti potessero quindi accordargli),
che nessuno si aspettava che i portavoce del governo neppure le dicessero queste
cose, altro che darne le prove! Non si disse nulla in modo chiaro, ma molto fu
lasciato capire.
Ma sebbene non si sia detto nulla, si fece molto. Mancando qualsiasi
enunciazione esplicita della sua politica da parte del governo “nazionale”,
mi trovai costretto a dedurne la politica dall’evidenza delle sue azioni.
Questo non era difficile. Per chi fosse abituato ad interpretare delle
testimonianze storiche, le cui azioni non ammettevano che una sola spiegazione.
Esso voleva la vittoria dei ribelli e intendeva celare questo fatto
all’elettorato. Sapeva che i ribelli non potevano vincere senza grave danno
agli interessi britannici, ed esso sacrificò quegli interessi.
Perché gli uomini al governo erano così solleciti per la vittoria dei ribelli?
Non a causa della “minaccia comunista”, poiché sebbene il mio vecchio
amico, il Daily Mail, sviscerato sostenitore del governo “nazionale”, ed ora
come sempre strenuo lavoratore nella causa della corruzione dell’opinione
pubblica, di solito facesse riferimento al governo spagnolo come “rosso”,
cioè comunista, il governo sapeva altrettanto bene del Daily Mail che la Spagna
repubblicana non era uno Stato comunista, ma una democrazia parlamentate e che
il gabinetto Negrin, ad es. conteneva un solo comunista dopo che il suo partito
aveva aderito alla generale dichiarazione di lealtà ai principi democratici. La
guerra civile spagnola fu una lotta tra dittatura fascista e democrazia
parlamentare. Il governo britannico, nonostante tutte le sue finte, si era
dichiarato partigiano della dittatura fascista.
Al principio del 1938, quando tutto ciò mi divenne chiaro, non formulai alcuna
opinione su questo: fino a che punto, cioè, i singoli membri di quel governo
sapessero quello che stavano facendo. Il fascismo, lo ripeto, è una cosa
confusa e contraddittoria. Trovai facile credere, che non c’era bisogno che la
politica del governo “nazionale” - di soggiacere codardamente alle potenze
fasciste e di rifiutarsi di dire al paese ciò che faceva - sgorgasse da una
chiara comprensione dei propri fini, unita a quella della sua detestabilità
agli occhi della nazione, e risultante in una cosciente decisione di ingannare
il paese. Poteva sorgere da stanchezza di volontà e debolezza di intelletto,
combinato con certe segrete ammirazioni e non certe non esaminate timidezze, con
un manchevole senso di responsabilità e con una debole e talvolta inoperante
stima della verità. Se qualcuno nel 1937, e persino nei primi mesi del 1938,
memore della risposta salace del Dr. Johnson al barcaiolo del Tamigi, avesse
detto al primo ministro: “Signore, il vostro governo, con la scusa di non
essere in grado di difendere gli interessi nazionali, sta conducendo una
rivoluzione fascista!” oso dire che il primo ministro avrebbe negato
l’accusa con tutta la sincerità che aveva.
Gli avvenimenti del 1938 non mi dissero nulla sul governo “nazionale”, che
io già non sapessi. Cominciai l’anno aspettandomi due avvenimenti: un urto
aperto tra il primo ministro ed i principi del governo parlamentare, ed un più
flagrante ripetere della formula spagnola in qualche altro posto: aggressione da
parte di uno Stato fascista fatta riuscire dall'appoggio del governo britannico
sotto la mascheratura di una paura della guerra artificialmente prodotta nel
popolo inglese da quello stesso governo.
La mia prima previsione si attuò al principio della estate, quando in aperta
sfida alle regole delle prerogative parlamentari, da parte dei membri del
gabinetto si fece un concertato tentativo di sopprimere la critica parlamentare
sulla ormai notoria inefficienza a portare a termine il programma di riarmo con
minacce di persecuzione in base all’Official Secrets Act contro il membro del
parlamento che aveva osato muovere critiche, Duncan Sandys.
La cosa fu con discrezione messa a tacere dai giornali governativi: ma chiunque
avesse accesso ai fatti sapeva che ciò significava guerra tra un gabinetto
fascista e la costituzione parlamentare del paese che esso governava.
La mia seconda previsione si avverò durante la crisi cecoslovacca in settembre,
quando il primo ministro britannico si recò in volo successivamente a
Berchtesgaden, Bad Godesberg e Monaco, ogni volta tornando con in tasca gli
ordini del dittatore tedesco per obbedire ai quali egli cambiò la politica del
paese alle spalle del parlamento e persino del gabinetto.
Per me quindi il tradimento alla Cecoslovacchia fu soltanto il terzo episodio di
quella stessa politica con cui il governo “nazionale” aveva tradito
l'Abissinia e la Spagna, e m’interessava meno il fatto in se stesso, quanto i
metodi con cui era ottenuta la paura della guerra, ben architettata su grande
scala nel paese, lanciata ufficialmente dalla simultanea distribuzione di
maschere antigas, dall'angosciosa trasmissione radio del primo ministro, due
giorni prima del suo viaggio aereo a Monaco e dalla scena isterica in
parlamento, architettata con cura nella notte seguente. Queste cose si
inserivano nella ormai stabilita tradizione dei metodi dittatoriali fascisti:
con la differenza che, mentre i dittatori italiano e tedesco dominavano le folle
facendo appello alla sete di gloria e all'espansione nazionale, il primo
ministro inglese faceva lo stesso giocando sul puro e semplice terrore.
Riuscì nel suo intento. Nel momento in cui scrivo, l’Inghilterra non ha
ancora ufficialmente detto addio alle sue istituzioni parlamentari: ha soltanto
permesso che esse divenissero inoperanti. Non ha rinunziato alla sua fede nella
libertà politica, ha soltanto buttato via ciò in cui essa ancora professa di
credere. Non ha liquidato il suo impero, ha soltanto consegnato il controllo
delle comunicazioni di quell’impero ad una potenza gelosa ed arida. Non ha
cessato di aver voce negli affari europei, ha soltanto usato la sua voce per
accrescere le pretese di un'altra potenza ancora più gelosa e più avida.
Questo non è stato fatto per volontà della nazione o di una parte
considerevole di essa, ma perché il paese è stato giocato.
Per richiamare ciò che ho detto più indietro, le forze che sono state al
lavoro per quasi mezzo secolo a corrompere la mente della nazione, producendo in
essa a poco a poco una remissività a trascurare quelle piene, pronte ed
accurate informazioni su cose di pubblica importanza che sono il nutrimento
indispensabile di una società democratica ed una disabitudine a prendere delle
decisioni su tali cose con quello spirito sociale che è la linfa vitale di una
società democratica, hanno allevato una generazione di uomini e donne inglesi
destinati ad essere le sciocche vittime di un politico che con tanto successo ha
fatto appello “alle loro passioni”, con promesse di privato guadagno (il
guadagno della sicurezza personale dagli orrori della guerra), che essi gli
hanno permesso di sacrificare gli interessi del paese, di buttar via il suo
prestigio e di oscurare il suo nome di fronte al mondo per permettergli di
guardare dalle fotografie con i ben noti occhi ipnotici del dittatore.
Non è il compito di questa autobiografia il chiedersi con quanta completezza il
paese sia stato di fatto ingannato, o per quanto tempo il presente grado di
inganno durerà.
Non sto scrivendo una relazione dei recenti avvenimenti inglesi: sto descrivendo
il modo in cui quegli eventi mi toccarono e ruppero la mia situazione di
distaccato pensatore di professione. So adesso che i piccoli filosofi della mia
giovinezza, per tutte quelle loro professioni di distacco “puramente
scientifico” dalle cose pratiche, erano i propagandisti del futuro fascismo.
So che il fascismo significa fine del pensiero chiaro e trionfo
dell’irrazionalismo. So di esser stato per tutta la vita impegnato, senza
averne coscienza, in una lotta politica, combattendo contro queste cose
nell’oscurità. D’ora innanzi combatterò alla luce del sole.
Robin
George Collingwood (1889-1943)
Sul
marxismo
54 – Del “Manifesto” (Antonio Labriola)
… La previsione storica, che
sta in fondo alla dottrina del Manifesto, e che il comunismo critico ha poi in
seguito ampliata e specificata con la più larga e più minuta analisi del mondo
presente, ebbe di certo, per circostanze del tempo in cui apparve la prima
volta, calore di battaglia, e colore vivissimo di espressione. Ma non implicava,
come non implica tuttora, né una data cronologica né la dipintura anticipata
di una configurazione sociale, come fu ed è proprio delle antiche e nuova
profezie e apocalissi. (…)
Qui, nella dottrina del comunismo critico, è la società tutta intera, che in
un momento del suo processo generale scopre la causa del suo fatale andare e, in
un punto saliente della sua curva, fa luce a se stessa per dichiarare la legge
del suo movimento. La previsione, che il Manifesto per la prima volta accennava,
era non cronologica, di preannunzio o di promessa; ma era, per dirla in una
parola - che a mio avviso esprime tutto e in breve - morfologica. (…)
Quando il Manifesto dichiarava, che tutta la storia fosse finora consistita
nelle lotte di classe, e che in queste fu la ragione di tutte le rivoluzioni,
come anche il motivo dei regressi, esso faceva due cose ad un tempo. Dava al
comunismo gli elementi di una nuova dottrina, e ai comunisti il filo conduttore
per ravvisare nelle intricate vicende della vita politica, le condizioni del
sottostante movimento economico.
Nei cinquanta anni corsi da allora in qua, la previsione generica di una nuova
era storica è diventata pei socialisti l’arte minuta dell’intendere caso
per caso quel che si convenga e sia dovere di fare; perché quell’era nuova è
per se stessa in continua formazione. Il comunismo è diventato un’arte, perché
i proletari sono diventati, o sono avviati a diventare, un partito politico. Lo
spirito rivoluzionario si plasma tuttodì nella organizzazione proletaria.
L'auspicata congiunzione dei comunisti e dei proletari è oramai un fatto.
Questi cinquant’anni furono la prova sempre crescente delle forze produttive
contro le forme della produzione.
Fuori di questa lezione intuitiva delle cose, noi non abbiamo da offrire altra
risposta, noi utopisti a quelli che parlano ancora di turbamenti meteorici che,
secondo l'opinione loro, torneranno tutti alla calma di questa insuperata ed
insuperabile epoca di civiltà. E tale lezione basta.
A undici anni di distanza dalla pubblicazione del Manifesto, Marx racchiudeva in
chiara e trasparente formula i principi direttivi della interpretazione
materialistica della storia; e ciò nella prefazione di un libro, che è il
prodromo del “Capitale”. Ecco riprodotto il brano:
“Il primo lavoro da me intrapreso, per risolvere i dubbi che mi assediavano,
fu quello di una revisione critica della “Filosofia del diritto” di Hegel;
del qual lavoro apparve la prefazione nei “Deutsch-Französische Jahrbücher”
pubblicati a Parigi nel 1844. La mia ricerca mise capo in questo risultato: che
i rapporti giuridici e le forme politiche dello Stato non possono intendersi né
per se stessi né per mezzo del così detto sviluppo generale dello spirito
umano; ma anzi hanno radice nei rapporti materiali della vita, il cui complesso
Hegel raccoglieva sotto il nome di società civile, secondo l'uso dei francesi
ed inglesi del secolo decimottavo; e che inoltre l'anatomia della società
civile è da ricercare nell'economia politica. Le ricerche intorno a questa,
dopo averle incominciate a Parigi, io le continuai a Bruxelles, dove ero
emigrato per l'ordine di sfratto avuto dal Signor Guizot. Il risultato generale
che ne ebbi e che, una volta ottenuto, mi valse come di filo conduttore dei miei
studi, può essere formulato come segue:
- Nella produzione sociale della loro vita gli uomini entrano fra loro in
rapporti determinati, necessari ed indipendenti dal loro arbitrio, cioè in
rapporti di produzione, i quali corrispondono a un determinato grado di sviluppo
delle materiali forze di produzione. L'insieme di tali rapporti costituisce la
struttura economica della società, ossia la base reale, sulla quale si eleva
una soprastruzione politica e giuridica, e alla quale corrispondono determinate
forme sociali della coscienza. La maniera della produzione della vita materiale
determina innanzi e soprattutto il processo sociale, politico e intellettuale
della vita. Non è la coscienza dell’uomo che determina il suo essere, ma è
all’incontro il suo essere sociale che determina la sua coscienza. A un
determinato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società
si trovano in contraddizione coi preesistenti rapporti della produzione (cioè
coi rapporti della proprietà, il che è l'equivalente giuridico di tale
espressione), dentro dei quali esse forze per l'innanzi s’erano mosse. Questi
rapporti della produzione, da forme di sviluppo delle forze produttive, si
convertono in loro impedimenti. E allora subentra un'epoca di rivoluzione
sociale. Col cangiare del fondamento economico si rivoluziona e precipita, più
o meno rapidamente, la soprastante colossale soprastruzione. Nella
considerazione di tali sommovimenti bisogna sempre distinguer bene tra la
rivoluzione materiale, che può essere naturalisticamente constatata per
rispetto alle condizioni economiche della produzione, e le forme giuridiche,
politiche, religiose, artistiche e filosofiche, ossia le forme ideologiche nelle
quali gli uomini acquistano coscienza del conflitto, e in cui nome lo compiono.
Come non può darsi giudizio di quello che un individuo è da ciò che egli
sembra a se stesso, così del pari non può valutarsi una determinata epoca
rivoluzionaria, dalla sua coscienza; anzi questa coscienza stessa deve essere
spiegata per mezzo delle contraddizioni della vita materiale, cioè per mezzo
del conflitto che sussiste tra forze sociali produttive e rapporti sociali della
produzione. Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate
tutte le forze produttive per le quali essa ha spazio sufficiente; e nuovi
rapporti di produzione non subentrano se prima le condizioni materiali di loro
esistenza non siano state covate nel seno della società che è in essere. Perciò
l'umanità non si propone se non quei problemi che essa può risolvere; perché
considerare le cose dappresso, si vede che i problemi non sorgono, se non quando
le condizioni materiali per la loro soluzione ci son già, e si trovano per lo
meno in atto di sviluppo. A guardar la cosa a grandi tratti, le forme di
produzione asiatica, antica, feudale e moderno-borghese possono considerarsi
come epoche progressive della formazione economica della società. I rapporti
borghesi della produzione sono l'ultima forma antagonistica del processo sociale
della produzione (antagonistica non nel senso dell'antagonismo individuale, anzi
di un antagonismo che sorge dalle condizioni sociali della vita degli
individui); ma le forze produttive che si sviluppano nel seno della società
borghese mettono già in essere le condizioni materiali per la risoluzione di
tale antagonismo. Con tale formazione di società cessa perciò la preistoria
del genere umano”.
Quando Marx così scriveva, da parecchi anni già egli era uscito dall’arena
politica, e non vi rientrò se non più tardi, ai tempi della Internazionale. La
reazione aveva battuto in Italia, in Austria, in Ungheria, in Germania la
rivoluzione, o patriottica, o liberale, o democratica. La borghesia, dal canto
suo, aveva battuto in pari tempo i proletari in Francia e in Inghilterra. Le
condizioni indispensabili allo sviluppo del movimento democratico e proletario
vennero d'un tratto a mancare. La schiera, non certo molto numerosa, dei
comunisti del Manifesto, che s'era mescolata alla rivoluzione, e poi dopo
partecipò a tutti gli atti di resistenza e di insurrezione popolare contro la
reazione, vide da ultimo troncata la sua attività col memorabile processo di
Colonia. I sopravvissuti del movimento tentarono di ricominciare a Londra; ma a
breve andare Marx e Engels ed altri volsero le spalle ai rivoluzionari di
professione, e si ritrassero dall'azione prossima. La crisi era passata. Una
lunga pausa sopraggiungeva. Ne era indizio la lenta sparizione del movimento
cartista, ossia del movimento proletario del paese che è la colonna vertebrale
del sistema capitalistico. La storia aveva per il momento dato torto alla
illusione dei rivoluzionari.
Prima di dedicarsi quasi esclusivamente alla prolungata incubazione degli
elementi già da lui trovati dalla critica dell'economia politica, Marx illustrò
in vari scritti di storia del periodo rivoluzionario, del 1848-50, e specie le
lotte di classe in Francia, documentando così, che se la rivoluzione, nelle
forme che essa aveva per il momento assunte, era fallita, non rimaneva perciò
solo smentita la teoria rivoluzionaria della storia. La traccia, appena indicata
nel Manifesto veniva già a metter capo nella esposizione piena. (…) Ma in
questi fatti particolari c’è una significazione più lata, e di maggior peso
per noi. Il comunismo critico non fabbrica le rivoluzioni, non prepara le
insurrezioni, non arma la sommosse.
È sì, tutt'una cosa col movimento proletario; ma vede e sorregge questo
movimento nella piena intelligenza della connessione che esso ha o può e deve
avere con l’insieme di tutti i rapporti della vita sociale. Non è più
insomma un seminario in cui si formi lo stato maggiore dei capitani della
rivoluzione; ma è solo la coscienza di tale rivoluzione e, soprattutto, in
certe contingenze, la coscienza delle sue difficoltà.
Il movimento proletario è venuto crescendo in modo colossale in questi ultimi
trent'anni. Attraverso a molte difficoltà e con molte vicende di passi indietro
e di passi in avanti, esso ha via via assunto forme politiche, con metodi a
grado a grado escogitati e lentamente provati. I comunisti non hanno evocato
tutto ciò con l'azione magica della dottrina, sparsa e comunicata con la virtù
persuasiva dalla parola e dallo scritto. Fin dal principio seppero di essere
l'estrema ala sinistra del movimento proletario; ma, a misura che questo si
sviluppava e specificava, era necessità e dovere ad un tempo per loro, di
secondare, nei programmi e nell'azione pratica dei partiti le varie contingenze
dello sviluppo economico, e della conseguente attuazione politica.
In questi cinquant'anni dalla pubblicazione del Manifesto in qua, le
specificazioni e le complicazioni del movimento proletario son divenute tali e
tante, che non è oramai mente che tutte le abbracci, e penetri, e intenda, e
spieghi nelle loro vere cause e relazioni. L’Internazionale unitaria durata
nel periodo di tempo del l864-73, assolto che ebbe l’ufficio suo, che fu
quello del pareggiamento preliminare nelle generali tendenze e nelle idee comuni
e indispensabili a tutto il proletariato, dovette sparire; né altri penserà, o
potrà mai pensare, di rifar nulla che le assomigli.
Due cause, fra le altre, hanno fortemente contribuito a questa vasta
specificazione e complicazione del movimento proletario. La borghesia ha sentito
in molti paesi il bisogno di limitare, a propria difesa, molti degli abusi che
seguirono alla prima e subitanea introduzione del sistema industriale; e di qui
nacque la legislazione operaia, o come altri pomposamente dice, sociale. La
stessa borghesia o a propria difesa, o sotto la pressione delle circostanze, ha
dovuto in molti paesi allargare, le generiche condizioni della libertà, e
specie estendere il diritto di suffragio. Per queste due circostanze, che ha
tratto il proletariato entro la cerchia della vita politica di tutti i giorni,
la sua capacità di movimento è grandemente cresciuta; e l’agilità e
pieghevolezza maggiore, di cui esso ora è fornito gli permettono di contendere
con la borghesia nell’arena dei comizi e nelle aule parlamentari. E come dal
processo delle cose viene il processo delle idee, così a questo multiforme
sviluppo pratico del proletariato, che è tanto vario di forme e d'intrecci che
nessuno può più vederselo innanzi agli occhi e ripensarlo tutto, ha
corrisposto un graduale sviluppo delle dottrine del comunismo critico
nell'intendere la storia e nell'intendere la vita presente, fino alla minuta
descrizione delle più piccole parti dell’economia: esso, insomma, è
diventato una scienza, se tal nome vuol essere inteso con la debita discrezione.
(...)
Qualunque concessione la borghesia faccia nell’ordine economico, fino alla
massima riduzione delle ore di lavoro, rimane sempre vero il fatto, che la
necessità dello sfruttamento, su cui poggia tutto l'ordine sociale presente, ha
limiti insormontabili, oltre dei quali il capitale come privato istrumento di
produzione non ha più la sua ragion d'essere. Se una determinata concessione può
oggi sedare una immediata forma di inquietezza nel proletariato, la concessione
stessa non può a meno di destare il desiderio di altre e nuove, e sempre
crescenti. Il bisogno della legislazione operaia, nato in Inghilterra in
anticipazione del movimento cartista e sviluppatosi poi con esso, ottenne i suoi
primi successi nel periodo di tempo immediatamente posteriore alla caduta del
Cartismo stesso. I principi e le ragioni di tale movimento furono,
nell'intrinseco delle cause e degli effetti, studiati criticamente da Marx nel
“Capitale” e poi passarono attraverso la “Internazionale” nel programma
dei partiti socialisti. Ed ecco che da ultimo tutto cotesto processo,
concentrandosi nella domanda delle otto ore, è diventato nella festa del I
maggio una rassegna internazionale del proletariato, e un modo di raccoglier gli
indici dei progressi di esso. D'altra parte, la giostra politica cui il
proletariato s'avvezza, ne democratizza le abitudini, anzi ne fa una vera
democrazia; la quale a lungo andare non potrà più adagiarsi nella presente
forma politica che, come organo della società dello sfruttamento, è una
gerarchia burocratica, una burocrazia giudicante, una associazione di mutuo
soccorso fra i capitalisti, ed è il militarismo a difesa dei dazi protettori,
della rendita perpetua del debito pubblico, della rendita della terra, e così
via dell’interesse del capitale in ogni altra sua forma. I due fatti, adunque,
che hanno apparenza, secondo l’opinione dei furenti e degli ipercritici, di
sviare in infinito le previsioni del comunismo, si convertono invece in nuovi
mezzi e condizioni che quelle previsioni confermano. Gli apparenti deviatori
della rivoluzione si convertono, insomma, in suoi moventi. (…)
Né il Manifesto volle esser altro e di meglio, se non il primo filo conduttore
di una scienza e di una pratica, che la sua esperienza e gli anni poteano e
doveano sviluppare. Ciò che esso reca intorno al generale andamento del moto
proletario concerne, dirò così, il solo schema e il solo ritmo. In ciò si
riflette, senza dubbio, la impressione che produceva allora su i comunisti la
esperienza dei due movimenti, che appunto cadevano sott'occhi; quello di
Francia, cioè, e soprattutto il Cartismo, a breve andare fu colto da paralisi
per la non accaduta manifestazione insurrezionale del 1848. Ma in tale schema
non è nulla d'idealizzato, che poi si converta in tassativa tattica di guerra;
come più volte era di fatti accaduto, che i rivoluzionari riducessero in
anticipato catechismo ciò che non può essere se non un semplice portato dello
sviluppo delle cose.
Quello schema è diventato poi più vasto e più complesso, grazie
all'allargarsi del sistema borghese, che tanta più parte di mondo ha investito
e comprende. Il ritmo del movimento è diventato più vario e più lento,
appunto perché la massa operaia è entrata su la scena, come vero e proprio
partito politico; il che, cambiando i modi e le scadenze dell'azione, ne cambia
le movenze.
Come, innanzi al perfezionamento delle armi e degli altri mezzi di difesa, la
tattica delle sommosse è apparsa inopportuna; come la complicazione dello stato
moderno fa apparire insufficiente la improvvisata occupazione di un Hotel de
Ville, per imporre ad un intero popolo il volere e le idee di una minoranza, sia
pur essa coraggiosa e progressiva: così dal canto suo la massa proletaria non
istà più alla parola d'ordine di pochi capi, né regola le sue mosse su le
prescrizioni di capitani che possono, se mai, su le rovine di un governo di
classe o di consorteria, crearne un altro dello stesso genere. La massa
proletaria, là dove essa si è svolta politicamente, ha fatto e fa la sua
propria educazione democratica. Cioè elegge e discute i suoi rappresentanti e
fa sue, esaminandole, le idee e le proposte che quelli per anticipazione di
studio o di scienza abbiano intuito o presagito; e sa già, o comincia almeno ad
intendere, secondo i vari paesi, che la conquista del potere politico non deve né
può esser fatta da altri in nome suo, sia pure da gruppi coraggiosi
antesignani, e che soprattutto quella conquista non può riuscire con un colpo
di mano. Essa, la massa proletaria, insomma, o sa o s’avvia ad intendere, che
la dittatura del proletariato, la quale dovrà preparare la socializzazione dei
mezzi di produzione, non può procedere da una sommossa di una turba guidata da
alcuni ma deve essere e sarà il risultato dei proletari stessi che siano, già
in sé, e per lungo esercizio una organizzazione politica.
Lo sviluppo e l'estensione del sistema borghese furono rapidi e colossali in
questi cinquant'anni. Oramai esso corrode la vecchia e santa Russia e crea, non
che nell'America e nell'Australia, e nell’India, ma perfino nel Giappone,
nuovi centri di produzione moderna, complicando le condizioni della concorrenza,
e gli intrecci del mercato mondiale. Gli effetti delle mutazioni politiche, o
non mancarono, o non si faranno lungamente aspettare. Egualmente rapidi e
colossali furono i progressi del proletariato. La sua educazione politica segna
ogni giorno un nuovo passo verso la conquista del potere politico. La ribellione
delle forze produttive contro la forma della produzione, ossia la lotta del
lavoro vivo contro il lavoro accumulato, si fa ogni giorno più palese. Il
sistema borghese è oramai su le difese, e rivela lo stato e la posizione sua in
questa singolare contraddizione che, cioè, il pacifico mondo della industria è
diventato un immane accampamento, entro del quale vegeta il militarismo. L'epoca
dell'industria pacifica è diventata, per l'ironia delle cose, l'epoca del
continuo ritrovamento di nuovi e più potenti mezzi di guerra e di distruzione.
Il socialismo s'è imposto. Perfino i semisocialisti, perfino i ciarlatani che
ingombrano di sé la stampa e le assemblee dei nostri partiti, non sempre senza
imbarazzo nostro, sono un omaggio che le vanità e le ambizioni di ogni maniera
rendono a modo loro alla nuova potenza che sorge all'orizzonte.
Malgrado il divieto anticipato del socialismo scientifico, che è dato a tutti
di intendere, pullulano e si moltiplicano ogni istante i farmacisti della
“questione sociale”, che han tutti qualcosa di particolare da suggerire o da
proporre, per curare od eliminare questo e quel malanno sociale;
nazionalizzazione del suolo, monopolio dei grani da parte dello Stato,
statizzazione delle ipoteche, municipalizzazione dei mezzi di trasporto, finanza
democratica, sciopero generale; e così via, da non finirla mai!
Ma la “democrazia sociale” elimina tutte coteste fantasie, perché l'istinto
della propria situazione induce i proletari, appena si addestrino nell'arena
politica, ad intendere il socialismo in modo integrale. A intendere, cioè, che
ad una cosa sola essi devono soprattutto mirare: all'abolizione del salariato;
che una sola forma di società è quella che rende possibile, e anzi necessaria,
la eliminazione delle classi; e cioè l'associazione che non produce merci; e
che tal forma di società non è più lo “Stato”, anzi è il suo opposto,
ossia il reggimento tecnico e pedagogico della convivenza umana, il
“self-governement” del lavoro. Non più giacobini, né quelli eroicamente
giganti del 1793 né quelli in caricatura del 1848! (...)
Dopo tale scorsa nel campo del socialismo contemporaneo, si torna volentieri col
pensiero e con l'animo al ricordo di quei primi precursori nostri di cinquanta
anni fa, i quali documentarono nel Manifesto la presa di possesso di un posto
avanzato sulla via del progresso. Né ciò è da intendere segnatamente ed
esclusivamente per rispetto ai soli teorici della schiera; cioè per Marx ed
Engels.
L’uno e l'altro avrebbero esercitato in ogni caso e sempre, o dalla cattedra,
o dalla tribuna, o con gli scritti, una non piccola influenza su la politica e
su la scienza, tale e tanta era in loro la potenza e la originalità
dell’ingegno e la estensione delle conoscenze, quando anche non si fossero i
battuti mai sul cammino della vita nella “Lega dei Comunisti”.
Ma intendo dire di quegli uomini, che nel gergo vano e orgoglioso della
letteratura borghese sarebbero detti oscuri, - di quel calzolaio Bauer, di quei
sarti Lessner ed Eccarius, di quell'orologiaio Moll, di quel Lochner, o come
altro si chiamino quei che primi iniziarono consapevolmente il nostro movimento.
Sta come indice della loro apparizione il motto: “Proletari di tutto il mondo,
unitevi”. Sta come risultato dell'opera loro: “Il passaggio del socialismo
dall'utopia alla scienza”. La sopravvivenza dell’istinto loro e del loro
primitivo impulso nell’opera nostra dell’oggi, è il titolo indimenticabile,
che quei precursori si acquistarono alla gratitudine di tutti i socialisti.
(...)
Antonio Labriola - 1895 (1843-1904)
55
- Del materialismo storico (Antonio
Labriola)
In questo genere di considerazioni, come in tanti
altri, ma in questo più che ogni altro, è di non piccolo impedimento, anzi
torna di fastidioso impaccio, quel vizio delle menti addottrinate coi soli mezzi
letterari della cultura, che di solito dicesi “verbalismo”. Si insinua e si
espande in ogni campo di conoscenza cotesto mal vezzo; ma nelle trattazioni che
si riferiscono al così detto mondo morale, ossia al complesso storico-sociale,
cade assai di sovente che il culto e l'impero delle parole riescano a corrodervi
e a spegnervi il senso vivo e reale delle cose.
Là dove la prolungata osservazione, il reiterato esperimento, il sicuro
maneggio di raffinati istrumenti, l'applicazione totale o almeno parziale del
calcolo, finiron per metter la mente in una metodica relazione con le cose e con
le variazioni loro, come è il caso delle scienze naturali propriamente dette,
ivi il mito ed il culto delle parole rimasero oramai superati e vinti, ed ivi le
questioni terminologiche non hanno in fin delle fini se non il valore
subordinato di una mera convenzione. Nello studio, invece, dei rapporti e delle
vicende umane, le passioni e gli interessi e i pregiudizi di scuola, di setta,
di classe, di religione, e poi l'abuso letterario dei mezzi tradizionali della
rappresentazione del pensiero, e poi la “scolastica” non mai vinta e anzi
sempre rinascente, o fanno velo alle cose effettuali, o inavvertitamente le
trasformano in termini, e parole, e modi di dire astratti e convenzionali.
Di tali difficoltà bisogna che innanzi tutto si renda conto chi mette fuori in
pubblico la espressione, o formula, di “concezione materialistica” della
storia. A molti è parso, pare e parrà sia ovvio e comodo il ritrarne il senso
dalla semplice analisi delle parole che la compongono, anziché dal contesto di
una esposizione, o dallo studio genetico del come la dottrina si è prodotta, o
dalla polemica con la quale i sostenitori suoi ribattono le obiezioni degli
avversari.
Il verbalismo tende sempre a rinchiudersi in definizioni puramente formali;
porta le menti nell’errore, che sia cosa facile il ridurre in termini e in
espressioni semplici e palpabili l'intricato ad immane complesso della natura e
della storia; e induce nella credenza che sia cosa agevole il vedersi sott'occhi
il multiforme e complicatissimo intreccio delle cause e degli effetti, come in
ispettacolo da teatrino; o, a dirla in modo più spiccio, esso oblitera il senso
dei problemi, perché non vede che denominazioni.
Se si dà poi il caso, che il verbalismo trovi sostegno in tali o tali altre
supposizioni teoretiche, come sarebbe questa, che materia voglia dire un qualche
cosa che sta di sotto o di contro ad un’altra cosa più alta, o più nobile
che vien chiamata lo spirito; o se si dà il caso che esso confonda con
l’abito letterario di contrapporre la parola materialismo, intesa in senso
dispregiativo, a tutto ciò che compendiosamente chiamasi idealismo, cioè
all’insieme d’ogni inclinazione e d’ogni atto antiegoistico: e allora sì
che siamo spacciati. Ed ecco che si sente a dire: qui in questa dottrina si
tenta di spiegare tutto l’uomo col solo calcolo degli interessi materiali,
negando qualsiasi valore ed ogni interesse ideale.
A far nascere di tali confusioni non è valso poco la inesperienza, la incapacità
e la frettolosità di certi propugnatori e propagatori di questa dottrina; i
quali, per la premura di spiegare agli altri ciò che essi medesimi non
intendevano a pieno, mentre la dottrina stessa non è se non agli inizi suoi ed
ha ancora bisogno di molto sviluppo, si son data l'aria di applicarla, pur che
sia, al primo caso o fatto storico che loro capitasse fra le mani, e l’han
quasi ridotta in briciole, esponendola alla facile critica, ed al dileggio degli
orecchianti di novità scientifiche e di altrettali sfaccendati.
Per quanto è lecito qui, in queste prime pagine, di respingere solo
preliminarmente cotesti pregiudizi e di redarguire le intenzioni e le tendenze
che li sorreggono, occorre di ricordare: - che il senso di questa dottrina, va
innanzitutto desunto dalla posizione che essa assume ed occupa di fronte a
quelle contro le quali si è effettivamente levata, e segnatamente di fronte
alle ideologie di ogni maniera; - che la riprova del suo valore consiste
esclusivamente nella spiegazione più conveniente e congrua del succedersi delle
vicende umane, che da essa stessa deriva - che questa dottrina non implica una
preferenza soggettiva ad una certa qualità e somma d'interessi umani,
contrapposta ad altri interessi per lezione d’arbitrio, ma enuncia soltanto la
obiettiva coordinazione e subordinazione di tutti gli interessi nello sviluppo
di ogni società, ed enuncia ciò per via di quel processo genetico il quale
consiste nell’andare dalla condizioni ai condizionati, dagli elementi della
formazione alla cosa formata.
Almanacchino pure i verbalisti, a posta loro, sul valore dalla parola materia,
in quanto è segno o ricordo di metafisica escogitazione, o in quanto è
espressione dell’ultimo sostrato ipotetico della esperienza naturalistica, noi
non siamo nel campo della fisica, della chimica o della biologia; ma cerchiamo
soltanto le condizioni esplicite del vivere umano in quanto esso non è più
semplicemente, animale. Non si tratta già di indurre o di dedurre nulla dai
dati della biologia; ma, anzi, di riconoscere innanzi ad ogni altra cosa le
peculiarità del vivere umano, che si forma e si sviluppa per il succedersi e
perfezionarsi delle attività dell'uomo stesso, in date e variabili condizioni;
e di trovare i rapporti di coordinazione e di subordinazione dei bisogni che
sono il sostrato del volere, e dell'operare. Non è una intenzione che si cerchi
di scoprire, non è una valutazione di pregio che si voglia enunciare; ma è la
sola necessità di fatto che si vuol mettere in evidenza. E come gli uomini, non
per elezione, ma perché non potrebbero altrimenti, soddisfano prima certi
bisogni elementari e poi da questi ne sviluppano degli altri, raffinandosi; e, a
soddisfare i bisogni quali si siano, trovano ed usano certi mezzi ed istrumenti,
e si consociano in certi determinati modi, il materialismo della interpretazione
storica non è se non un tentativo di rifare nella mente, con metodo, la genesi
e la complicazione del vivere umano sviluppatosi attraverso i secoli. La novità
di tale dottrina non è difforme da quella di tutte le altre dottrine che, dopo
molte peripezie entro i campi della fantasia, son giunte da ultimo, assai
faticosamente ad afferrare la prosa della realtà ed a fermarsi in essa. (…)
Le idee non cascano dal cielo; né noi riceviamo il ben di dio in sogno.
La mutazione nei modi del pensiero, che da ultimo ha prodotta la dottrina
storica, della quale si fa qui l'esame e la esposizione preliminare, s'è venuta
svolgendo, prima con lentezza e poscia con cresciuta rapidità, appunto in
questo periodo del divenire umano, in cui si avverarono le grandi rivoluzioni
politico-economiche ossia in quest'epoca, che guardata nelle sue forme politiche
dicesi liberale, ma che guardata nel suo fondo - per effetto del dominio del
capitale su la massa proletaria - è l’epoca della produzione anarchica. La
mutazione nelle idee, fino alla creazione di nuovi metodi di concezione, è
venuta, passo passo riflettendo l’esperienza di una nuova vita. Come questa,
nelle rivoluzioni degli ultimi due secoli, si è andata via via spogliando degli
involucri mitici, mistici e religiosi, a misura, che è venuta acquistando la
coscienza pratica e precisa delle sue condizioni immediate e dirette, così il
pensiero - che questa vita riassume e teorizza – s’è alla sua volta
spogliato dei presupposti teologici e metafisici per racchiudersi, infine, in
questa prosaica, esigenza: nella interpretazione della storia occorre
restringersi alla coordinazione obiettiva delle condizioni determinanti e degli
effetti determinati. La concezione materialistica segna il culmine di questo
nuovo indirizzo nel ritrovamento delle leggi storico-sociali; in quanto non è
un caso particolare di una generica sociologia, o di una generica filosofia
dello stato di diritto e della storia, ma è il risolvente di tutti i dubbi e di
tutte le incertezze che accompagnano le altre forme di filosofare su le cose
umane, ed è l'inizio della interpretazione integrale di queste. (...)
Perché, in verità, i precursori effettivi della nuova dottrina furono i fatti
della storia moderna, che è diventata così perspicua e rivelatrice di se
stessa, da che si operò in Inghilterra la grande rivoluzione industriale della
fine del secolo scorso e in Francia avvenne quella gran dilacerazione sociale
che tutti sanno; le quali cose, “mutatis mutandis” si sono poi andate
riproducendo, in varia combinazione e in forme più miti, in tutto il mondo
civile. E che altro è, in fondo, il pensiero se non il cosciente e sistematico
completamento dell'esperienza; e che è questa, se non il riflesso e la
elaborazione mentale delle cose e dei processi che nascono e si svolgono o fuori
della volontà nostra, o per opera della nostra attività; e che altro è il
genio se non la individuata e conseguente ed acuita forma di quel pensiero, che
per suggestione della esperienza sorge in molti uomini della medesima epoca, ma
nella più parte di loro rimane frammentario, incompleto, incerto, oscillante e
parziale?
Le idee non cascano dal cielo, e anzi, come ogni altro prodotto dell'attività
umana, si formano in date circostanze, in tale precisa maturità di tempi, per
l'azione di determinati bisogni e per reiterati tentativi di dare a questa
soddisfazione, e col ritrovamento di tali o tali altri mezzi di prova, che sono
come gli istrumenti della produzione ed elaborazione loro. Anche le idee
suppongono un terreno di condizioni sociali ed hanno la loro tecnica: il
pensiero è anch’esso una forza di lavoro. Spostare quelle e questo, ossia le
idee e il pensiero, dalle condizioni e dall’ambito del loro proprio nascimento
e sviluppo, gli è svisarne la natura e il significato.
Mostrare come la concezione materialistica della storia fosse nata precisamente
in date condizioni e cioè non come personale e discutibile opinione di due
scrittori, ma come una nuova conquista del pensiero per la inevitabile
suggestione di un nuovo mondo che si sta già generando, ossia la rivoluzione
proletaria, questo fu l'assunto del mio primo saggio. Il che è quanto dire, che
una nuova situazione storica si è completata del suo congruo strumento mentale.
Ora, immaginare che cotesta produzione intellettuale potesse avverarsi in ogni
tempo e luogo, gli è come assumere a regola delle proprie ricerche l'assurdo.
Trasferire le idee a capriccio, dal terreno e dalle condizioni storiche in cui
sono nate, in qualunque altro terreno, ciò è come prendere a base del
ragionamento il semplice irrazionale.
La nostra dottrina suppone lo sviluppo ampio, chiaro, cosciente ed incalzante
della tecnica moderna; e con questa la società che produce le merci negli
antagonismi della concorrenza, la società che suppone come sua condizione
iniziale e come mezzo indispensabile al suo perpetuarsi, l'accumulazione
capitalistica nella forma della proprietà privata, la società che produce e
riproduce di continuo i proletari, e a reggersi ha bisogno di rivoluzionare
incessantemente i suoi strumenti, compreso lo stato e gli ingranaggi giuridici
di questo.
Questa società che, per leggi stesse del suo movimento, ha messa a nudo la sua
propria anatomia, produce di contraccolpo la concezione materialistica. Essa,
come ha prodotto nel socialismo la sua negazione positiva, così ha generato
nella nuova dottrina storica la sua negazione ideale. Se la storia è il
prodotto, non arbitrario, ma necessario e normale degli uomini in quanto si
sviluppano, e si sviluppano in quanto socialmente sperimentano, ed esperimentano
in quanto perfezionano e raffinano il lavoro, ed accumulano e serbano i prodotti
e risultati di questo, la fase di sviluppo in cui noi ora viviamo non può
essere l’ultima e definitiva, e i contrasti a questa intimi e inerenti sono le
forze produttive di nuove condizioni. Ed ecco come il periodo delle grandi
rivoluzioni economiche e politiche di questi due ultimi secoli ha maturato nelle
menti questi due concetti: l’immanenza e costanza del processo nei fatti
storici e la dottrina materialistica che in fondo è la teoria obiettiva delle
rivoluzioni sociali. (...)
Innanzi a questo genere di realistiche considerazioni, cadono tutte le ideologie
fondate su la missione etica dello Stato, o sopra qualunque altra frase simile.
Lo Stato è per così dire, messo al suo posto e rimane come inquadrato nei
contorni del divenire sociale, in quanto forma che è effetto di altre
condizioni e che a sua volta, poi che esiste, reagisce naturalmente sul resto.
E qui spunta un'altra questione.
Cotesta forma sarà superata mai? - ossia, ci può essere una società senza
Stato – ovvero, ci può essere una società senza classi? – e, se giova di
spiegarsi meglio ci sarà mai una forma di produzione comunistica, con tale
spartizione di lavoro e di uffici che non possa dar luogo allo sviluppo delle
disuguaglianze, da cui si genera il dominio dell’uomo su l’uomo?
Nella risposta affermativa a coteste domande consiste la somma del socialismo
scientifico; in quanto esso enuncia l'avvento della produzione comunistica, non
come postulato di critica, né come meta di una volontaria elezione, ma come il
risultato dell'immanente processo della storia.
Come è risaputo, la premessa di tale previsione è nelle condizioni stesse
della presente produzione capitalistica.
Questa socializza di continuo il modo di produrre e avvince sempre di più il
lavoro vivo e regolamentato alle condizioni obiettive della tecnica, concentra
di giorno in giorno sempre più la proprietà dei mezzi di produzione nelle mani
di pochi che come azionisti e negoziatori di azioni si trovano sempre più
assenti dal lavoro immediato, la cui direzione passa all’intelligenza.
Col crescere della coscienza di tale situazione nei proletari, cui
l'insegnamento della solidarietà viene dalle condizioni stesse della loro
reggimentazione, e col decrescere della capacità nei detentori di capitale a
conservare la privata direzione del lavoro produttivo, si verrà ad un punto in
cui, di un modo o dell'altro, con la eliminazione di ogni forma di rendita,
interesse e profitto privato, la produzione passerà all'associazione
collettiva, ossia sarà comunistica. Così cesseranno tutte le disuguaglianze
che non siano quelle naturali del sesso, dell’età, del temperamento e della
capacità; cesseranno, cioè, tutte le disuguaglianze che hanno attinenza alle
classi economiche e, anzi, da queste sono generate: e sparite le classi verrà
meno la possibilità dello Stato, come dominio dell’uomo su l’uomo. Il
governo tecnico e pedagogico dell'intelligenza sarebbe l'unico ordine della
società.
Per cotal via il socialismo scientifico, per ora idealmente almeno, ha superato
lo Stato; e superandolo lo ha inteso a fondo, così sul suo modo di origine,
come nelle ragioni di sua naturale sparizione. E lo ha inteso appunto perché
non gli si leva contro in modo unilaterale e soggettivo, come fecero il più
volte in altri tempi cinici, stoici, ed epicurei d'ogni maniera e poi settari
religiosi e cenobiti visionari e utopisti da conventicola e, da ultimo,
anarchisti d'ogni tinta e colore.
Anzi, più che levarglisi da sé contro, il socialismo scientifico ha mirato a
mostrare come lo Stato si sollevi di continuo da sé contro se stesso, creando
nei mezzi di cui non può fare a meno (p. es.: colossale finanza, militarismo,
suffragio universale, estensione della cultura, e così via), le condizioni
della sua propria rovina.
La società che lo ha prodotto lo riassorbirà: ossia, come la società, in
quanto forma di produzione, eliminerà le antitesi di capitale e lavoro; così,
con la sparizione dei proletari e cessando le condizioni che rendono possibile
il proletariato, sparirà ogni dipendenza dell’uomo dall’uomo, in qualunque
forma di gerarchia.
I termini entro i quali s’aggira la genesi e lo sviluppo dello Stato, dal suo
punto iniziale di apparizione entro una determinata comunità, in cui cominciò
la differenziazione economica fino a questo momento in cui la sua sparizione
principia a designarsi nella mente, ce lo rendono oramai comprensibile.
E per tale comprensibilità, che lo riduce a necessario complemento di
determinate forme economiche, la presunzione di considerarlo qual fattore
autonomo della storia, rimane eliminata per sempre.
Antonio Labriola - 1896
56 - Dai “Principi del comunismo” (1847 ?) (Friedrich Engels)
… 20) Quali saranno le
conseguenze della eliminazione finale della proprietà privata?
Anzitutto, per il fatto che la società sottrae dalle mani dei capitalisti
privati l'uso di tutte le forze produttive e di tutti i mezzi di scambio come
pure lo scambio e la distribuzione dei prodotti, e li amministra secondo un
piano risultante dai mezzi che si hanno a disposizione e dai bisogni della
società intera, vengono eliminate le cattive conseguenze che oggi sono ancora
connesse all'esercizio della grande industria. Le crisi scompaiono; la
produzione estesa, che per l'ordinamento attuale della società è
sovrapproduzione e causa tanto potente di miseria, non potrà, dopo la
rivoluzione raggiungere neppure la sufficienza, e dovrà essere ancora molto più
estesa. Invece di essere apportatrice di miseria, la sovrapproduzione garantirà,
ben più che il fabbisogno immediato della società, la soddisfazione dei
bisogni di tutti, e genererà nuovi bisogni e insieme i mezzi per soddisfarli.
Essa sarà condizione e occasione di nuovi progressi, ed attuerà questi
progressi senza che perciò - come è accaduto ogni volta fino ad ora -
l'ordinamento della società, sia messo in scompiglio. La grande industria,
liberata dalla pressione della proprietà privata, si svilupperà in dimensioni
di fronte alle quali il suo perfezionamento attuale apparirà meschino quanto
appare la manifattura nei confronti della grande industria dei nostri giorni.
Questo sviluppo dell'industria metterà a disposizione della società, una massa
di prodotti sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti.
Così anche l’agricoltura alla quale pure la pressione della proprietà
privata e del parcellamento impedisce di appropriarsi i miglioramenti già
compiuti e gli sviluppi scientifici, prenderà uno slancio assolutamente nuovo,
e metterà a disposizione della società una quantità di prodotti del tutto
sufficiente.
A questo modo la società darà prodotti sufficienti perché si possa
organizzare la distribuzione in modo che siano soddisfatti i bisogni di tutti i
suoi membri. Così diventa superflua, la divisione della società in differenti
classi contrapposte le une alle altre. E non solo superflua, ma addirittura
incompatibile con il nuovo ordinamento sociale. L'esistenza delle classi ha
origine nella divisione del lavoro, e nella nuova società la divisione del
lavoro del tipo che s'è avuta, finora, scomparirà totalmente.
Poiché per portare la produzione industriale ed agricola, all’altezza
suesposta, non bastano da soli gli ausili meccanici e chimici; debbono essere
sviluppate in misura corrispondente anche le capacità degli uomini che fanno
funzionare quegli ausili. Come i contadini e gli operai manifatturieri del
secolo passato hanno mutato tutto il loro tipo di vita e sono diventati essi
stessi uomini del tutto nuovi quando furono trascinati nella grande industria,
così l'esercizio comune della produzione da parte dell'intera società, e il
conseguente sviluppo nuovo della produzione, abbisognerà di uomini del tutto
nuovi e li genererà anche.
L’esercizio comune della produzione non può essere attuato da uomini come
quelli di oggi, ognuno dei quali è subordinato a un unico ramo della
produzione, incatenato ad esso, da esso sfruttato, ognuno dei quali ha
sviluppato una sola delle sue attitudini a spese di tutte le altre e conosce
soltanto un ramo di un ramo della produzione complessiva. Già l'industria
attuale ha sempre minor uso per tali uomini. L’industria esercitata in comune
e secondo un piano da tutta la società presuppone assolutamente uomini le cui
attitudini siano sviluppate in tutti i sensi e che siano in grado di abbracciare
tutto il sistema della produzione. La divisione del lavoro già ora minata dalle
macchine, la quale fa di uno un contadino, dell'altro un calzolaio, d'un terzo
un operaio di fabbrica, d'un quarto uno speculatore in borsa, scomparirà dunque
del tutto.
L'educazione potrà far seguire ai giovani rapidamente l’intero sistema della
produzione, li metterà in grado di passare a turno da uno all’altro ramo
della produzione, a seconda dei motivi offerti dai bisogni della società o
dalle loro proprie inclinazioni.
Toglierà ai giovani il carattere unilaterale impresso ad ogni individuo
dall'attuale divisione del lavoro. A questo modo la società organizzata
comunisticamente offrirà ai suoi membri l'occasione di applicare in tutti i
sensi le loro attitudini sviluppate in tutti i sensi. Ma con ciò scompaiono
necessariamente anche le differenti classi. Cosicché da una parte la società
organizzata comunisticamente è incompatibile con l'esistenza delle classi, e
dall’altra parte l'instaurazione di questa società offre essa stessa i mezzi
per abolire queste differenze tra le classi.
Risulta da ciò che scomparirà anche l’antagonismo fra città e campagna.
L'esercizio dell’agricoltura e dell'industria per opera degli stessi uomini,
invece che per opera di due classi differenti, è condizione necessaria
dell'associazione comunista già per cause del tutto materiali.
La dispersione della popolazione dedita all'agricoltura nelle campagne, accanto
al conglomeramento della popolazione industriale nelle grandi città, è una
situazione che corrisponde solo a uno stadio ancora poco sviluppato
dell’agricoltura e dell’industria, un ostacolo ad ogni ulteriore sviluppo
che è già ora molto sensibile.
L'associazione generale dei membri della società per lo sfruttamento comune e
pianificato delle forze produttive, l'estensione della produzione a un grado
tale che essa soddisferà i bisogni di tutti, la cessazione di una situazione
nella quale i bisogni dell’uno vengono soddisfatti a spese dell'altro, la
distruzione completa delle classi e dei loro antagonismi, lo sviluppo universale
della capacità di tutti i membri della società mediante l’eliminazione della
divisione del lavoro esistente finora, mediante l'educazione industriale,
mediante l’alternarsi delle attività, mediante la partecipazione di tutti ai
godimenti prodotti da tutti, mediante la fusione di città e campagna - ecco i
risultati principali dell'abolizione della proprietà privata.
21) Che influenza eserciterà l'ordinamento comunistico sulla famiglia?
L'ordinamento comunista della società farà del rapporto fra i due sessi un
semplice rapporto privato che riguarderà solo le persone che vi partecipano, e
nel quale la società non ha da ingerirsi. Potrà farlo perché elimina la
proprietà privata ed educa in comune i bambini, distruggendo così le due
fondamenta del matrimonio come si è avuto finora: la dipendenza della donna
dall'uomo e dei figli dai genitori dovuta alla proprietà privata.
Qui sta anche la risposta alle strida dei filistei moralisti contro la comunanza
“comunista” delle donne. La comunanza delle donne è una situazione legata
totalmente alla società borghese e che oggigiorno esiste in pieno nella
prostituzione, ma la prostituzione, poggia sulla proprietà privata e cade con
essa.
Dunque, l'organizzazione comunista, anziché introdurre la comunanza delle
donne, la abolisce invece.
Friedrich
Engels (1820-l895)
57
- Per la storia della “Lega dei Comunisti” (Friedrich
Engels)
Con la condanna dei comunisti di Colonia nel 1852
cala il sipario sul primo periodo del movimento autonomo degli operai tedeschi.
Oggi questo periodo è quasi dimenticato. Eppure esso durò dal 1836 al 1852,
grazie alla diffusione all'estero degli operai tedeschi si sviluppò in quasi
tutti i paesi civili. E non è tutto. In realtà l’odierno movimento operaio
internazionale è una continuazione diretta di quello tedesco di allora, che fu
il primo movimento operaio internazionale in generale e da cui uscirono molti
degli uomini che ebbero una parte direttiva, nell'Associazione Internazionale
degli operai. I principali teorici che la Lega dei Comunisti aveva scritto sulla
sua bandiera nel “Manifesto comunista” del 1847/48, formano oggi il più
forte legame internazionale di tutto il movimento proletario d'Europa e
d’America. (…)
Dell’associazione segreta democratica repubblicana dei Proscritti fondata a
Parigi nel 1834 da profughi tedeschi si separarono nel 1836 gli elementi
estremi, per lo più proletari, e fondarono la nuova Lega dei Giusti,
anch’essa segreta. L'associazione madre, in cui rimasero solo gli elementi più
neghittosi (...), presto si addormentò completamente. Quando la polizia nel
1840 riuscì a scoprirne alcune sezioni in Germania essa era quasi ridotta a
un’ombra. La nuova Lega invece si sviluppò con relativa rapidità.
Originariamente essa era la propaggine tedesca del comunismo operaio francese,
legato a reminiscenze babuvistiche, che si sviluppò in quello stesso tempo a
Parigi; la comunanza dei beni veniva reclamata come conseguenza necessaria
dell’eguaglianza. Gli scopi erano gli stessi delle società segrete esistenti
allora a Parigi. Si trattava di un’associazione per metà di propaganda, per
metà di cospirazione, e si considerava pur sempre Parigi come punto centrale
dell'azione rivoluzionaria, benché non si escludesse la preparazione di
eventuali colpi di mano in Germania.
Ma siccome Parigi restava il campo di battaglia decisivo, la Lega non era in
realtà molto più che la diramazione tedesca delle società segrete francesi,
specialmente della “Societé des saisons” diretta da Blanqui e Barbès, con
la quale esisteva un'intima connessione. I francesi insorsero il 12 maggio 1839;
le sezioni della Lega marciarono con loro e quindi furono coinvolte nella comune
disfatta.
Dei tedeschi furono arrestati, tra gli altri, Karl Schapper e Heinrich Bauer; il
governo di Luigi Filippo si accontentò di espellerli dopo una prigionia
piuttosto lunga. Entrambi si recarono a Londra. Schapper, nato a Weilburg nel
Nassau, mentre era studente di scienze forestali a Giessen nel 1832 era stato
affiliato alla congiura di Georg Büchner; il 3 aprile 1833 aveva partecipato
all’attacco al posto di polizia di Francoforte; riparato all’estero si unì
alla spedizione di Mazzini in Savoia nel 1834.
Di statura gigantesca, risoluto ed energico, sempre pronto a mettere a
repentaglio l'esistenza del pacifico borghese e la vita, egli era il modello del
rivoluzionario di professione che ebbe una certa funzione tra il 1830 e il 1840.
Pur non avendo una grande elasticità mentale, non era però accessibile a
migliori concezioni teoriche, come è sufficiente dimostrare la sua evoluzione
da “demagogo” a comunista, e tanto più tenacemente rimaneva attaccato alle
cose una volta apprese. Appunto per questo la sua passione rivoluzionaria era
spesso in contrasto con la sua ragione; ma in seguito egli comprendeva sempre il
suo errore e lo riconosceva apertamente. Era veramente un uomo e quanto egli ha
fatto per la fondazione del movimento operaio tedesco non sarà dimenticato.
Heinrich Bauer era un calzolaio della Franconia; un ometto vivace, sveglio,
spiritoso nel cui piccolo corpo si nascondevano però molta furberia e
risolutezza. Con l’arrivo di Bauer a Londra, dove Schapper - che a Parigi
aveva fatto il compositore tipografico - cercava di tirare avanti dando lezioni
di lingua, i due riannodarono le fila strappate della Lega e fecero di Londra il
centro di essa. Ad essa si unì, se pur non lo aveva già fatto prima a Parigi,
Joseph Moll, orologiaio di Colonia, un ercole di media statura: quante volte
egli e Schapper difesero gloriosamente l’entrata di una sala contro
l’attacco di centinaia di avversari! un uomo che, per lo meno uguale ai suoi
due compagni per energia e risolutezza, li superava però entrambi,
intellettualmente. Non solo era un diplomatico nato, come lo provarono i
successi delle sue numerose missioni; era anche più facilmente accessibile alle
concezioni teoriche. Li conobbi tutti e tre a Londra, nel 1843. Erano i primi
rivoluzionari proletari che vedevo; e per quanto allora le nostre vedute
divergessero nei particolari - perché al loro angusto comunismo egualitario io
contrapponevo una buona dose di altrettanto angusta altezzosità filosofica -
non dimenticherò mai la grande impressione che fecero su di ma questi tre
uomini veri, nel momento in cui io incominciavo soltanto a voler diventare un
uomo.
A Londra, come in minor misura nella Svizzera, la libertà di associazione e di
riunione tornò loro utile. Già il 7 febbraio 1840 venne apertamente fondata la
pubblica “Associazione educativa operaia tedesca”, che ancor oggi esiste.
Questa associazione servì alla Lega come base per l'arruolamento di nuovi
membri e poiché, come sempre, i comunisti erano i soci più attivi e più
intelligenti, fu ovvio che la direzione dell’Associazione fosse completamente
nelle mani della Lega. La Lega ebbe presto a Londra molte comunità o, come si
chiamavano ancora a quel tempo, “fucine”. La stessa, ovvia tattica fu
seguita in Svizzera e altrove. Dove si potevano fondare associazioni operaie,
esse venivano utilizzate allo stesso modo. Dove le leggi lo proibivano, si
entrava nelle società corali, nelle società ginnastiche, e così via. I
collegamenti venivano per lo più mantenuti a mezzo di continui viaggi dei
membri, i quali, in caso di bisogno, fungevano ancora da emissari. Sotto questi
due aspetti la Lega fu potentemente aiutata dalla saggezza dei governi, i quali
con l’espulsione trasformavano in un emissario ogni operaio indesiderabile, e
nove su dieci si trattava di un membro della Lega.
La diffusione della Lega ricostituita, fu notevole. Particolarmente nella
Svizzera, Weitling, August Becker (uomo di grande intelligenza, ma che si
perdette, come molti tedeschi, per mancanza di consistenza interiore), e altri
avevano formato una forte organizzazione, più o meno tendente al sistema
comunista di Weitling. Non è qui il luogo di criticare il comunismo di Weitling.
Per quanto riguarda però la sua importanza come primo movimento teorico
autonomo del proletariato tedesco, ancor oggi sottoscrivo le parole di Marx nel
Vorwärts parigino del 1844:
“Dove potrebbe la borghesia tedesca, compresi i suoi filosofi e i suoi
esegeti, mostrare - in rapporto all’emancipazione della borghesia, alla
emancipazione politica – un’opera simile alle ‘garanzie dell’armonia e
della libertà’, di Weitlig? Se si confronta l'arida e meschina mediocrità
della letteratura politica tedesca con questo grandioso e brillante esordio
degli operai tedeschi, se si confrontano queste gigantesche scarpe da bambino
del proletariato con le minuscole ciabatte politiche fruste della borghesia, si
è costretti a prevedere che questa cenerentola diventerà un atleta”.
Questo atleta sta ora davanti a noi, benché non abbia ancora raggiunto tutto il
suo sviluppo.
Anche in Germania per necessità di cose esistevano molte sezioni di carattere
precario; ma quelle che sorgevano erano più numerose di quelle che
scomparivano. Solo dopo sette anni, alla fine del 1846, la polizia scoprì a
Berlino (Mentel) e a Magdeburgo (Beck) tracce della Lega, senza essere in grado
di seguirle ulteriormente.
A Parigi Weitling, che vi si trovava ancora nel 1840, prima di passare in
Svizzera, aveva ugualmente riunito di nuovo gli elementi dispersi.
Il nucleo della Lega era formato dai sarti. Sarti tedeschi ve ne erano
dappertutto, in Svizzera, a Londra, a Parigi. In quest'ultima città, la lingua
tedesca era dominante nel ramo della sartoria, a tal punto che io conobbi nel
1846 a Parigi un sarto norvegese, venuto in Francia direttamente da Drontheim
per via mare, il quale in diciotto mesi non aveva imparato quasi nemmeno una
parola di francese, ma aveva imparato a perfezione il tedesco. Delle comunità
parigine della Lega del 1847 due erano composte in prevalenza di sarti, una di
stipettai.
Da quando il centro di gravità era stato spostato da Parigi a Londra, un altro
elemento venne a prendere rilievo: la Lega, da tedesca, divenne a poco a poco
internazionale. Nell’Associazione operaia si trovavano, oltre a tedeschi e
svizzeri, anche membri di tutte quelle nazionalità a cui la lingua tedesca
serviva principalmente come mezzo per intendersi con gli stranieri, in
particolare dunque scandinavi, olandesi, ungheresi, cechi, slavi del sud, e
anche russi e alsaziani. Nel 1847 tra gli altri frequentava regolarmente le
riunioni un granatiere inglese della guardia in uniforme. L'Associazione si
chiamò presto “Associazione educativa operaia comunista”, e sulle tessere
dei soci era scritto il motto: “Tutti gli uomini sono fratelli” per lo meno
in venti lingue, anche se qua e là non senza errori. Come l’associazione
pubblica, anche la Lega segreta assunse presto un carattere più internazionale;
sulle prime, però, solo in un senso limitato, praticamente per la diversa
nazionalità dei suoi membri, teoricamente per comprensione che ogni
rivoluzione, per essere vittoriosa, doveva essere europea. Non si andava più in
là, ma la base era posta.
Coi rivoluzionari francesi si manteneva uno stretto collegamento a mezzo dei
profughi londinesi, compagni di lotta del 12 maggio 1839. Lo stesso coi polacchi
più radicali. L’emigrazione ufficiale polacca, al pari di Mazzini, era
naturalmente più nemica che alleata. I cartisti inglesi, a causa del carattere
specificamente inglese del loro movimento, venivano lasciati in disparte come
non rivoluzionari. Solo più tardi, per mezzo mio, i dirigenti londinesi della
Lega entrarono in rapporto con essi.
Con lo sviluppo degli avvenimenti il carattere della Lega era cambiato anche
sotto altri aspetti. Benché si continuasse ancora - e allora con pieno diritto
- a considerare Parigi come la città madre della rivoluzione, ci si era però
emancipati dalla dipendenza dai congiurati parigini. La Lega, estendendosi, era
divenuta più consapevole delle proprie forze. Si aveva la sensazione di
radicarsi sempre più nella classe operaia tedesca, e che questi operai tedeschi
fossero storicamente chiamati a essere gli antesignani degli operai del
settentrione e dell'oriente europeo. Si aveva in Weitling un teorico comunista
che poteva arditamente porre a fianco dei suoi concorrenti francesi di allora.
Finalmente, l’esperienza del 12 maggio insegnava che di tentativi di colpi di
mano per il momento non era il caso di parlarne. E per quanto si continuasse a
interpretare ogni avvenimento come inizio dell'imminente tempesta, se in
sostanza si mantenevano in vigore i vecchi statuti semicospirativi, ciò era più
che altro una conseguenza della vecchia testardaggine rivoluzionaria, che già
incominciava a entrare in conflitto con una comprensione più giusta che si
andava affermando.
Invece la dottrina sociale della Lega, per quanto indeterminata, conteneva un
errore molto grave, derivante, del resto, dagli stessi rapporti sociali. I
membri, nella misura in cui erano operai, erano in realtà quasi esclusivamente
artigiani. L'uomo che li sfruttava era egli stesso anche nelle grandi metropoli,
soltanto un piccolo maestro artigiano. Perfino nella sartoria lo sfruttamento su
grande scala, quella che oggi si chiama industria dell'abbigliamento, basata
sulla trasformazione della sartoria artigiana in industria a domicilio per conto
di un grande capitalista, era allora agli inizi anche a Londra. Da un lato lo
sfruttatore di questi artigiani era un piccolo maestro, d'altro lato essi
stessi, speravano di diventare alla fine dei piccoli maestri artigiani. Inoltre
gli artigiani tedeschi di quel tempo erano ancora affetti da una quantità di
idee corporative tradizionali. Torna certamente a loro sommo onore il fatto che
- mentre non erano nemmeno ancora dei proletari nel senso vero e proprio della
parola, ma soltanto un’appendice della piccola borghesia in via di diventare
proletariato moderno e non ancora in conflitto diretto con la borghesia, cioè
col grande capitale - questi artigiani fossero in grado di anticipare
istintivamente la loro evoluzione futura e di costituirsi in partito del
proletariato, anche se non ancora con piena coscienza. Ma era anche inevitabile
che i vecchi pregiudizi artigianeschi fossero loro d’inciampo ad ogni istante,
ogni volta che si trattava di criticare la società moderna nei particolari, cioè
di analizzare fatti economici. E io non credo ci fosse in tutta la Lega un solo
membro che avesse mai letto un libro di economia. Ciò importava poco:
l’”eguaglianza”, la “fratellanza”, la “giustizia”, aiutavano per
il momento a scalare qualsiasi vetta teorica.
Frattanto si era formato accanto al comunismo della lega e di Weitling un
secondo comunismo, essenzialmente diverso. Vivendo a Manchester io avevo per così
dire toccato con mano che i fatti economici, che sino allora la storiografia
aveva disdegnati e tenuti in nessun conto sono, per lo meno nel mondo moderno,
una forza storica decisiva; che essi formano la base delle origini degli attuali
contrasti di classe; che questi contrasti di classe a loro volta, nei paesi dove
grazie alla grande industria si sono pienamente sviluppati, e quindi
specialmente in Inghilterra, formano la base della formazione dei partiti
politici, delle lotte dei partiti e quindi di tutta la storia politica. Marx non
soltanto era giunto alla stessa concezione, ma l’aveva già anche
generalizzata nei “Deutsch-Französische Jahrbücher” (1844), nel senso che
non lo Stato condiziona e regola la società civile, ma la società civile
condiziona e regola lo Stato, che dunque la politica e la sua storia devono
essere spiegate sulla base dei rapporti economici e del loro sviluppo, e non
vice versa. Quando nell'estate del 1844 feci visita a Marx a Parigi risultò che
concordavamo in tutti i campi della teoria, e da allora data il nostro lavoro
comune. Quando ci trovammo a Bruxelles nella primavera del 1845, Marx dalle
premesse suddette aveva già pienamente elaborata nelle sue linee fondamentali
la sua concezione materialistica della storia, e allora ci accingemmo a
sviluppare nei particolari e nelle direzioni più diverse questa nostra nuova
concezione.
Ma questa scoperta, che rivoluzionava la scienza storica e che, come si vede è
essenzialmente opera di Marx e di cui non posso attribuirmi che una parte
minima, era di una importanza immediata per il movimento operaio di quel tempo.
Il comunismo dei francesi e dei tedeschi, il cartismo degli inglesi, non
apparivano più come qualcosa di casuale, che avrebbe potuto anche non esistere.
Questi movimenti apparivano ora come un movimento della moderna classe operaia
oppressa, il proletariato, come forme più o meno sviluppate della lotta
storicamente necessaria di questa classe contro la classe dominante, la
borghesia; come forme della lotta di classe, ma diverse da tutte le precedenti
lotte di classe per il fatto che oggi la classe oppressa, il proletariato, non
può compiere la propria emancipazione senza emancipare in pari tempo tutta le
società dalla divisione in classi e quindi dalle lotte di classe. E comunismo
non voleva quindi più dire escogitazione a mezzo della fantasia, della società
ideale più perfetta possibile, ma comprensione della natura, delle condizioni e
dei conseguenti fini generali della lotta condotta dal proletariato.
Non pensavamo però affatto di sussurrare i nuovi risultati scientifici in
grossi volumi esclusivamente al mondo dei “dotti”. Al contrario. Entrambi
eravamo già profondamente impegnati nel movimento politico, avevamo qualche
seguito nel mondo intellettuale, specialmente della Germania occidentale, e ampi
contatti col proletariato organizzato. Eravamo obbligati a dare una
giustificazione scientifica della nostra concezione; ma altrettanto importante
era per noi conquistare alle nostre idee il proletariato europeo, e prima di
tutto il proletariato tedesco. Non appena chiarite a noi stessi le nostre idee
ci ponemmo al lavoro. Fondammo a Bruxelles un’”Associazione operaia
tedesca” e ci impadronimmo della “Deutsche Brüsseler Zeitung” in cui
avemmo un organo sino alla rivoluzione di febbraio. Con la parte rivoluzionaria
dei cartisti inglesi eravamo in contatto attraverso Julian Harney, direttore
dell'organo centrale del movimento, “The Northern Star”, di cui ero
collaboratore. Eravamo pure in una specie di blocco coi democratici di Bruxelles
(Marx era vicepresidente dell’Associazione democratica) e così coi
socialdemocratici francesi della “Réforme”, alla quale fornivo informazioni
sul movimento inglese e tedesco. In una parola, i nostri collegamenti con le
organizzazioni radicali e proletarie e con gli organi di stampa, erano del tutto
conformi ai nostri desideri.
I nostri rapporti con la Lega dei Giusti erano i seguenti. L'esistenza della
Lega ci era naturalmente nota; nel 1843 Schapper mi aveva offerto di entrarvi,
ma io naturalmente allora non ne avevo voluto sapere. Però non soltanto eravamo
rimasti in corrispondenza continua con gli elementi londinesi, ma in contatto
anche più stretto col Dr. Ewerbeck, attuale dirigente della comunità parigina.
Senza immischiarci negli affari interni della Lega, eravamo però informati di
tutto ciò che vi accadeva di importante. D’altra parte esercitavamo una
influenza orale, scritta e attraverso la stampa sulle concezioni teoriche dei più
importanti membri della Lega. A questo scopo ci servirono anche le diverse
circolari litografate, che mandavamo ai nostri amici e corrispondenti nel mondo
in occasione di avvenimenti riguardanti le cose interne del partito comunista
che si stava formando. In queste circolari si trattava talora della Lega stessa.
Così, per esempio, un giovane studente della Westfalia, Hermann Kriege,
recatosi in America, si era spacciato per emissario della Lega, si era associato
con lo squilibrato Harro Harring per sollevare l'America meridionale dai propri
cardini a mezzo della Lega, e aveva fondato un giornale in cui predicava a nome
della Lega un comunismo basato sull’“amore” sentimentaloide e svenevole.
Lo attaccammo duramente in una circolare che non mancò di avere la sua
influenza. Kriege sparì dalla scena della Lega.
Più tardi venne a Bruxelles Weitling. Ma egli non era più il giovane ingenuo
garzone sarto che, meravigliato delle proprie doti, cerca di rendersi ragione
del modo come potrebbe presentarsi una società comunista. Egli era il grand’uomo
perseguitato dagli invidiosi per la sua superiorità, che voleva dappertutto
rivali, nemici nascosti e trappole; il profeta cacciato di paese in paese, che
aveva in tasca la ricetta bella e pronta per realizzare il cielo in terra, e si
immaginava che ognuno volesse rubargliela. A Londra era già venuto in contrasto
con i membri della Lega, e anche a Bruxelles, dove Marx e sua moglie lo
trattarono con pazienza quasi sovrumana, non poté andar d’accordo con
nessuno. Perciò parti poco dopo per l'America, per tentarvi il mestiere del
profeta.
Tutte queste circostanze contribuirono alla rivoluzione che si compì
inavvertitamente nella Lega e specialmente tra i suoi dirigenti londinesi. La
insufficienza della concezione avuta sino allora del comunismo, tanto del
semplice comunismo elitario francese quanto di quello di Weitling, diventò loro
sempre più chiara. Il ricondurre il comunismo al cristianesimo primitivo, come
aveva fatto Weitling - per quanto nel suo “Vangelo di un povero peccatore”
possano trovarsi singoli passi geniali - aveva fatto sì che in Svizzera il
movimento cadesse nelle mani, prima di pazzi come Albrecht, poi di profeti
imbroglioni e truffatori come Kuhlmann. Il “vero socialismo” diffuso da
alcuni letterati, una traduzione in cattivo tedesco hegheliano di espressioni
socialiste francesi e l'umanitarismo sentimentale, che Kriege e la lettura degli
scritti relativi avevano introdotto nella Lega, dovevano presto nauseare per la
loro bavosa impotenza i vecchi rivoluzionari della Lega stessa. Di fronte
all'inconsistenza delle teorie sino allora diffuse, di fronte alle aberrazioni
pratiche che ne derivavano, si comprendeva sempre più a Londra che Marx e io e
le nostre nuove teorie avevamo ragione. Questa, convinzione venne senza dubbio
favorita dal fatto che ora tra i dirigenti londinesi si trovavano due uomini
notevolmente superiori agli altri per la loro capacità di conoscenza teorica:
il miniaturista Karl Pfänder di Heilbronn e il sarto Georg Eccarius della
Turingia.
Infine, nella primavera del 1847, Moll si recò da Marx a Bruxelles e subito
dopo venne da me a Parigi per invitarci con insistenza, a nome dei suoi
compagni, ad entrare nella Lega. Essi, ci disse, erano altrettanto convinti
della giustezza delle nostre idee in generale quanto della necessità di
liberare la Lega dalle vecchie tradizioni e forme cospirative. Se acconsentivamo
ad entrare ci sarebbe stata data la possibilità di esporre in un congresso
della Lega il nostro comunismo critico in un manifesto che poi sarebbe stato
pubblicato come manifesto della Lega stessa; egualmente avremmo potuto
contribuire da parte nostra a sostituire alla organizzazione invecchiata della
Lega una nuova organizzazione più corrispondente ai tempi e lo scopo.
Non dubitavamo che in seno alla classe operaia tedesca fosse necessaria una
organizzazione, magari solo a scopo di propaganda, e che questa organizzazione
per non essere puramente locale, dovesse di necessità mantenersi segreta, anche
fuori della Germania. Ma una simile organizzazione esisteva già, era la Lega.
Ciò che noi avevamo criticato fino allora nella Lega veniva ora abbandonato
come sbagliato dai suoi rappresentanti stessi, e noi medesimi eravamo chiamati a
collaborare alla sua riorganizzazione. Potevamo rifiutarci? No, certamente.
Entrammo quindi nella Lega. Marx formò a Bruxelles una comunità della Lega,
coi nostri amici più stretti, mentre io frequentavo le tre comunità parigine.
Nell’estate del 1847 ebbe luogo a Londra il primo congresso della Lega, nel
quale W. Wolff rappresentava le comunità di Bruxelles ed io quelle di Parigi.
In questo congresso ci si occupò anzitutto della riorganizzazione della Lega.
Ciò che ancora rimaneva dei vecchi nomi mistici del periodo cospirativo venne
soppresso. La Lega si organizzò in comunità, circoli, circoli dirigenti,
organi centrali e congresso e da allora venne chiamata Lega dei Comunisti.
“Lo scopo della Lega è l’abbattimento della borghesia, il dominio del
proletariato, la liquidazione della vecchia società borghese basata su
contrasti di classe, la fondazione di una nuova società senza classi e senza
proprietà privata”.
Così diceva il primo articolo degli statuti. L'organizzazione stessa era
assolutamente democratica, con dirigenti eletti sempre rimovibili, il che
bastava per sbarrare il passo a tutte le manie di cospirazione, cui è
necessaria la dittatura, e a trasformare la Lega - almeno nei tempi pacifici
ordinari - in una semplice organizzazione di propaganda. E si procedette in modo
così democratico che questi nuovi statuti vennero posti in discussione nelle
comunità, quindi esaminati ancora una volta nel secondo congresso e approvati
da esso definitivamente l’8 dicembre 1847. Essi sono pubblicati in Wermuth e
Stieber, I, pag. 239, appendice X.
Il secondo congresso ebbe luogo alla fine di novembre e inizio di dicembre dello
stesso anno. Ad esso fu presente anche Marx, che difese in lunghe discussioni
(il congresso durò almeno dieci giorni) la nuova teoria. Tutte le divergenze e
tutti i dubbi vennero infine eliminati; i nuovi principi vennero approvati
all’unanimità, e Marx ed io fummo incaricati di redigere il manifesto. Lo
facemmo immediatamente, e poche settimane prima della rivoluzione di febbraio,
il manifesto fu spedito a Londra per la stampa. Da allora esso ha fatto il giro
del mondo, è stato tradotto in quasi tutte le lingue e serve anche ora di guida
al movimento proletario nei più diversi paesi. Al posto del vecchio motto della
Lega “Tutti gli uomini sono fratelli”, subentrò il nuovo grido di
battaglia: “Proletari di tutto il mondo, unitevi” che proclamava apertamente
il carattere internazionale della lotta. Diciassette anni più tardi esso risuonò
per tutto il mondo come grido di lotta dell’Associazione Internazionale degli
operai e oggi il proletariato battagliero di tutti i paesi lo ha scritto sulla
propria bandiera.
Scoppiò la rivoluzione di febbraio. Immediatamente il Comitato centrale di
Londra trasmise i suoi poteri al circolo dirigente di Bruxelles. Ma questa
decisione sopraggiunse in un momento in cui a Bruxelles regnava di fatto lo
stato di assedio e specialmente i tedeschi non potevano più riunirsi da nessuna
parte. Noi eravamo appunto tutti in procinto di partire per Parigi, quindi il
nuovo Comitato Centrale decise di sciogliersi subito, di trasmettere tutti i
poteri a Marx e di autorizzarlo a costituire immediatamente a Parigi un nuovo
Comitato Centrale. Le cinque persone che avevano preso questa decisione (3 marzo
1848) si erano appena separate quando la polizia fece irruzione in casa di Marx,
lo arrestò e lo obbligò a partire il giorno seguente per la Francia, che era
il paese dove egli voleva per l’appunto recarsi.
Ci ritrovammo presto tutti insieme a Parigi. Ivi venne composto anche il
documento seguente che fu firmato dai membri del nuovo Comitato Centrale e
diffuso in tutta la Germania, e dal quale anche oggi molti possono imparare
qualche cosa.
Rivendicazioni del partito comunista in Germania
Tutta la Germania è proclamata repubblica una e indivisibile.
I rappresentanti del popolo saranno stipendiati, affinché anche l’operaio
possa sedere nel parlamento del popolo tedesco.
Armamento generale del popolo.
Le terre dei principi e le altre terre feudali, tutte le miniere, le cave, ecc.
vengono trasformate in proprietà dello Stato. In queste terre verrà
organizzata la coltivazione su grande scala e con i mezzi scientifici più
moderni nell’interesse della collettività.
Le ipoteche sui beni dei contadini vengono dichiarate proprietà dello Stato;
gli interessi per queste ipoteche verranno pagate dai contadini allo Stato.
Nelle regioni dove vige la conduzione d’affitto, il canone d’affitto o i
tributi agricoli verranno pagati allo Stato come imposte.
Tutti i mezzi di trasporto: ferrovie, canali, battelli a vapore, strade, poste,
ecc. sono presi in mano dallo Stato. Essi vengono trasformati in proprietà
dello Stato e posti a disposizione della classe non abbiente.
Limitazione del diritto di eredità.
Introduzione di imposte fortemente progressive e abolizione delle imposte di
consumo.
Istituzione di fabbriche nazionali. Lo Stato garantisce a tutti i lavoratori la
loro esistenza e provvede agli inabili al lavoro.
Istruzione popolare generale e gratuita.
È nell'interesse del proletariato tedesco, della piccola borghesia e dei
piccoli contadini di adoprarsi con tutta l’energia per ottenere la
realizzazione delle misure sopra indicate. Soltanto con la realizzazione di
esse, infatti, i milioni di uomini che oggi vengono sfruttati in Germania da una
piccola minoranza (e che si cercherà di mantenere ulteriormente oppressi),
potranno ottenere i loro diritti e quel potere che compete loro, quali
produttori di tutte le ricchezze.
Il
Comitato: K. Marx, K. Schapper, H. Bauer, F. Engels, J. Moll, W. Wolff.
A Parigi regnava allora la
mania delle legioni rivoluzionarie. Spagnoli, italiani, belgi, olandesi,
polacchi, tedeschi si raccoglievano in schiere destinate a liberar le loro
patrie rispettive. La legione tedesca era diretta da Herwegh, Bornstedt e
Bornstein. Poiché subito dopo la rivoluzione tutti gli operai stranieri non
erano soltanto disoccupati, ma anche trattati male dalla popolazione, queste
legioni trovarono numerose reclute. Il nuovo governo vide in esse un mezzo per
liberarsi degli operai stranieri e concesse loro l’”étape du soldat”, cioè
quartieri e soldo di mancia nella misura di cinquanta centesimi al giorno sino
alla frontiera, dove poi il ministro degli esteri, il pretore Lamartine, sempre
commosso fino alle lacrime, trovava il modo di consegnarli a tradimento ai loro
rispettivi governi.
Ci opponemmo nel modo più deciso a questi trastulli rivoluzionari, mentre la
Germania era in preda al fermento, organizzare un’invasione che avrebbe dovuto
importare la rivoluzione con la violenza dal di fuori significava porre un
intralcio allo sviluppo della rivoluzione nella Germania stessa, rafforzare i
governi, e quanto ai legionari, consegnarli senza difesa (di ciò era
mallevadore Lamartine), alle truppe tedesche. Quando poi la rivoluzione ebbe
vinto a Vienna e a Berlino, la legione più non aveva nessuno scopo, ma poiché
il gioco era incominciato, si volle giocarlo sino all’ultimo.
Noi fondammo un circolo comunista tedesco, in cui consigliavamo gli operai di
tenersi lontani dalla legione e di ritornare invece in patria individualmente,
per agirvi in favore del movimento. Il nostro vecchio amico Flocon, membro del
governo provvisorio, ottenne per gli operai inviati da noi le stesse
facilitazioni di viaggio che si davano ai legionari. In questo modo provvedemmo
a far ritornare in Germania tre o quattrocento operai, in grande maggioranza
membri della Lega.
Come facilmente si poteva prevedere, di fronte all'irrompente movimento delle
masse popolari la Lega risultò essere una leva troppo debole. Tre quarti dei
membri della Lega che prima abitavano all’estero, ritornando in patria avevano
cambiato il luogo della propria residenza; le comunità a cui avevano
appartenuto prima erano quindi per lo più disciolte, ogni contatto con la Lega
era andato per essi perduto. Una parte dei più ambiziosi non cercò nemmeno di
ristabilirlo, ma ognuno di essi incominciò a creare nella propria località un
piccolo movimento separato per conto proprio. E, infine, le condizioni di ogni
staterello, di ogni provincia, di ogni città erano così diverse, che la Lega
non sarebbe stata in grado di dare altro che direttive del tutto generali. Ma
queste era molto più facile diffonderle con la stampa. In una parola, dal
momento in cui cessarono le pause che avevano reso necessario che la Lega fosse
segreta, anche la Lega segreta cessò di avere come tale un’importanza
qualunque. Ma ciò meno di tutti gli altri poteva sorprendere coloro che poco
tempo prima si erano sforzati di togliere alla Lega segreta l’ultimo resto del
suo carattere cospirativo.
Si ebbe però ora la prova che la Lega era stata un’eccellente scuola di
attività rivoluzionaria. Sul Reno, dove la “Neue Rheinische Zeitung”
offriva un solido centro nel Nassau, nella Assia renana, ecc., dappertutto i
membri della Lega, erano a capo del movimento democratico estremo. Lo stesso ad
Amburgo. Nella Germania meridionale lo impediva il predominio della democrazia,
piccolo borghese. A Breslavia Wilhelm Wolff svolse la sua attività con grande
successo fino all’estate del 1848; egli ottenne anche un mandato della Slesia
come sostituto deputato al parlamento di Francoforte. A Berlino, infine, il
compositore tipografo Stephan Born, che era stato membro attivo della Lega a
Bruxelles e a Parigi, fondò una Fratellanza operaia che ebbe discreta
diffusione ed esistette sino al 1850. Born, giovane di molto talento, ma che
aveva troppa fretta di diventare un astro politico, “fraternizzava” con gli
elementi più disparati pur di raccogliere gente intorno a sé, e non era per
niente l’uomo che potesse portare l’unità, nelle opposte tendenze, la luce
nel caos. Perciò nelle pubblicazioni ufficiali della sua associazione le vedute
propagate nel “Manifesto comunista” si intrecciano e si confondono con
reminiscenze e aspirazioni corporative, avanzi di Louis Blanc e di Proudhon,
idee protezionistiche, ecc.; in breve, egli voleva essere tutto per tutti.
Specialmente ci si occupò di organizzare scioperi, associazioni di mestiere,
cooperative di produzione, dimenticando che si trattava anzitutto di
conquistarsi con vittorie politiche il terreno sul quale soltanto cose simili
potevano avere una esistenza durevole. Quando poi le vittorie della reazione
fecero sentire ai dirigenti della Fratellanza la necessità di entrare in modo
diretto nella lotta rivoluzionaria, essi vennero naturalmente lasciati in asso
dalla massa disorientata che avevano raccolto attorno a sé. Born partecipò
all’insurrezione di Dresda del maggio 1849 e ne scampò felicemente. Ma la
Fratellanza operaia, di fronte al grande movimento politico del proletariato,
aveva mantenuto la posizione di una società a parte, la quale aveva per lo più
una esistenza fittizia e una funzione tanto subordinata, che la reazione trovò
necessario sopprimerla solo nel 1850 e sopprimere le sue successive incarnazioni
solo diversi anni dopo. Born, il cui vero nome è Buttermilch, non diventò un
astro della politica, ma un piccolo professore svizzero, che non traduce più
Marx in linguaggio corporativo, ma il mite Renan nel suo proprio tedesco
dolciastro.
Col 13 giugno 1849 a Parigi - con la disfatta delle insurrezioni tedesche di
maggio e coll’abbattimento della rivoluzione ungherese da parte dei russi - si
chiuse un grande periodo della rivoluzione del 1848. Ma la vittoria della
reazione era ben lungi dall’esser definitiva. S'imponeva una nuova
organizzazione delle forze rivoluzionarie disperse, e quindi anche della Lega.
La situazione impediva nuovamente, come prima del 1848, ogni organizzazione
pubblica del proletariato; bisognava dunque, organizzarsi di nuovo segretamente.
Nell'autunno 1849 la maggior parte dei membri dei precedenti comitati centrali e
congressi si ritrovarono assieme a Londra. Mancava ormai soltanto Schapper
detenuto a Wiesbaden, ma che giunse egli pure dopo la sua assoluzione nella
primavera del 1850; e Moll, che dopo una serie di missioni e di viaggi di
agitazione dei più pericolosi - negli ultimi tempi aveva reclutato nella
provincia renana fra l’esercito prussiano dei cannonieri a cavallo per
l’artiglieria del Palatinato - era entrato nella compagnia operaia di Besançon
del corpo di Willich ed era stato ucciso da una fucilata alla testa nella
battaglia sulla Murg, davanti al ponte di Rotenfels. Invece entrò nella Lega
Willich. Willich era uno di quei comunisti sentimentali, così numerosi nella
Germania occidentale dopo il 1845, e quindi già per questo avversario
istintivo, inconsapevole del nostro indirizzo critico. Ma egli era qualcosa di
più, era un perfetto profeta, convinto della sua missione personale come
predestinato liberatore del proletariato tedesco, e come tale pretendente
diretto alla dittatura politica non meno che alla dittatura militare. Al
comunismo a base di cristianesimo primitivo predicato precedentemente da
Weitling si accompagnò dunque una specie di Islam comunistico. Ma la propaganda
di questa nuova religione rimane limitata in un primo tempo alle caserme di
profughi sottoposte al comando di Willich.
La Lega venne quindi riorganizzata, venne emanato l’indirizzo del marzo 1850
(…) e Heinrich Bauer venne inviato come emissario in Germania. L’indirizzo
redatto da Marx e da me ha ancor oggi interesse, perché la democrazia
piccolo-borghese è ancora oggi il partito che nel prossimo sconvolgimento
europeo, quasi imminente (i periodi di tempo che dividono l’una dall’altra
le rivoluzioni europee: 1815, 1830, 1848-52, 1870 si succedono nel nostro secolo
ad intervalli dai quindici ai diciotto anni), dovrà certamente andare al potere
in Germania per salvare la società dagli operai comunisti. Molto di quel che vi
è detto si adatta perciò anche ad oggi. La missione di Heinrich Bauer fu
coronata da un successo completo. Il piccolo e allegro calzolaio era un
diplomatico nato. Egli richiamò all’organizzazione attiva i vecchi membri
della Lega, in parte diventati inattivi, in parte operanti per conto proprio, e
tra l’altro anche gli attuali dirigenti della Fratellanza operaia. La Lega
incominciò ad avere nelle associazioni operaie, contadine e ginnastiche una
funzione dirigente in misura molto più grande che nel 1848, cosicché già il
successivo indirizzo trimestrale del giugno 1850 alle comunità poteva rilevare
che lo studente Schurz di Bonn (futuro ex ministro in America), il quale aveva
fatto un viaggio in Germania per conto della democrazia piccolo-borghese,
“aveva già trovato tutte le forze utilizzabili nelle mani della Lega”. La
Lega era indiscutibilmente l’unica organizzazione rivoluzionaria che avesse in
Germania qualche importanza.
Ma lo scopo cui doveva servire questa organizzazione dipendeva essenzialmente
dal fatto che si realizzassero le prospettive di un nuovo periodo ascendente
della rivoluzione. E la cosa divenne sempre più inverosimile, anzi impossibile,
nel corso del 1850. La crisi industriale del l847, che aveva preparato la
rivoluzione del 1848, era superata. Si era aperto un periodo di nuova inaudita
prosperità industriale. Per chi aveva occhi per vedere e ne faceva uso doveva
essere chiaro che l’ondata rivoluzionaria del 1848 si veniva a poco a poco
esaurendo.
“Data questa prosperità generale, in cui le forze produttive della società
borghese si sviluppano così rigogliosamente, nei limiti in cui in generale lo
consentano i rapporti borghesi, non si può pensare a una vera rivoluzione. Una
tale rivoluzione è possibile soltanto nei periodi in cui questi due fattori: le
forze produttive moderne e le forze di produzione borghesi, vengono fra loro in
contraddizione. Le diverse baruffe a cui si abbandonano e in cui si
compromettono reciprocamente le singole frazioni del partito dell’ordine sul
continente, ben lungi dall'offrire occasione a nuove rivoluzioni, sono al
contrario possibili soltanto perché la base della situazione è momentaneamente
così sicura, e (ciò che la reazione non sa), così borghese. Su di essa tutti
i tentativi della reazione di frenare la evoluzione borghese si spezzeranno
tanto sicuramente, quanto tutta l'indignazione morale e tutti i proclami
infiammati dei democratici”.
Così scrivevamo Marx ed io nella “Rassegna politica da maggio a ottobre
1850” della “Neue Rheinische Zeitung” rivista, fascicolo V e VI, 1850.
Questo freddo apprezzamento della situazione era però per molti un’eresia, in
un tempo in cui Ledru-Rollin, Louis Blanc, Mazzini, Kossuth e, tra i minori
luminari tedeschi, Ruga, Kinkel, Gögg e tutti gli altri, comunque si
chiamassero, si univano a Londra a mucchi per formarvi dei governi provvisori
dell’avvenire, non solo per i loro rispettivi paesi, ma anche per tutta
l’Europa; e in cui non si trattava più che di raccogliere in America il
denaro necessario sotto la forma di prestito rivoluzionario per realizzare in un
attimo la rivoluzione europea, e con essa, naturalmente, le diverse repubbliche.
Che un uomo come Willich cadesse in questa corrente, e che anche Schapper si
lasciasse trarre in inganno grazie al suo vecchio impeto rivoluzionario, che la
maggioranza degli operai di Londra, per lo più profughi essi stessi, li
seguisse nel campo dei facitori di rivoluzioni democratico-borghesi, chi se ne
può meravigliare? Infine, l’atteggiamento prudente che noi consigliavamo era
contrario al gusto di questa gente; bisognava unirsi a questi facitori di
rivoluzioni, e noi ci rifiutammo nel modo più deciso. Si venne alla scissione;
e il resto si può leggere nelle “Rivelazioni”. Poi sopravvenne l’arresto
ad Amburgo prima di Nothjung, poi di Haupt, che tradì, rivelando i nomi dei
membri del comitato Centrale di Colonia, e avrebbe dovuto apparire al processo
come testimone principale. I suoi parenti, non vollero però sottostare a questa
vergogna e lo fecero partire per Rio de Janeiro, dove in seguito si dette al
commercio e in riconoscimento dei suoi servizi divenne prima console prussiano e
poi console generale tedesco. Adesso è di nuovo in Europa.
Per migliore intelligenza di quanto segue ho qui la lista degli accusati di
Colonia: 1. P.G. Röser, operaio sigaraio; 2. Heinrich Bürgers, morto più
tardi deputato Progressista al Landtag; 3. Peter Nothjung, sarto, morto pochi
anni fa, fotografo a Breslavia; 4. W. I. Reiff; 5. Dr.
Hermann Becker, oggi primo borgomastro di Colonia e membro della Camera dei
Signori; 6. Dr. Roland Daniels, medico, morto pochi anni dopo il processo di
tisi contratta in carcere; 7. Karl Otto, chimico; 8. Dr. Abraham Jacoby, ora medico a New York; 9. Dr, I. I. Klein, ora medico e consigliare comunale
di Colonia; 10. Ferdinand Freligrath, che però allora si trovava già a Londra;
11. I. L. Ehrhard, commesso; 12. Fiedrich Lessner, sarto, ora a Londra. Di
questi, dopo il pubblico dibattito svoltosi davanti ai giurati dal 4 ottobre al
12 novembre 1852, vennero condannati per tentato alto tradimento: Röser, Bürgers
e Nothjung a sei anni di fortezza, Reiff, Otto e Becker a cinque anni della
stessa pena, Lessner a tre anni. Daniels, Klein, Jacoby ed Ehrhard vennero
assolti.
Col processo di Colonia si chiude questo primo periodo del movimento operaio
comunista tedesco. Subito dopo la condanna sciogliemmo la nostra Lega; alcuni
mesi dopo anche la Lega dissidente di Willich-Schapper passò a godere
l’eterno riposo.
(in nota: Schapper morì a Londra nel 1870. Willich prese parte alla guerra
civile americana e vi si distinse. Nella battaglia di Murfreesboro, Tennesee,
era generale di brigata e ricevette una palla nel petto; guarì e morì circa
dieci anni or sono in America. Delle altre persone di cui si parla sopra, voglio
ancora ricordare che Heinrich Bauer è scomparso in Australia e che Weitling ed
Ewerbeck morirono in America).
Una generazione separa quel tempo dal tempo nostro. Allora la Germania era un
paese di artigianato e di industria domestica basata sul lavoro manuale; ora è
un grande paese industriale in cui continua a svolgersi un processo di
rivoluzione dell’industria. Allora bisognava andare a cercare ad uno ad uno
gli operai che comprendessero la loro situazione come operai e il loro
antagonismo storico-economico col capitale, poiché questo antagonismo stesso
era appena al suo sorgere. Oggi si deve sottomettere tutto il proletariato
tedesco a una legge eccezionale, soltanto per rallentare di un poco il processo
del suo sviluppo verso la piena coscienza della propria situazione di classe
oppressa. Allora i pochi che erano pervenuti al riconoscimento della funzione
storica del proletariato dovevano unirsi in segreto, adunarsi clandestinamente
in comunità da tre a venti uomini. Oggi il proletariato tedesco non ha più
bisogno di nessuna organizzazione ufficiale, né pubblica né segreta. Il
semplice legame, che si comprende da sé, tra compagni di classe della stessa
opinione è sufficiente, senza tutti gli statuti, le istanze dirigenti, le
decisioni e tutte le altre forme immaginabili, per scuotere tutto il Reich
tedesco. Bismarck è arbitro dell’Europa, ma al di fuori delle frontiere della
Germania; all’interno di esse diventa sempre più minacciosa quell’atletica
figura del proletariato tedesco che Marx aveva già previsto nel 1844: il
gigante per il quale l’edificio del Reich, fatto sulla misura del filisteo,
diventa già troppo angusto, e la cui potente statura e le cui larghe spalle
stanno crescendo a tal segno che solo levandosi in piedi egli farà a pezzi
tutto l’edificio della Costituzione del Reich. E anche di più. Il movimento
internazionale del proletariato europeo e americano è diventato adesso così
forte che non solo la sua prima forma ristretta - la Lega segreta - ma perfino
la sua seconda forma infinitamente più larga - la pubblica Associazione
Internazionale degli operai - è diventata per esso un inciampo; e che il
semplice sentimento di solidarietà, basato sulla convinzione dell’identità
della situazione di classe, è sufficiente per creare, e tenere assieme tra gli
operai di tutti i paesi e di tutte le lingue uno stesso grande partito del
proletariato. Le dottrine che furono quelle della Lega dal 1847 al 1852 e che
allora potevano essere trattate dai saggi filistei con una scrollata di spalle,
come fantasticherie di teste esaltate e teorie segrete di pochi settari
dispersi, hanno ora innumerevoli seguaci in tutti i paesi civili del mondo, tra
i condannati delle miniere siberiane e tra i cercatori d’oro della California;
e il creatore di quelle dottrine, l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo,
Karl Marx era, quando morì, il consigliere sempre ricercato e sempre pronto del
proletariato dei due mondi.
Londra, 8 ottobre 1885
Friedrich Engels
58
- Una lettera di Antonio Labriola a Friedrich Engels (Antonio Labriola)
Napoli, 31 luglio 1891 - (Riviera di Chiaia, 180)
Egregio Signore,
se le mie lettere la impegnassero ad alcuna risposta, io mi guarderei bene dal
mandargliele. Non ardisco di toglierla ai suoi seri e gravi lavori, per solo
diletto di corrispondenza: e del terzo volume del “Capitale” abbiamo tutti
bisogno. Ma faccia conto di leggerle come relazioni, che tengono luogo dei
giornali socialisti, i quali in Italia non mancano, o non sono degni di essere
presi sul serio. Alla vigilia del Congresso di Bruxelles le riassumo un po’ la
situazione.
Degli arrestati per i fatti del I Maggio a Roma, un centinaio all’incirca
furono giudicati a precipizio dal giudice di città (pretore), e furono
condannati a piccole pene di carcere o di multa.
Poi venne un processo serio, di cinquantuno imputati di resistenza a mano armata
alla forza pubblica. Furono ad arte sottratti al giudizio dei giurati e
rimandati al tribunale penale, che li condannò tutti meno sei l’altro venerdì,
in mezzo ad un iscrivibile tumulto dell'aula e delle vie adiacenti.
Trattavasi fatta eccezione di due studenti di Università e di uno studente di
liceo, di gente ignota in tutti i circoli politici di Roma, di gente arrestata a
caso su la piazza, o dopo. Processo indecente, di puri indizi, di semplici
testimonianze di agenti di pubblica sicurezza, e queste e quelli anche
contraddittori e inconcludenti. Furono pronunciate delle pene gravissime, in una
sentenza, che non era da magistrati, ma da poliziotti: circa cento anni di
carcere!
D’uno dei condannati (ebbe due anni e mezzo di reclusione) risultava soltanto
che lanciando un sasso aveva rotto un lampione. Letta la sentenza, il presidente
del Tribunale dovette scappare dall’aula, per il tumulto che ne seguì.
Quella sentenza non fu che un atto di meditata repressione. Tutti sanno a Roma
che quei cinquantuno non furono né i promotori né gli autori principali della
sommossa. È risaputo anche, che molti e molti operai se ne tornarono alle loro
case tranquillamente, feriti o ammaccati. Gli è anche fuori di dubbio che in un
tumulto durato dalle 4 e mezza alle 8 di sera, fra la piazza e le vie adiacenti,
la cosa non sarebbe andata così liscia, se gli operai avessero usato altro che
delle pietre raccolte a caso, e se i soldati non avessero tirato in aria.
Si trattava di avere nelle mani dei capri espiatori; si trattava di compiere un
atto di terrore bianco. A ciò l’opinione pubblica era stata preparata dalla
stampa vilissima e, più che vile, ignorante. Nella piccola testa dei nostri
giornalisti i fatti del I Maggio hanno assunto le proporzioni di un grande
avvenimento storico, e il carattere di una grave minaccia rivoluzionaria. La
stampa in questo momento è quasi tutta nelle mani del bicipite governo (Rudinì,
di destra pura, e Nicotera di sinistra ed ex radicale).
Gli stessi radicali si sono condotti indecentemente. I loro rappresentanti di
estrema sinistra fecero il pugilato alla camera per salvare Nicotera, cioè la
caricatura di Crispi; il Nicotera che offendendo il “diritto comune”, proibì
tutti i comizi contro la triplice alleanza, e che dopo aver trattato con
anarchici, con socialisti, con repubblicani perché il I maggio riuscisse “a
suo onore e gloria”, fu così sfacciato da dire in parlamento “che aveva
portato tanta gente su di una piazza per metterla in trappola”. E tre quinti
dei deputati applaudirono.
In questa condizione dello spirito pubblico, gli è naturale che polizia e
magistratura non abbiano alcun freno. Il giorno dello Statuto furono premiati
con la medaglia del merito civile, gli agenti della sicurezza pubblica, e gli
ufficiali dei carabinieri che diressero la repressione del I Maggio. La corona
per la guerra civile: oh, siamo in Russia? Arrossirei per il mio paese, se non
avessi scritto già da molti anni - e non mi hanno ancora lapidato - che i miei
coetanei sono come gli Italiani del cinquecento, ma soltanto imporciti e
incanagliti, con meno ingegno, senza cultura e senza quattrini.
Alla sentenza di Roma corrispondono a capello quelle pronunciate nelle parti
d’Italia, che furono da per tutto violente e feroci, e specialmente a Firenze,
a Parma e a Gubbio. Oramai i giudicati e i giudicabili ascendono a migliaia come
se fossimo del 1849-50!
Poi verrà a Roma il processo grande di cospirazione anarchica che, in mancanza
di leggi speciali, si assimila a cospirazione di malfattori. In questo processo
è lo studente Koerner. Sarà discusso forse in ottobre. È ancora al periodo
istruttorio, ed io fui interrogato come testimone appena ieri l’altro.
L’imbastitura del processo è la seguente: Congresso di Capolago del gennaio,
in cui fu decisa l’organizzazione dei gruppi rivoluzionari: viaggio di
Cipriani a Roma, dopo aver girato tutta l’Italia e sua presenza nella capitale
durante la preparazione del I Maggio; viaggio clandestino di Malatesta per
l’Italia; venuta del famoso Palla da Parigi (che tale è il nome del preteso
Venerio Landi); esistenza di gruppi anarchici in tutta Italia, e loro
deliberazioni segrete (?!); corrispondenze trovate di convegno in Roma; discorsi
eccitanti durante il comizio; disegno fatto la notte innanzi di rientrare in
città in modo rivoluzionario.
Al processo di Roma si connettono altri processi che si fanno qui, a Messina, a
Catania ecc., e ci si riconnetteva anche l’arresto di Malatesta in Svizzera,
di cui fu chiesta l’estradizione e non ottenuta. Il Malatesta aveva alle
costole quella famosa spia del Terzaghi, di cui si ricorderà le gesta nella
sezione torinese della Internazionale del 1872. I carcerati di qui li han tenuti
per un pezzo al Castello del Carmine, al di sotto del livello dal mare! Tutta
l’imbastitura del processo di Roma potrebbe essere smontata da abili avvocati,
i quali potrebbero anzi convertire il dibattimento in un atto di accusa contro
il governo e contro la polizia e specie contro il passato del Crispi. Ma questi
abili avvocati difficilmente li troveranno e forse saranno come quelli
dell’altro processo, che furono 32, ma fatta eccezione del Lollini, del Mazza
e del Fratti, erano tutti sbarbatelli, presuntuoselli e in gran parte di idee
conservative, e chiamati d'ufficio essendo poveri gli imputati.
Le dirò di volo alcuni fatti tristissimi, perché gettano tanta luce su le
misere acque in cui ci muoviamo in Italia.
Le risoluzioni del Congresso di Capolago furono propalate fino all’ultima
sillaba nei giornali liberali e conservatori, durante tutto il gennaio: e il
governo non si mosse. Anzi è notorio che il Sig. C., andato al congresso come
delegato, fu pagato da due giornali conservatori di Roma, perché mandasse delle
corrispondenze, che poi furono la fonte di tutte le informazioni. Il Sig. C. fu
sempre sospettato di spia, ed ora è tra gli imputati. Continuava la commedia
crispina, di sfruttare le passioni di ciascun partito e di ciascun gruppo contro
gli altri. Cipriani girò sì tutta l’Italia, ma appena giunto a Forlì
dichiarò in una pubblica lettera, che egli era stato ingannato e che in Italia,
non c’era per ora speranza di rivoluzione. Lo stesso linguaggio ha tenuto da
per tutto o che parlasse o che scrivesse, mentre il governo mandava comunicati
ai giornali per dire che Cipriani preparava la rivoluzione. La “trappola”,
di cui parlò Nicotera è dunque una schietta, per quanto indubbia verità.
L’”inganno” di cui accennava Cipriani veniva di certo da un tale che in
pubblico è anarchico, ma che a tempo perso è negoziatore di affari ed agente
elettorale. È cosa notoria che molti predicatori d’astensionismo son poi
negoziatori di voti o in senso positivo o in senso negativo.
Cipriani intervenne a Roma a molte riunioni schiettamente operaie, e non vi
prese parola e non vi votò mai: ma ecco che la questura mandava comunicati ai
giornali che quella era stata una riunione di anarchici!
A Roma si erano formati dei gruppi rivoluzionari, ma si riunivano in osterie ed
in altri luoghi pubblici. Presto si trovarono ai fianchi degli agenti
provocatori e delle spie che avevano il mandato di spingere ad atti o ridicoli o
delittuosi. Tutto ciò fu messo in chiaro molti giorni prima del I Maggio,
specie per opera del Koerner e ci fu come una specie di giurì con la
confessione di uno dei principali intriganti, il signor M., giornalista, che
messo al muro dichiarò di ricevere 200 lire al mese per tale nobile mestiere.
Il I Maggio e l’arresto di tante centinaia di persone, e il terrore che n’è
seguito, hanno reso inutile quelle inchieste che io seguo da lontano. Risoluto a
trarne la materia di un grande scandalo, ora che l’insidia ha avuto il suo
effetto completo non è il caso più di parlarne. Ci vorrebbe un bell’opuscolo
umoristico intitolato così: “La trappola dell’on. Nicotera spiegata al
popolo”. Ma i fatti assodati furono i seguenti: più volte i predicatori
dell’astensionismo erano stati pagati, e ciò a danno dei candidati
antigovernativi; gli agenti provocatori spinsero gli anarchici a guastare il
movimento dei disoccupati che pigliava un piede serio e seriamente minaccioso:
quando tre anarchici andarono a minacciare il Nicotera nel suo gabinetto, non
fecero che recitare il discorso fatto loro imparare a mente da un certo N.N. che
aveva anche incarico di far venire a Roma il Malatesta per consegnarlo alla
polizia; un certo B., negoziava con la questura per il rinvio dei disoccupati!
Ci furono persino consigli dati a disgraziati, a matti, a esaltati di
furti, di ricatti e d’incendi.
È il caso proprio che io esclami: dove è andata a finire la mia povera
filosofia! Perché molti di questi malfattori li ho visti e li ho sentiti e li
ho studiati con santa pazienza. E dicevo spesso a quel povero Koerner, che
voleva evangelizzare, che per vivere in Italia dovesse prima imparare a mente il
“Fiesco”, di Schiller e leggersi tutte le sere la storiella di Gaudy, lo “Schneidergesell”.
Dopo il I Maggio le insidie durarono, ed io mi son visto la casa guardata dalla
polizia per due mesi. Si fiutava l’anarchico da per tutto, continuava sempre
la ricerca delle false bombe e dei pretesi documenti, e a furia d’intrighi e
per opera specialmente del sig. G. durarono gli arresti ancora un mese.
Ora credo che si cominci a provare imbarazzo di questo colossale processo e già
il pubblico comincia a fiutare le colpe del governo. Io farò quanto è in me
perché il pubblico dibattimento pigli tale piega, da scoprire il dietroscena
che le ho accennato di volo.
Immagini che noie, che fastidi, che angustie, io abbia avuto in questo tempo, ed
a quante insinuazioni e velate accuse io sia stato fatto segno. Ma su tutto ciò
io passerei sopra, se le cose accadute fossero ammaestramento e consiglio a far
meglio. Purtroppo non hanno prodotto che spavento e delusione.
La massa degli operai è rimasta nella persuasione che governo, che
repubblicani, che anarchici, che tutti li abbiamo ingannati. Il manipolo dei
mazziniani, che si era messo a capitanare il I Maggio a Roma, s’è poi fatto
indietro in santa pace. A Roma non è stato mai più possibile di tenere una
sola riunione di operai.
A Milano ci doveva essere il 29 di giugno una riunione di delegati di società
operaie per scegliere i rappresentanti da inviare a Bruxelles. Ma poi per
mancanza di adesione la cosa fu dovuta differire al 14 luglio, e poi finalmente
al 2 agosto. Dopo domani, dunque, la riunione, che la magniloquenza italiana
chiama congresso, avrà luogo. Temo che si tratti dei soliti avvocati e
patrocinatori, ai quali mette conto di agitare il proletariato e di servirsene,
purché quello si rassegni a rimanere inerme e disorganizzato. Così scrissi
ieri l’altro francamente al guantaio Croce di Milano, che m’invitava:
“maturino ma non inventino il partito operaio”.
Ma tra le cose indecenti che le ho narrato, è stata indecentissima poi la
condotta dei legalitari, ossia della “frazione dei socialisti”, che piglia
cotesto nome. Hanno considerato la disgrazia di Roma come la vittoria per loro.
In massima si astennero dal venire alla Camera fino al l0 giugno, e il Costa,
che c’era, si tacque durante la discussione dell’l e 2 e 3 maggio. Dacché
fu amnistiato s’è chiuso nella sua Imola, e dice che la sua “qualità di
Sindaco e di presidente della Congregazione di Carità gli impone l’obbligo di
dimostrare che i socialisti sono maturi per il governo dello Stato” (sic). Il
Prampolini fece di più, perché nella sua “Giustizia” di Reggio Emilia,
attaccò nominativamente i pretesi promotori dei disordini di Roma. Degli altri
deputati socialisti non parlo, perché son pure nullità: e il Colajanni non
vuol essere del branco.
In questa misera condizione di cose mentre il nome di socialista apparisce ormai
in Italia come equivalente o di matto o di affarista; e specie apparisce tale al
grossolano buon senso dei napoletani (se fossi romagnolo direi la mia Napoli)
che hanno a memoria le gesta antiche dei Gambuzzi, dei Caporusso, etc. ed hanno
sott’occhi le gesta presenti del sig. D’A., proprietario della
“Montagna”, sedicente socialista, ma in fatti agente di emigrazione nel
Brasile a 2.000 lire il mese.
Tutto questo non è principio di nuova vita, ma l’estremo limite della
corruzione borghese, italianamente allegra e sciamannata.
Il povero Koerner mi mandò dalle prigioni l’unito biglietto, che reca un
saluto degli studenti carcerati a Roma, al Congresso di Bruxelles. Desiderava
che io lo mandassi al Bebel, tradotto in tedesco. Ma io non conosco il Bebel, e
prego perciò lei di voler soddisfare questo onesto desiderio del mio buono e
bravo Koerner.
Se le cose del I Maggio fossero andate bene a Roma, io avevo l’idea di andare
a Bruxelles, per pigliare un po’ l’aria del mondo che vive, e per fare delle
conoscenze. Sarei corso fino a Londra per vederla. Ma ora non ho né qualità né
modo di andarci da privato a tutte mie spese. Non mi rimarrebbe che di andarci
da corrispondente di qualche giornale: cosa del resto, un po’ ripugnante per
me.
Questa lettera è troppo lunga e gliene chiedo scusa. Né è proprio di bello
stile, sono parole buttate lì da chi ha fretta.
Mi sdebito tardivamente da lei, ringraziandola dei due opuscoli del Marx, da lei
non solo rinfrescati, ma rifatti e completati.
Il povero Martignetti ha perduto l’impiego di Bergamo e ne sono straziato, ma
non so cosa fargli. A Roma, ove mi trovo in cattivo momento, mi fece tanta
compassione!
Mi creda con affetto e stima
Suo A. Labriola
59
- Una seconda lettera di Labriola a Engels (Antonio Labriola)
Roma, 14 marzo 1894 - (Corso v.
E., 251)
Caro Engels,
domani 15 - è un mese preciso - rimando per pacco ferroviario assicurato la
“Heilige Familie” sana e salva, come giunse. Sono stato ammalato di una
forte influenza con molti giorni di febbre. Ciò nonostante ho estratto,
ricopiando e traducendo, tutto quello che mi occorre.
Mi rincresce di staccarmi dal libro. Ho bisogno di possederlo. Mi permetto di
darvi un consiglio. Fatene fare una riproduzione anastatica, come si è fatto
per lo “Evangelium des armen Sünders” del Weitling. Così si taglierebbe
corto su le difficoltà di una nuova edizione; la quale suppone, o una estesa
prefazione, o un lungo commentario, cosa indispensabile anche per tedeschi della
nuova generazione, con la riproduzione anastatica, “qui potest capere capiat”.
Ho letto, capito e gustato tutto. Capire potranno molti, ma gustare come me ora
pochi. A Napoli, privatamente dal 1840-60, e poi pubblicamente all’Università
dal 1860-75, ci fu la rinascenza dell’hegelismo. Il bravo Tari (del resto un
uomo geniale) deduceva gli strumenti musicali e la cupola di S. Pietro, e
costruiva i romanzi di Balzac. Il gran divulgatore Vera ha lasciato molti libri
e molti scolari. Soprattutto ora il mio quasi coetaneo Mariano, che insegna
ancora a Napoli dell’hegelismo di estrema destra. Lo Spaventa (ottimo fra
tutti, e taccio gli altri) scrisse di dialettica in modo squisito, scovrì di
nuovo Bruno e Campanella, delineò la parte utile e utilizzabile di Vico, e trovò
da sé (nel 1864) la connessione fra Hegel e Darwin.
Sono nato in tale ambiente. A 19 anni scrissi una invettiva contro Zeller per il
ritorno a Kant (prolusione di Heidelberg). Tutta la letteratura hegeliana e
posthegeliana ci era familiare. Ora quei libri sono finiti, o nelle botteghe
degli antiquari o sulle bancarelle. Studiai Feuerbach nel 1866-69, e poi la
scuola di Tubinga: “ich habe, leider, auch Theologie studiert” (ho studiato,
purtroppo, anche teologia - nel Faust di Goethe). Tutto ciò è finito perché
questo nostro paese è come un pozzo della storia. Ora domina il “demi-mond”
positivistico.
Forse - anzi senza forse - io sono diventato comunista per effetto della mia
educazione (rigorosamente) hegeliana, dopo aver passato attraverso la psicologia
di Herbart, e la Völkerpsychologie di Steinthal ed altro.
Dunque nel leggere la “Heilige Familie” mi son trovato assai facilmente
nella situazione psicologica di voi che la scrivevate. Sono lieto di scrivere
queste parole nel dichiarare che non esisteva, ma che fingeva di esistere.
Vi prego di leggere con un po’ di pazienza il qui unito brano della “Critica
sociale”, pubblicato col permesso dei superiori, e sotto l’inevitabile egida
della Germania. Il Governo non sa più come continuare nelle persecuzioni, perché
non trova più gli operai che, secondo la “Critica” si sono “nascosti”!
E poi si tratterebbe di fare un partito di soli socialisti senza operai, insomma
uno stracotto ragout di sola cipolla, un verso di sole cesure, un bakunismo
senza Bakunin! Leggere ed ammirare!! O si creano tanti falsi martiri? Vedete
voi la “Leipziger Volkszeitung”?
Vostro A. Labriola
60
- Sull’alienazione: 1.
Sulla produzione della coscienza
(Karl Marx, Friedrich Engels)
Nella storia fino ad oggi
trascorsa è certo un fatto empirico che i singoli individui - con
l’allargarsi dell’attività sul piano storico universale, sono stati sempre
asserviti a un potere a loro estraneo (oppressione che essi si sono
rappresentati come un dispetto del mondo), a un potere del cosiddetto spirito
che è diventato sempre più smisurato e che in ultima istanza si rivela come
mercato mondiale.
Ma è altrettanto empiricamente dimostrato che col rovesciamento dello stato
attuale della società attraverso la rivoluzione comunista (di cui parleremo più
avanti) e l’abolizione della proprietà privata che con essa si identifica,
questo potere così misterioso per i teorici tedeschi verrà liquidato, e allora
verrà attuata la liberazione di ogni singolo individuo nella stessa misura in
cui la storia si trasforma in storia universale.
Che la ricchezza spirituale reale dell’individuo dipenda interamente dalla
ricchezza delle sue relazioni reali, è chiaro dopo quanto si è detto. Soltanto
attraverso quel passo i singoli individui vengono liberati dai vari limiti
nazionali locali, posti in relazione pratica con la produzione (anche
spirituale) di tutto il mondo e messi in condizione di acquistare capacità, di
godere di questa produzione universale di tutta la terra (creazioni degli
uomini).
La dipendenza universale, questa forma spontanea della cooperazione degli
individui su piano storico universale, è trasformata da questa rivoluzione
comunista nel controllo e nel dominio cosciente di queste forze le quali,
prodotte dal reciproco agire degli uomini, finora si sono imposte ad essi e li
hanno dominati come forze assolutamente estranee.
Questa concezione può a sua volta essere formulata in maniera
speculativo-idealistica, ossia fantasticamente, come “auto produzione della
specie” (la “società come soggetto”) e quindi la serie susseguentesi di
individui che stanno in connessione può essere immaginata, come un singolo
individuo che compie il mistero di produrre se stesso.
Appare qui che gli individui, certo, si fanno l'un l’altro, fisicamente e
spiritualmente, ma non fanno se stessi ne nel non-senso di Bruno Bauer né nel
senso di Max Stirner (“L’Unico”), dell’uomo “fatto”.
Questa concezione della storia si fonda dunque su questi punti: spiegare il
processo reale della produzione, e precisamente muovendo dalla produzione
materiale della vita immediata, assumere come fondamento di tutta la storia la
forma di relazioni che è connessa con quel modo di produzione e che da esso è
generata, dunque la società civile nei suoi diversi stadi, e sia rappresentarla
nella sua azione come Stato, sia spiegare partendo da essa tutte le varie
creazioni teoriche e le forme della coscienza, religione, filosofia, morale,
ecc. ecc. e seguire sulla base di queste il processo della sua origine, ciò che
consente naturalmente anche di rappresentare la cosa nella sua totalità (e
quindi anche la reciproca influenza di questi lati diversi l’uno sull'altro).
Essa non deve cercare in ogni periodo una categoria, come la concezione
idealistica della storia, ma resta salda costantemente sul terreno storico
reale. (…)
Essa mostra che la storia non finisce col risolversi nella “autoscienza”
come “spirito dello spirito”, ma che in esse, ad ogni grado si trova il
risultato materiale in una somma di forze produttive, un rapporto storicamente
prodotto con la natura, e degli individui tra loro; che ad ogni generazione è
stata tramandata dalla precedente una massa di forze che da una parte può senza
dubbio essere modificata dalla nuova generazione ma dall’altra parte impone ad
essa le sue proprie condizioni di vita e le dà uno sviluppo determinato, uno
speciale carattere; che dunque le circostanze fanno gli uomini non meno di
quanto gli uomini facciano le circostanze.
Questa somma di forze produttive, di capitali e di forme, di relazioni sociali,
che ogni individuo e ogni generazione trova come qualche cosa di dato, è la
base reale di ciò che i filosofi si sono rappresentati come “sostanza” ed
“essenza del’uomo”, di ciò che essi hanno divinizzato e combattuto, una
base reale che non è minimamente disturbata dal fatto che questi filosofi si
ribellano ad essa.
Queste condizioni di vita preesistenti in cui le varie generazioni vengono a
trovarsi, decidono anche se la scossa rivoluzionaria periodicamente ricorrente
nella storia sarà o no abbastanza forte per rovesciare la base di tutto ciò
che è costituito, e qualora non vi siano questi elementi materiali per un
rivolgimento totale, cioè da una parte le forze produttive esistenti,
dall’altra la formazione di una massa rivoluzionaria che agisce
rivoluzionariamente non solo contro alcune condizioni della società fino allora
esistente, ma contro la stessa “produzione della vita” come è stata fino a
quel momento, l’”attività totale” su cui questa si fondava, allora è del
tutto indifferente – per lo sviluppo pratico - se l’idea di questo
rivolgimento sia già stata espressa mille volte: come dimostra la storia del
comunismo.
Finora tutta la concezione della storia ha puramente e semplicemente ignorato
questa base reale della storia oppure la ha considerata come un semplice fatto
marginale, privo di qualsiasi legame con il corso storico. (…)
Il rapporto dell’uomo con la natura è quindi escluso dalla storia, e con ciò
si è creato l’antagonismo fra natura e storia. Questa concezione quindi ha
visto nella storia soltanto azioni di capi di Stati e lotte religiose e in
genere teoriche, e in ogni epoca, in particolare, ha dovuto condividere
l’illusione dell’epoca stessa.
Se un’epoca, per es., immagina di essere determinata da motivi puramente
“politici” o “religiosi”, benché “religione” e “politica” siano
soltanto forme dei suoi motivi reali, il suo storico accetta questa opinione.
L’”immagine”, la “rappresentazione” che questi determinati uomini si
fanno della loro prassi reale, viene trasformata nell’unica forza determinante
e attiva che domina e determina la prassi di questi uomini. (...)
La storia non è altro che la successione delle singole generazioni, ciascuna
delle quali sfrutta i materiali, i capitali, le forze produttive che le sono
stati trasmessi da tutte le generazioni precedenti, e quindi da una parte
continua - in circostanze del tutto cambiate – l’attività che ha ereditato;
dall'altra, modifica le vecchie circostanze con un’attività del tutto
cambiata; è un processo che sul terreno speculativo viene distorto al punto di
fare della storia successiva lo scopo della storia precedente (di assegnare, per
es., alla scoperta dell’America lo scopo di favorire lo scoppio della
Rivoluzione francese); per questa via poi la storia riceve i suoi scopi speciali
e diventa una “persona accanto ad altre persone”, mentre ciò che viene
designato come “destinazione”, “scopo”, “germe”, “idea” della
storia anteriore, altro non è che un'astrazione della storia posteriore,
un'astrazione della influenza attiva che la storia anteriore esercita sulla
successiva. (…)
Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti: cioè, la
classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la
sua potenza spirituale dominante.
La classe che dispone dei mezzi di produzione materiale dispone con ciò, in
pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale, cosicché ad essa in
complesso sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della
produzione intellettuale.
Le idee dominanti non sono altro che l'espressione ideale dei rapporti materiali
dominanti, sono i rapporti materiali presi come idee; sono dunque
l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe
dominante, e dunque sono le idee del suo dominio.
Gli individui che compongono la classe dominante posseggono fra l’altro anche
la coscienza, e quindi pensano in quanto dominano come classe e determinano
l’intero ambito di un’epoca storica, è evidente che essi lo fanno in tutta
la loro estensione, e quindi fra l'altro dominano anche come pensanti, come
produttori d’idee che regolano la produzione e la distribuzione delle idee del
loro tempo: è dunque evidente che le loro idee sono le idee dominanti
dell'epoca.
Per esempio: in un periodo e in un paese in cui potere monarchico, aristocrazia
e borghesia lottano per il potere, il quale quindi è diviso, appare come idea
dominante la dottrina della divisione dei poteri, dottrina che allora viene
enunciata come “legge eterna”. La divisione del lavoro, che abbiamo già
visto come una delle forze principali della storia finora trascorsa, si
manifesta anche nella classe dominante come divisione del lavoro intellettuale e
manuale, cosicché all’interno di questa classe una parte si presenta
costituita dai pensatori della classe (i suoi ideologi attivi, concettivi, i
quali nell’elaborazione dell'illusione di questa classe su se stessa fanno il
loro mestiere principale), mentre gli altri nei confronti di queste idee e di
queste illusioni hanno un atteggiamento più passivo e più ricettivo, giacché
in realtà sono i membri attivi di questa classe e hanno meno tempo di farsi
delle idee e delle illusioni su se stessi.
All’interno di questa classe questa scissione può addirittura svilupparsi
fino a creare fra le due parti una certa opposizione e una certa ostilità, che
tuttavia cade da sé se sopraggiunge una collisione pratica che metta in
pericolo la classe stessa: allora si dilegua anche la parvenza che le idee
dominanti non siano le idee della classe dominante, abbiano un potere distinto
dal potere di questa classe.
L'esistenza di idee rivoluzionarie in una determinata epoca presuppone già
l'esistenza di una classe rivoluzionaria, sui cui presupposti abbiamo già detto
quanto occorre.
Se ora nel considerare il corso della storia si svincolano le idee della classe
dominante e si rendono autonome, se ci si limita a dire che in un’epoca hanno
dominato queste o quelle idee, senza preoccuparsi delle condizioni della
produzione e dei produttori di queste idee, e se quindi si ignorano gli
individui e le situazioni del mondo che stanno alla base di queste idee, allora
si potrà dire per esempio che al tempo, in cui dominava l’aristocrazia
dominavano i concetti di onore, di fedeltà ecc., e che durante il dominio della
borghesia dominavano i concetti di libertà, di uguaglianza, ecc.
Queste sono, in complesso, le immaginazioni della stessa classe dominante.
Questa concezione della storia che è comune a tutti gli storici,
particolarmente a partire dal diciottesimo secolo, deve urtare necessariamente
contro il fenomeno che dominano idee sempre più astratte, cioè idee che
assumono sempre più la forma dell’universalità.
Infatti ogni classe che prenda il posto di un’altra che ha dominato prima è
costretta, non fosse che per aggiungere il suo scopo, a rappresentare il suo
interesse come interesse comune di tutti i membri della società ossia, per
esprimerci in forma idealistica, a dare alla propria idea la forma
dell’universalità, a rappresentarle come le sole forme razionali e
universalmente valide.
La classe rivoluzionaria si presenta senz’altro, per il fatto che si
contrappone a una classe, non come classe ma come rappresentante dell'intera
società, appare come l’intera massa della società di contro all’unica
classe dominante.
Ciò le è possibile perché in realtà all’inizio il suo interesse è ancora
legato all'interesse comune di tutte le altre classi non dominanti, e sotto la
pressione dei rapporti fino allora esistenti non si è ancora potuto sviluppare
come interesse particolare di una classe particolare?
La sua vittoria giova perciò anche a molti individui delle altre classi che non
giungono al dominio, ma solo in quanto pone questi individui in condizione di
ascendere nella classe dominante.
Quando la borghesia francese rovesciò il dominio dell’aristocrazia, con ciò
rese possibile a molti proletari di innalzarsi al disopra del proletariato, ma
solo in quanto essi diventarono borghesi.
Quindi ogni nuova classe non fa che porre il suo dominio su una base più larga
della precedente, per la qual cosa anche l’opposizione delle classi non
dominanti contro quella ora dominante si sviluppa più tardi con tanta maggiore
asprezza e profondità.
Queste due circostanze fanno sì che la lotta da condurre contro questa nuova
classe dominante tenda a sua volta a una negazione della situazione sociale
esistente più decisa e più radicale di quanto fosse possibile a tutte le
classi che precedentemente avevano aspirato al dominio.
Tutta questa parvenza, che il dominio di una determinata classe altro non sia
che il dominio di certe idee, cessa naturalmente da sé non appena il dominio di
classe in generale cessa di essere la forma dell’ordinamento sociale, non
appena quindi non è più necessario rappresentare un interesse particolare come
universale o l’universale come dominante.
Una volta che tutte le idee dominanti siano state separate dagli individui
dominanti e soprattutto dai rapporti che risultano da un dato stadio del modo di
produzione, e si sia giunti di conseguenza al risultato che nella storia
dominano sempre le idee, è facilissimo astrarre da queste varie idee
l’”idea”, ecc. come ciò che domina nella storia e concepire così tutte
queste singole idee e concetti come “autodeterminazioni” del concetto che si
sviluppa nella storia.
Allora è anche naturale che tutti i rapporti degli uomini possano venire
ricavati dal concetto dell’uomo, dall’uomo come viene rappresentato,
dall’essenza dell’uomo, dall’uomo. È ciò che ha fatto la filosofia
speculativa.
Hegel arriva a confessare, alla fine della sua filosofia della storia, “di
avere considerato soltanto il processo del concetto e di avere esposto nella
storia la “vera teodicea”. Si può quindi ritornare ai produttori “del
concetto”, ai teorici, agli ideologi e ai filosofi, e giungere quindi al
risultato che i filosofi, i pensatori come tali, hanno dominato da sempre nella
storia; un risultato che, come abbiamo visto, fu anche già espresso da Hegel.
Quindi tutto il gioco di abilità, per dimostrare la sovranità dello spirito
nella storia (gerarchia in Stirner), si riduce ai seguenti efforts:
1) si devono separare le idee di coloro che dominano per ragioni empiriche,
sotto condizioni empiriche e come individui materiali, da questi dominatori, e
con ciò riconoscere il dominio di idee o illusioni nella storia.
2) Si deve mettere un ordine in questo dominio delle idee, dimostrare un nesso
mistico fra le successive idee dominanti, al che si perviene considerandole come
“autodeterminazioni del concetto” (la cosa è possibile perché fra queste
idee, attraverso la loro base empirica, esiste realmente un nesso e perché
esse, concepite come pure idee, diventano autodistinzioni, distinzioni fatte dal
pensiero.
3) Per eliminare l’aspetto mistico di questo “concetto autodeterminantesi”,
lo si trasforma in una persona – “l’aurocoscienza” – oppure, per
apparire perfetti materialisti, in una serie di persone che rappresentano “il
concetto” nella storia, i “pensatori”, i “filosofi”, gli ideologi, i
quali ancora una volta, sono concepiti come i fabbricanti della storia, come il
“consesso dei guardiani”, come i dominatori.
Con ciò si sono eliminati dalla storia tutti quanti gli elementi materialistici
e si possono allentare tranquillamente le briglie al destriero speculativo.
Mentre nella vita ordinaria qualsiasi bottegaio sa distinguere benissimo fra ciò
che ciascuno pretende di essere e ciò che realmente è, la nostra storiografia
non è ancora arrivata a questa ovvia conoscenza. Essa crede sulla parola ciò
che ogni epoca dice e immagina di se stessa.
Questo metodo storiografico che domina soprattutto in Germania, e specie perché
vi ha dominato, va spiegato movendo dalla sua connessione con l’illusione
degli ideologi in genere, per esempio le illusioni dei giuristi, dei politici
(ivi compresi i pratici uomini di Stato), dai vaneggiamenti dogmatici di codesti
tipi; la quale illusione è semplicissimamente appagata dalla loro posizione
pratica nella vita, dal loro mestiere e dalla divisione del lavoro.
Karl Marx
e Friedrich Engels
61 – Sull’alienazione: 2. Il lavoro estraniato (Karl Marx, Friedrich Engels)
Noi siamo partiti dai presupposti
dell'economia politica. Abbiamo accettato la sua lingua e le sue leggi. Abbiamo
preso in considerazione la proprietà privata, la distinzione tra lavoro,
capitale e terra, ed anche tra salario, profitto del capitale e rendita
fondiaria, come pure la divisione del lavoro, la concorrenza, il concetto del
valore di scambio, ecc.
Partendo dalla stessa economia politica, e valendoci delle sue stesse parole
abbiamo mostrato che l’operaio decade a merce, alla più misera delle merci,
che la miseria dell’operaio sta in rapporto inverso con la potenza e la
quantità della sua produzione, che il risultato necessario della concorrenza è
l’accumulazione del capitale in poche mani, e quindi la più temibile
ricostituzione del monopolio, che infine scompare la differenza tra capitalista
e proprietario fondiario, così come scompare la differenza tra contadino e
operaio di fabbrica, e tutta intera la società deve scindersi nelle due classi
dei proprietari e degli operai senza proprietà.
L’economia politica parte dal fatto della proprietà privata.
Ma non ce la spiega. Coglie il processo materiale della proprietà privata quale
si rivela nella realtà, ma lo coglie in formule generali, astratte, che hanno
per essa il valore di leggi.
Essa non comprende queste leggi, cioè non riflette in qual modo esse derivino
dall’essenza della proprietà privata.
L'economia politica non ci dà nessuna spiegazione sul fondamento della
divisione di capitale e lavoro, di capitale e terra.
Se, per esempio, determina il rapporto del salario col profitto del capitale
l’interesse del capitalista vale per essa come la ragione suprema; cioè essa
presuppone ciò che deve spiegare, parimenti interviene dappertutto la
concorrenza.
Ma questa viene spiegata in base a circostanze esterne.
L’economia politica non c’insegna nulla altro che l’espressione di uno
svolgimento necessario.
Abbiamo visto, come lo stesso scambio le appiana come un fatto accidentale. Gli
unici ingranaggi che l’economia politica mette in moto sono l’avidità del
denaro e la guerra tra coloro che ne sono affetti, la concorrenza.
Proprio perché l’economia politica non comprende la connessione del movimento
storico, si è potuto di nuovo contrapporre, ad esempio, la dottrina della
concorrenza a quella del monopolio, la dottrina della libertà di commercio a
quella della corporazione, la dottrina della divisione del possesso fondiario a
quella della grande proprietà fondiaria; e infatti concorrenza, libertà di
commercio, divisione del possesso fondiario sono state svolte e comprese
soltanto come conseguenze casuali, volontarie, violente del monopolio, della
corporazione e della proprietà feudale, e non come conseguenze necessarie,
inevitabili, naturali.
Quindi ora noi dobbiamo comprendere la connessione essenziale che corre tra la
proprietà privata, l’avidità di denaro, la distinzione tra lavoro, capitale
e proprietà fondiaria, tra scambio e concorrenza, ecc. La connessione di tutto
questo processo di estraniazione col sistema monetario.
Non trasferiamoci, come fa l’economista quando vuol dare una spiegazione, in
uno stato originario fantastico. Un tale stato originario non spiega nulla. Non
fa che rinviare il problema in una lontananza grigia e nebulosa.
Presuppone in forma di fatto, di accadimento, ciò che deve dedurre, cioè il
rapporto necessario tra due fatti per es. tra la divisione del lavoro e lo
scambio.
Allo stesso modo la teologia spiega l’origine del male col peccato originale,
cioè presuppone come un fatto, in forma di storia, ciò che deve spiegare.
Noi partiamo da un fatto dell'economia politica, da un fatto presente.
L’operaio diventa tanto più povero quanto maggiore è la ricchezza che
produce, quanto più la sua produzione cresce di potenza e di estensione.
L’operaio diventa una merce che produce. La svalorizzazione del mondo umano
cresce in rapporto diretto con la valorizzazione del mondo delle cose.
Il lavoro non produce soltanto merci; produce se stesso e l’operaio come una
merce, e proprio nella stessa proporzione in cui produce in generale le merci.
Questo fatto non esprime ulteriormente null’altro che questo: l'oggetto che il
lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso come un essere
estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo produce. Il prodotto del
lavoro che si è fissato in un oggetto, è diventato una cosa, è
l’oggettivazione del lavoro.
La realizzazione del lavoro è la sua oggettivazione. Questa oggettivazione del
lavoro appare nello stadio della economia privata come un annullamento
dell’operaio, l’oggettivazione appare come perdita e asservimento
dell’oggetto, l’appropriazione come estraniazione, come alienazione.
La realizzazione del lavoro si presenta come annullamento in tal maniera che
l’operaio si presenta come perdita dell’oggetto in siffatta guisa che
l’operaio è derubato degli oggetti più necessari non solo per la vita, ma
anche per il lavoro.
Già il lavoro stesso diventa un oggetto, di cui egli riesce a impadronirsi,
soltanto col più grande sforzo e con le più irregolari interruzioni.
L'appropriazione dell’oggetto si presenta come estraniazione in tale modo che
quanti più oggetti l’operaio produce, tanto meno egli ne può possedere e
tanto più va a finire sotto la signoria del suo prodotto, del capitale.
Tutte queste conseguenze sono implicite nella determinazione che l'operaio si
viene a trovare rispetto al prodotto del suo lavoro come rispetto ad un oggetto
estraneo. Infatti, partendo da questo presupposto è chiaro che: quanto più
l’operaio si consuma nel lavoro, tanto più potente diventa il mondo estraneo,
oggettivo, che egli si crea dinanzi, tanto più povero diventa egli stesso, e
tanto meno il suo mondo interno gli appartiene in proprio.
Lo stesso accade nella religione. Quante più cose l’uomo trasferisce in Dio,
tanto meno egli ne ritiene in se stesso. L'operaio ripone la sua vita
nell’oggetto, ma d’ora in poi la sua vita non appartiene più a lui, ma
all’oggetto. Quanto più grande è dunque questa attività, tanto più
l’operaio è privo di oggetto.
Quello che è il prodotto del suo lavoro, non è egli stesso. Quanto più grande
è dunque questo prodotto, tanto meno è egli stesso. L’alienazione
dell’operaio nel suo prodotto significa non solo che il suo lavoro diventa, un
oggetto, qualcosa che esiste all’esterno, ma che esso esiste fuori di lui,
indipendentemente da lui, a lui estraneo, e diventa di fronte a lui una potenza,
per se stante; significa che la vita che egli ha dato all’oggetto, gli si
contrappone ostile ed estranea.
Ed ora consideriamo più da vicino l’oggettivazione, la produzione
dell’operaio, e in essa l’estraniazione, la perdita dell’oggetto, del suo
prodotto.
L’operaio non può produrre nulla senza la natura, senza il mondo esterno
sensibile. Questa è la materia su cui si realizza il suo lavoro, su cui il
lavoro agisce, dal quale e per mezzo del quale esso produce.
Ma come la natura fornisce al lavoro i mezzi di sussistenza, nel senso che il
lavoro non può sussistere senza oggetti su cui applicarsi; così essa, d'altra
parte, fornisce pure i mezzi di sussistenza in senso più stretto, cioè i mezzi
di sostentamento fisico dello stesso operaio.
Quindi quanto più l’operaio si appropria col proprio lavoro del mondo
esterno, la natura sensibile, tanto più egli si priva dei mezzi di sussistenza
nella seguente duplice direzione: prima di tutto, per il fatto che il mondo
esterno cessa sempre più di essere un oggetto appartenente al suo lavoro, un
mezzo di sussistenza del suo lavoro, e poi per il fatto che lo stesso mondo
esterno cessa sempre più di essere un mezzo di sussistenza nel senso immediato,
cioè un mezzo per il suo sostentamento fisico.
In questa duplice direzione, dunque, l’operaio diventa uno schiavo
dell’oggetto, in primo luogo perché egli riceve un oggetto da lavorare, cioè
riceve un lavoro; in secondo luogo, perché riceve dei mezzi di sostentamento. E
quindi, in primo luogo perché deve esistere come operaio, e in secondo luogo
perché deve esistere come soggetto fisico.
Il colmo di questo asservimento si ha quando egli si può mantenere come
soggetto fisico solo più in quanto è operaio ed è operaio soltanto più in
quanto è operaio ed è operaio soltanto più in quanto è soggetto fisico.
(Secondo le leggi dell’economia politica, l’estraniazione dell’operaio nel
suo oggetto si esprime nel fatto che quanto più l’operaio produce, tanto meno
ha da consumare; quanto maggior valore produce, tanto minor valore e minore
dignità egli possiede; quanto più bello è il suo prodotto, tanto più
l’operaio diventa deforme; quanto più raffinato il suo oggetto, tanto più
egli s’imbarbarisce; quanto più potente il lavoro, tanto più egli diventa
impotente; quanto più il lavoro è spirituale, tanto più egli è diventato
materiale e schiavo della natura).
L’economia politica nasconde l’estraniazione insita nell’essenza stessa
del lavoro per il fatto che non considera il rapporto immediato tra l’operaio
(il lavoro) e la produzione. Certamente, il lavoro produce per i ricchi cose
meravigliose; ma per gli operai produce soltanto privazioni. Produce palazzi, ma
per l’operaio spelonche. Produce bellezza, ma per l’operaio deformità.
Sostituisce il lavoro con macchine, ma ricaccia una parte degli operai in un
lavoro barbarico e trasforma l’altra parte in macchina. Produce cose dello
spirito, ma per l'operaio idiotaggine e cretinismo.
Il rapporto immediato esistente tra il lavoro e i suoi prodotti è il rapporto
tra l’operaio e gli oggetti della sua produzione. Il rapporto che il ricco ha
con gli oggetti della produzione e con la stessa produzione è soltanto una
conseguenza di quel primo rapporto. Considereremo quest’altro aspetto più
oltre.
Quando noi dunque ci domandiamo: qual è il rapporto essenziale del lavoro? La
domanda che ci poniamo verte intorno al rapporto dell’operaio con la
produzione.
Sinora abbiamo considerato l’estraniazione, l’alienazione dell'operaio da un
solo lato, cioè abbiamo considerato il suo rapporto coi prodotti del suo
lavoro. Ma l'estraniazione si mostra non soltanto nel risultato, ma anche
nell’atto della produzione, entro la stessa attività produttiva.
Come potrebbe l’operaio rendersi estraneo nel prodotto della sua attività, se
egli non si estraniasse da se stesso nell’atto della produzione? Il prodotto
non è altro che il resumé dell’attività, della produzione.
Quindi se il prodotto del lavoro è l’alienazione, la produzione stessa deve
essere alienazione attiva, alienazione dell’attività, l’attività
dell’alienazione. Nell’estraniazione dell'oggetto del lavoro si riassume la
estraniazione, l'alienazione che si opera nella stessa attività del lavoro.
E ora, in che cosa consiste l’alienazione del lavoro?
Consiste prima di tutto nel fatto che il lavoro è esterno all’operaio, cioè
non appartiene al suo essere, e quindi nel suo lavoro egli non si afferma, ma si
nega, si sente non soddisfatto, ma infelice, non sviluppa una libera energia
fisica e spirituale, ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo spirito.
Perciò l’operaio solo fuori del lavoro si sente presso di sé; e si sente
fuori di sé nel lavoro. È a casa propria
se non lavora; e se lavora non è a casa propria. Il suo lavoro quindi non è
volontario, ma costretto, è un lavoro forzato. Non è quindi il soddisfacimento
di un bisogno, ma soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei.
La sua estraneità, si rivela chiaramente nel fatto che non appena viene meno la
coazione fisica o qualsiasi altra coazione, il lavoro viene fuggito come la
peste. Il lavoro esterno, il lavoro in cui l’uomo si aliena, è un lavoro di
sacrificio di se stessi, di mortificazione. Infine l’esteriorità del lavoro
per l’operaio appare in ciò che il lavoro non è suo proprio, ma di un altro.
Non gli appartiene, ed egli, nel lavoro, non appartiene a se stesso, ma ad un
altro. (...)
Ne viene quindi come conseguenza che l’uomo (l’operaio) si sente libero
soltanto nelle sue funzioni animali, come il mangiare, il bere, il procreare, e
tutt’al più ancora abitar una casa e il vestirsi; e invece si sente nulla più
che una bestia nelle sue funzioni umane. Ciò che è animale diventa umano e ciò
che è umano diventa animale.
Certamente mangiare, bere e procreare sono anche funzioni schiettamente umane.
Ma in quell’astrazione, che le separa dalla restante cerchia dell’attività
umana e le fa diventare scopi ultimi ed unici, sono funzioni animali.
Abbiamo considerato l’atto dell’estraniazione dell'attività pratica
dell’uomo, cioè il lavoro da due lati. 1) Il rapporto dell’operaio col
prodotto del lavoro considerato come oggetto estraneo e oppressivo.
Questo rapporto è ad un tempo il rapporto col mondo esterno sensibile, con gli
oggetti della natura, inteso come un mondo estraneo che gli sta di fronte in
modo ostile. 2) Il rapporto del lavoro con l’atto della produzione entro il
lavoro.
Questo rapporto è il rapporto dell’operaio con la sua propria attività
estranea che non gli appartiene, l’attività come passività, la forza come
impotenza, la procreazione come svirilimento, l’energia fisica e spirituale
propria dell’operaio, la sua vita personale – e infatti che (altro) è la
vita se non attività - come un’attività rivolta contro di lui, da lui
indipendente, e che non gli appartiene.
L’estraniazione di sé come prima, l’estraniazione della cosa.
Ora dobbiamo ancora ricavare dalle due determinazioni sin qui descritte una
terza determinazione del lavoro estraniato.
L’uomo è un essere generico (che appartiene a un “genus”), non solo perché
del genere, tanto del proprio quanto di quello delle altre cose, fa teoricamente
e praticamente il proprio oggetto, ma anche (e si tratta soltanto di una diversa
espressione per la stessa cosa) perché si comporta verso se stesso come verso
il genere presente e vivente, perché si comporta verso se stesso come verso un
essere universale e perciò libero.
La vita del genere, tanto nell’uomo quanto negli animali, consiste fisicamente
anzitutto nel fatto che l'uomo (come l’animale) vive della natura inorganica,
e quanto più universale è l’uomo dell’animale, tanto più universale è il
regno della natura inorganica di cui egli vive. Le piante, gli animali, le
pietre, l'aria, la luce, ecc. come costituiscono teoricamente una parte della
coscienza umana, in parte come oggetti della scienza naturale, in parte come
oggetti dell’arte - si tratta della natura inorganica spirituale, dei mezzi
spirituali di sussistenza, che egli non ha che da apprestare per goderne e
assimilarli - così costituiscono anche praticamente una parte della vita umana
e dell’umana attività.
L’uomo vive fisicamente soltanto di questi prodotti naturali, si presentino
essi nella forma di nutrimento o di riscaldamento, di abbigliamento o di
abitazione, ecc. L'universalità dell’uomo appare praticamente proprio in
quella universalità, che fa della intera natura il corpo inorganico
dell’uomo, sia perché essa 1) è un mezzo immediato di sussistenza, sia 2)
perché è la materia, l’oggetto, lo strumento della sua attività vitale. La
natura è il corpo inorganico dell’uomo, precisamente la natura in quanto non
è essa stessa corpo umano. Che l’uomo viva della natura vuol dire che la
natura è il suo corpo, con cui deve stare in costante progresso per non morire.
Che la vita fisica e spirituale dell’uomo sia congiunta con la natura, non
significa altro che la natura è congiunta con se stessa, perché l’uomo è
una parte della natura.
Poiché il lavoro estraniato rende estranea all'uomo 1) la natura e 2) l’uomo
stesso, la sua propria funzione attiva, la sua attività vitale, rende estraneo
all'uomo il genere; fa della vita del genere un mezzo della vita individuale. In
primo luogo il lavoro rende estranea la vita del genere e la vita individuale,
in secondo luogo fa di quest’ultima nella sua estrazione uno scopo della
prima, ugualmente nella sua forma astratta ed estraniata.
Infatti il lavoro, l’attività vitale, la vita produttiva stessa appaiono
all’uomo in primo luogo soltanto come un mezzo per la soddisfazione di un
bisogno, del bisogno di conservare l’esistenza fisica. Ma la vita produttiva,
è la vita del genere. È la vita che produce la vita. In una determinata
attività vitale sta interamente il carattere di una “specie”, sta il suo
carattere specifico; e l'attività libera e cosciente è il carattere
dell’uomo. La vita stessa appare soltanto come mezzo di vita.
L’animale è immediatamente una cosa sola con la sua attività vitale. Non si
distingue da essa. È quella stessa. L’uomo fa, della sua attività vitale
l'oggetto stesso della sua volontà e della sua coscienza. Ha un’attività
vitale cosciente. Non c’è una sfera determinata in cui l’uomo
immediatamente si confonda. L’attività vitale cosciente dell'uomo distingue
l'uomo immediatamente dall’attività vitale dell’animale. Proprio soltanto
per questo egli è un essere della specie.
O meglio egli è un essere cosciente, cioè è la sua propria vita, è un suo
oggetto, proprio soltanto perché egli è un essere generico. Soltanto perciò
la sua attività è un’attività libera. Il lavoro estraniato rovescia il
rapporto in quanto l’uomo, proprio perché è un essere cosciente, fa della
sua attività vitale, della sua essenza soltanto un mezzo per la sua esistenza.
La creazione pratica d’un mondo oggettivo, la trasformazione della natura
inorganica dotata di coscienza, cioè di un essere che si comporta verso il
genere come verso il suo proprio essere o verso se stesso come verso il suo
essere generico. Certamente anche l’animale produce. Si fabbrica un nido,
delle abitazioni, come fanno la api, i castori, le formiche, ecc.
Solo che l’animale produce unicamente ciò che gli occorre immediatamente per
sé o per i suoi nati; produce in modo unilaterale, mentre l’uomo produce in
modo universale; produce solo sotto l’impegno del bisogno fisico immediato,
mentre l’uomo produce anche libero dal bisogno fisico, e produce veramente
soltanto quando è libero da esso; l'animale riproduce l’intera natura; il
prodotto dell'animale appartiene immediatamente al suo corpo fisico, mentre
l’uomo si pone liberamente di fronte al suo prodotto. L’animale costruisce
soltanto secondo la misura inerente a quel determinato oggetto; quindi l'uomo
costruisce, anche secondo le leggi della bellezza.
Proprio soltanto nella trasformazione del mondo oggettivo l’uomo si mostra
quindi realmente come un essere generico. Questa produzione è la sua vita come
essere generico. Mediante essa la natura appare come la sua opera e la sua realtà.
L’oggetto del lavoro è quindi l’oggettivazione della vita dell’uomo come
essere generico, in quanto egli si raddoppia, non soltanto nella coscienza,
intellettualmente, ma anche attivamente, realmente, e si guarda quindi in un
mondo da esso creato. E quindi in quanto il lavoro estraniato strappa all’uomo
l’oggetto della sua produzione, gli strappa la sua vita di essere appartenente
ad una specie, la sua oggettività reale specifica e muta il suo primato dinanzi
agli animali nello svantaggio consistente nel fatto che il suo corpo inorganico,
la natura, gli viene sottratta.
Parimenti in quanto il lavoro estraniato degrada a mezzo l’attività autonoma,
l’attività libera, fa della vita dell’uomo come essere generico un mezzo
della sua esistenza fisica.
Per opera dell’alienazione, la coscienza, che l’uomo ha del suo genere, si
trasforma quindi in ciò che la sua vita generica diventa per lui un mezzo.
Il lavoro alienato fa dunque: 3) dell’essere dell’uomo, come essere
generico, tanto della natura quanto della sua specifica capacità spirituale, un
essere a lui estraneo, un mezzo della sua esistenza individuale. Esso rende
all’uomo estraneo il suo proprio corpo, tanto la natura esterna, quanto il suo
essere spirituale, il suo essere umano. 4) Una conseguenza immediata del fatto
che l’uomo è reso estraneo al prodotto, è l’estraniazione dell'uomo
dall'uomo. Se l’uomo si contrappone a se stesso, l’altro uomo si contrappone
a lui. Quello che vale del rapporto dell’uomo con l’altro uomo, ed altresì
col lavoro e con l’oggetto del lavoro dell’altro uomo.
In generale, la proposizione che all’uomo è reso estraneo il suo essere
generico, significa che un uomo è reso estraneo all’altro uomo, e altresì
che ciascuno di essi è reso estraneo all'essere dell’uomo.
L’estraniazione dell’uomo, in generale ogni rapporto in cui l’uomo è con
se stesso, è attuato, e si esprime soltanto nel rapporto in cui l’uomo è con
l’altro uomo.
Dunque nel rapporto del lavoro estraniato ogni uomo considera gli altri secondo
il criterio e il rapporto in cui egli stesso si trova come lavoratore.
Abbiamo preso le mosse da un fatto dell’economia politica,
dall’estraniazione dell’operaio e della sua produzione. Abbiamo espresso il
concetto di questo fatto: il lavoro estraniato, alienato.
Abbiamo analizzato questo concetto
e quindi abbiamo analizzato semplicemente un fatto dell’economia politica.
Ora, proseguendo, vediamo come il concetto del lavoro estraniato, alienato,
debba esprimersi e rappresentarsi nella realtà.
Se il prodotto del lavoro mi è estraneo, mi sta di fronte come una potenza
estranea, a chi mai appartiene?
Se un’attività che è mia non appartiene a me, ed è un’attività altrui,
un’attività coatta a chi mai appartiene?
Ad un essere diverso da me.
Ma chi è questo essere?
Son forse gli dei? Certamente, in antico non soltanto la produzione principale,
come quella dei templi, in Egitto, in India, nel Messico, appare eseguita al
servizio degli dei, ma agli dei appartiene anche lo spirito prodotto, soltanto
che gli dei non furono mai essi stessi i padroni. E neppure la natura. Quale
contraddizione mai sarebbe se quanto più col proprio lavoro l’uomo si
assoggetta la natura, quanto più i miracoli divini diventano superflui a causa
dei miracoli dell’industria, l'uomo dovesse per amore di queste forze,
rinunciare alla gioia della produzione e al godimento del prodotto.
L’essere estraneo, a cui appartengono il lavoro e il prodotto del lavoro, che
si serve del lavoro e gode del prodotto del lavoro, non può essere che
l’uomo.
Se il prodotto del lavoro non appartiene all'operaio, e un potere estraneo gli
sta di fronte, ciò è possibile soltanto per il fatto che esso appartiene ad un
altro uomo estraneo all’operaio. Se la sua attività è per lui un tormento,
deve essere per un altro un godimento, deve essere la gioia della vita altrui.
Non già gli dei, non la natura ma soltanto l'uomo stesso può essere questo
potere estraneo al disopra dell’uomo.
Si ripensi ancora alla tesi sopra esposta, che il rapporto dell’uomo con se
stesso è per lui un rapporto oggettivo e reale soltanto attraverso il rapporto
che egli ha con gli altri uomini.
Se quindi egli sta in rapporto al prodotto del suo lavoro, al suo lavoro
oggettivato come in rapporto ad un oggetto estraneo, ostile, potente,
indipendente da lui, sta in rapporto ad esso in modo che padrone di questo
oggetto è un altro uomo, a lui estraneo, ostile, potente, e indipendente da
lui. Se si riferisce alla sua propria attività, come a una attività non
libera, si riferisce a essa come a un'attività, che è al servizio e sotto il
dominio, la coercizione e il giogo di un altro uomo.
Ogni auto estraniazione dell’uomo da sé e dalla natura si rivela nel rapporto
che egli stabilisce tra sé e la natura da un lato e gli altri uomini, distinti
da lui, dall’altro. Perciò l’auto estraniazione religiosa appare
necessariamente nel rapporto del laico col prete, oppure - trattandosi qui del
mondo intellettuale - con un mediatore, ecc.
Nel mondo reale pratico l’auto estraniazione può presentarsi soltanto nel
rapporto reale pratico con gli altri uomini. Il mezzo con cui avviene
l’estraniazione, è esso stesso un mezzo pratico. Col lavoro estraniato l'uomo
costituisce quindi non soltanto il suo rapporto con l’oggetto e con l’atto
della produzione come rapporto con uomini estranei e ostili; ma costituisce pure
il rapporto in cui altri uomini stanno con la sua produzione e col suo prodotto,
e il rapporto in cui egli sta con questi altri uomini.
Come l’uomo fa della propria produzione il proprio annientamento, la propria
punizione, come pure fa del proprio prodotto una perdita, cioè un prodotto che
non gli appartiene, così pone in essere la signoria di colui che non produce,
sulla produzione e sul prodotto. Come egli rende a sé estranea la propria
attività, così rende propria all’estraneo l’attività che non gli è
propria.
Abbiamo sinora considerato il rapporto soltanto dal lato dell’operaio e lo
considereremo più tardi anche dal lato del non operaio.
Dunque, col lavoro estraniato, alienato, l’operaio pone in essere il rapporto
di un uomo che è estraneo e al di fuori del lavoro, con questo stesso lavoro.
Il rapporto dell’operaio col lavoro pone in essere il rapporto del capitalista
- o come altrimenti si voglia chiamare il padrone del lavoro - col lavoro. La
proprietà privata è quindi il prodotto, il risultato, la conseguenza
necessaria del lavoro alienato, del rapporto di estraneità, che si stabilisce
tra l’operaio, da un lato, e la natura e lui stesso dall'altro.
La proprietà privata si ricava quindi mediante l’analisi del concetto del
lavoro alienato, del lavoro estraniato, della vita estraniata, dell’uomo
estraniato.
Certamente abbiamo acquisito il concetto di lavoro alienato (di vita alienata),
traendolo dall’economia politica, come risultato del movimento della proprietà,
privata. Ma con un’analisi di questo concetto, si mostra che, anche se la
proprietà privata appare come il fondamento, la causa del lavoro alienato, essa
ne è piuttosto la conseguenza; allo stesso modo che originariamente gli dei non
sono la causa, ma l’effetto dell’umano vaneggiamento. Successivamente questo
rapporto si converte in un’azione reciproca.
Solo al vertice del suo svolgimento, la proprietà privata rivela il suo
segreto, vale a dire anzitutto che essa è il prodotto del lavoro alienato, in
secondo luogo che è il mezzo con cui il lavoro si aliena, è la realizzazione
di questa alienazione.
Questo svolgimento getta immediatamente luce su diverse contraddizioni sinora
non risolte: 1) l'economia politica, prende le mosse dal lavoro inteso come
l’anima propria della produzione, eppure non dà al lavoro nulla mentre dà
alla proprietà privata tutto.
Da questa contraddizione Proudhon ha concluso in favore del lavoro contro la
proprietà privata. Ma noi invece ci rendiamo conto che questa apparente
contraddizione è la contraddizione del lavoro estraniato con se stesso, e che
l'economia politica non ha fatto altro che esporre le leggi del lavoro
estraniato.
Quindi riconosciamo pure che salario e proprietà privata sono la stessa cosa,
poiché il salario, nella misura in cui il prodotto, l’oggetto del lavoro,
retribuisce il lavoro stesso, non è che una conseguenza necessaria
dell’estraniazione del lavoro; e infatti nel salario anche il lavoro non
appare come fine a se stesso, ma è in servizio della retribuzione, Vedremo ciò
minutamente più tardi; ora tiriamo ancora soltanto alcune poche conseguenze.
Un violento aumento del salario (prescindendo da tutte le altre difficoltà,
prescindendo dal fatto che essendo un’anomalia si potrebbe anche mantenere
soltanto con la violenza) non sarebbe altro che una migliore rimunerazione degli
schiavi e non eleverebbe né all’operaio né al lavoro la loro funzione umana
e la loro dignità.
Appunto l’uguaglianza dei salari quale è richiesta da Proudhon, non fa che
trasformare il rapporto dell’operaio d’oggi col suo lavoro in un rapporto di
tutti gli uomini col salario. La società viene quindi concepita come un
astratto capitalista.
Il salario è una conseguenza immediata del lavoro estraniato, e il lavoro
estraniato è la causa immediata della proprietà privata. Con l’uno deve
quindi cadere anche l’altro.
Dal rapporto del lavoro estraniato con la proprietà privata segue inoltre che
l’emancipazione della società dalla proprietà privata ecc., dalla schiavitù
si esprime nella forma politica della emancipazione degli operai, non già come
se si trattasse soltanto di questa emancipazione, ma perché in questa
emancipazione è contenuta l’emancipazione universale dell’uomo; la quale è
ivi contenuta perché nel rapporto dell’operaio con la produzione è incluso
tutto intero l'asservimento dell’uomo, e tutti i rapporti di servaggio altro
non sono che modificazioni e conseguenze del primo rapporto.
Avendo trovato mediante l’analisi del concetto della proprietà privata
partendo dal concetto del lavoro estraniato, alienato, ora possiamo col sussidio
di questi due fattori sviluppare tutte le categorie dell’economia politica, e
ritroveremo in ogni categoria come, ad es., lo scambio, la concorrenza, il
capitale, il denaro, solo una espressione determinata e sviluppata di questi
primi concetti fondamentali.
Ma prima di prendere in considerazione questa struttura, cerchiamo di svolgere
due temi:
Determinare l’essenza universale della proprietà privata, quale si è venuta
deducendo in quanto risultato del lavoro estraniato, nel suo rapporto con la
proprietà veramente umana e sociale;
Abbiamo accolto come un fatto l’estraniazione del lavoro, la sua alienazione,
e abbiamo analizzato questo fatto. Ora domandiamo: come arriva l’uomo a
alienare, ad estraniare il proprio lavoro?
Come questa estraniazione è fondata sull’essenza, dello svolgimento
dell’uomo? Per la risoluzione di questo tema, abbiamo già ottenuto molto,
avendo trasformato il problema dell’origine della proprietà privata nel
problema del rapporto del lavoro alienato con lo sviluppo storico dell’umanità.
E infatti, quando si parla della proprietà privata, si crede di aver a che fare
con una cosa fuori dell’uomo. Quando si parla del lavoro, si ha a che fare
immediatamente con l'uomo stesso. Questa nuova impostazione del problema
contiene già la sua soluzione.
L’essenza generale della proprietà privata è il suo rapporto con la proprietà
veramente umana.
Il lavoro alienato si è risolto per noi in due elementi che si condizionano a
vicenda, o meglio che sono soltanto due diverse espressioni di un identico
rapporto.
L’appropriazione si presenta come estraniazione, come alienazione, e
l'alienazione come appropriazione, la condizione di straniero come la vera
cittadinanza.
Abbiamo considerato un aspetto, il lavoro alienato in rapporto con l’operaio
stesso, cioè il rapporto del lavoro alienato con se stesso.
Quale prodotto, quale risultato necessario di questo rapporto abbiamo trovato il
rapporto di proprietà del non operaio nei confronti dell’operaio e del
lavoro.
La proprietà privata, intesa come l’espressione materiale, riassuntiva del
lavoro alienato, abbraccia entrambi i rapporti, tanto il rapporto dell’operaio
col lavoro e col prodotto del suo lavoro e col non-operaio, quanto il rapporto
del non-operaio con l’operaio e col prodotto del suo lavoro.
Avendo ormai visto che in relazione dell’operaio, che si appropria la natura
col lavoro, l’appropriazione si presenta come estraniazione, l’attività
propria come attività per un altro e come attività di un altro, la vitalità
come sacrificio della vita, la produzione dell’oggetto come perdita
dell’oggetto in favore di un potere estraneo, di un uomo estraneo, prendiamo
ora in considerazione il rapporto che corre tra questo uomo estraneo al lavoro e
all’operaio, il lavoro e il suo oggetto.
Primamente è da osservare che tutto ciò che nell’operaio appare come attività
di alienazione, di estraniazione, appare nel non-operaio come stato di
alienazione, di estraniazione.
In secondo luogo, che il comportamento pratico reale dell’operaio nella
produzione e nei confronti del prodotto (come stato d'animo) appare nel
non-operaio che gli sta di fronte come comportamento teorico.
In terzo luogo.
Il non-operaio fa contro l'operaio tutto ciò che l’operaio fa contro se
stesso, ma non fa contro se stesso quello che egli fa contro l'operaio.
Prendiamo a considerare più da vicino questi tre rapporti.
Karl Marx - 1844
62 - Della guerra di indipendenza in Italia (Karl Marx)
Secondo le ultime notizie giunte
dall’Italia, la disfatta subita dai piemontesi a Novara, non è affatto così
decisiva come hanno riferito i dispacci telegrafici inviati a Parigi.
I piemontesi sono battuti, tagliati da Torino e gettati nelle montagne. Questo
è tutto.
Se il Piemonte fosse una repubblica, se il governo di Torino fosse un governo
rivoluzionario ed avesse il coraggio di ricorrere ai mezzi rivoluzionari, nulla
sarebbe perduto. Ma l’indipendenza italiana sta per essere perduta, non in
seguito all’invincibilità delle armi austriache, ma per la viltà del potere
regio piemontese.
Perché gli austriaci hanno vinto? Perché, in seguito al tradimento di Ramorino,
due divisioni dell’esercito piemontese sono state separate dalle altre tre e
queste tre divisioni, rimaste isolate, sono state battute dalla violenza
numerica austriaca. Ora esse sono state respinte ai piedi delle valli Valdesi.
I piemontesi hanno commesso un errore enorme fin dall’inizio, contrapponendo
agli austriaci soltanto un esercito regolare e volendo condurre una guerra
ordinaria, borghese, “onesta”. Un popolo che vuole conquistarsi
l'indipendenza non deve limitarsi ai mezzi di guerra ordinari. L’insurrezione
in massa, la guerra rivoluzionaria, la guerriglia dappertutto, sono gli unici
mezzi con i quali un piccolo popolo può vincerne uno più grande con i quali un
esercito più debole può far fronte ad un esercito più forte e meglio
organizzato.
Gli spagnoli lo hanno dimostrato nel 1807-12. Gli ungheresi lo dimostrano ora.
Chrzanowski è stato battuto presso Novara e tagliato da Torino. Radetzky era a
nove miglia da Torino. Per una monarchia come quella piemontese, anche se
costituzionale, la campagna con questo è decisa e si domanda la pace a Radetzky.
Ma in una repubblica ciò non avrebbe deciso nulla. Se l’inevitabile viltà
della monarchia, la quale non ha mai avuto il coraggio di ricorrere ai mezzi
rivoluzionari estremi, non l’avesse fatta astenere da questi mezzi, la
sconfitta di Chrzanowski avrebbe potuto diventare una fortuna per l’Italia.
Se il Piemonte fosse una repubblica, che non deve nessun riguardo alle
tradizioni monarchiche, avrebbe la via aperta per finire la campagna in tutt’altro
modo.
Chrzanowski è stato respinto verso Biella e Borgomanero. Là, dove le Alpi
svizzere sbarrano ogni ulteriore ritirata, e le due o tre anguste valli fluviali
rendono impossibile la dispersione delle truppe, sarebbe facile concentrare
l’esercito e, con un’ardita marcia, rendere infruttuosa la vittoria di
Radetzky.
Se i capi dell’esercito piemontese avessero posseduto il coraggio
rivoluzionario, se essi avessero saputo che a Torino sedeva un governo
rivoluzionario risoluto fino all'estremo, il loro modo di agire sarebbe stato
semplicissimo.
Dopo la battaglia di Novara sul Lago Maggiore vi erano 30-40 mila uomini di
truppe piemontesi. Questi corpi, concentrati in due giorni, avrebbero potuto
gettarsi in Lombardia, dove vi erano non più di 12.000 austriaci, occupare
Milano, Brescia, Cremona; organizzare l’insurrezione generale, battere
separatamente i singoli corpi austriaci che sarebbero giunti dal Veneto, e far
così saltare in aria tutta la base d’operazioni di Radetzky.
Radetzky, invece di marciare contro Torino avrebbe dovuto voltare subito
indietro e ritirarsi in Lombardia, seguito dalla leva in massa dei piemontesi
che sarebbe stata appoggiata, naturalmente, dall’insurrezione lombarda.
Questa guerra veramente nazionale, una guerra come quella che condussero i
lombardi nel marzo 1848, quando Radetzky fu cacciato al di là dell’Oglio e
del Mincio, questa guerra avrebbe fatto sorgere tutta l'Italia alla lotta ed
infuso nei toscani e nei romani ben altre energie.
Mentre Radetzky si trovava ancora fra il Po ed il Ticino, riflettendo se doveva
andare avanti o tornare indietro, i piemontesi e i lombardi avrebbero potuto
marciare fino a Venezia, liberarla dall’assedio, disturbare o indebolire il
feldmaresciallo austriaco con un’infinità di operazioni dei guerriglieri,
attirare dalla loro parte Lamarmora, far giungere le truppe romane, spezzettare
le truppe di Radetzky ed infine batterlo. La Lombardia, che attendeva soltanto
l’arrivo dei piemontesi è insorta “senza attenderli”. Solo le cittadelle
austriache frenavano le città lombarde: 10 mila piemontesi erano già in
Lombardia, bastava che ne avanzassero ancora 20 o 30 mila e la ritirata di
Radetzky sarebbe stata impossibile.
Ma la rivolta delle masse, l’insurrezione generale del popolo sono mezzi che
il potere regio ha paura d’impiegare. Sono mezzi che soltanto la repubblica
impiega, lo prova il 1789. Sono mezzi la cui applicazione presuppone il terrore
rivoluziona rio; e quando mai c'è stato un monarca che si sia deciso per questi
mezzi?
Quello che ha rovinato gli italiani non sono le sconfitte di Novara e di
Vigevano, sono la viltà e la moderazione alle quali la monarchia li ha
costretti. La perdita della battaglia di Novara costituiva un pregiudizio
puramente strategico; essi erano tagliati da Torino mentre gli austriaci avevano
la via aperta verso questa città. Questo svantaggio sarebbe stato del tutto
insignificante se la battaglia perduta fosse stata seguita da una guerra
veramente rivoluzionaria, se i resti dell’esercito italiano si fossero subito
proclamati il nocciolo del sollevamento generale delle masse, se
l’”onesta” guerra strategica degli eserciti si fosse trasformata in una
guerra di popolo come quella condotta dai francesi nel 1793.
Ma, naturalmente, la monarchia non si arrischierà mai ad una guerra
rivoluzionaria, a un sollevamento delle masse, al terrore rivoluzionario.
Piuttosto di allearsi con il popolo, essa preferirà concludere la pace con il
suo peggiore nemico purché le sia pari di origine.
Carlo Alberto, sia o no un traditore, basta la sua corona, la monarchia, a
rovinare l’Italia.
Ma Carlo Alberto è un traditore. Su tutti i giornali francesi corre la notizia
di un grande complotto controrivoluzionario europeo di tutte le grandi potenze e
del piano di campagna della controrivoluzione la quale mira all’oppressione
definitiva di tutti i popoli europei. La Russia e l’Inghilterra, la Prussia e
l’Austria, la Francia e la Sardegna hanno firmato questa nuova Santa Alleanza.
Carlo Alberto aveva l’ordine di cominciare la guerra contro l’Austria, di
farsi battere dando così agli austriaci la possibilità di ristabilire la
“calma” in Piemonte, a Firenze e a Roma e di far concedere dappertutto delle
costituzioni da stato d’assedio. In cambio Carlo Alberto doveva ricevere Parma
e Piacenza, i russi l’incarico di “pacificare” l’Ungheria, la Francia
sarebbe diventata un impero e così sarebbe stata ristabilita la pace in Europa.
Secondo i giornali francesi questo è il grande piano della controrivoluzione e
questo piano spiega il tradimento di Ramorino e la sconfitta degli italiani.
Ma la vittoria di Radetzky ha assestato un nuovo colpo alla monarchia. La
battaglia di Novara e la successiva paralisi dei piemontesi dimostrano che nel
caso estremo in cui un popolo ha bisogno della massima tensione delle sue forze
per salvarsi, nulla gli è di maggior ostacolo della monarchia. Se l’Italia
non vuole perire per mano della monarchia, in Italia deve anzitutto perire la
monarchia.
Karl Marx (1849)
63 - Da “Rivoluzione e controrivoluzione in Germania” (Karl Marx)
...Ma l’insurrezione è un’arte, come la guerra
e le altre arti. Essa è soggetta a norme d’azione determinate le quali,
quando vengono trascurate, portano alla rovina del partito che le trascura.
Queste norme d’azione, che derivano logicamente dalla natura dei partiti e
dalle circostanze con cui si ha da fare nel caso determinato, sono così
semplici e chiare che la breve esperienza del 1848 le ha rese abbastanza note al
popolo tedesco.
Prima di tutto, non si deve mai giocare con l’insurrezione, se non si è
decisi ad accettare tutte le conseguenze del proprio gioco. L’insurrezione è
un’equazione con grandezze molto indeterminate, il cui valore può cambiare
ogni giorno; le forze che si oppongono a voi hanno tutti i vantaggi
dell’organizzazione, della disciplina e dell’autorità tradizionale; se non
opponete loro delle grandi forze, siete battuti e rovinati.
In secondo luogo, una volta incominciata l’insurrezione, si deve agire con la
più grande decisione, passare all’offensiva. La difensiva è la morte di ogni
insurrezione armata; se rimane sulla difensiva, l’insurrezione è sconfitta
prima di misurarsi col nemico. Bisogna sorprendere gli avversari mentre le loro
forze sono disperse e avere dei nuovi successi, sia pure piccoli, ma ogni
giorno; bisogna conservare l'ascendente morale datovi dalla prima sollevazione
vittoriosa; raccogliere così attorno a voi quegli elementi vacillanti, che
seguono sempre la spinta più forte e si schierano sempre dalla parte che ha dei
successi; dovete costringere il nemico a ritirarsi prima che abbia potuto
riunire le sue forze contro di voi; insomma, seguire le parole di Danton, il più
grande maestro di tattica rivoluzionaria finora conosciuto: “de l’audace, de
l’audace, encore de l’audace!”
Che cosa doveva fare dunque l’Assemblea nazionale di Francoforte, se voleva
sfuggire alla rovina sicura che la minacciava? Prima, di tutto, doveva rendersi
conto chiaramente della situazione e convincersi che non vi era altra
alternativa che sottomettersi senza condizioni ai governi, oppure far propria,
senza riserve e senza esitazione, la causa dell’insurrezione armata. Secondo:
riconoscere pubblicamente come legittime tutte le insurrezioni che già erano
scoppiate, a chiamare il popolo a prendere dappertutto le armi in difesa della
rappresentanza nazionale, mettendo fuori legge i principi, i ministri e tutti
coloro che osassero opporsi al popolo sovrano rappresentato dai suoi deputati.
Terzo: deporre immediatamente il reggente imperiale tedesco; creare un potere
esecutivo forte, attivo, senza timori; chiamare le truppe insorte a Francoforte,
per darle una protezione immediata, offrendo così in pari tempo un pretesto
legale all'estensione dell’insurrezione; organizzare in un solo corpo compatto
tutte le forze a sua disposizione e, in una parola, approfittare rapidamente e
senza esitazione di tutti i mezzi a sua disposizione per rafforzare la propria
posizione e indebolire quella degli avversari.
I virtuosi democratici dell'Assemblea di Francoforte fecero esattamente il
contrario di tutto ciò. Non contenti di lasciare che le cose prendessero il
corso che volevano, questi illustri signori arrivarono fino a soffocare con la
loro opposizione tutti i movimenti insurrezionali che si stavano preparando. Così
fece, per esempio, il signor Carlo Vogt a Norimberga. Lasciarono che le
insurrezioni della Sassonia, della Prussia Renana e della Vestfalia venissero
riprese senza che fosse dato loro altro aiuto che una protesta postuma,
sentimentale, contro la violenza brutale del governo prussiano. Mantennero un
contatto diplomatico segreto con gli insorti della Germania meridionale, ma non
dettero mai loro l’appoggio di un riconoscimento aperto. Sapevano che il
reggente dell’impero parteggiava per i governi e ciò nonostante chiesero a
lui - che non se ne dette per inteso - di opporsi agli intrighi di questi
governi. I ministri dell’impero, vecchi conservatori, in ogni seduta, si
facevano beffe di questa impotente Assemblea ed essa lo tollerava. E quando
Guglielmo Wolff - deputato della Slesia - (e uno dei redattori della “Neue
Rheinische Zeitung”), chiese loro di dichiarare fuori legge il reggente
dell’impero il quale, come egli giustamente dichiarò, non era altro che il
primo e principale traditore dell’impero, venne accolto con grida di sdegno
unanime e “virtuoso”, da questi democratici rivoluzionari! In breve, essi
continuarono a chiacchierare, protestare, lanciare dei proclami, fare delle
dichiarazioni, ma non ebbero mai né il coraggio né la capacità di agire; e ciò
mentre le truppe ostili dei governi avanzavano sempre più e il loro proprio
organo esecutivo, il reggente dell’impero, stava complottando con zelo,
insieme coi principi tedeschi, la loro rapida perdizione. Così perdette questa
spregevole Assemblea anche l’ultimo residuo di prestigio; gli insorti che si
erano sollevati per difenderla cessarono sempre più di occuparsene, e quando
finalmente terminò vergognosamente la sua esistenza, essa morì senza che
nessuno prestasse attenzione alla sua fine ingloriosa.
Karl Marx (1850)
64
- Una lettera della moglie di Carlo Marx (Jenny
Marx)
“...così entrò in casa Marx
la più nera miseria. Essa si palesa in modo commovente in una lettera diretta
dalla signora Marx a Weydemeyer. La riportiamo integralmente perché oltre al
suo valore biografico e letterario, rispecchia la figura di quella rara donna,
cui le sofferenze più tormentose non infransero la fierezza dell'animo, né
valsero a turbare la limpida serenità”. - Franz Mehring
20 maggio 1850
Caro signor Weydemeyer,
è trascorso quasi un anno da quando ebbi da lei e dalla sua cara moglie
un’accoglienza tanto amichevole, da quando in casa sua mi trovai tanto bene,
come a casa mia, e in tutto questo frattempo non ho dato alcun segno di vita.
Tacqui quando sua moglie mi scrisse tanto gentilmente, rimasi muta quando
ricevemmo la notizia della nascita del vostro bambino. Questo silenzio spesso
opprimeva me stessa, ma quasi sempre non riuscivo a scrivere e anche oggi lo
scrivere mi è molto penoso.
Ma le circostanze mi costringono a prendere in mano la penna. La prego di
inviarci quanto prima le somme ricavate o quelle che ancora si ricavano dalla
rivista (si tratta della “Neue Rheinische Zeitung”, edita da Marx e,
pubblicata dal marzo al novembre 1850 – nota nostra). Ne abbiamo molto, molto
bisogno. Non si può certo dire che noi abbiamo mai fatto gran chiasso attorno
ai sacrifici che da anni sopportiamo; ben poco o quasi mai abbiamo infastidito
il pubblico con le nostre questioni personali.
Mio marito è assai sensibile in queste cose e, piuttosto di prestarsi a questue
democratiche come usano i grandi uomini rappresentativi, sacrifica anche
l’ultima risorsa. Ma poteva ben aspettarsi dai suoi amici, specie a Colonia,
un interessamento attivo ed energico per la sua rivista. Poteva aspettarsi
questo interessamento soprattutto là dove i suoi sacrifici per la “Neue
Rheinische Zeitung” erano noti. L’azienda fu invece portata alla completa
rovina da una gestione negletta e disordinata, e non è dato sapere se il danno
maggiore sia venuto dagli indugi del libraio o dei gerenti e dei conoscenti di
Colonia, oppure dal comportamento della democrazia in generale.
Mio marito è rimasto qui quasi schiacciato dalle più meschine preoccupazioni
della vita quotidiana e ciò in modo così nauseante che, per sostenerlo in
queste lotte di ogni giorno, ci volle tutta la limpida, serena, cosciente
fermezza del suo carattere. Lei sa, caro signor Weydemeyer, quali sacrifici mio
marito abbia fatto per il giornale; per esso spese migliaia in contanti e,
spinto dalle belle parole dei gentiluomini democratici, assunse la proprietà
del giornale quando già esistevano poche prospettive di successo per salvare
l’onore politico del giornale e l’onore civile dei conoscenti di Colonia, si
assunse tutti gli oneri, sacrificò la sua macchina da stampa, sacrificò ogni
introito e, anzi, partendo, prese a prestito trecento talleri per pagare
l’affitto del nuovo locale e gli stipendi arretrati del redattore, ecc. Ed era
stato cacciato con la forza. Lei sa che non abbiamo serbato per noi nulla di
nulla; io andai a Francoforte per impegnare la mia argenteria, l’ultima cosa
che ci restava, feci vendere i miei mobili a Colonia. Quando incominciò
l’infelice periodo della controrivoluzione, mio marito andò a Parigi, io lo
seguii con i mie i tre bambini. Appena ambientati a Parigi scacciati di nuovo;
nemmeno a me e ai miei bambini fu concesso di soggiornare ulteriormente. Lo
seguii di nuovo, oltre mare, il mese dopo nasce il nostro quarto bambino. Lei
dovrebbe conoscere Londra e le condizioni locali per rendersi conto cosa
significhino tre bambini e la nascita di un quarto. Solo di affitto dovevamo
pagare 42 talleri al mese. Riuscimmo a coprire tutte queste spese con i mezzi
che ci eravamo procurati. Ma le nostre piccole risorse si esaurirono quando uscì
la rivista. Nonostante gli accordi il denaro non giunse, e poi giunse di volta
in volta, in piccole somme, in modo da farci trovare nelle più tremende
situazioni.
Le descriverò una sola giornata di quella vita, così come si svolgeva e lei si
renderà conto che forse pochi profughi sono passati attraverso simili
peripezie. Siccome qui le balie sono troppo care, decisi di allattare io stessa
il mio bambino nonostante continui, tremendi dolori al petto e alla schiena. Ma,
il povero angioletto assorbiva assieme al mio latte, tante preoccupazioni e
intimi crucci che era continuamente malaticcio e soffriva giorno e notte di
acuti dolori. Da quando è al mondo non ha ancora dormito tutta una notte,
tutt’al più due o tre ore. Ultimamente sopravvennero pure violente
convulsioni così che il bambino è stato continuamente sospeso tra la morte e
una vita di sofferenze. Durante questi spasimi succhiava con tale forza, che il
mio petto si piagava e sanguinava, e spesso il sangue, colava nella sua
boccuccia tremante. Un giorno, mentre ero in queste condizioni, apparve d’un
tratto la nostra padrona di casa cui avevamo pagato più di 250 talleri e con la
quale ci eravamo accordati per contratto di pagare le somme ulteriori non a lei
ma al suo padrone di casa, il quale per l’addietro le aveva fatto fare il
pignoramento. Ora essa non riconosceva il contratto ed esigeva cinque lire
sterline di cui le saremmo stati debitori, e poiché al momento non le avevamo,
entrarono in casa due pignoratori e misero sotto sequestro tutto il mio piccolo
avere: letti, biancheria, vestiti, tutto, perfino la culla del mio misero
bambino ed i migliori giocattoli delle bambine che assistevano piangendo
dirottamente. Minacciarono di prendere tutto entro due ore. Io giacevo in terra
con i bambini tremanti di freddo, con il mio petto dolorante. Schramm, un amico
nostro corre in città in cerca di aiuto: prende una vettura, i cavalli
imbizzariscono, egli salta a terra e ce lo portano sanguinante a casa, dove
stavo piangendo con miei poveri bambini tremanti.
Il giorno dopo dovemmo lasciare la casa, faceva freddo, un tempo fosco e
piovoso, mio marito va in cerca di un’abitazione, nessuno vuole prenderci
appena si parla di quattro bambini. Finalmente un amico ci aiuta, paghiamo e io
vendo in fretta tutti i miei letti per pagare il farmacista, fornaio, macellaio,
lattaio che messi in allarme dallo scandalo del sequestro, d’un tratto mi
assalgono con i loro conti. I letti venduti vengono portati davanti alla porta,
caricati su di un carretto. Ma che succede? Si era fatto tardi, il sole era
tramontato, la legge inglese non lo permette, il padrone di casa si fa avanti
con due gendarmi sostenendo che poteva esserci della roba sua, che noi volevamo
fuggire in un paese straniero. In meno di cinque minuti più di due o trecento
persone erano davanti la nostra porta, tutta la plebaglia di Chelsea. I letti
ritornano in casa. Soltanto la mattina seguente, dopo la levata del sole, è
permesso consegnarli al compratore. Messi in condizione di pagare fino
all’ultimo centesimo con la vendita di tutta la nostra roba, mi trasferii con
i miei piccoli tesori nelle due stanzette che attualmente occupiamo
nell’albergo tedesco, (1, Leicester street - Leicester Square) dove trovammo
per 5 sterline e mezza alla settimana un’accoglienza umana.
Perdoni, caro amico, se le ho descritto in modo così ampio e prolisso sia pure
una sola giornata della nostra vita di qui; è immodesto, lo so, ma questa sera
il mio cuore si è riversato nelle mie mani tremanti e sentivo di dovere una
volta tanto sfogare il mio cuore con uno dei nostri più vecchi, migliori, più
fedeli amici. Non creda che queste meschine sofferenze mi abbiano piegata, so
troppo bene che la mostra lotta non è una lotta isolata e che personalmente mi
è toccata la sorte di essere fortunata e favorita ben più di altri poiché è
al mio fianco anche il mio caro marito, il sostegno della mia vita. Ma ciò che
veramente annienta il mio animo e fa sanguinare il mio cuore è il fatto che mio
marito è costretto a subire tanta meschinità, mentre un’inezia sarebbe
bastata per sollevarlo e che colui che volentieri e con gioia aiutò tanti
altri, rimase senza aiuto. Ma non creda, caro signor Weidermeyer che avanziamo
pretese verso chicchessia. L’unica cosa che mio marito poteva esigere da
coloro che più di una volta ebbero da lui idee, sollievo e appoggio era che
accudissero alla sua rivista con maggiore energia commerciale, con maggiore
interessamento. Ardisco sostenerlo con fierezza. Almeno quel poco gli si doveva.
Nessuno, credo, ne sarebbe rimasto gabbato. Questo mi addolora. Mio marito però
la pensa diversamente. Mai e poi mai, nemmeno nelle più terribili circostanze,
gli vennero meno la certezza nell’avvenire e la piena serenità dello spirito,
ed egli era sempre intimamente contento quando mi vedeva serena e quando i
nostri deliziosi bambini circondavano e accarezzavano la loro cara mamma. Egli
non sa, caro signor Weidermeyer che io le ho scritto tanto ampiamente sulle
nostre condizioni; non faccia dunque alcun uso di queste righe. Egli sa soltanto
che a nome suo le ho rivolto la preghiera di sollecitare, più che possibile la
riscossione e l’invio del denaro.
Addio, caro amico! Saluti di tutto cuore la sua cara moglie da parte mia, e dia
un bacio al suo angioletto da parte di una madre che tante lagrime ha versato
sul suo bambino. I nostri tre figlioli maggiori crescono magnificamente
nonostante tutto. Le ragazze sono graziose, fiorenti, serene e di buon umore e
il grosso maschietto un portento di allegria e inesauribile nelle più buffe
trovate. Quel piccolo folletto canta tutto il giorno con enfasi grandiosa, e con
voce tonante, e quando intona col suo vocione le parole della “Marseillaise”
di Freiligrath: “Vieni o giugno e portaci imprese, nuove imprese ambisce il
nostro cuor”, tutta la casa rimbomba. Forse la storia universale riserva a
questo mese, come ai suoi due sfortunati predecessori, il compito di dare inizio
alla lotta titanica in cui tutti ci stringeremo di nuovo la mano. Addio!
Jenny Marx
65
- Sulla tomba di Marx (Friedrich Engels)
Il 14 marzo, alle due e
quarantacinque pomeridiane, ha cessato di pensare la più grande mente
dell’epoca nostra. L’avevamo lasciato solo da appena due minuti e al nostro
ritorno lo abbiamo trovato, tranquillamente addormentato nella sua poltrona, ma
addormentato per sempre.
Non è possibile misurare la gravità della perdita che questa morte,
rappresenta per il proletariato militante d’Europa e d’America, nonché per
la scienza storica! Non si tarderà a sentire il vuoto lasciato dalla scomparsa
di questo titano.
Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica,
Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana e cioè il fatto
elementare, finora nascosto sotto l'orpello ideologico, che gli uomini devono
innanzi tutto, mangiare, bere, avere un tetto e vestirsi, prima di occuparsi di
politica, di scienza, di arte, di religione, ecc.; e che, per conseguenza, la
produzione dei mezzi materiali immediati di esistenza e, con essa, il grado di
sviluppo economico di un popolo e di un’epoca in ogni momento determinato
costituiscono la base sulla quale si sviluppano le istituzioni statali, le
concezioni giuridiche, l’arte ed anche le idee religiose degli uomini e
partendo dalla quale esse devono venir spiegate e non inversamente come si era
fatto finora.
Ma non è tutto. Marx ha anche scoperto la legge peculiare dello sviluppo del
moderno modo di produzione capitalistico e della società borghese da esso
generata. La scoperta del plusvalore ha subitamente gettato un fascio di luce
nell’oscurità in cui brancolavano prima, in tutte le loro ricerche, tanto gli
economisti borghesi che i critici socialisti.
Due scoperte simili sarebbero più che sufficienti a riempire tutta una vita.
Fortunato chi avesse avuto la sorte di farne anche una sola. Ma in ognuno dei
campi in cui Marx ha svolto le sue ricerche - e questi campi furono molti e
nessuno fu toccato da lui in modo superficiale - in ognuno di questi campi,
compreso quello delle matematiche egli ha fatto delle scoperte originali.
Tale era lo scienziato. Ma lo scienziato non era neppure la metà di Marx. Per
lui la scienza era una forza motrice della storia, una forza rivoluzionaria. Per
quanto grande fosse la gioia che gli dava ogni scoperta in una qualunque
disciplina teorica, e di cui non si vedeva forse ancora l’applicazione
pratica, una gioia ben diversa gli dava ogni innovazione che determinasse un
cambiamento rivoluzionario immediato nell’industria e in generale, nello
sviluppo storico. Così egli seguiva in tutti i particolari le scoperte nel
campo dell'elettricità e, ancora in questi ultimi tempi, quelle di Marcello
Deprez.
Perché Marx era prima di tutto un rivoluzionario. Contribuire in un modo o
nell’altro all’abbattimento della società capitalistica e delle istituzioni
statali che essa ha creato, contribuire all’emancipazione del proletariato
moderno al quale egli, per primo, aveva dato la coscienza della propria
situazione e dei propri bisogni, la coscienza delle condizioni della propria
liberazione: questa era la sua reale vocazione. La lotta era il suo elemento. Ed
ha combattuto con una passione, con una tenacia e con un successo come pochi
hanno combattuto.
La prima “Rheinische Zeitung” nel 1842, il “Vorwärts” di Parigi nel
1844, la “Deutsche Brüsseler Zeitung” nel 1847, la “Neue Rheinische
Zeitung” nel 1850, la “New York Tribune” dal 1852 al 1861 e, inoltre, i
numerosi opuscoli di propaganda, il lavoro a Parigi, a Bruxelles, a Londra, il
tutto coronato dalla grande “Associazione Internazionale degli operai”, ecco
un altro risultato di cui colui che lo ha raggiunto potrebbe essere fiero anche
se non avesse fatto niente altro.
Marx era perciò l’uomo più odiato e calunniato dal suo tempo. I governi
assoluti e repubblicani, lo espulsero; i borghesi, conservatori e democratici
radicali, lo coprirono a gara di calunnie. Egli sdegnò tutte queste miserie,
non prestò loro nessuna attenzione e non rispose se non in caso di estrema
necessità. È morto venerato, amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro
rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla
California. E posso aggiungere, senza timore: poteva avere molti avversari, ma
nessun nemico personale.
Il suo nome vivrà nei secoli, e così la sua opera!
Friedrich Engels
(Discorso pronunciato al cimitero di Highgate, Londra, il 17 marzo 1883)
66
– I destini storici della dottrina di Carlo Marx (Nicolaj Lenin)
Il punto essenziale della
dottrina di Karl Marx è l’interpretazione della funzione storica mondiale del
proletariato come creatore della società socialista. Ha il corso degli
avvenimenti nel mondo intero confermato questa dottrina, dopo che essa venne
annunciata da Marx?
Marx la formulò per la prima volta nel 1844. Il “Manifesto comunista” di
Marx ed Engels, pubblicato nel 1848, ne dà già un’esposizione completa e
sistematica, rimasta, fino ad oggi, la migliore. Da allora, la storia universale
si divide manifestamente in tre periodi principali:
dalla rivoluzione del 1848 alla Comune di Parigi (1871);
dalla comune di Parigi alla rivoluzione russa (1905);
dalla rivoluzione russa ai nostri giorni.
Diamo uno sguardo ai destini della dottrina di Marx in ciascuno di questi tre
periodi.
I) All’inizio del primo periodo, la dottrina di Marx non predomina affatto.
Essa non rappresenta che una delle frazioni o correnti straordinariamente
numerose del socialismo. Predominano, invece, quelle forme di socialismo che, in
sostanza, sono apparentate al nostro populismo (russo): incomprensione della
base materialistica del movimento storico, incapacità di discernere la funzione
e l'importanza di ciascuna delle classi della società capitalistica,
dissimulazione della natura borghese delle riforme democratiche con frasi
pseudosocialiste sul “popolo”, la “giustizia”, il “diritto”, ecc.
La rivoluzione del 1848 assesta un colpo mortale a tutte queste forme rumorose,
variopinte, chiassose del socialismo premarxista. In tutti i paesi, la
rivoluzione ci mostra le diverse classi della società all’opera. Il massacro
degli operai parigini consumato dalla borghesia repubblicana, nelle giornate del
giugno 1848, attesta in modo definitivo la natura socialista del solo
proletariato. La borghesia liberale teme l’indipendenza di questa classe,
cento volte più di qualsiasi reazione. Il liberalismo vile striscia dinanzi
alla reazione. I contadini si accontentano dell’abolizione delle vestigia
feudali e si schierano a fianco dell’ordine, di rado esitando tra la
democrazia operaia, e il liberalismo borghese. Tutte le dottrine che parlano di
un socialismo non classista, di una politica non classista, dimostrano di essere
frottole vane.
La Comune di Parigi (1871) porta a compimento questo sviluppo delle
trasformazioni borghesi; la repubblica, cioè la forma di organizzazione statale
nella quale i rapporti di classe si manifestano nel modo meno velato, deve il
suo consolidamento soltanto all’eroismo del proletariato.
Di tutti gli altri paesi di Europa, uno sviluppo più confuso e meno completo
conduce alla stessa società borghese. Alla fine del primo periodo (1848-1871),
periodo di burrasche e di rivoluzioni, il socialismo premarxista muore. Nascono
i partiti proletari indipendenti: la Iª Internazionale (1864-1872) e la
socialdemocrazia tedesca.
II) Il secondo periodo (1872-1904) si distingue dal primo per il suo carattere
“pacifico”, per l’assenza di rivoluzioni. L'Occidente ha terminato le
rivoluzioni borghesi. L’Oriente non è ancora maturo per esse.
L'Occidente entra nella fase della preparazione “pacifica”
dell’epoca delle trasformazioni future. Dappertutto si formano dei partiti
socialisti, proletari per la loro base, che imparano a servirsi del
parlamentarismo borghese, a creare la loro stampa quotidiana, le loro
istituzioni di organizzazione, i loro sindacati, le loro cooperative. La
dottrina di Marx riporta una completa vittoria e si diffonde in estensione.
Lentamente, ma inflessibilmente continua il processo di selezione e di
raggruppamento delle forze del proletariato, di preparazione, alle battaglie
future.
La dialettica della storia è tale, che la vittoria del marxismo teorico
costringe i suoi nemici a travestirsi da marxisti. Il liberalismo, interiormente
putrefatto, tenta di rivivere nella veste dell’opportunismo socialista. Esso
interpreta il periodo della preparazione delle forze per le grandi battaglie
come una rinuncia a queste battaglie. Esso intende il miglioramento della
condizioni della lotta degli schiavi contro la schiavitù del salario nel senso
di una vendita per qualche quattrino, da parte degli schiavi, dei loro diritti
alla libertà. Esso predica vilmente “la pace sociale” (ossia la pace con lo
schiavismo), la rinuncia alla lotta di classe, e così via. L’opportunismo
trova moltissimi fautori tra i deputati socialisti al parlamento, i vari
funzionari del movimento operaio e gli intellettuali “simpatizzanti”.
III) Gli opportunisti non erano ancora riusciti a glorificare la “pace
sociale” e l’assenza di necessità di burrasche nella “democrazia” che
una nuova fonte delle più grandi tempeste mondiali si apriva in Asia. La
rivoluzione russa (del 1905) era seguita dalle rivoluzioni turca, persiana e
cinese. Oggi (1913) noi attraversiamo precisamente l’epoca di queste tempeste
e della loro “ripercussione” in Europa. Qualunque sia la sorte della grande
repubblica cinese, contro la quale oggi aguzzano i denti le diverse iene
“civili”, nessuna forza al mondo riuscirà a ristabilire il vecchio
servaggio in Asia, né spazzerà dalla faccia della terra il democratismo eroico
delle masse popolari dei paesi asiatici e semiasiatici.
Taluni, che non tenevano nel dovuto conto le condizioni di preparazione e di
sviluppo della lotta delle masse, sono caduti nella disperazione e
nell’anarchismo, vedendo lungamente differita la lotta decisiva contro il
capitalismo in Europa. Noi vediamo oggi come questa disperazione anarchica sia
miope e pusillanime.
Non disperazione, ma coraggio bisogna attingere dal fatto che 800 milioni di
asiatici sono trascinati nella lotta per gli stessi ideali europei.
Le rivoluzioni dell'Asia ci hanno mostrato la stessa mancanza di carattere e la
stessa viltà del liberalismo, la stessa straordinaria importanza
dell'indipendenza delle masse democratiche, la stessa demarcazione netta tra il
proletariato e qualsiasi borghesia. Dopo l'esperienza dell’Europa e dell'Asia,
chi parla di una politica non classista e di un socialismo non classista merita
semplicemente di essere esposto in una gabbia insieme a un canguro australiano.
Dopo l’Asia si è messa in movimento l’Europa, ma non alla maniera asiatica.
Il periodo “pacifico” del 1872-1904 appartiene a un passato scomparso per
sempre. Il carovita e il giogo dei trust provocano un inasprimento inaudito
della lotta economica, che scuote financo gli operai inglesi, i più corrotti
dal liberalismo. Una crisi politica matura sotto i nostri occhi nella stessa
Germania, nella “cittadella” della borghesia e dei grandi proprietari
fondiari. Gli armamenti folli e la politica dell’imperialismo danno
all’Europa moderna una “pace sociale” che assomiglia piuttosto a un barile
di dinamite. E la decomposizione di tutti i partiti borghesi e la maturazione
del proletariato proseguono intanto ininterrottamente.
Ciascuno dei tre grandi periodi della storia universale posteriori
all’apparizione del marxismo, ha portato al marxismo nuove conferme e nuovi
trionfi. Ma il prossimo periodo storico apporterà al marxismo, dottrina del
proletariato, un trionfo ancora più grande.
Nicolaj Lenin - 1913 (1870-1924)
Mehring racconta nelle note di
cui corredò la sua edizione degli articoli di Marx pubblicati nel 1848 nella
“Nuova gazzetta renana” che le pubblicazioni borghesi facevano tra l’altro
la seguente accusa a questo giornale: la “Nuova gazzetta renana”, avrebbe
rivendicato l’istituzione immediata della dittatura, come unico mezzo per
realizzare la democrazia. Dal punto di vista borghese volgare la nozione di
dittatura e la nozione di democrazia si escludono l’un l’altra. Non
comprendendo la teoria della lotta di classe, assuefatto a vedere sulla scena
della lotta politica le meschine baruffe dei diversi gruppi e “coteries”
della borghesia, il borghese per dittatura intende l'assenza di ogni libertà e
di ogni garanzia democratica, l’arbitrio generalizzato, l’abuso
generalizzato del potere negli interessi personali del dittatore. In fondo, è
proprio questa concezione borghese volgare che trapela nel nostro Martynov,
allorché, per terminare la sua “nuova campagna” nella nuova “Iskra”,
egli spiega la predilezione (...) per la parola d’ordine della dittatura col
fatto che Lenin “desidera ardentemente tentare la sua sorte”, per spiegare a
Martynov la differenza che esiste tra la nozione di dittatura di una classe e
quella di dittatura di un individuo, tra i compiti della dittatura democratica e
quelli della dittatura socialista, non sarà inutile soffermarci sulle opinioni
della “Nuova gazzetta renana”.
“Ogni organizzazione provvisoria dello Stato - scrive la “Nuova gazzetta”,
il 14 settembre 1848 - dopo la rivoluzione esige la dittatura, e una dittatura
energica. Noi abbiamo sin dall'inizio rimproverato a Camphausen (presidente del
Consiglio dei ministri dopo il 18 marzo 1848), di non agire in modo
dittatoriale, di non spezzare ed estirpare immediatamente i resti delle vecchie
istituzioni. E mentre il signor Camphausen si cullava nelle illusioni
costituzionali, il partito vinto (ossia quello della reazione) rafforzava le sue
posizioni nella burocrazia e nell’esercito e qua e là si arrischiava persino
a riprendere di nuovo apertamente la lotta”.
In queste parole - come disse giustamente Mehring - è riassunto in poche tesi
ciò che è stato sviluppato con ricchezza di particolari dalla “Nuova
gazzetta renana”, in lunghi articoli sul ministero Camphausen. Che cosa ci
dicono queste parole di Marx? Che il governo rivoluzionario provvisorio deve
agire dittatorialmente (tesi che, nel sacro orrore per le parole d’ordine di
dittatura l”Iskra” non ha mai potuto comprendere), che il compito di questa
dittatura è di distruggere i resti delle vecchie istituzioni (...). Infine e in
terzo luogo da queste parole risulta che Marx sferzava i democratici borghesi
per le loro “illusioni costituzionali” nell'epoca della rivoluzione e della
guerra civile aperta. Il vero senso di queste parole risulta con maggior rilievo
dall’articolo della “Nuova gazzetta renana”, del 6 giugno 1848.
“L'Assemblea costituente popolare - scriveva Marx - deve essere innanzi tutto
una assemblea attiva, rivoluzionariamente attiva. E l'Assemblea di Francoforte
si occupa di esercizi scolastici di parlamentarismo e lascia al governo la cura
di agire. Ammettiamo che questo dotto concilio riesca, dopo matura riflessione,
ad elaborare il miglior ordine del giorno e la migliore costituzione. A che varrà
il migliore ordine del giorno e la migliore costituzione, se nel frattempo i
governi tedeschi avranno già messo all’ordine del giorno la baionetta?”
Ecco il senso della parola d’ordine: “dittatura”. Si può vedere da ciò
quale sarebbe stato l'atteggiamento di Marx verso le risoluzioni che chiamano
vittoria decisiva “la decisione di organizzare l'Assemblea costituente”, o
invitano “a rimanere il partito di estrema opposizione rivoluzionaria”!
I grandi problemi della vita dei popoli vengono risolti esclusivamente con la
forza. Le classi più reazionarie sono abitualmente le prime a far ricorso alla
forza, alla guerra civile, a “mettere all’ordine del giorno la baionetta”,
come ha fatto e continua a fare sistematicamente, inflessibilmente, sempre e
dappertutto l’autocrazia russa sin dal 9 gennaio. E dal momento che una tale
situazione si è creata, dal momento che la baionetta figura realmente in testa
all’ordine del giorno politico e che l’insurrezione si è dimostrata
necessaria e urgente, le illusioni costituzionali e gli esercizi scolastici di
parlamentarismo non servono più che a nascondere il tradimento della borghesia
verso la rivoluzione, a nascondere il modo con cui la borghesia “si
allontana” dalla rivoluzione. La classe effettivamente rivoluzionaria deve
allora enunciare precisamente la parola d'ordine della dittatura.
A proposito dei compiti di questa dittatura, Marx scriveva, sempre sulla
“Nuova gazzetta renana”:
“L’Assemblea nazionale avrebbe dovuto agire dittatorialmente contro le
velleità reazionarie dei governi invecchiati; e allora si sarebbe conquistata
nell’opinione popolare una forza tale contro la quale tutte le baionette si
sarebbero spezzate... Questa Assemblea, al contrario, stanca il popolo tedesco
con dei discorsi noiosi, invece di trascinarlo al suo seguito o di esserne
trascinata”. L’Assemblea nazionale avrebbe dovuto, secondo Marx,
“eliminare dal regime che esiste effettivamente in Germania tutto ciò che è
contrario al principio della sovranità del popolo”, e quindi “consolidare
il terreno rivoluzionario sul quale essa poggia e premunire contro tutti gli
attacchi la sovranità del popolo conquistata dalla rivoluzione”.
Per conseguenza, i compiti che Marx assegnava nel 1848 al governo rivoluzionario
o alla dittatura, si riducevano in sostanza innanzi tutto alla rivoluzione
democratica: difesa contro la controrivoluzione ed eliminazione effettiva di
tutto ciò che è contrario alla sovranità del popolo. Ciò è appunto la
dittatura democratica rivoluzionaria e null'altro.
Proseguiamo. Quali sono le classi che, secondo Marx, potevano e dovevano
realizzare questo compito (realizzare fino in fondo il principio della sovranità
del popolo e respingere gli attacchi della controrivoluzione)? Marx parla del
“popolo”. Ma noi sappiamo che egli combatté sempre implacabilmente contro
le illusioni piccolo-borghesi sulla unità del popolo, sull’assenza della
lotta di classe in seno al popolo. Impiegando la parola “popolo”, Marx non
velava con questo termine la distinzione fra le classi, ma riuniva in questo
termine elementi determinati, capaci di condurre a termine la rivoluzione.
Dopo la vittoria del proletariato berlinese del 18 marzo - scriveva la “Nuova
gazzetta renana” i risultati della rivoluzione si sono rivelati duplici:
“Da una parte l’armamento del popolo, la libertà di associazione, la
sovranità del popolo effettivamente conquistata; dall’altra, il mantenimento
della monarchia e il ministero Camphausen-Hansemann, un governo cioè di
rappresentanti della grande borghesia. La rivoluzione ha avuto così risultati
di due sorte che dovevano inevitabilmente finire con una rottura. Il popolo ha
vinto; esso ha conquistato delle libertà di carattere decisamente democratico,
ma il dominio effettivo non è passato nelle sue mani, ma nelle mani della
grande borghesia. Insomma, la rivoluzione non è stata condotta a termine. Il
popolo ha lasciato ai rappresentanti della grande borghesia la cura di fornire
il ministero e questi rappresentanti della grande borghesia hanno subito
rivelato i loro intenti, proponendo un’alleanza alla vecchia nobiltà
prussiana e alla burocrazia. Arnim, Kanitz e Schwerin sono entrati nel
ministero.
Per paura del popolo, vale a dire del proletariato e della borghesia
democratica, la grande borghesia, sin dall’inizio antirivoluzionario, ha
concluso con la reazione un’alleanza difensiva e offensiva!
Così non soltanto la “decisione di organizzare l'Assemblea costituente” non
è ancora sufficiente per la vittoria decisiva della rivoluzione, ma non lo è
neppure la sua convocazione effettiva! Anche dopo una vittoria parziale nella
lotta armata (vittoria degli operai berlinesi sulla truppa, il 18 marzo 1848),
è possibile una rivoluzione “incompleta”, “non portata a termine”. Da
che cosa dipende dunque la possibilità di condurre a termine la rivoluzione? Da
questo: in quali mani passa il dominio effettivo, in quelle dei Petrunkevic e
dei Rodicev, vale a dire dei Camphausen e degli Hansemann, oppure nelle mani del
popolo, vale a dire degli operai e della borghesia democratica. Nel primo caso
la borghesia avrà il potere, e il proletariato la “libertà di criticare”,
la libertà di “rimanere il partito di estrema opposizione rivoluzionaria”.
Subito dopo la vittoria, la borghesia concluderà una alleanza con la reazione
(ciò che avverrebbe inevitabilmente anche in Russia se, ad es., gli operai
pietroburghesi riportassero solo una vittoria parziale nella battaglia di strada
contro la truppe e lasciassero ai signori Petrunkevic e consoci la cura di
formare il nuovo governo). Nel secondo caso, la dittatura democratica
rivoluzionaria, vale a dire la vittoria completa della rivoluzione, sarebbe
possibile.
Rimane a determinare con maggiore precisione ciò che Marx intendeva
propriamente per “borghesia democratica” (demokratische Bürgerschaft), che
egli chiamava, insieme con gli operai, “popolo”, contrapponendola alla
grande borghesia.
Il seguente brano dell’articolo della “Nuova gazzetta renana” del 29
luglio 1848, dà una chiara risposta a questa domanda:
“…La rivoluzione tedesca del 1848 non è che una parodia della rivoluzione
francese del 1785.
Il 4 agosto 1789, tre settimane dopo la presa della Bastiglia, il popolo
francese in una sola giornata, ebbe ragione di tutti gli obblighi feudali.
L’11 luglio del 1848, quattro mesi dopo le barricate di marzo, gli obblighi
feudali hanno avuto ragione del popolo tedesco. (...)
La borghesia francese del 1789 non abbandonò nemmeno per un istante i suoi
alleati, i contadini. Essa sapeva che la base del suo dominio era l’abolizione
del feudalesimo nei villaggi e il sorgere di una classe libera di contadini
proprietari (Grundbesitzenden).
La borghesia tedesca dal 1848 tradisce senza alcuno scrupolo i contadini, i suoi
alleati più naturali, che sono carne della sua carne, e senza i quali è
impotente di fronte alla nobiltà.
Il mantenimento dei diritti feudali, la loro consacrazione sotto l’apparenza
(illusoria) di un riscatto: tale è il risultato della rivoluzione tedesca del
1848. La montagna ha partorito un topo!
Brano molto istruttivo, che ci dà quattro tesi importanti: 1) La rivoluzione
tedesca incompiuta differisce dalla Rivoluzione francese portata a termine in ciò:
che la borghesia tradì non solamente la democrazia in generale, ma anche i
contadini in particolare. 2) La realizzazione completa di una rivoluzione
democratica ha per base la creazione di una classe libera di contadini. 3)
Creare questa classe, significa abolire gli obblighi feudali, distruggere il
feudalesimo; ma con ciò non è ancora affatto la rivoluzione socialista. 4) I
contadini sono gli alleati più naturali della borghesia, e appunto della
borghesia democratica la quale, senza di essi, è “impotente” di fronte alla
reazione.
Tutte queste tesi, modificate conformemente alle nostre particolarità nazionali
concrete, sostituendo il servaggio al feudalesimo, possono essere applicate per
intero alla Russia del l905.
Non vi è dubbio che gli insegnamenti tratti dall’esperienza tedesca,
illustrata da Marx, non possono condurci a nessun’altra parola d’ordine di
vittoria decisiva della rivoluzione che non sia quella di dittatura democratica,
rivoluzionaria del proletariato e dei contadini. Non v’è dubbio che le
principali parti costituenti il “popolo”, che Marx contrapponeva nel 1848
alla reazione che resisteva ed alla perfida borghesia, sono il proletariato e i
contadini.
N. Lenin (1905)
68
- Il crollo della seconda Internazionale (Zinoviev
e Lenin)
I socialisti di tutti i paesi
dichiararono liberamente a Basilea nel 1912 di considerare la futura guerra
europea come opera delittuosa e reazionaria di tutti i governi e affermarono
altresì doversi affrettare il crollo del capitalismo e la rivoluzione contro di
esso. Scoppiata la guerra, la maggioranza dei partiti socialisti ha seguito, in
luogo d’una tattica rivoluzionaria, una tattica reazionaria, schierandosi a
lato dei rispettivi governi e delle rispettive borghesie.
Questo tradimento al socialismo significa il crollo della seconda Internazionale
(1889-1914) e noi dobbiamo renderci conto delle cause di un simile crollo, delle
origini del social-patriottismo e di ciò da cui proviene la sua forza.
In tutta la storia della seconda internazionale si è avuta, in tutti i paesi
socialisti, la lotta fra gli elementi rivoluzionari e quelli opportunistici. In
una quantità di paesi ne è conseguita una scissione (Olanda, Inghilterra,
Italia, Bulgaria).
Nessun marxista ha messo in dubbio che l’opportunismo rappresenti la politica
borghese nel movimento dei lavoratori, che risponda agli interessi della piccola
borghesia, che significhi l’unione di una ristretta cerchia
dell’aristocrazia dei lavoratori con la loro borghesia, unione che si volge
contro gli interessi della massa dei lavoratori oppressi.
Le condizioni obiettive dei tempi, alla fine del sec. XIX hanno rafforzato in
modo particolare l’opportunismo con la trasformazione della legalità borghese
in una genuflessione dinanzi ad essa, con la creazione di una piccola cerchia
della burocrazia e aristocrazia dei lavoratori, con l’entrata nelle file del
socialismo di moltissimi elementi della piccola borghesia.
La guerra ha accelerato l’evoluzione (o involuzione?) trasformando
l’opportunismo in social-patriottismo, e il legame segreto dell’opportunismo
con la borghesia in un legame palese. Da per tutto le autorità militari hanno
posto lo stato di guerra, che incatena la classe lavoratrice, mentre in pari
tempo gli antichi capi sono, nella grande maggioranza, passati nel campo della
borghesia. La base economica dell’opportunismo e del socialpatriottismo è la
medesima: gli interessi d'una piccola cerchia di lavoratori privilegiati e
piccolo borghesi, i quali difendono i loro privilegi, il loro diritto alle
briciole della mensa della loro borghesia, il loro diritto a una parte di quei
profitti dei borghesi che si traggono dal saccheggio imperialistico.
Il concetto politico del social-patriottismo e dell'opportunismo è il medesimo:
collaborazione di classe in luogo di lotta di classi, diniego di mezzi di lotta
rivoluzionaria e sottomissione al proprio governo nella sua difficile posizione,
in luogo di sfruttamento di questa ai fini rivoluzionari. (...)
La solidarietà con l’opportunismo è ora una completa ipocrisia di cui dà
l’esempio il socialismo tedesco. In tutte le circostanze importanti (come fu
il 4 agosto 1914) ecco gli opportunisti col loro voto, frutto dei loro
molteplici rapporti con la borghesia. (…)
La guerra ha indubbiamente causato la più grave crisi e acuito le passioni
delle masse popolari. Il carattere reazionario di questa guerra, la spudorata
menzogna della borghesia di tutti i paesi, che nasconde i suoi fini briganteschi
sotto il manto della ideologia
nazionale, tutto ciò determinerà immancabilmente - sul terreno della
situazione obiettiva rivoluzionaria - consensi rivoluzionari fra le masse. Il
nostro dovere è di rendere coscienti tali consensi, approfondirli e dar loro
consistenza.
Un simile compito verrà giustamente espletato solo mediante la
“trasformazione della guerra imperialista in guerra civile” e ogni
vittoriosa lotta di classe durante la guerra, ogni tattica seriamente svolta
dalle “azioni collettive”, porta inevitabilmente a questo. Non si può
sapere se il grande movimento rivoluzionario verrà prima o dopo la seconda
guerra delle grandi potenze, se scoppierà durante la guerra o dopo di essa, ma
in ogni caso è nostro dovere imprescindibile agire in questo senso
sistematicamente e con fermezza.
Il manifesto di Basilea si richiama esplicitamente all’esempio della Comune di
Parigi, all’esempio cioè della trasformazione della guerra dei governi in
guerra civile. Mezzo secolo fa il proletariato era troppo debole, i presupposti
obiettivi del socialismo non erano ancora maturi, non si poteva pensare a
un’unione dei moti rivoluzionari di tutti i paesi belligeranti; l'entusiasmo
di una parte dei lavoratori parigini per l’ideologia nazionale (la tradizione
del 1792) era la loro debolezza rivoluzionaria, già indicata a sua volta da
Marx, e una delle cause della caduta della Comune.
Mezzo secolo dopo le condizioni, che avevano allora indebolito la rivoluzione,
sono mutate e oggi sarebbe imperdonabile se un socialista volesse negare la
forza dello spirito comunardo parigino.
Giornali borghesi di tutti i paesi in guerra hanno riportato esempi di
fraternizzazione fra soldati di nazioni nemiche perfino nelle trincee. Divieti
draconiani, emanati in proposito dai comandi di guerra (Germania, Inghilterra),
hanno dimostrato come si governi e alla borghesia non sfuggisse il significato
di simili episodi. Se oggi, nel pieno trionfo dell’opportunismo, nei circoli
dirigenti dei partiti socialisti dell’Europa occidentale, malgrado la
dedizione di tutta la stampa socialista e di tutte le autorità della seconda
Internazionale al social-patriottismo, sono stati possibili tali episodi di
fraternizzazione, ciò dimostra quanto si potrebbe oggi abbreviare l’attuale
criminosa guerra reazionaria e asservitrice, organizzando un movimento
rivoluzionario internazionale, solo che i socialisti di sinistra di tutti i
paesi belligeranti si adoperassero sistematicamente in questo senso. (...)
I sostenitori della vittoria del proprio governo nella guerra attuale, come pure
i propugnatori della tesi “né vittoria né sconfitta”, si trovano allo
stesso livello dei social-patrioti.
La classe rivoluzionaria non può mai non desiderare la sconfitta del proprio
governo; essa non può non scorgere la relazione esistente fra l’insuccesso
bellico del governo e l’agevolazione ad abbatterlo. Solo un borghese, che viva
nella fede che la guerra ordita dai governi terminerà inevitabilmente come
guerra dei governi e desideri anche ciò, trova ridicola e pazzesca l’idea che
i socialisti di tutti i paesi in guerra debbano desiderare la sconfitta di tutti
i propri governi. Al contrario, anche un simile fatto si accorderebbe benissimo
col pensiero segreto di ogni lavoratore evoluto e cosciente e lo metterebbe
subito sulla giusta via della nostra azione, intesa alla trasformazione della
guerra imperialistica in guerra civile.
Il mezzo più comune di inganno della borghesia in questa guerra è il
mascheramento dei suoi fini briganteschi con l’ideologia della “liberazione
dei popoli”. Gli inglesi promettono di liberare i belgi, i tedeschi promettono
di liberare i polacchi, e cosi via. In realtà questa è, come abbiamo visto,
una guerra fra gli oppressori della maggior parte dei popoli della terra per la
conservazione e lo accrescimento di questa oppressione.
I socialisti non possono conseguire il loro grande fine senza combattere contro
questa oppressione di popoli. Essi devono perciò esigere incondizionatamente
che i partiti socialisti dei paesi oppressori, (specialmente delle cosiddette
grandi potenze), riconoscano e difendano il diritto di autodecisione dei popoli
“oppressi”, e lo riconoscano e difendano nel senso politico della parola,
cioè come diritto all’indipendenza politica. Il socialista d’un popolo
appartenente a un grande Stato o a uno Stato coloniale, che non difende un
simile diritto, è uno sciovinista.
L'imperialismo rappresenta l'epoca dell’oppressione progressiva di tutto il
mondo sotto il tallone delle “grandi potenze”, e perciò la lotta per la
rivoluzione internazionale socialista è impossibile senza il riconoscimento dei
diritti all’autodecisione dei popoli.
“Non può esser libero quel popolo che opprime altri popoli” (Marx ed
Engels). Non può esser socialista quel proletariato che ammette il menomo atto
di violenza della sua nazione contro altre nazioni.
Zinoviev e Lenin (1915)
69
- L'epoca rivoluzionaria (Lev
Trotzky)
... I metodi di opposizione
nazionale parlamentare restano non solo obiettivamente senza efficacia, ma
perdono addirittura, per le classi lavoratrici, ogni forza di attrazione
subiettiva in considerazione del fatto che dietro le spalle dei parlamentari
l'imperialismo a mano armata pone il salario e perfino l’esistenza stessa dei
lavoratori in sempre maggior dipendenza dai suoi successi sul mercato mondiale.
Che il passaggio del proletariato dall'opportunismo alla rivoluzione potesse
compiersi per mezzo di tentativi di agitazione, ma solo per mezzo di
rivolgimenti storici, era più che chiaro ad ogni socialista ben pensante. Ma
che il corso delle vicende storiche avrebbe fatto precedere a questo inevitabile
mutamento di tattica un simile catastrofico crollo della Internazionale, questo
non lo prevedeva nessuno. La storia opera con titanica inesorabilità. Che cosa
importa ad essa della Cattedrale di Reims e che cosa le importa, di qualche
centinaio o migliaio di nomi politici e che cosa le importa della vita o della
morte di centinaia di migliaia o di milioni di individui? Troppo tempo è
rimasto il proletariato negli asili d’infanzia, assai più tempo di quel che
non abbiano pensato i grandi patrocinatori. La storia ha preso in mano la scopa,
ha spazzato via l’Internazionale degli epigoni e ha buttato pesantemente
milioni di uomini sul campo di battaglia, dove vengono tolte loro, col sangue,
le ultime illusioni.
Spaventoso esperimento! Dal suo risultato dipende forse la sorte della cultura
europea! (...)
La guerra attuale dimostra come la Germania, che ha compiuto i maggiori passi
sulla via del capitalismo, sia capace di spiegare la più grande forza militare.
In pari tempo questa guerra mostra, nei riguardi di tutti i paesi in essa
coinvolti, quale colossale energia specializzata spieghi il proletariato nella
sua attività bellica. Non si tratta qui dell’eroismo passivo di gregge delle
masse campagnole, animate da rassegnazione fatalistica o da superstizione
religiosa: qui si tratta dello spirito di sacrificio individuale che,
provvedendo da un'intima convinzione, si pone sotto la bandiera d’un’idea.
L'idea sotto la cui bandiera trovasi oggi il proletariato armato è l’idea del
nazionalismo guerrafondaio, del nemico mortale dei veri interessi del
proletariato. Le classi dominanti si sono rivelate abbastanza potenti per
imporre le proprie idee al proletariato e il proletariato ha coscientemente
posta la propria intelligenza, la propria passione e il proprio spirito di
sacrificio al servizio della causa dei suoi nemici di classe.
In questo modo vien suggellata la spaventosa disfatta del socialismo. Ma con
essa vengono a schiudersi anche tutte le passibilità d’una definitiva
vittoria.
È fuor di dubbio che una classe, che è capace di dimostrare tanta fermezza e
tanto spirito di sacrificio in una guerra da essa riconosciuta come giusta, si
mostrerà ancor meglio capace di spiegare tale sua qualità allorché
l'ulteriore svolgersi degli avvenimenti la porrà di fronte a compiti veramente
degni della sua missione storica.
L’epoca del risveglio, delle rivelazioni e dell’organizzazione del
proletariato ha palesato in esso inaudite fonti di energia rivoluzionaria, che
non hanno trovato alcuna estrinsecazione adeguata nella lotta quotidiana. Il
socialismo ha chiamato in campo non soltanto le categorie superiori del
proletariato, ma ha anche stimolato la sua energia rivoluzionaria dando
necessariamente alla sua tattica il carattere della perseveranza (“strategia
dell’esaurimento”). Il pertinace e reazionario carattere di quest’epoca
non ha permesso al socialismo di affidare al proletariato compiti tali da
richiedere tutto il suo spirito di sacrificio.
Simili esigenze vengono ora vantate sul proletariato dall’imperialismo. In tal
modo questo ha raggiunto il suo scopo mettendo il proletariato in posizione di
“difesa nazionale”, il che doveva significare pei lavoratori difesa di ciò
che essi avevano creato con le proprie mani; non soltanto dunque delle colossali
ricchezze della nazione, ma anche delle loro proprie organizzazioni di classe,
delle loro casse, della loro stampa, in breve, di tutto ciò che erano riusciti
a ottenere attraverso faticose, instancabili lotte decennali.
L'imperialismo ha strappato violentemente la società dallo stato di instabile
equilibrio, ha abbattuto gli argini che il socialismo aveva creato contro la
corrente di energia rivoluzionaria del proletariato ed ha incanalato questa
corrente nel suo letto. Un simile inaudito esperimento storico, che ha spezzato
con un sol colpo la schiena dell’Internazionale socialista, nasconde pertanto
in sé il pericolo mortale per la stessa società borghese. Il martello viene
strappato di mano al lavoratore e trasformato in arma. Il lavoratore, avvinto
dal meccanismo dell’economia capitalistica, viene repentinamente tolto dal suo
ambiente e gli viene insegnato a considerare i fini della comunità come più
alti perfino della felicità domestica e della vita.
Con l’arma in mano ch’esso si è preparata, il lavoratore viene messo in tal
posizione che la sorte politica dello Stato viene a dipendere da lui. Quelli che
in tempi normali l’opprimevano e lo disprezzavano, ora l’adulano e lo
strisciano. Nello stesso tempo egli viene a trovarsi nel più stretto contatto
con quei medesimi cannoni che formano una delle più importanti parti
costitutive delle costituzioni. Egli oltrepassa i confini, prende parte a
requisizioni violente, con la sua cooperazione passano le città da una mano
all’altra. Avvengono trasformazioni che la generazione attuale non ha mai
veduto. (…)
Non è dunque chiaro, che tutte queste circostanze debbano produrre una profonda
trasformazione nella psiche dei lavoratori guarendo radicalmente il proletariato
dall’ipnosi della legalità in cui s’è manifestata l’epoca della
stagnazione politica?
Le classi abbienti debbono presto convincersene con terrore. Il proletariato
passato a traverso la scuola della guerra, comincerà al primo serio ostacolo
che gli si frapporrà nel proprio paese, a usare il linguaggio della forza:
“Necessità non conosce legge!” griderà esso a colui che cercherà di
trattenerlo in base alle disposizioni della legislazione borghese. (...)
“Cessazione immediata della guerra!” è la formula con cui il socialismo può
nuovamente raccogliere le sparpagliate fila tanto dei singoli partiti nazionali
quanto di tutta l’Internazionale. La sua volontà di pace il proletariato non
può farla dipendere dalle esigenze strategiche degli stati maggiori, ma deve
invece contrapporre con ogni energia a queste esigenze la sua volontà di pace.
Quella che i governi in guerra chiamano lotta per l’auto-conservazione
nazionale, non è, al contrario, che annientamento nazionale reciproco. La vera
autodifesa nazionale consiste ora nella lotta per la pace.
Una simile lotta non significa per noi soltanto lotta per la preservazione dei
beni materiali e culturali dell’umanità, ma significa in prima linea la lotta
per la conservazione dell'energia rivoluzionaria del proletariato. (…)
L’agitazione per la pace deve compiersi contemporaneamente da per tutto; con
tutti i mezzi di cui dispone ora il socialismo, con quelli di cui può
impadronirsi con la buona volontà, non solo esso strapperà i lavoratori
all’ipnosi del nazionalismo ma compirà anche un’intima operazione di
epurazione salvatrice nei circoli agli attuali partiti ufficiali del
proletariato. I revisionisti nazionali ed i social-patrioti in seno alla seconda
Internazionale, i quali esercitano l'influenza storicamente conquistata dal
socialismo sulle masse lavoratrici per fini nazionalistici-militaristici, devono
venir respinti nel campo dei nemici di classe del proletariato da
un’agitazione rivoluzionaria implacabile per la pace. (...)
La guerra suscita i più spaventosi rivolgimenti contro se stessa, ogni giorno
di guerra che passa porterà nuove e sempre nuove masse sotto la nostra
bandiera, se essa sarà la bandiera d'una pace onorevole e della democrazia. Nel
compimento della pace il socialismo rivoluzionario isolerà certamente la
reazione bellica in Europa, e spingerà il proletariato a passare
all’offensiva. (…)
I principali riformisti che speravano di risolvere la “questione sociale”
coi trattati di tariffa, con le unioni di consumo e con la collaborazione
parlamentare del socialismo coi partiti borghesi, tutti costoro pongono adesso
le loro speranze nella vittoria delle armi “nazionali”! Aspettano che le
classi abbienti vengano spontaneamente incontro ai bisogni del proletariato che
ha dato prova del suo patriottismo.
Una simile speranza sarebbe semplicemente idiota se un’altra speranza, assai
meno idealistica, non si celasse dietro di essa: la speranza, cioè, che la
vittoria delle armi abbia a creare un’assai più vasta base di arricchimento
imperialistico per la borghesia, a spese della borghesia di altri paesi e
permetterle di ripartire col proletariato nazionale una parte del proprio
bottino a spese del proletariato degli altri paesi. Il riformismo socialista si
è effettivamente trasformato in un imperialismo socialista!
Dinanzi ai nostri occhi svanisce completamente la speranza d’un pacifico
progresso del benessere proletario. I riformisti sono stati costretti a cercare
la via d’uscita dal ginepraio politico, contro la loro dottrina, nella forza;
ma non nella forza dei popoli contro le classi dominanti, bensì nella forza
militare delle classi dominanti contro altri popoli.
La borghesia tedesca, dopo il 1848, ha rinunciato a risolvere i suoi problemi
col metodo della rivoluzione e ha lasciato ai feudatari il compito di risolvere
le questioni borghesi coi metodi della guerra. L’evoluzione sociale ha posto
il proletariato dinanzi al problema della rivoluzione. Evitando la rivoluzione,
i riformisti sono stati costretti a ripetere lo storico affondamento della
borghesia liberale: hanno abbandonato alle loro classi dominanti, cioè agli
stessi feudatari, la cura di risolvere la questione proletaria coi metodi della
guerra.
Ma qui termina l’analogia. La formazione di Stati nazionali ha nel fatto
risolto per un lungo periodo di tempo la questione borghese e la lunga serie di
guerre coloniali dopo il 1871 ha compiuto questa rivoluzione ampliando il campo
d’azione per lo sviluppo delle forze capitalistiche. Il periodo delle guerre
coloniali degli Stati nazionali ha portato all'attuale guerra fra Stati
nazionali per le colonie!
A questo proposito c'è un fatto di capitale importanza: il risveglio
capitalistico perfino delle colonie, risveglio cui l'attuale guerra dovrà dare
un potente impulso. Qualunque sia per essere l’esito di questa guerra, la base
imperialistica del capitalismo europeo non si amplierà, ma si restringerà
invece. La guerra non risolve neppure la questione dei lavoratori su fondamenti
imperialistici: al contrario, essa acuisce queste questioni ponendo il mondo
capitalistico dinanzi all’alternativa: o guerra in permanenza o rivoluzione.
Se la guerra ha colpito sul capo la seconda Internazionale, le sue conseguenze
colpiranno sul capo la borghesia di tutto il mondo. Noi, socialisti
rivoluzionari, non vogliano la guerra. Ma non la temiamo neppure. Il fatto che
la guerra ha distrutto l’Internazionale - che era già stata liquidata dalla
storia - non è certo tale da farci disperare.
L’epoca rivoluzionaria creerà
nuove forme organiche dalle inesauribili fonti del socialismo proletario, le
quali esprimeranno la grandezza dei nuovi compiti. A tale impresa accingiamoci
subito fra il folle clamore dei cannoni, lo schianto della cattedrale che crolla
e l’urlo patriottico degli sciacalli capitalistici. Conservi in questa
infernale musica di morte ben chiaro il nostro pensiero, intatto il nostro punto
di vista e sentiamo di essere l’unica forza creativa dell’avvenire! Molti
sono già ora con noi, assai più di quel che non possa sembrare. Domani saremo
assai più numerosi che oggi. Dopodomani accorreranno sotto la nostra bandiera
milioni e milioni di uomini che anche oggi, sessantotto anni dopo
l’apparizione del “Manifesto” comunista, null’altro hanno da perdere che
le proprie catene!
Leone D. Trotzky (1916) (1879-1940)
70
– L’Esercito rosso (Lev
Trotzky)
Compagni!
La dottrina comunista o socialista si è proposta come uno dei suoi più
importanti compiti il raggiungimento - in questo reo e vecchio mondo – d’un
tale stato di cose che gli uomini debbano cessare dall’avventarsi l’uno
contro l’altro, uno degli obiettivi del comunismo o socialismo è la creazione
d’un ordinamento tale da rendere, per la prima volta, l’uomo degno del suo
nome. Noi siamo abituati a udire che la parola uomo suona orgoglio. Ma in verità,
se gettiamo uno sguardo su questi quasi quattr’anni di sanguinosa carneficina,
si potrebbe ben esclamare: “L’uomo! Ciò suona vergogna! vergogna!”
Orbene, creare una tal forma, un tale ordinamento sociale, in cui non si abbia
alcuna reciproca sopraffazione di popoli, è questo il semplice e chiaro compito
che ci pone dinanzi la dottrina del comunismo. Ciò nonostante, voi vedete, o
compagni, come il partito comunista, al quale io appartengo, il partito cioè
che ha nominato l'attuale assemblea, il partito dei comunisti bolscevichi,
faccia appello all’esercito rosso, invitandolo ad organizzarsi e ad armarsi.
In ciò sembrerebbe, a prima vista, di scorgere una profonda contraddizione.
Da una parte noi propugniamo la creazione di rapporti sociali tali che a nessun
uomo sia lecito di togliere ad un altro il più prezioso dei beni: la vita; ed
è questo il più alto compito, uno dei più importanti del nostro partito, del
partito mondiale internazionale dei lavoratori. Dall’altra parte invece noi vi
chiamiamo nell’esercito rosso e vi diciamo: “Armatevi, unitevi, imparate a
sparare, e imparatelo così bene e con tanto impegno, che nessun colpo vi abbia
a fallire! …”
A prima, vista dunque sembra questa una contraddizione; si sente qualche cosa
che contrasta con l’atteggiamento vagheggiato. E vi sono stati effettivamente
comunisti che han seguito altra via, si son valsi di altri mezzi e, anzi che
rivolgersi agli oppressi con le parole infiammanti: “Unitevi! Armatevi!”, si
sono rivolti agli oppressori, agli sfruttatori, ai potenti con parole di
persuasione, dicendo loro: “Disarmatevi! cessate di opprimere!”
Parlavano di lupi e pretendevano di togliere loro i denti! Così predicavano,
basandosi su errati concetti, gli utopisti, cioè i socialisti comunisti
ingenui. I loro sforzi erano indubbiamente nobili in sommo grado; ricordano il
grande utopista Leone Tolstoi il quale, propugnando l’avvento di un migliore
assetto del mondo, credeva che si sarebbe potuto pervenirvi con un rinnovamento
intimo degli oppressori. Ma invece le mire degli oppressori, i loro sentimenti,
i loro istinti seguitano a trasmettersi di generazione in generazione: essi
succhiano col latte materno la loro tendenza al potere, all’oppressione e al
dominio e credono che tutte le altre masse, le masse dei lavoratori siano create
proprio apposta per servire di base e sostegno al prepotere del loro piccolo
gruppo, di quel ceto, cioè, di privilegiati che viene al mondo, per così dire,
con gli sproni ai piedi per montare a cavallo sul collo del popolo lavoratore.
Compagni! eccoci alle radici della questione. Noi propugniamo la creazione
dell’ordinamento comunista, in cui nessun odio di classe contro le altre deve
esistere; ché nessuna classe deve prevalere: nessun odio deve esistere fra
popolo e popolo perché i popoli, vivendo tutti sulla medesima terra, devono
avere tutti comuni occupazioni e intenti.
Ma, mentre noi auspichiamo un simile assetto mondiale, diciamo ai lavoratori:
“Finché questo non è raggiunto, pensate che siete voi la sola potenza capace
di realizzarlo”. E pensate bene - e noi in Russia lo sappiamo anche troppo per
esperienza! - che le classi internazionali dominanti non cederanno su questo
campo un solo palmo di terreno senza
combattere; esse si aggrapperanno ai loro privilegi, ai loro beni, al loro
potere coi denti e con le unghie, fino all’ultimo alito, e semineranno
discordia, malumori, disordine, caos, scompiglio fra la folla dei lavoratori al
solo fine di poter conservare il loro potere. Noi, in Russia, abbiamo compiuto
soltanto il primo passo, abbattendo il dominio politico della classe borghese e
instaurando quello della classe lavoratrice. La borghesia non ha più
alcuna forza presso di noi, il potere è tutto dei lavoratori. Dire che esso
è cattivo equivale a dire che la classe lavoratrice è mal conscia di quel che
le incombe. Essa ha tutto il potere che le occorre, e ne ha quindi tutta la
responsabilità. Il potere costituito a Pietrogrado, a Mosca e in altre città
può - in quanto esso è conferito dai lavoratori - essere in qualsiasi momento
da essi stessi ritolto, potendo essi convocare il Congresso panrusso dei
Consigli (Soviet); essi possono, quando vogliono, rieleggere i Consigli, il
Comitato esecutivo centrale, il Consiglio dei commissari del popolo. È questa
la potenza della classe degli operai e dei contadini, dei poveri contadini; è
questa la base su cui noi poggiamo!
Ci si dice: “Perché non cercate di conseguire questo potere mediante il
suffragio elettorale universale, uguale, diretto e segreto, con la formazione di
un'Assemblea costituente?”
È vero, noi parteggiamo per essa. Noi fummo sempre del parere che l’Assemblea
costituente fosse di gran lunga migliore del regime zaristico, di gran lunga
migliore dell’autocrazia dell’impero di Plehwe, dei briganti di Stolypin,
della nobiltà; l’Assemblea costituente è indubbiamente di gran lunga
migliore di tutto ciò.
Ma che cosa è l’Assemblea costituente, che cos’è il suffragio universale?
È un referendum di tutta la popolazione, una richiesta fatta a tutti di
esprimere la propria volontà. Tutti nel paese vengono interrogati: i lavoratori
e gli oppressi, gli oppressori e i loro servi del ceto intellettuale che sono
avvinti anima e corpo alla borghesia, servendo ai suoi fini. A ciascuno si
domandi, col sistema del suffragio universale: “Che cosa volete? Ditelo per
mezzo del voto”. E se, nel marzo o aprile dell’anno scorso, Kerenski avesse
convocato l’Assemblea costituente, questo sarebbe stato indubbiamente un passo
avanti. Lo Zar era abbattuto, la burocrazia rovesciata; il potere non era ancora
nelle mani dei lavoratori, ma in quelle di Guckov, Milukov e simili. Se allora,
per mezzo dell'Assemblea costituente, si fosse chiesto al paese: "Che cosa
volete voi, o uomini della Russia?” si sarebbe avuta una risposta nettamente
in antitesi con quella che avrebbero desiderata la borghesia e i suoi servi che
erano al potere. Poiché la rivoluzione consiste appunto nella ribellione delle
classi oppresse contro gli oppressori.
Che cosa è una rivoluzione? Evidentemente per Krestovnikov e per Riabuscinski
essa consiste nell’abbattere lo Zar e nel sostituire vecchi ministri con
nuovi; ecco tutto! Ma l'essenza della rivoluzione non è in ciò; essa bensì
risveglia e solleva le masse operaie sfruttate e maltrattate che trascorrono i
loro giorni senza un raggio di luce, senza un attimo di respiro, come bestie da
soma; la rivoluzione le ridesta e fa loro vedere come esse altro non siano in
questo loro stato, che bestie e schiave di altre classi. Eccola la rivoluzione,
vedete! Essa non si contenta di abbattere lo Zar, di mutare un paio di ministri.
Se si accontentasse di questo, non sarebbe una rivoluzione: sarebbe, per così
dire l’aborto d’una rivoluzione. Questa è una falsa origine storica, la
vera, la sana origine storica si ritrova quando la classe lavoratrice,
sollevandosi, prende nelle sue mani tutto il potere del paese e si accinge a
creare un nuovo ordinamento, in cui non vi sia più alcun sfruttamento di una
classe sull’altra; in cui tutti i mezzi di produzione, tutte le ricchezze del
paese si trovino a disposizione e sotto il controllo dei lavoratori. La classe
lavoratrice è allora come un signore in un buon regime economico: il signore,
il proprietario sa quanto terreno ha, quanta semente, quanto bestiame, quale è
il suo inventario economico, qual pezzo di terra deve fino a un dato momento
seminare; egli sa tutto questo, tutto è ben regolato e messo a profitto.
Ma questo è il regime economico di un singolo. Gli altri, che vivono accanto a
lui hanno anch’essi la loro economia nella reciproca cooperazione. Ebbene, noi
vogliamo che la classe lavoratrice sia come un signora nei riguardi della
propria terra, sicché essa sappia, quanto terreno ha, di quante ricchezze
naturali, di quanto rame, di quanto carbone, di quante macchine, di quanta
materia greggia, di quante forze di lavoro,
di quanto grano dispone; noi vogliamo che tutto ciò sia messo in valore,
affinché, essendo tutto ben nato, il lavoro possa essere razionalmente
distribuito. Il proprietario deve essere un buon padrone che sia al tempo stesso
padrone e lavoratore. E l’economia comunista, vedete, altro non è che una
società di compagni.
Dicono che questa sia un’utopia. Affermano i nostri nemici che tutto ciò non
potrà mai avverarsi. Così parlano coloro cui tutto questo non conviene, o
coloro che han venduto la propria anima alla classe dominante. Per essi
l’ideale è irraggiungibile. Ma io, o compagni, vi dico che, se gli uomini non
sono capaci di realizzarle allora tutto il genere umano non varrebbe davvero un
centesimo: gli uomini resterebbero sempre bestie da soma, peggiori anzi di
qualunque bestia, perché le bestie non conoscono divisioni di classe, e fra
esse non accade, che un bue, per esempio, acquisti predominio su un altro, o un
cavallo su un altro.
Noi, invece, abbiamo sempre sostenuto che, se dobbiamo abbattere un simile
organismo di classi, dobbiamo farlo per salire sempre più in alto; contro
questa divisione di classi noi dobbiamo combattere; e, se non riusciremo in
questa prova, cui ci siamo accinti ora che abbiamo in mano il potere, se si
dovesse dimostrare che non siamo preparati, che non siamo capaci di assolvere il
nostro compito; allora, sì, tutte la nostre speranze, tutte le nostre
aspettative, i nostri piani, la nostra scienza, l’arte, tutto ciò che
interessa l’uomo, tutti gli ideali nel cui nome egli combatte, non sarebbero
che menzogne, e l’intero genere umano non sarebbe altro che un gran letamaio
quale esso appare dall’attuale carneficina, che dura da quattro anni, in cui
gli uomini si ammazzano l’un l’altro a decine di migliaia, a milioni, col
solo e unico risultato di lasciare ogni cosa al punto di prima.
Anche per questo noi diciamo ai nostri nemici che ci criticano: noi sappiamo
benissimo che non siamo ancora al termine della nostra opera, che abbiamo ancora
del cammino da percorrere pel quale occorrono ancora molto lavoro e molti
sforzi. Ma una cosa noi abbiamo compiuto: la preparazione. Se è necessario
costruire un nuovo edificio, tutto deve rifarsi da capo.
Noi abbiamo tolto il potere alla borghesia e ci accingiamo all’impresa.
Abbiamo cominciato col tener saldamente in mano il potere e dichiariamo a tutti
i nostri nemici che questo potere non dovrà giammai cadere di mano alla classe
lavoratrice.
Si parla, dunque, dell'Assemblea costituente. Torno su questo importante
argomento. Che cosa è essenzialmente il suffragio universale, diretto, uguale e
segreto? Che cosa è un semplice referendum, un appello alle urne? Se tentassimo
l’esperimento, che cosa succederebbe? Una parte dei cittadini voterebbe in un
dato senso, un’altra in un altro. Ma qualche cosa bisogna fare. E poiché
qualche cosa bisogna fare, è chiaro che le due parti si troverebbero in
conflitto operando ciascuna per fini opposti. L’Assemblea costituente può
servire sì per un referendum dei diversi voleri, ma per l’opera creatrice
della rivoluzione, no. Del resto il referendum noi lo abbiamo compiuto anche
senza l'Assemblea costituente. Miliukov prima e Kerenski poi lasciarono passare
i mesi uno dopo l’altro senza convocare l'Assemblea costituente. E che cosa
sarebbe essa stata se anche si fosse fatto rivivere il suo cadavere, ammesso che
esistesse al mondo un medicamento o una magia qualsiasi capace di tanto?
Ammettiamolo pure. L’Assemblea costituente è convocata. Che vuol dire ciò?
Vuol dire che da un lato, alla sinistra, sederebbero i rappresentanti delle
classi lavoratrici e direbbero: “Noi vogliamo che il potere serva alfine al
dominio della classe lavoratrice e all'abolizione di qualsiasi oppressione e
rapina”. Dalla parte opposta, sederebbero i rappresentanti della borghesia, i
quali vorrebbero che il potere tornasse come prima alla classe borghese. Essi
parlerebbero con bel garbo e cautela, senza dire apertamente classi borghesi, ma
classi colte, pur significando sostanzialmente la stessa cosa. Nel mezzo
starebbero quegli uomini politici che oscillano costantemente fra la destra e la
sinistra, i rappresentanti dei menscevichi e dei “socialisti rivoluzionari”
di destra. Essi direbbero: “Il potere deve essere ripartito equamente fra
l'una e l'altra parte”.
Ma, o compagni, il potere non è una pagnotta che si possa tagliare in due o
quattro parti, a piacere. Il potere è uno strumento, col quale una determinata
classe afferma il proprio dominio. Un tale strumento o serve alla classe
lavoratrice, o serve contro di essa. Finché vi sono due nemici - la borghesia e
il proletariato - col miserrimo ceto dei contadini e finché questi due nemici
si combattono reciprocamente, non possono evidentemente adoperarsi entrambi con
le medesime armi. Non è ammissibile che un fucile o un cannone serva
contemporaneamente a due eserciti in conflitto fra loro. Così anche il potere
statale è una determinata organizzazione che può servire o alla classe
lavoratrice contro la borghesia o, viceversa, alla borghesia contro la classe
lavoratrice. I “centristi”, che domandano se il potere non si possa in
qualche modo dividere in due, non sono che dei ciarlatani, che pretendono di
aver in tasca la ricetta per far sì che il potere statale - il cannone - possa
servire contemporaneamente ai lavoratori e alla borghesia. La storia, o
compagni, non ci dà esempio di simili magiche ricette e se anche ce ne
proponesse una, la politica di Tseretelli e di Cernov noi ben sappiamo che il
loro cannone non sparerebbe che in una direzione: contro la classe lavoratrice e
noi non abbiamo alcun desiderio né alcuna inclinazione a tornare in un simile
stato.
Compagni, noi dichiariamo al nostro partito comunista, al Governo dei Consigli,
che noi fummo attivamente per l'Assemblea costituente allorché questa,
rappresentava un passo innanzi sotto lo zarismo; noi parteggiammo allora per un
referendum ma dopo che il popolo ebbe rovesciato lo Zar, allora noi dicemmo:
“Ora voi dovete portare a compimento l’impresa; è necessario che il potere
sia assunto da quella classe che è chiamata a ricostruire la Russia su nuove
basi: alla classe dei lavoratori”. E, ciò dicendo, non ci siamo né vi
abbiamo in alcun modo ingannati.
Noi affermammo che infinite erano le difficoltà nel nostro cammino, colossali
gli ostacoli, tremenda l’opposizione della classe borghese, e non solo da
parte della borghesia russa, che per se stessa è debole, ma anche da parte
della borghesia internazionale, poiché la borghesia russa altro non è che una
diramazione delle classi borghesi di tutti i paesi. Queste si muovono, sì,
guerra fra loro, si urtano a vicenda, ma in sostanza sono compatte nella
questione fondamentale: la difesa della proprietà e di tutti i privilegi che ad
essa si connettono. Vi ricorderete senza dubbio come fu fra noi, fino a poco
tempo fa, prima della rivoluzione, infiniti fossero i partiti nella classe
borghese, fra i possidenti della grande e piccola borghesia. C’erano i cento
neri di destra, i nazionalisti, gli ottobristi, i progressisti di sinistra, i
cadetti, ecc.: un vero e proprio sciame di partiti. Donde venivano? Precisamente
da diversi gruppi di possidenti. Gli uni rappresentavano gli interessi dei
grandi possidenti, gli altri quelli dei medi e dei piccoli; alcuni gli interessi
dei capitalisti bancari, altri gli interessi dei capitalisti industriali, altri
ancora gli interessi degli intellettuali laureati, professori, medici, avvocati,
ingegneri, ecc. In sostanza, dunque, anche la stessa borghesia, le stesse classi
abbienti si dividono in gruppi, in sezioni, in partiti. Ma non appena la nostra
rivoluzione ha fatto sorgere in piedi i lavoratori, tutta la borghesia si è
trovata compatta, i partiti sono tutti scomparsi, altro non restando che il
partito dei cadetti, in cui si raggruppavano tutte le classi abbienti in lotta
per la difesa della proprietà contro le classi operaie.
Lo stesso, o compagni, avviene anche nella borghesia internazionale. Essa
scatena guerre orrende e sanguinose, ma appena la classe rivoluzionaria, la
classe proletaria alza la testa minacciando le basi del capitalismo, subito
cominciano i borghesi a sostenersi l’un l’altro in tutti i paesi, per
formare un campo comune contro il progrediente spaventoso “spettro” della
rivoluzione socialista e per questo vedete, noi consacriamo le nostre energie
alla formazione dell’ordinamento comunista, in cui non vi saranno più lotte
fra popolo e popolo. Ma finché a questo non saremo arrivati, dobbiamo tenerci
pronti ad affrontare le più aspre difficoltà, a sostenere le più grandi
battaglie, così all'interno del nostro paese come ai suoi confini; poiché
quanto più sarà esteso, quanto più sarà forte il movimento rivoluzionario,
tanto più la borghesia di tutti i paesi stringerà le sue file. L'Europa sarà
posta a ferro e fuoco dalla guerra civile e la borghesia russa appoggiandosi
alla borghesia europea e a quella di tutto il mondo, compirà più di uno sforzo
contro di noi, per questo noi sosteniamo sì che siamo in cammino verso la pace,
ma verso una pace che non sarà raggiunta se non attraverso battaglie cruente
delle masse lavoratrici contro gli oppressori, gli sfruttatori, gli imperialisti
di tutti i paesi.
Questa via noi seguiremo sino alla fine!...
Di tutto ciò o compagni, dobbiamo ben renderci conto. Certo chi pensa che già
tutto abbiamo raggiunto, dimostra di non comprendere esattamente gli
insegnamenti della storia. La storia non è una madre premurosa e tenera, che
protegge la classe dei lavoratori: è una cattiva matrigna, che insegna loro,
con l’esperienza del sangue, il modo di innalzarsi e conseguire i propri fini.
È questa la disgrazia dei lavoratori. Io dico spesso, e ripeto nei comizi ai
compagni che essi hanno corta memoria. Essi si sentono facilmente portati alla
conciliazione, troppo facilmente dimenticano. Appena scorgono un barlume di
miglioramento, appena ottengono qualche cosa, subito sembra loro che il più sia
fatto e si sentono disposti alla generosità, si sentono disposti ad arrestare
la loro opera e cessare la lotta; e intanto le classi abbienti non interrompono
la loro campagna e contrappongono salda resistenza agli attacchi delle masse
operaie. Una passività da parte nostra, una scissione, un’incertezza vuol
dire per noi esporre il nostro lato debole ai colpi della classe abbiente, vuol
dire che domani o dopodomani, in un nuovo assalto, saremo sconfitti.
La classe dei lavoratori ha bisogno di vigorosa tempre, fermezza inesorabile e
convinzione profonda che senza combattere a ogni passo pel miglioramento del
proprio destino, senza questa lotta instancabile, sono impossibili la salvezza e
la liberazione.
Nelle file del partito comunista, noi chiamiamo, o compagni, anzitutto i
lavoratori e in seconda linea tutti gli amici sinceri e fidati della nostra
classe. Ma chi, o compagni, cela dubbi o incertezze nell’animo, resti lontano
dalle nostre file. Per noi vale più un solo seguace fidato che dieci indecisi,
poiché nello svolgimento della lotta questi trascinerebbero seco qualcuno dei
nostri; se invece i compagni sicuri, uniti tutti in una sola schiera, muovono
alla battaglia contro il nemico, essi trascinano anche gli incerti e i
reticenti. Per questo noi vogliamo nelle file del nostro partito soltanto coloro
che abbiano ben compreso come la nostra lotta contro gli oppressori di tutti i
paesi sia inesorabile. Qui non c’è posto per i “centristi” che si
interpongano fra l’una e l’altra parte per proporre accordi. Nessuno deve
ascoltare costoro. La borghesia non cederà mai spontaneamente il suo potere.
Bisogna da parte nostra resistere e combattere, bisogna che noi ci sentiamo
pronti alla battaglia fino alla fine!...
È questo il compito essenziale del partito comunista che appare attualmente
come il partito direttivo nei Consigli, organi del potere. Esso si propone di
riuscire a far sì che ogni suo addetto, ogni lavoratore sia spiritualmente
temprato a dire a se stesso: “Nella lotta che attualmente si svolge
evidentemente anch’io forse soccomberò. Ma che cosa è, in confronto d’una
vita da schiavi senza un raggio di luce, sotto il tallone degli oppressori, la
morte gloriosa d’un combattente che lascia la sua bandiera a nuove
generazioni, morendo con la consapevolezza di non sacrificare la vita per gli
interessi dei re o degli zar, per gli interessi degli oppressori, bensì per
quelli della propria classe? Dobbiamo insegnare ai nostri compagni a vivere fino
all’ultimo anelito e a morire per gli interessi della classe lavoratrice, con
la fede nell’animo. Ecco, vedete, a che cosa voi siete chiamati.
Noi ben sappiamo contro quali ostacoli e difficoltà urtiamo nella nostra
politica. La nostra rivoluzione è una conseguenza diretta della guerra, ma la
guerra è una conseguenza del capitalismo e noi, fin da lungo tempo prima della
guerra, avevamo già presagito come il colossale incremento degli armamenti e la
lotta fra le borghesie dei vari paesi pei profitti e pei mercati avrebbero
dovuto terminare con una spaventosa catastrofe.
La borghesia tedesca addossa la colpa alla borghesia inglese questa a quella
tedesca, e così tutti si scaricano reciprocamente le responsabilità della
sanguinosa guerra, proprio come fanno i pagliacci coi loro giochi nel circo. Noi
avevamo presentito l’inevitabilità della guerra, inevitabilità derivante non
dalla volontà d’uno o due re e ministri, ma da tutto l’insieme
dell’ordinamento capitalistico. Questa guerra è un esempio per l'intero
sistema borghese, economico e morale. E per questo, vedete, noi dicevamo al
principio del conflitto che esso avrebbe suscitato un terribile movimento
rivoluzionario fra le masse lavoratrici di tutti i paesi.
Mi è toccato, durante la guerra, di attraversare molti Stati. Dapprima fui
costretto a lasciare l’Austria per non esservi fatto prigioniero, poi fui in
Svizzera, paese che trovandosi fra la Germania, l’Austria e la Francia
costituisce il punto d’incrocio delle vie di questi tre Stati in conflitto.
Poi dovetti trascorrere un paio d’anni circa in Francia e finalmente, allorché
gli Stati Uniti d’America entrarono nel conflitto, mi recai colà. Dappertutto
ho osservato la medesima cosa, in un primo momento la guerra stordisce le masse
lavoratrici, le confonde, le tenta, ma poi le sconvolge, le spinge alla
protesta, alla ribellione contro la guerra, contro l’ordinamento che porta ad
essa, contro i dominatori.
Perché mai la guerra eccita dapprima lo stimolo patriottico fra le masse
lavoratrici? Per questo: perché, malgrado che esistono i partiti
socialisti-comunisti esistono ancora dappertutto, milioni di attivi lavoratori
che non conoscono alcuna vita spirituale. E qui è proprio la nostra principale
disgrazia: nell’esservi ancora milioni di simili lavoratori che vivono
automaticamente, automaticamente lavorano, mangiano e dormono, pur avendo appena
appena quanto basta per mangiare e dormire lavorando perciò sopra le forze;
costoro non pensano ad altro regime di vita che quello. La loro mentalità è
così delineata: il loro cervello non sa pensare ad altro, la loro intelligenza,
il loro pensiero, la loro coscienza dormono nella maggior parte del tempo e una
volta ogni tanto, nei giorni di festa, bevono un po’ di grappa!
No, o compagni, tutto ciò non è affatto ridicolo. È questo il tragico destino
di molti e molti milioni di lavoratori, tormentati, condannati a una simile vita
dal sistema capitalistico; che sia maledetto dal momento che danna i lavoratori
a una così mostruosa vita!
Ma viene la guerra. Il popolo è mobilitato, esce sulle vie, indossa la divisa,
militare. Gli vien detto “Noi marciamo contro il nemico; vinceremo e allora
tutto cambierà”. E così nascono le speranze. Gli uomini abbandonano
l’aratro e il tornio. In tempo di pace non avrebbero certo pensato a niente,
come bestie da soma; ma ora si propone loro un nuovo compito; essi si vedono
d’attorno centinaia di migliaia di soldati, tutti sono eccitati, la musica
militare suona, si promettono grandi vittorie e gli uomini sperano che qualche
mutamento verrà davvero, qualche cosa di meglio succederà, dato che niente di
peggio potrebbe più immaginarsi.
Essi credono che la guerra sia una guerra di liberazione, che porterà delle
novità. Anche per questo abbiamo osservato come in tutti i paesi, sul
principio, senza eccezione, nel primo periodo della guerra si ha sempre uno
slancio di patriottismo. La borghesia si sente più forte perché dice: “Tutto
il popolo è con me!”; sotto la bandiera della borghesia marciano i bravi
lavoratori dei campi e delle città. Tutto sembra fondersi in un solo sentimento
nazionale. Ma poi la guerra compie la sua intima opera; esaurisce la terra,
lascia il popolo senza tetto, arricchisce qualche gruppo di masnadieri,
speculatori, fornitori militari, conferisce gradi e onori a diplomatici e
generali, e le masse lavoratrici si impoveriscono sempre più; e le mogli, le
madri, le operaie, si trovano ogni giorno dinanzi all’arduo problema, che si
fa sempre più stringente, del come riempire la pentola per sfamare i bambini. E
tutto questo provoca fra le masse operaie una colossale rivoluzione.
Dapprima dunque la guerra desta e lusinga false speranze, ma poi, una volta
destatele, le fa crollare, sì che la classe lavoratrice si risente e comincia a
domandarsi da che cosa derivi tutto ciò e che cosa significhi. Ma la borghesia
non è stupida - non si può negarlo - essa ha già preveduto, fin dal principio
della guerra, il pericolo e perciò ha sempre contenuto, finché le è stato
possibile, la rivoluzione, con l'aiuto dei suoi zelanti generali.
Così avvenne in Europa, dopo la guerra franco-prussiana. Ma già nel primo
periodo dell’attuale guerra, allorché sembrava che il patriottismo invadesse
tutti gli animi, proprio nel tempo in cui io mi trovavo a Parigi, parlando con
uomini politici della borghesia, sentii dire, qua e là, da essi stessi che il
risultato di questa guerra sarebbe stato la grande rivoluzione. Costoro, questi
uomini politici borghesi, confidando evidentemente di trovarsi pronti a tale
evento. Se leggiamo i giornali e le riviste borghesi dei mesi di agosto e
settembre o ottobre 1914, cioè del
primo anno di guerra, per esempio, quel giornale inglese che si chiama “Economist”,
vediamo che già, fin da allora, si prevede che il risultato finale della guerra
in tutti i paesi che vi sono coinvolti, sarà il movimento socialista
rivoluzionario. Si era ben compreso fin da allora l'ineluttabilità di tutto ciò
e ben a ragione; allo stesso modo come avevamo ragione noi quando dicevamo che
questa guerra avrebbe inevitabilmente portato la Russia alla rivoluzione e che
questa rivoluzione, se potrà esser compiuta fino alla fine, porterà al potere
le classi lavoratrici. (…)
Ed ora noi stiamo formando l'esercito rosso degli operai e dei contadini.
Nel Comitato esecutivo centrale dei deputati degli operai e dei soldati e dei
cosacchi è già stata approvata la legge sul servizio militare obbligatorio
universale. Secondo questa legge ogni cittadino, nel corso di un determinato
numero di settimane per ogni anno (sei od otto settimane, per un’ora al
giorno), è obbligato a compiere l’istruzione militare sotto la guida di
appositi istruttori.
Una questione ci si presenta, o compagni: dobbiamo noi estendere l'obbligo
militare anche alle donne?
Facciamo una prova in questo senso: nel progetto di legge è detto che le donne
possono compiere l’istruzione militare, come gli uomini, con gli stessi
sistemi e con gli stessi principi, qualora lo desiderano. Ma, se una donna avrà
compiuto la stessa preparazione degli uomini, con gli stessi sistemi e con gli
stessi principi, allora, in caso di pericolo della Repubblica dei consigli, essa
sarà obbligata a impugnare le armi, come l’uomo, quando il Governo dei
Consigli la chiami.
Voi sapete, o compagni, che noi stiamo formando i quadri dell'esercito rosso.
Essi non sono numerosi: non rappresentano, per così dire, che l’ossatura
dell'esercito. Ma l’esercito attuale non è costituito da quelle migliaia e
migliaia di soldati che ci sono e che hanno bisogno di disciplina e istruzione,
bensì da tutto il popolo dei lavoratori dalle innumerevoli riserve di operai
istruiti delle città e delle fabbriche e dai contadini della campagna. E
qualora, un nuovo pericolo ci minacci da parte della controrivoluzione o di un
tentativo degli imperialisti, allora questa ossatura deve di colpo rivestirsi di
carne e di sangue, deve cioè completarsi con le riserve dei lavoratori evoluti
delle fabbriche e dei contadini dei campi. Per questo, se noi da una parte
istituiamo l’esercito rosso, dall’altra insegniamo a tutti gli operai e a
tutti i contadini a non trascurare la preparazione generale alle armi.
Sul principio questa deve compiersi con circospezione: non vogliamo armare la
borghesia. Alla borghesia, agli sfruttatori che non si rassegnano a rinunciare
ai loro diritti e privilegi, non vogliamo dar in mano alcun’arma. Noi diciamo:
“Il dovere di ogni cittadino nello stato, di ognuno senza eccezione, è di
difendere il paese ogni qualvolta esso sia minacciato da un pericolo. Parlo del
paese in cui governa l’onorata classe dei lavoratori, che non desidera nulla
di straniero”.
Ma la nostra borghesia non ha ancora rinunciato ai suoi diritti e al suo potere:
la borghesia non è ancor disposta a dar tutto alla comunità. E così essa si
agita, combatte, dirama i suoi agenti - i menscevichi, e i “socialisti
rivoluzionari di destra” - per propugnare l’Assemblea costituente. E così,
finché la borghesia non avrà rinunciato alle sue pretese, al potere statale e
al dominio del paese, finché non avrà compreso che noi abbiamo abbattuto,
annientato una volta per sempre lo spirito borghese, noi non daremo loro nelle
mani alcun'arma. Ma stabiliremo anche che la borghesia, che non vuole muovere
con noi all’assalto, debba scavare le trincee o compiere altri lavori.
Compagni, noi non dobbiamo ripetere gli errori delle precedenti rivoluzioni.
Oggi si nota come la classe lavoratrice sia troppo conciliativa e troppo
facilmente dimentichi la potenza della nobiltà, che per secoli l'ha tenuta
schiava, l’ha derubata, l’ha spogliata e angariata. Tutto questo troppo
facilmente dimentica la classe lavoratrice, incline a generosità e debolezza.
(…)
Per istruire l’esercito rosso noi ci serviamo degli antichi generali; ma va da
sé che noi scegliamo soltanto quelli che ci convengono e di cui possiamo
fidarci.
Tutti ci dicono: “E perché dunque chiamate i generali? Non è pericoloso ciò?”
Noi rispondiamo: “Senza dubbio, tutto al mondo ha il suo lato pericoloso. Ma
noi abbiamo bisogno di istruttori che conoscano l’arte militare. Noi diciamo
ai signori generali: “Ecco il
nuovo padrone del paese: la classe lavoratrice. Essa ha bisogno di istruttori
per preparare militarmente i lavoratori alla lotta contro la borghesia”
Nei primi tempi i generali erano fuggiti, si erano nascosti nelle fessure, come
le tignole, nella speranza che Dio avrebbe forse in qualche modo mutato le cose:
il potere dei Consigli, pensavano, durerà una o due settimane e poi precipiterà
ed essi, i generali, potranno tornare al loro posto. E i generali si
trascinarono dietro alla borghesia che pensava parimenti che la classe
lavoratrice, avuto in mano il potere, non l’avrebbe conservato più d’un
paio di settimane.
Ed ora vediamo che i sabotatori di ieri, a poco a poco, come tignole, escono
fuori dai loro nascondigli, movendo qua e là le loro antenne per tastare il
terreno: non si potrebbe, dopo tutto, andar d’accordo coi nuovi padroni?
E noi diciamo: “Siate i benvenuti, signori ingegneri, noi vi invitiamo nelle
fabbriche; insegnate agli operai a farle funzionare. Gli operai non ci riescono
bene da soli; aiutateli, mettetevi al loro soldo, fate servizio al loro fianco.
Finora siete stati al servizio della borghesia: fate adesso servizio alla classe
lavoratrice”.
E ai generali diciamo: “Voi avete appreso l’arte militare e l’avete
appresa bene, avete studiato all'Accademia di guerra. È una scienza evoluta,
una disciplina complessa, specialmente presso i Tedeschi, che sanno in modo
straordinario mettere in opera le più grandi macchine per l’assassinio e per
la distruzione. E noi dobbiamo imparare; ma per imparare ci occorrono
specialisti; signori ex-generali ed ex-ufficiali: noi vi offriamo un posto!”
Ci si obbietta che ciò è pericoloso e può esser causa di controrivoluzioni.
Io non so; fors’anche è possibile che qualcuno di costoro lo tenti, ma c’è
un proverbio che dice: “Non si può trascurare il necessario per timore di un
pericolo possibile".
Dal momento che noi pensiamo di formare un esercito, non possiamo, per
raggiungere questo fine, fare a meno di persone competenti. Proviamo dunque ad
ammettere al nostro servizio gli antichi generali. Se essi serviranno
fedelmente, sarà loro garantita la nostra protezione. Molti di essi, molti
generali - io stesso ho parlato con loro - hanno compreso che ora è uno spirito
nuovo quello che domina il paese, che adesso tutti coloro che vogliono
proteggere, difendere e riordinare la Russia, devono servire fedelmente le
classi lavoratrici. Io ho conosciuto molti uomini nella mia vita e credo di
saper distinguere un uomo che parla con sincerità da un disonesto. Alcuni di
questi generali dicevano, con piena lealtà, di aver compreso come le classi
lavoratrici debbano costituirsi una forza armata e di voler sinceramente
prestarsi a questo fine. Ma, per coloro che volessero servirsi dell’armamento
per una congiura controrivoluzionaria, vi saranno speciali provvedimenti da
prendere. Essi sanno benissimo che noi teniamo gli occhi aperti su tutto e,
qualora volessero stornare l’organizzazione dell’esercito rosso dagli operai
e dai contadini per farla servire ai fini della borghesia, noi sapremmo ben far
sentir loro il nostro pugno di ferro e ricordar loro le giornate di ottobre.
Essi possono ben cacciarsi in mente che, di fronte a un tradimento noi saremmo
inesorabili contro di essi, come contro chiunque volesse volger contro di noi la
nostra organizzazione. (...) Compagni, i lavoratori di tutti i paesi volgono a
noi gli occhi pieni di speranza e di ansia, chiedendoci se anche noi non
precipiteremo e macchieremo la bandiera rossa della nostra classe. Quando la
controrivoluzione e la nostra disorganizzazione ci avessero abbattuti, ciò
significherebbe che le speranze di tutte le classi lavoratrici degli altri paesi
sarebbero perdute e la borghesia potrebbe dir loro: “Vedete come la classe
proletaria russa era salita in alto e come invece ora è nuovamente precipitata
e giace al suolo crocifissa e annientata?”
Per questo, o compagni, noi dobbiamo difendere la nostra posizione con
raddoppiata e triplicata energia e combattere con centuplicato eroismo perché
ora non siamo solo i campioni della libertà per noi stessi, ma abbiamo in
nostra mano i sogni dell’umanità per la liberazione del mondo. Contro di noi
sta la borghesia di tutti i paesi. Con noi sono le speranze della classe
lavoratrice.
Rafforziamoci sempre più, o compagni, stringiamoci l’un l’altro le mani per
combattere fino alla fine, fino alla piena vittoria pel dominio della nostra
classe e quando i lavoratori d’Europa ci chiameranno, allora correremo in loro
aiuto, tutti, fino all’ultimo uomo, coi fucili in mano e con bandiere rosse,
moveremo loro incontro in nome della fratellanza di tutti i popoli della terra,
in nome del socialismo.
Leone D. Trotzky (1918)
71
– Come organizzare l’emulazione? (Nicolaj
Lenin)
Gli scrittori borghesi hanno
imbrattato e imbrattano montagne di carta inneggiando alla concorrenza, alla
iniziativa privata e ad altre magnifiche prodezze e bellezze dei capitalisti e
del regime capitalistico. Si rimprovera ai socialisti di non voler comprendere
l’importanza della “natura dell'uomo”. Ma in realtà, il capitalismo ha da
lungo tempo sostituito alla piccola produzione mercantile indipendente, dove la
concorrenza poteva sviluppare in proporzioni più o meno larghe
l’intraprendenza, l’energia, la iniziativa audace, la grande e grandissima
produzione industriale, le società per azioni, i sindacati e altri monopoli. La
concorrenza, sotto siffatto capitalismo, vuol dire il soffocamento di una
ferocia inaudita, dell’intraprendenza, dell’energia, dell’iniziativa
audace delle masse della popolazione, della sua immensa maggioranza, del
novantanove per cento dei capaci di lavoro; e significa anche sostituire
all’emulazione la truffa finanziaria, il dispotismo, il servismo al sommo
della scala sociale.
Il socialismo non soltanto non spegne l’emulazione, ma crea bensì per la
prima volta la possibilità di applicarla in modo veramente largo, in
proporzioni veramente di massa, di fare entrare realmente la maggioranza dei
lavoratori nell’arena di una attività in cui possono manifestare, sviluppare
effettivamente le loro capacità, rivelare le doti che sono nel popolo -
sorgente dalla quale non si è mai attinto e che il capitalismo calpestava,
comprimeva, soffocava a migliaia e milioni.
Il nostro compito, ora che un governo socialista è al potere, è di organizzare
l’emulazione.
I reggicoda ed i cagnotti della borghesia hanno descritto il socialismo come una
caserma grigia, monotona, abbruttente, uniforme. I lacchè del sacco di scudi,
servi degli sfruttatori - i signori intellettuali borghesi - hanno fatto del
socialismo uno “spauracchio” per il popolo che, precisamente in regime
capitalista, è condannato al bagno e alla caserma, a un lavoro estenuante e
monotono, a una esistenza semi-affamata, a una profonda miseria. I primi passi
verso la liberazione dei lavoratori da questo bagno penale è la confisca delle
terre dei proprietari fondiari, l’istituzione del controllo operaio, la
nazionalizzazione delle banche. I passi successivi saranno: nazionalizzazione
delle fabbriche e delle officine, organizzazione obbligatoria di tutta la
popolazione in società di consumo, che saranno al tempo stesso società per la
vendita dei prodotti, monopolio di Stato del commercio del grano e degli altri
articoli di prima necessità.
Oggi soltanto appare la possibilità di manifestare ampiamente, con
un’estensione veramente di massa, l’intraprendenza, l’emulazione e
l’iniziativa audace. Ogni fabbrica dalla quale il capitalista è stato
cacciato o per lo meno domato da un vero controllo operaio, ogni villaggio dal
quale è stato sloggiato il proprietario fondiario sfruttatore, al quale la
terra è stata tolta, sono ora, e ora soltanto, un campo d’azione nel quale
l’uomo del lavoro può manifestarsi, può raddrizzare un tantino la schiena,
tenersi diritto, sentirsi uomo. Dopo secoli di lavoro per altri, di lavoro
servile per gli sfruttatori, per la prima volta appare la possibilità di
lavorare per sé e di lavorare inoltre approfittando di tutte le conquiste della
tecnica e della cultura moderne.
È evidente che questa sostituzione al lavoro servile del lavoro per sé - la più
grande che conosca la storia dell’umanità - non può prodursi senza'attriti,
difficoltà e conflitti, senza violenza nei confronti dei parassiti inveterati e
dei loro reggicoda. Quanto a ciò, nessun operaio si fa delle illusioni a
profitto degli sfruttatori, delle innumerevoli vessazioni e ingiurie da parte di
questi ultimi, temprati da una dura miseria, gli operai e i contadini poveri
sanno che ci vuole del tempo per spezzare la resistenza degli sfruttatori. Gli
operai e i contadini non sono per nulla contaminati dalle illusioni sentimentali
dei signori intellettuali, di tutti i rammolliti i quali hanno “vociferato”
sino alla raucedine contro i capitalisti, “gesticolato”, “tuonato”
contro di essi, per poi scoppiare in lagrime e comportarsi come dei cani
bastonati il giorno in cui si è trattato di passare agli atti, di mettere in
esecuzione le minacce, di mettere in pratica il rovesciamento dei capitalisti.
La grandiosa sostituzione al lavoro servile del lavoro per sé, del lavoro
organizzato metodicamente - su scala gigantesca - secondo un piano nazionale (e
in una certa misura, anche su scala internazionale, mondiale), esige per di più
- oltre ai provvedimenti “militari” di repressione della resistenza dei
sfruttatori - immensi sforzi di organizzazione e di iniziativa da parte del
proletariato e dei contadini poveri. Il compito organizzativo si intreccia, in
un tutto indissolubile, con il compito di reprimere militarmente, in modo
implacabile, la resistenza degli schiavisti di ieri (i capitalisti) e della muta
dei loro lacchè, i signori intellettuali borghesi. Noi siamo sempre stati gli
organizzatori e i capi, noi abbiamo comandato - dicono e pensano gli schiavisti
di ieri e i loro commessi reclutati tra gli intellettuali - noi vogliamo
rimanere ciò che eravamo, non ci metteremo a dare ascolto al “popolino”,
agli operai, ai contadini; non ci sottometteremo ad essi, faremo del nostro
sapere un’arma per difendere i privilegi del sacco di scudi e il dominio del
capitale sul popolo.
Così parlano, pensano ed agiscono i borghesi e gli intellettuali borghesi. Dal
punto di vista dei loro interessi bassamente egoistici, la loro condotta è
comprensibile: anche per i cagnotti e i parassiti dei proprietari fondiari
feudali, - i preti, gli scribi e i funzionari descritti da Gogol, gli
intellettuali che detestavano Bielinski, - fu difficile separarsi dal servaggio.
Ma la causa degli sfruttatori e del loro servitorame di intellettuali è una
causa disperata. Gli operai e i contadini stanno spezzando la loro resistenza -
con una fermezza, una risolutezza e una implacabilità ancora insufficienti,
purtroppo - e finiranno con lo spezzarla.
“Questi signori” pensano che il “popolino”, i “semplici” operai e
contadini poveri non sapranno adempiere il grande compito - veramente eroico nel
senso storico e universale della parola - di carattere organizzativo che la
rivoluzione socialista ha imposto ai lavoratori. “Non si può fare a meno di
noi”, si dicono a mo’ di consolazione gli intellettuali abituati a servire i
capitalisti e lo Stato capitalista. Il loro cinico calcolo sarà sventato: già
ora uomini colti si staccano da loro e passano dalla parte del popolo, dalla
parte dei lavoratori e li aiutano a spezzare la resistenza dei servi del
capitale. Quanto ai contadini e agli operai, molti sono fra loro gli uomini
dotati di capacità organizzative, e questi uomini cominciano solo ora a essere
coscienti di questa loro capacità a sentirsi attratti verso un lavoro vivo,
creativo, grandioso, ad accingersi essi stessi all’edificazione della società
socialista.
Uno dei compiti più importanti, se non il più importante, consiste oggi nello
sviluppare il più largamente possibile questa libera iniziativa degli operai,
di tutti i lavoratori e di tutti gli sfruttati in generale nell’opera del
lavoro creativo nel campo dell’organizzazione. Bisogna distruggere ad ogni
costo il pregiudizio assurdo, selvaggio, infame, abominevole secondo il quale
soltanto le cosiddette classi superiori, soltanto i ricchi e coloro che sono
passati per la scuola delle classi ricche possono dirigere lo Stato e
l'edificazione organizzativa della società socialista.
Questo è un pregiudizio. Esso viene sostenuto dal consuetudinarismo putrido,
fossilizzato, dall’abitudine alla schiavitù e, più ancora, dalla sordida
cupidigia dei capitalisti che hanno interesse ad amministrare derubando e a
derubare amministrando. No, gli operai non dimenticheranno nemmeno per un
istante di aver bisogno della forza del sapere. Lo zelo straordinario che,
precisamente ora, gli operai dimostrano nel campo dell’istruzione attesta che
da questo lato non vi sono e non vi possono essere errori nel seno del
proletariato. Ma il lavoro di organizzazione è anche alla portata di un comune
cittadino, operaio o contadino, che sappia leggere e scrivere, conosca gli
uomini e sia provvisto di un'esperienza pratica. Simili uomini sono masse nel
“popolino”, del quale gli intellettuali parlano in modo altezzoso e con
disprezzo. La classe operaia e i contadini posseggono una sorgente ricchissima -
sorgente dalla quale non si è mai attinto - di tali uomini dotati di capacità.
Gli operai e i contadini sono ancora “timidi”, non sono abituati all’idea
che essi sono ora la classe dirigente, e non sono ancora abbastanza risoluti. La
rivoluzione non poteva dare di colpo queste qualità a milioni di uomini che la
fame, la miseria avevano costretto tutta la vita a lavorare sotto il bastone. Ma
ciò che precisamente fa la forza, la vitalità e l’invincibilità della
Rivoluzione d’Ottobre 1917 è che essa suscita queste qualità, abbatte tutte
le vecchie barriere, spezza i legami vetusti, fa entrare i lavoratori nella via
dove creano essi stessi la nuova vita.
Il censimento e il controllo, tale è il principale compito economico di ogni
Soviet dei deputati operai, soldati e contadini, di ogni cooperativa di consumo,
di ogni unione o comitato di approvvigionamento, di ogni comitato di officina di
ogni cooperativa di consumo o organo di controllo operaio in generale.
La lotta contro la vecchia abitudine di considerare la misura del lavoro e i
mezzi di produzione dal punto di vista dell’uomo asservito che si domanda:
come liberarsi da un carico supplementare, come strappare almeno qualche cosa
alla borghesia? - questa lotta è indispensabile. Gli operai d'avanguardia,
coscienti, l’hanno già cominciata ed oppongono una vigorosa resistenza ai
nuovi venuti nell’ambiente di fabbrica, che sono apparsi numerosi specialmente
durante la guerra e che vorrebbero ora considerare la fabbrica appartenente al
popolo, diventata proprietà del popolo, come nel passato, dal punto di vista
dell’unico pensiero: “Strappare il più grosso boccone e alzare il tacco”.
Tutto ciò che vi è di cosciente, di onesto, di pensante tra i contadini e la
masse lavoratrici si ergerà in questa lotta a fianco degli operai di
avanguardia.
Il censimento e il controllo, se vengono effettuati dai Soviet operai, soldati e
contadini, potere supremo dello Stato, oppure attenendosi alle indicazioni, al
mandato di questo potere, - censimento e controllo praticato ovunque, generale e
universale, censimento della quantità di lavoro e della ripartizione dei
prodotti, - costituiscono la essenza stessa della trasformazione socialista, una
volta acquistata e assicurata la direzione politica del proletariato.
Il censimento e il controllo, necessari per il passaggio al socialismo, possono
essere soltanto opera delle masse. Soltanto la collaborazione volontaria e
cosciente delle masse degli operai e contadini, compiuta con entusiasmo
rivoluzionario, nel censimento e nel controllo dei ricchi, dei furfanti, dei
parassiti, dei teppisti può vincere queste sopravvivenze della maledetta società
capitalistica, questi rifiuti dell’umanità, queste membra incancrenite e
putrescenti della società, questo contagio, questa peste, questa piaga che il
capitalismo ha lasciato in eredità al socialismo.
Operai e contadini, lavoratori e sfruttati! La terra, le banche, le fabbriche e
le officine sono diventate proprietà del popolo! Accingetevi voi stessi al
censimento e al controllo della produzione e della distribuzione dei prodotti,
questa e soltanto questa è la strada che porta alla vittoria del socialismo, è
il pegno della sua vittoria, il pegno della vittoria su qualsiasi sfruttamento,
su qualsiasi indigenza e miseria. Poiché in Russia vi è abbastanza grano,
ferro, legna, lana, cotone e lino per tutti, purché il lavoro e i prodotti
siano ben distribuiti, purché il controllo sia ben organizzato dal popolo
intiero, un controllo efficace, pratico di questa ripartizione, purché siano
abbattuti, non soltanto in politica, ma anche nella vita economica di tutti i
giorni, i nemici del popolo: i ricchi, i loro reggicoda; poi i furfanti, i
parassiti e i teppisti. (…)
La Comune di Parigi ha fornito un grand’esempio d’iniziativa,
d’indipendenza, di libertà di movimento, di dispiegamento di energia che
partono dalla base, combinati con un centralismo volontario, estraneo a
qualsivoglia stampo. I nostri Soviet seguono la stessa strada. Ma sono ancora
“timidi”, non hanno ancora preso lo slancio, non sono “entrati a fondo”
nel nuovo, grande, fecondo lavoro di creazione di un regime socialista. È
necessario che tutte le “comuni” - qualsiasi fabbrica, villaggio, società
cooperativa di consumo, comitato di approvvigionamento - entrino fra di loro in
emulazione, come organizzatori, pratici del censimento e del controllo del
lavoro e della ripartizione dei prodotti. Il programma di questo censimento e di
questo controllo è semplice, chiaro, comprensibile per tutti: che tutti abbiano
del pane, portino delle scarpe solide e dei vestiti in buono stato, abbiano un
alloggio caldo, lavorino coscienziosamente; che nemmeno un furfante (compresi
gli scansafatiche) sia lasciato in libertà invece di essere rinchiuso in
prigione, o di scontare la pena a un duro lavoro; che nemmeno un ricco il quale
contravviene alle regole e alle leggi del socialismo possa evitare la sorte del
furfante, sorte che giustizia vuole egli debba condividere. (…)
Migliaia di forme e di procedimenti pratici di censimento e di controllo sui
ricchi, sui furfanti e sui parassiti debbono essere elaborati e provati al fuoco
della pratica dalle comuni stesse, dalle piccole cellule nella campagna e nella
città. La varietà è qui una garanzia di vitalità, il pegno del successo nel
raggiungimento dell’obiettivo comune e unico: ripulire il suolo della Russia
di qualsiasi insetto nocivo, delle pulci: i furfanti; delle cimici: i ricchi,
ecc., ecc.
In un luogo si metterà in carcere una decina di ricchi, una dozzina di
furfanti, una mezza dozzina di operai scansafatiche (teppisti scansafatiche,
come molti tipografi di Pietrogrado, soprattutto nelle tipografie di partito).
In un altro luogo si faranno pulir loro le latrine. In un altro ancora verrà
escogitata una combinazione di diversi procedimenti, ad esempio, la liberazione
condizionale per ottenere che gli elementi correggibili tra i ricchi, gli
intellettuali borghesi, i furfanti e i teppisti si emendino rapidamente. Più vi
sarà varietà, tanto meglio, tanto più ricca sarà l’esperienza generale,
tanto più sicuro e immediato sarà il trionfo del socialismo, tanto più
facilmente la pratica elaborerà - poiché essa solo può farlo - i migliori
modi e mezzi di lotta.
In quale comune, in quale quartiere di una grande città, in quale fabbrica, in
quale villaggio non vi sono affamati, non vi sono disoccupati, non vi sono
ricchi parassiti, non vi sono canaglie, lacchè della borghesia, sabotatori che
si dicono intellettuali? Dove è stato fatto di più per aumentare la
produttività del lavoro, per costruire case nuove e buone per i poveri, per
alloggiarli nelle case dei ricchi? Per distribuire effettivamente una bottiglia
di latte ad ogni bambino di famiglia povera?
Ecco, attorno a quali questioni si deve svolgere l’emulazione delle comuni,
delle comunità, delle società, e delle associazioni di consumo e di
produzione, dei Soviet dei deputati operai, soldati e contadini. È in questo
campo di attività che debbono praticamente essere distinti e chiamati a
funzioni amministrative gli organizzatori capaci. Essi sono numerosi fra il
popolo. Ma sono soffocati. Bisogna aiutarli a farsi valere. Essi, e soltanto
essi, sostenuti dalle masse, potranno salvare la Russia e salvare la causa del
socialismo.
N. Lenin (1918)
72
- La IIIª Internazionale e il suo posto nella storia (Nicolaj
Lenin)
Gli imperialisti dei paesi dell’Intesa bloccano la
Russia, mirano a isolare la Repubblica sovietica, come un focolaio
d’infezione, dal mondo capitalista. Questa gente che si gloria della
“democrazia” delle sue istituzioni, è talmente accecata dall’odio contro
la Repubblica Sovietica che non si accorge nemmeno di rendersi ridicola essa
stessa. Pensate: i paesi più avanzati, più civili e più “democratici”,
armati fino ai denti e che, dal punto di vista militare, dominano, soli, su
tutta la terra, temono come il fuoco il contagio ideologico proveniente da un
paese in rovina, affamato, arretrato e, secondo le loro affermazioni, perfino
semiselvaggio!
Questa sola contraddizione apre gli occhi alle masse lavoratrici di tutti i
paesi e contribuisce a smascherare l’ipocrisia degli imperialisti Clemenceau,
Lloyd George, Wilson e dei loro governi.
Ma non ci aiuta soltanto il cieco odio dei capitalisti contro i Soviet; ci
aiutano anche i loro litigi, che li spingono a darsi reciprocamente lo
sgambetto. I capitalisti, che temono più di ogni altra cosa la diffusione di
informazioni veridiche sulla Repubblica sovietica in generale e, in particolare,
la diffusione dei suoi documenti ufficiali, hanno stretto fra loro una vera e
propria congiura del silenzio. Ciononostante, l’organo principale della
borghesia francese, “Le Temps”, ha pubblicato un’informazione sulla
fondazione a Mosca della III Internazionale, dell’Internazionale comunista.
Per questa pubblicazione, noi presentiamo all’organo principale della
borghesia francese, a questo capo dello sciovinismo e dell’imperialismo
francese, i nostri più rispettosi ringraziamenti. Siamo pronti a inviare al
"Temps” un messaggio solenne, come espressione della nostra riconoscenza
per l’aiuto, così proficuo e intelligente, che esso ci dà.
Dal modo come il “Temps” ha redatto la sua informazione in base al nostro
radiogramma, si scorge con la più grande chiarezza, quali sono i motivi che
hanno ispirato questo organo del sacco di scudi. Esso voleva punzecchiare
Wilson, pungerlo: guardate con che razza di gente voi consentite a trattare!
Questi sapientissimi che scrivono per eseguire l’ordinazione del sacco di
scudi, non si accorgono che il loro tentativo di servirsi dei bolscevichi per
spaventare Wilson si trasforma, davanti alle masse lavoratrici, in una pubblicità
per i bolscevichi. Ancora una volta: i nostri più rispettosi ringraziamenti
all’organo dei milionari francesi!
La fondazione della III Internazionale è avvenuta in una situazione mondiale
tale che nessuna proibizione, nessuna piccola e misera astuzia degli
imperialisti della “Intesa” o dei servi del capitalismo, come gli
Scheidemann in Germania, i Renner in Austria, riesce ad impedire che la notizia
della nascita di questa Internazionale e la simpatia per essa si diffondano tra
la classe operaia del mondo intero. Questa situazione è stata creata dalla
rivoluzione proletaria, che si sviluppa manifestamente dappertutto, non giorno
per giorno, ma ora per ora. Questa situazione è stata creata dal movimento
sovietico tra le masse lavoratrici, il quale ha già acquistato una tal forza
che è diventato effettivamente “internazionale”.
La I Internazionale (1864-1872) aveva gettato le fondamenta
dell’organizzazione internazionale del movimento proletario per la
preparazione del loro assalto rivoluzionario contro il capitale. La II
Internazionale (1889-1914) è stata l’organizzazione internazionale del
movimento operaio che si sviluppava in estensione, non senza un temporaneo
rafforzamento dell’opportunismo che ha condotto, in fin dei conti, al
vergognoso fallimento di questa Internazionale.
La III Internazionale è stata creata di fatto nel 1918, quando il processo di
molti anni di lotta contro l'opportunismo e contro il social sciovinismo,
particolarmente durante la guerra, ha condotto alla formazione dei partiti
comunisti in un buon numero di nazioni. Formalmente la III Internazionale è
stata fondata al suo primo Congresso, nel marzo 1919, a Mosca. E il tratto più
caratteristico di questa Internazionale, la sua missione, - applicare, tradurre
in pratica i comandamenti del marxismo e attuare i secolari ideali del
socialismo e del movimento operaio, - questo tratto eminentemente caratteristico
della III Internazionale si è subito rivelato nel fatto che la nuova, la terza
“Associazione internazionale degli operai” già oggi incomincia a
coincidere, in una certa misura, con l’unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche.
La I Internazionale gettò le fondamenta della lotta proletaria internazionale
per il socialismo.
La II Internazionale è stata l'epoca della preparazione del terreno per una
diffusione larga, di massa, del movimento in un buon numero di paesi.
La III Internazionale ha assimilato i frutti dell’attività della II
Internazionale, ne ha amputato il marciume opportunista, social sciovinista,
borghese e piccolo-borghese e ha incominciato ad attuare la dittatura del
proletariato.
L’unione internazionale dei partiti che dirigono il movimento più
rivoluzionario del mondo, il movimento del proletariato per l’abbattimento del
giogo del capitale, ha oggi un fondamento solido come nessun altro mai: alcune
Repubbliche sovietiche, le quali incarnano, internazionalmente, la dittatura del
proletariato, la sua vittoria sul capitalismo.
L’importanza storica mondiale della III Internazionale, dell’Internazionale
Comunista, sta nell'aver essa incominciato a tradurre in pratica la più grande
parola d’ordine di Marx, la parola d’ordine che riassume il secolare
sviluppo del socialismo e del movimento operaio, la parola d’ordine che si
esprime nel concetto: dittatura del proletariato.
Questa geniale previsione, questa geniale teoria diventa realtà.
Oggi, queste parole latine sono tradotte in tutte le lingue nazionali
dell’Europa moderna, anzi, in tutte le lingue del mondo.
È incominciata una nuova epoca della storia mondiale.
Il genere umano si libera dell’ultima forma di schiavitù: della schiavitù
capitalistica o schiavitù salariata.
Liberandosi dalla schiavitù, il genere umano passa per la prima volta alla
libertà effettiva.
Come è potuto accadere che il primo paese il quale ha attuato la dittatura del
proletariato, organizzato una Repubblica sovietica, fosse uno dei paesi europei
più arretrati? Non sbaglieremo dicendo che appunto questa contraddizione tra
l’arretratezza della Russia e il suo “salto” oltre la democrazia borghese,
verso la forma più alta della democrazia, la democrazia sovietica o la
democrazia proletaria, appunto questa contraddizione (oltre la schiavitù delle
abitudini opportuniste e dei pregiudizi filistei che pesano sulla maggioranza
dei capi del socialismo), è stata una delle ragioni che hanno ostacolato o
rallentato in modo particolare la comprensione della funzione dei Soviet
nell'Europa occidentale.
Le masse operaie hanno afferrato per istinto, in tutto il mondo, il significato
dei Soviet, come strumenti per la lotta del proletariato e come forma dello
Stato proletario. Ma i “capi” corrotti dall’opportunismo continuavano e
continuano ad adorare la democrazia borghese, chiamandola “democrazia” in
generale.
C’è forse da stupirsi se l’attuazione della dittatura del proletariato ha
mostrato prima di tutto la contraddizione tra l’arretratezza della Russia e il
suo salto oltre la democrazia borghese? Ci sarebbe invece da stupirsi se nuova
forma di democrazia ci fosse regalata dalla storia senza una serie di
contraddizioni.
Qualunque marxista anzi chiunque conosce la scienza moderna in generale, se gli
vien posto il quesito: “È probabile che il passaggio dei diversi paesi
capitalistici alla dittatura del proletariato avvenga in modo uniforme, cioè
armonicamente proporzionato?” - darà indubbiamente una risposta negativa. Nel
mondo capitalistico non vi sono mai state e non potevano esservi né uniformità
né armonia né proporzione. Ogni paese sviluppava con particolare rilievo ora
uno ora un altro lato o carattere o gruppo di particolarità del capitalismo e
del movimento operaio. Il processo di sviluppo avveniva in modo ineguale.
Quando la Francia fece la sua Grande Rivoluzione borghese svegliando a nuova
vita storica tutto il continente europeo, l’Inghilterra si trovò alla testa
della coalizione controrivoluzionaria, pur essendo nello stesso tempo molto più
sviluppata della Francia dal punto di vista capitalistico. E il mondo operaio
inglese di quel tempo anticipava genialmente parecchi aspetti del futuro
marxismo.
Quando l’Inghilterra diede al mondo il primo vasto movimento proletario
rivoluzionario, un effettivo movimento di massa, politicamente definito, il
cartismo, sul continente europeo avvennero - nella maggior parte dei casi –
delle deboli rivoluzioni borghesi e in Francia si accese la prima grande guerra
civile tra il proletariato e la borghesia. La borghesia sconfisse ad uno ad uno
i vari reparti nazionali del proletariato, e in vari modi nei diversi paesi.
L'Inghilterra fornì il modello di un paese nel quale, secondo l’espressione
di Engels, la borghesia, accanto alla aristocrazia imborghesita, ha creato uno
strato superiore del proletariato più imborghesito. Un paese capitalistico
progredito si è dimostrato in ritardo di alcuni decenni dal punto di vista
della lotta rivoluzionaria del proletariato. La Francia si direbbe che abbia
esaurite le forze del proletariato nelle due eroiche insurrezione della classe
operaia contro la borghesia, nel 1848 e nel 1871, le quali diedero un contributo
straordinariamente grande dal punto di vista storico mondiale. In seguito, dal
decennio 1870-1880, l'egemonia dell’Internazionale del movimento operaio passò
alla Germania, la quale, allora, era economicamente in ritardo rispetto
all’Inghilterra e alla Francia. E quando la Germania sorpassò nel campo
economico entrambi questi due paesi, e cioè all’inizio del secondo decennio
del secolo ventesimo, alla testa del partito operaio marxista della Germania,
che serviva di modello in tutto il mondo, si trovò un gruppo di perfetti
mascalzoni, formato dalle più luride canaglie vendute ai capitalisti - da
Scheidemann e Noske a David e Legien, - dai più ripugnanti carnefici
provenienti dalle file operaie e passati al servizio della monarchia e della
borghesia controrivoluzionaria.
La storia mondiale procede inflessibilmente verso la dittatura del proletariato,
ma segue delle vie tutt’altro che piane, facili, diritte.
Quando Carlo Kautsky era ancora un marxista, e non quel rinnegato del marxismo
che egli è divenuto nella sua qualità di propugnatore dell’unità con gli
Scheidemann e della democrazia borghese contro la democrazia sovietica e
proletaria, al principio del sec. XX scrisse un articolo: “Gli slavi e la
rivoluzione”. In questo articolo egli esponeva le condizioni storiche che
facevano prevedere la possibilità del passaggio agli slavi dell’egemonia nel
movimento rivoluzionario internazionale.
Così è avvenuto. Per un certo tempo - soltanto per un breve periodo di tempo,
è ovvio – l’egemonia nell’internazionale rivoluzionaria proletaria è
passata ai russi, come in diversi periodi del secolo decimonono era stata degli
inglesi, poi dei francesi e in seguito dei tedeschi.
Ho già avuto più volte l’occasione di dire: per i russi, in confronto ai
paesi più avanzati, è stato più facile iniziare la grande rivoluzione
proletaria; ma sarà per essi più difficile il continuarla e il condurla fino
alla vittoria definitiva, nel senso della completa organizzazione della società
socialista. Per noi è stato più facile incominciare, innanzi tutto perché
l’arretratezza politica eccezionale - eccezionale per l’Europa del secolo
ventesimo - della monarchia zarista ha dato una forza straordinaria
all’assalto rivoluzionario delle masse. In secondo luogo, l’arretratezza
della Russia ha fuso in modo originale la rivoluzione proletaria contro la
borghesia con la rivoluzione dei contadini contro i proprietari fondiari.
Nell’ottobre 1917 noi abbiamo incominciato da questo, e non avremmo vinto
allora così facilmente se non avessimo incominciato da questo. Fin dal 1856, a
proposito della Prussia, Marx rilevava la possibilità di una combinazione
originale della rivoluzione proletaria con la guerra dei contadini. I
bolscevichi, dall’inizio del 1905, difesero l’idea della dittatura
democratica rivoluzionaria del proletariato e dei contadini. In terzo luogo, la
rivoluzione del 1905 contribuì immensamente all’educazione politica delle
masse degli operai e dei contadini, tanto nel senso della conoscenza
dell’”ultima parola” del socialismo occidentale da parte della loro
avanguardia, quanto nel senso dell’azione rivoluzionaria delle masse. Senza
una “prova generale” come quella del 1905, le rivoluzioni nel 1917, - la
rivoluzione borghese di febbraio come la rivoluzione borghese di ottobre, - non
sarebbero state possibili. In quarto luogo, le condizioni geografiche della
Russia le permettevano di resistere più a lungo degli altri paesi contro la
preponderanza esterna dei paesi capitalistici avanzati. In quinto luogo,
l'atteggiamento originale del proletariato verso i contadini facilitava il
passaggio dalla rivoluzione borghese alla rivoluzione socialista, favoriva
l’influenza dei proletari della città sugli strati semiproletari, sugli
strati poveri dei lavoratori della campagna. In sesto luogo, la lunga scuola di
lotta mediante gli scioperi e l’esperienza del movimento operaio di massa
europeo, in una situazione profondamente rivoluzionaria che si aggravava con
rapidità, hanno facilitato la nascita di una norma di organizzazione proletaria
rivoluzionaria originale come i Soviet.
Questo elenco, si capisce, non è completo. Ma per ora possiamo limitarci a
questo.
La democrazia sovietica o proletaria è nata in Russia. Rispetto alla Comune di
Parigi, si è fatto un secondo passo di importanza storica mondiale. La
Repubblica sovietica proletaria e contadina è la prima salda repubblica
socialista del mondo. Come “nuovo tipo di Stato” essa non può più morire.
Oggi essa non è più sola.
Per continuare il lavoro della costruzione del socialismo e per condurlo a
termine, ci vuole ancora moltissimo. Le repubbliche sovietiche nei paesi più
civili dove il peso e l’influenza del proletariato sono maggiori, hanno tutte
le probabilità di sorpassare la Russia quando si metteranno sulla via della
dittatura del proletariato.
La fallita II Internazionale si spegne e va in putrefazione ancor prima di
morire.
In pratica, essa fa la parte del servitore della borghesia internazionale. È
una vera e propria Internazionale gialla. I suoi maggiori capi ideologici, del
genere di Kautsky, esaltano la democrazia borghese, chiamandola “democrazia”
in generale, oppure, - e questo è ancora più sciocco e più grossolano –
“democrazia pura”.
La democrazia borghese ha fatto il suo tempo, come ha fatto il suo tempo anche
la II Internazionale, la quale ha svolto un lavoro storicamente necessario e
utile quando si trattava della preparazione delle masse operaie nei limiti di
questa democrazia borghese.
La più democratica delle repubbliche borghesi non è mai stata altro, e non
poteva esser altro, che una macchina del capitale per schiacciare i lavoratori,
uno strumento del potere politico del capitale, la dittatura della borghesia. La
repubblica democratica borghese prometteva il potere alla maggioranza, ma non ha
mai potuto attuarlo finché esisteva la proprietà privata della terra e degli
altri mezzi di produzione.
La “libertà” nella repubblica democratica borghese era, di fatto, la libertà
per i ricchi. I proletari e i contadini lavoratori potevano e dovevano
servirsene al fine di preparare le loro forze per abbattere il capitale, per
sorpassare la democrazia borghese; ma, di regola, le masse lavoratrici, sotto il
capitalismo, non potevano utilizzare effettivamente la democrazia.
Per la prima volta nel mondo la democrazia sovietica o proletaria ha, di fatto,
creato la democrazia per le masse, per i lavoratori, per gli operai e per i
piccoli contadini.
Non c'era mai stato al mondo un simile potere statale della maggioranza della
popolazione, un potere effettivo di questa maggioranza, come è il potere
sovietico.
Esso reprime la “libertà” degli sfruttatori e dei loro accoliti, strappa
loro la “libertà” di sfruttare, la “libertà” di arricchirsi sulla
fame, la “libertà” di lotta per la restaurazione del potere del capitale,
la “libertà” di una intesa con la borghesia straniera contro gli operai e i
contadini del loro paese.
Difendano pure i Kautsky una siffatta libertà. Per fare una cosa simile bisogna
essere un rinnegato del marxismo, un rinnegato del socialismo.
In nulla il fallimento dei capi ideologici della II Internazionale, come
Hilferding e Kautsky, si è espresso tanto chiaramente quanto nella loro
completa incapacità di comprendere il significato della democrazia sovietica o
proletaria, il rapporto che intercorre tra essa e la comune di Parigi, il suo
posto nella storia, la sua necessità come forma della dittatura del
proletariato.
Nel n. 74 del giornale “La Libertà “ (“Die Freiheit”), organo della
socialdemocrazia tedesca “indipendente” (leggi piccolo-borghese, filistea),
l’11 febbraio 1919, è comparso un appello intitolato “Al proletariato
rivoluzionario della Germania”.
Questo appello è firmato dalla direzione del partito e da tutto il suo gruppo
all’”Assemblea nazionale”, alla “Costituente” tedesca.
Questo appello accusa gli Scheidemann di voler eliminare i Soviet e propone -
non si scherza! - di combinare i Soviet con la “Costituente”, di dare ai
Soviet certi diritti statali, un certo posto nella Costituzione.
Conciliare, unificare la dittatura della borghesia con la dittatura del
proletariato. Come è semplice tutto questo! Che idea genialmente filistea!
Peccato che essa sia già stata sperimentata in Russia al tempo di Kerenski dai
menscevichi e dai “socialisti-rivoluzionari” uniti, questi democratici
piccolo-borghesi che immaginano di essere dei socialisti.
Chi, leggendo Marx, non ha capito che nella società capitalistica, in ogni
momento grave, in ogni serio conflitto tra le classi, è soltanto possibile o la
dittatura della borghesia o la dittatura del proletariato, non ha capito nulla
della dottrina economica, né della dottrina politica di Marx.
Ma l’idea genialmente filistea di Hilferding, di Kautsky e consorti, l’idea
di una pacifica combinazione della dittatura della borghesia e della dittatura
del proletariato, esige un esame speciale se si vuol dar fondo agli assurdi
economici e politici accumulati in questo notevolissimo e comicissimo appello
dell’11 febbraio. Converrà rinviare questo esame ad un altro articolo.
N. Lenin (Mosca, 15 aprile 1919)
73
- Lenin è morto (Iosif
Stalin)
Compagni, noi comunisti siamo
gente di una fattura particolare. Siamo fatti di una materia speciale. Siamo
coloro che formano l’esercito del grande stratega proletario, l’esercito del
compagno Lenin. Nulla è più elevato dell’onore di appartenere a questo
esercito. Nulla è più elevato dell’appellativo di membro del partito che è
stato fondato e diretto dal compagno Lenin. Non ha tutti è dato esser membri di
un tale partito. Non a tutti è dato sopportare i rovesci e le tempeste che
l'appartenenza a tale partito comporta. I figli della classe operaia, i figli
del bisogno e della lotta, i figli delle privazioni inimmaginabili e degli
sforzi eroici, - ecco coloro che, innanzi tutto, debbono appartenere a un tale
partito. Ecco perché il partito dei leninisti, il partito dei comunisti, si
chiama al tempo stesso partito della classe operaia.
Lasciandoci il compagno Lenin ci ha comandato di tener alto e serbar puro il
grande appellativo di membro del Partito. Ti giuriamo, compagno Lenin, che noi
adempiremo con onore al tuo comandamento!
Per 25 anni Lenin ha educato il nostro partito e ne ha fatto il partito operaio
più forte e più temprato del mondo. I colpi dello zarismo e dei suoi sbirri, a
rabbia della borghesia e dei proprietari fondiari, gli attacchi armati di
Kolciak e di Denikin, gli interventi armati dell’Inghilterra e della Francia,
le menzogne e le calunnie della stampa borghese dalle cento bocche - tutti
questi scorpioni si sono costantemente scagliati sul nostro partito nel corso di
un quarto di secolo. Ma il nostro partito ha resistito, saldo come una roccia,
ha respinto gli innumerevoli colpi dei nemici e ha condotto avanti la classe
operaia, verso la vittoria. In queste battaglie furibonde, il nostro partito ha
forgiato l’unità e la compattezza delle proprie fila. L'unità e la
compattezza gli hanno dato la vittoria sui nemici della classe operaia.
Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di salvaguardare, come la pupilla
dei nostri occhi, l’unità del nostro partito. Ti giuriamo, compagno Lenin,
che adempiremo con onore anche a questo tuo comandamento!
Grave, insopportabile è la sorte della classe operaia. Penose e gravi le
sofferenze dei lavoratori. Schiavi e schiavisti, servi e signori, contadini e
proprietari fondiari, operai e capitalisti, oppressi e oppressori, - così
attraverso i secoli si fece il mondo, così lo è ancora nella più gran parte
dei paesi. Decine e centinaia di volte, nel corso dei secoli, i lavoratori
tentarono di rigettare alle loro spalle il giogo degli oppressori e di diventare
padroni dei propri destini. Ma ogni volta, sconfitti e avviliti, furono
costretti a retrocedere serbando nell’anima l’onta e l’offesa, l’odio e
lo scoraggiamento, volgendo gli occhi al cielo ignoto, dove speravano trovare la
salvezza. Le catene della schiavitù rimanevano ben salde, oppure le vecchie
catene erano sostituite da catene nuove, altrettanto pesanti e avvilenti. Solo
nel nostro paese le masse lavoratrici oppresse e schiacciate sono riuscite a
rigettare dalle loro spalle il dominio dei latifondisti e dei capitalisti e a
instaurare al suo posto il dominio degli operai e dei contadini. Voi sapete
compagni, e il mondo intiero oggi lo riconosce, che questa lotta gigantesca è
stata guidata da Lenin e dal suo partito. La grandezza di Lenin sta innanzi
tutto nel fatto che egli, creando la Repubblica dei Soviet, ha mostrato con ciò
praticamente alle masse oppresse del mondo intiero che la speranza della
liberazione non è perduta, che il dominio dei capitalisti e dei proprietari
fondiari non durerà più a lungo, che il regno del lavoro si deve creare sulla
terra e non in cielo. In questo modo egli ha acceso nel cuore degli operai e dei
contadini di tutto il mondo la speranza nella liberazione. Così si spiega perché
il nome di Lenin è divenuto il nome più amato dalle masse lavoratrici e
sfruttate.
Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di salvaguardare e rafforzare la
dittatura del proletariato. Ti giuriamo, compagno Lenin, che non risparmieremo
le nostre forze per adempiere con onore anche questo tuo comandamento!
La dittatura del proletariato è stata creata nel nostro paese sulla base
dell’alleanza degli operai e dei contadini. Questa è la base prima ed
essenziale della Repubblica dei Soviet. Senza questa alleanza, gli operai e i
contadini non avrebbero potuto vincere i capitalisti e i proprietari fondiari.
Gli operai non avrebbero potuto battere i capitalisti senza l’appoggio dei
contadini. I contadini non avrebbero potuto battere i proprietari fondiari se
non fossero stati diretti dagli operai. Ciò è dimostrato da tutta la storia
della guerra civile nel nostro paese. Ma la lotta per il rafforzamento della
Repubblica dei Soviet è ben lontana dall’essere terminata: essa ha assunto
un’altra forma. Prima la alleanza degli operai e dei contadini aveva la forma
di un’alleanza militare, poi che era diretta contro Kolciak e Denikin. Adesso
l’alleanza degli operai e dei contadini deve assumere la forma di una
collaborazione economica fra la città e la campagna, fra gli operai ed i
contadini, poiché è diretta contro il mercante e i kulaki, poiché ha per
scopo di rifornire reciprocamente contadini e operai di tutto il necessario. Voi
sapete che nessuno ha perseguito con tanta tenacia questo compito come il
compagno Lenin.
Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di rinsaldare con tutte le forze
l’alleanza degli operai e dei contadini. Ti giuriamo, compagno Lenin, che
adempiremo con onore anche questo tuo comandamento!
La seconda base della Repubblica dei Soviet è l’unione dei lavoratori delle
varie nazionalità del nostro paese. I russi e gli ucraini, i basckiri e i
bielorussi, i georgiani e i kirghisi, gli usbechi e i turkmeni, - tutti sono
ugualmente interessati al rafforzamento della dittatura del proletariato. Non
solo la dittatura del proletariato libera questi popoli dalle catene e
dall’oppressione ma, a loro volta, questi popoli con la loro indefettibile
devozione alla Repubblica dei Soviet, col loro spirito di sacrificio,
salvaguardano la nostra Repubblica dalle trame e dagli attacchi dei nemici della
classe operaia. Ecco perché il compagno Lenin ci parlava instancabilmente della
necessità di una fraterna collaborazione nel quadro dell’Unione delle
Repubbliche.
Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di rafforzare e di estendere
l’Unione delle Repubbliche. Ti giuriamo, compagno Lenin, che adempiremo con
onore anche questo tuo comandamento!
La terza base della dittatura del proletariato è il nostro Esercito Rosso, la
nostra Flotta Rossa. Più di una volta Lenin ci ha detto che la tregua strappata
agli stati capitalistici poteva essere di breve durata. Più di una volta Lenin
ci ha detto che il rafforzamento dell’Esercito Rosso e il suo perfezionamento
sono uno dei compiti essenziali del nostro partito. Gli avvenimenti legati
all’ultimatum di Curzon e alla crisi in Germania, hanno confermato ancora una
volta, che come sempre, Lenin aveva ragione. Giuriamo dunque, compagni, che non
risparmieremo le nostre forze per rafforzare il nostro Esercito Rosso e la
nostra Flotta Rossa!
Il nostro paese è come una roccia gigantesca, circondata dall’oceano degli
stati borghesi. Le onde si infrangono l’una dopo l’altra contro di essa,
minacciando di sommergerla e di sgretolarla. Ma la roccia è incrollabile. In
che cosa consiste la sua forza? Non solo nel fatto che il nostro paese si
appoggia sull’alleanza degli operai e contadini, che esso incarna l’unione
delle libere nazionalità, che è difeso dalla mano potente dell’Esercito
Rosso e della Flotta Rossa. La forza del nostro paese, il suo vigore, la sua
fermezza risiedono nel fatto che essa possiede la profonda simpatia e l'appoggio
costante degli operai e contadini dal mondo intiero. Gli operai e i contadini di
tutto il mondo vogliono salvaguardare la Repubblica dei Soviet, freccia che è
stata lanciata dalla mano sicura del compagno Lenin nel campo dei nemici;
baluardo delle loro speranze nella liberazione dall’oppressione e dallo
sfruttamento; faro sicuro che addita loro il cammino della liberazione. Essi
vogliono salvaguardarla; essi non permetteranno che i proprietari fondiari e i
capitalisti la distruggano. In ciò sta la nostra forza. In ciò sta la forza
dei lavoratori di tutti i paesi e in ciò sta la debolezza della borghesia di
tutto il mondo.
Lenin non considerò mai la Repubblica dei Soviet come fine a se stessa. Egli la
considerò sempre come un anello necessario per lo sviluppo del movimento
rivoluzionario nei paesi dell’occidente e dell’oriente, come un anello
necessario per agevolare la vittoria dei lavoratori del mondo intiero sul
capitale. Lenin sapeva che solo questa concezione è giusta, non solo dal punto
di vista internazionale, ma anche dal punto di vista della semplice salvaguardia
della stessa Repubblica dei Soviet. Lenin sapeva che solo in questo modo è
possibile infiammare i cuori dei lavoratori di tutto il mondo per le lotte
decisive per la liberazione. Ecco perché Lenin, il capo più geniale fra i capi
geniali del proletariato, il giorno dopo l’instaurazione della dittatura del
proletariato gettò le fondamenta dell’Internazionale degli operai. Ecco perché
egli non si stancava mai di estendere, di rafforzare l’Unione dei lavoratori
di tutto il mondo, l’Internazionale comunista.
Avete assistito in questi giorni al pellegrinaggio di decine e centinaia e
migliaia di lavoratori al feretro del compagno Lenin. Fra qualche tempo
assisterete al pellegrinaggio dei rappresentanti di milioni di lavoratori alla
tomba del compagno Lenin. Potete essere certi che, dopo i rappresentanti di
milioni di lavoratori, verranno i rappresentanti di decine e centinaia di
milioni di uomini, da tutte le parti del mondo, per attestare che Lenin fu il
capo non solo del proletariato russo, non solo degli operai europei, non solo
dell’oriente coloniale, ma dei lavoratori di tutto il mondo.
Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha comandato di essere fedeli ai principi
dell’Internazionale comunista. Ti giuriamo, compagno Lenin, che non
risparmieremo la nostra vita pur di rafforzare e di estendere l’unione dei
lavoratori di tutto il mondo, l’Internazionale comunista!
Giuseppe Stalin (1879-1953)
(Discorso pronunciato al II Congresso dei Soviet dell’U.R.S.S. il 26 gennaio
1924)
74 - Da “I principi del leninismo” (Iosif Stalin)
I principi del leninismo: vasto
argomento. Occorrerebbe un libro intero per esaurirlo. Anzi, occorrerebbe una
serie di libri. È naturale, quindi, che le mie lezioni non potranno essere una
esposizione esauriente del leninismo. Nel migliore dei casi, potranno essere
soltanto un riassunto conciso dei principi del leninismo. Ciononostante, ritengo
utile fare questo riassunto per fissare alcuni punti di partenza fondamentali,
indispensabili per uno studio proficuo del leninismo.
Esporre i principi del leninismo non vuole ancora dire esporre i principi della
concezione del mondo di Lenin. La concezione del mondo di Lenin ed i principi
del leninismo non sono, per l’ampiezza, la stessa cosa. Lenin è un marxista e
la base della sua concezione del mondo è naturalmente, il marxismo. Ma, da
questo non deriva affatto che una esposizione del leninismo debba partire dalla
esposizione dei principi del marxismo. Esporre il leninismo significa esporre ciò
che vi è di particolare e di nuovo nell’opera di Lenin, ciò che Lenin ha
apportato al tesoro comune del marxismo e che naturalmente è legato al suo
nome. Soltanto in questo senso parlerò nelle mie lezioni dei principi del
leninismo.
Dunque, che cosa è il leninismo?
Gli uni dicono che il leninismo, è l’applicazione del marxismo alle
condizioni originali della situazione russa. In questa definizione vi è una
parte di verità, ma essa è ben lontana dal contenere tutta la verità. Lenin
ha effettivamente applicato il marxismo alla situazione russa e l’ha applicato
in modo magistrale. Ma se il leninismo non fosse che l’applicazione del
marxismo alla situazione originale della Russia, sarebbe un fenomeno puramente
nazionale e soltanto nazionale, puramente russo e soltanto russo. Invece noi
sappiamo che il leninismo è un fenomeno internazionale, che ha le sue radici in
tutta l’evoluzione internazionale e non è, quindi, soltanto un fenomeno
russo. Ecco perché penso che questa definizione pecchi di unilateralità.
Altri dicono che il leninismo è la rinascita degli elementi rivoluzionari del
marxismo del decennio 1840-1850, per distinguerlo dal marxismo degli anni
successivi, divenuto, a loro avviso, moderato, non più rivoluzionario. A
prescindere dalla sciocca e banale divisione della dottrina di Marx in due
parti, una rivoluzionaria e una moderata, bisogna riconoscere che anche questa
divisione, del tutto insufficiente e insoddisfacente, contiene una parte di
verità. Questa parte di verità, consiste nel fatto che Lenin ha effettivamente
risuscitato il contenuto rivoluzionario del marxismo, ch’era stato sotterrato
dagli opportunisti della II Internazionale. Ma questa non è che una parte della
verità. La verità intera è che il leninismo non solo ha risuscitato il
contenuto rivoluzionario dal marxismo, ma ha fatto ancora un passo avanti
sviluppando ulteriormente il marxismo nelle nuove condizioni del capitalismo e
della lotta di classe del proletariato.
Che cosa è dunque, in ultima analisi il leninismo?
Il leninismo è il marxismo dell’epoca dell’imperialismo e dalla rivoluzione
proletaria. Più esattamente: il leninismo è la teoria e la tattica della
rivoluzione proletaria in generale, la teoria e la tattica della dittatura del
proletariato in particolare. Marx ed Engels militarono nel periodo
prerivoluzionario (ci riferiamo alla rivoluzione proletaria), quando
l’imperialismo non si era ancora sviluppato, nel periodo di preparazione dei
proletari alla rivoluzione, nel periodo in cui la rivoluzione proletaria non era
ancora diventata una necessità pratica immediata. Lenin invece, discepolo di
Marx e di Engels, militò nel periodo di pieno sviluppo dell’imperialismo, nel
periodo dello scatenamento della rivoluzione proletaria, quando la rivoluzione
proletaria aveva già trionfato in un paese, aveva distrutto la democrazia
borghese e aperto l’era della democrazia proletaria, l’era dei Soviet.
Ecco perché il leninismo è lo sviluppo ulteriore del marxismo.
Si mette spesso in rilievo il carattere straordinariamente combattivo,
straordinariamente rivoluzionario del leninismo. Ciò è del tutto giusto. Ma
questa caratteristica del leninismo si spiega con due motivi: in primo luogo,
col fatto che il leninismo è sorto dalla rivoluzione proletaria, e non può non
portarne l’impronta; in secondo luogo, col fatto che esso è cresciuto e si è
rafforzato nella lotta contro l’opportunismo della II Internazionale, lotta
che fu ed è condizione necessaria e preliminare per il successo della lotta
contro il capitalismo. Non bisogna dimenticare che fra Marx ed Engels da una
parte, e Lenin dall’altra, si stende un intero periodo di dominio
incontrastato dell’opportunismo della II Internazionale. La lotta spietata
contro l’opportunismo non poteva non essere uno dei compiti più importanti
del leninismo.
Il leninismo sorse e si formò nelle condizioni del periodo dell’imperialismo,
quando le contraddizioni del capitalismo erano giunte al punto più alto, quando
la rivoluzione proletaria era diventata un problema pratico immediato, quando il
precedente periodo di preparazione della classe operaia alla rivoluzione si era
chiuso, e si era entrati nel nuovo periodo dell’assalto diretto al
capitalismo.
Lenin chiamava l’imperialismo “capitalismo morente”. Perché? Perché
l’imperialismo porta le contraddizioni del capitalismo all'ultimo termine, ai
limiti estremi, oltre i quali comincia la rivoluzione. Di queste contraddizioni,
tre devono essere considerate come le più importanti.
La prima contraddizione è la contraddizione tra il lavoro e il capitale.
L’imperialismo è l’onnipotenza, nei paesi industriali, dei trust e dei
sindacati monopolistici, delle banche e dell’oligarchia finanziaria. Nella
lotta contro questa onnipotenza, i metodi abituali della classe operaia –
sindacati e cooperative, partiti parlamentari e lotta parlamentare - si sono
rivelati assolutamente insufficienti. O abbandonarsi alla mercé del capitale,
vegetare all’antica e scendere sempre più in basso, o impugnare una nuova
arma: così l’imperialismo pone il problema alle masse innumerevoli del
proletariato. L’imperialismo avvicina la classe operaia alla rivoluzione.
La seconda contraddizione è la contraddizione fra i diversi gruppi finanziari e
le diverse potenze imperialiste nella loro lotta per le fonti di materie prime e
per i territori altrui. L’imperialismo è esportazione di capitale verso le
fonti di materie prime, lotta accanita per il possesso esclusivo di queste
fonti, lotta per una nuova spartizione del mondo già diviso, lotta che viene
condotta con particolare asprezza dai gruppi finanziari nuovi e dalle potenze in
cerca di un “posto al sole”, contro i vecchi gruppi e le potenze che non
vogliono a nessun costo abbandonare il bottino. Questa lotta accanita tra
diversi gruppi di capitalisti è degna di nota perché racchiude in sé, come
elemento inevitabile, le guerre imperialiste, le guerre per la conquista di
territori altrui. Questa circostanza, a sua volta, è degna di nota perché
porta all’indebolimento reciproco degli imperialisti, all’indebolimento
delle posizioni del capitalismo in generale, perché avvicina il momento della
rivoluzione proletaria, perché rende praticamente necessaria questa
rivoluzione.
La terza contraddizione è la contraddizione tra un pugno di nazioni
“civili” dominanti e centinaia di milioni di uomini appartenenti ai popoli
coloniali e dipendenti del mondo. L’imperialismo è lo sfruttamento più
spudorato, l’oppressione più inumana di centinaia di milioni di abitanti
degli immensi paesi coloniali e dipendenti. Spremere dei sopraprofitti: ecco lo
scopo di questo sfruttamento e di questa oppressione. Ma per sfruttare questi
paesi l’imperialismo è costretto a costruirvi delle ferrovie, delle
fabbriche, delle officine, a crearvi dei centri industriali e commerciali.
L’apparire di una classe di proletari, il sorgere di uno strato intellettuale
indigeno, il risveglio di una coscienza nazionale, il rafforzarsi del movimento
per l’indipendenza: tali sono gli effetti inevitabili di questa
“politica”. L’incremento del movimento rivoluzionario in tutte le colonie
e in tutti i paesi dipendenti, senza eccezione, ne fornisce la prova evidente.
Questa circostanza è importante per il proletariato perché mina alle radici le
posizioni del capitalismo, trasformando le colonie e i paesi dipendenti da
riserve dell’imperialismo in riserve della rivoluzione proletaria.
Tali sono, in generale, le principali contraddizioni dell’imperialismo che
hanno trasformato il “florido” capitalismo di una volta in capitalismo
morente.
L’importanza della guerra imperialista, scatenatasi dieci anni fa, consiste,
tra l’altro, nel fatto che essa ha raccolto in un sol fascio tutte queste
contraddizioni e le ha gettate sul piatto della bilancia, accelerando e
facilitando le battaglie rivoluzionarie del proletariato.
L’imperialismo, in altri termini, non solo ha fatto sì che la rivoluzione
proletaria è diventata una necessità pratica, ma ha pure creato le condizioni
favorevoli per l’assalto diretto alle fortezze del capitalismo.
Tale è la situazione internazionale che ha generato il leninismo.
Tutto ciò va benissimo, si dirà; ma che c’entra la Russia, la quale certo
non era e non poteva essere il paese classico dell’imperialismo? Che c'entra
Lenin, il quale ha lavorato soprattutto in Russia e per la Russia? Perché mai
proprio la Russia è diventata il focolaio del leninismo, la patria della teoria
e della pratica della rivoluzione proletaria?
Per il fatto che la Russia era il punto nodale di tutte queste contraddizioni
dell’imperialismo.
Per il fatto che la Russia era, più di qualsiasi altro paese, gravida di
rivoluzione, e perciò soltanto essa era in grado di risolvere queste
contraddizioni per via rivoluzionaria.
Innanzi tutto, la Russia zarista era un focolaio di ogni genere di oppressione,
- e capitalistica, e coloniale, e militare, - esercitata nella forma più
barbara e più inumana. Chi non sa che in Russia l’onnipotenza del capitale si
fondeva col potere dispotico dello zarismo, l’aggressività del nazionalismo
russo con la ferocia dello zarismo verso i popoli non russi, lo sfruttamento di
intere regioni – della Turchia, della Persia, della Cina - con la conquista di
queste regioni da parte dello zarismo, con le guerre volte a conquistarle? Lenin
aveva ragione di dire che lo zarismo era un “imperialismo feudale militare”.
Lo zarismo concentrava in sé i lati più negativi dell’imperialismo, elevati
al quadrato.
E non basta. La Russia era un’immensa riserva dell’imperialismo occidentale
non soltanto nel senso che dava libero accesso al capitale straniero - il quale
teneva in pugno settori decisivi dell’economia russa, come i combustibili e la
metallurgia - ma anche nel senso che poteva mettere al servizio degli
imperialisti dell’occidente milioni di soldati. Ricordate l’esercito russo
di dodici milioni di uomini, che ha versato il sangue sui fronti della guerra
imperialista per assicurare favolosi profitti ai capitalisti anglo-francesi.
Ancora. Lo zarismo non era soltanto il cane da guardia dell’imperialismo
nell’Europa orientale. Era anche un’agenzia dell’imperialismo occidentale
per estorcere alla popolazione centinaia di milioni per il pagamento degli
interessi dei prestiti che gli erano stati concessi a Parigi, a Londra, a
Berlino e a Bruxelles.
Infine, lo zarismo era l’alleato più fedele dell’imperialismo occidentale
nella spartizione della Turchia, della Persia, della Cina, ecc. Chi non sa che
la guerra imperialista è stata condotta dallo zarismo in unione con gli
imperialisti dell’Intesa, che la Russia è stata un elemento essenziale di
questa guerra? Ecco perché gli interessi dello zarismo e dell’imperialismo
occidentale si intrecciavano e si fondevano, in ultima analisi, nell’unico
gomitolo degli interessi dell’imperialismo. Poteva l’imperialismo
occidentale rassegnarsi alla perdita di un così potente appoggio in oriente e
di un così ricco serbatoio di forze e di mezzi, quale era la vecchia Russia
zarista e borghese, senza impegnare tutte le propria forze per condurre una
lotta a morte contro la rivoluzione in Russia, allo scopo di difendere e
conservare lo zarismo? Evidentemente, non poteva!
Ma da questo deriva che chiunque voleva battere lo zarismo, inevitabilmente
alzava la mano contro l’imperialismo, chiunque insorgeva contro lo zarismo
doveva insorgere anche contro l’imperialismo poiché chi voleva rovesciare lo
zarismo doveva abbattere anche l’imperialismo, se voleva realmente non solo
vincere lo zarismo, ma debellarlo definitivamente. La rivoluzione contro lo
zarismo collegava, perciò, alla rivoluzione contro l’imperialismo e doveva
trasformarsi in rivoluzione proletaria.
In Russia si scatenava pertanto la più grande rivoluzione popolare, a capo
della quale si trovava il proletariato più rivoluzionario del mondo che
disponeva di un alleato dell’importanza dei contadini rivoluzionari della
Russia. Vi è bisogno di dimostrare che tale rivoluzione non poteva fermarsi a
mezza strada, che in caso di insuccesso essa doveva procedere oltre, innalzando
la bandiera dell’insurrezione contro l’imperialismo?
Ecco perché la Russia doveva diventare il punto nodale delle contraddizioni
dell’imperialismo, non solo nel senso che queste contraddizioni si rivelavano
proprio in Russia più che in ogni altro paese - per il loro carattere
particolarmente scandaloso e particolarmente intollerabile - e non solo perché
la Russia era il punto di appoggio principale dell’imperialismo d’occidente
- costituendo un legame tra capitale finanziario dell’occidente e le colonie
dell’oriente - ma anche perché solo in Russia esisteva una forza reale,
capace di risolvere le contraddizioni dell’imperialismo per via
rivoluzionaria.
Ma da questo deriva che la rivoluzione, in Russia, non poteva non diventare
proletaria, che essa non poteva non prendere fin dai primi giorni del suo
sviluppo un carattere internazionale, che essa non poteva quindi non scuotere le
basi stesse dell'imperialismo mondiale.
Potevano i comunisti russi, in questa situazione, contenere il loro lavoro nel
quadro strettamente nazionale della rivoluzione russa? Evidentemente no! Al
contrario, tutta la situazione tanto interna (profonda crisi rivoluzionaria),
quanto esterna (guerra), li spingeva a uscire, nel corso del loro lavoro, da
questo quadro, a trasportare la lotta sull’arena internazionale, a mettere a
nudo le piaghe dell’imperialismo, a dimostrare l’ineluttabilità della
catastrofe del capitalismo, a battere il social-sciovinismo e il
social-pacifismo e, infine, ad abbattere il capitalismo nel proprio paese e a
forgiare per il proletariato una nuova arma di lotta: la teoria e la tattica
della rivoluzione proletaria, allo scopo di facilitare ai proletari di tutti i
paesi il compito dell’abbattimento del capitalismo. I comunisti russi non
potevano, del resto, agire in altro modo, poiché solo seguendo questa via si
poteva contare su alcune modificazioni della situazione internazionale, atte a
garantire la Russia dalla restaurazione del regime borghese.
Ecco perché la Russia è diventata il focolaio del leninismo, e il capo dei
comunisti russi, Lenin, ne è diventato il creatore. Per la Russia e per Lenin
“è avvenuto” qualche cosa di simile a quel che, tra il 1840 e il 1850,
“era avvenuto” per la Germania, e per Marx ed Engels. Come la Russia al
principio del sec. XX, la Germania era gravida allora della rivoluzione
borghese. Nel “Manifesto dei comunisti” Marx scriveva allora che:
“Sulla Germania rivolgono i comunisti specialmente la loro attenzione, perché
la Germania è alla vigilia della rivoluzione borghese, e perché essa compie
tale rivoluzione in condizioni di civiltà generale europea più progredite e
con un proletariato molto più sviluppato che non avessero l’Inghilterra nel
sec. XVII e la Francia nel sec. XVIII; per cui la rivoluzione borghese tedesca
non può essere che l'immediato preludio di una rivoluzione proletaria”.
In altri termini, il centro del movimento rivoluzionario si spostava verso la
Germania.
Non vi può esser dubbio che appunto questa circostanza, segnalata da Marx nel
passo sopra riportato, fu probabilmente la causa per cui appunto la Germania fu
la patria del socialismo scientifico ed i capi del proletariato tedesco - Marx
ed Engels - ne furono i creatori, all’inizio del sec. XX. La Russia si trovava
in questo periodo alla vigilia di una rivoluzione borghese; ma doveva compiere
questa rivoluzione quando le condizioni dell’Europa erano più progredite, il
proletariato più sviluppato che nel caso della Germania (senza parlare
dell’Inghilterra e della Francia) e tutti i dati indicavano che questa
rivoluzione sarebbe stata il lievito e il preludio della rivoluzione proletaria.
Non si può reputare accidentale il fatto che già nel 1902, quando la
rivoluzione russa era soltanto all’inizio, Lenin scrivesse nel suo opuscolo
“Che fare?” queste parole profetiche:
“La storia pone oggi a noi (cioè ai marxisti russi - G. Stalin) un compito
immediato, il più rivoluzionario di tutti i compiti immediati del proletariato
di qualsiasi altro paese”. “L’adempimento di questo compito, la
distruzione del baluardo più potente della reazione non soltanto europea, ma
anche asiatica, farebbe del proletariato russo l’avanguardia del proletariato
rivoluzionario internazionale”.
In altri termini, il centro del movimento rivoluzionario doveva spostarsi verso
la Russia.
È noto che il corso della rivoluzione in Russia ha più che confermata questa
predizione di Lenin.
C’è dunque da meravigliarsi che un paese, il quale ha fatto una tale
rivoluzione ed ha un tale proletariato, sia stato la patria della teoria e della
tattica della rivoluzione proletaria?
C’è da meravigliarsi che il capo di questo proletariato, Lenin, sia diventato
in pari tempo il creatore di questa teoria e di questa tattica e il capo del
proletariato internazionale ?.
G. Stalin (1924)
75 - Deviazioni nel campo della questione nazionale (Iosif Stalin)
Il quadro della lotta contro le deviazioni nel
partito sarebbe incompleto se non ci occupassimo delle deviazioni nel campo
della questione nazionale, esistenti nel partito. Alludo, prima di tutto, alla
deviazione verso lo sciovinismo grande-russo e, in secondo luogo, alla
deviazione verso il nazionalismo locale. Queste deviazioni non sono così
visibili come le deviazioni di sinistra o di destra. Si potrebbero chiamare
deviazioni equivoche. Ma questo non vuol dire che non esistano.
Al contrario, esistono e si sviluppano. Su questo non può esservi dubbio. Non
può esservi alcun dubbio, poiché l’atmosfera generale di esasperazione della
lotta di classe non può non condurre ad un’esasperazione degli attriti
nazionali, che hanno il loro riflesso nel partito, perciò bisogna scoprire e
mettere in luce le caratteristiche di queste deviazioni.
In che cosa consiste l’essenza della deviazione verso lo sciovinismo
grande-russo nelle nostre attuali condizioni?
L’essenza della deviazione verso lo sciovinismo grande-russo consiste
nell’aspirazione a non tener conto delle differenze nazionali di lingua, di
cultura, di modo di vivere; nella tendenza a preparare la liquidazione delle
repubbliche e delle regioni nazionali; nella tendenza a scalzare il principio
dell’uguaglianza delle nazioni e ad abbandonare la politica del partito che si
prefigge di dare un carattere nazionale all’apparato, alla stampa, alla scuola
e alle altre organizzazioni statali e sociali.
Coloro che cadono in deviazioni di questo tipo partono dal presupposto che
dovendo le nazioni, con la vittoria del socialismo, fondersi insieme, e le loro
lingue nazionali trasformarsi in una lingua comune, sia venuto il momento di
liquidare le differenze nazionali e di rinunciare a una politica che favorisca
lo sviluppo della cultura nazionale dei popoli precedentemente oppressi.
Per questo si richiamano a Lenin, citandolo in modo sbagliato e talora
addirittura deformandolo e calunniandolo: Lenin diceva che nel socialismo gli
interessi delle nazionalità si fondono in un tutto unico; non ne consegue che
è ora di finirla con le repubbliche e con le regioni nazionali nell’interesse
dell’internazionalismo? Lenin diceva nel 1913, in polemica con i membri del
Bund, che la parola d’ordine della cultura nazionale è una parola d'ordine
borghese; non ne consegue che è ora di finirla con una politica che tien conto
delle particolarità nazionali, dei popoli dell’URSS e di passare ad una
politica di assimilazione nell’interesse dell’internazionalismo? E così di
seguito.
Non ci può esser dubbio, che questa deviazione nel modo di intendere la
questione nazionale (che si copre per giunta con la maschera
dell’internazionalismo e col nome di Lenin), sia la forma più raffinata e
perciò più pericolosa del nazionalismo grande-russo.
In primo luogo, Lenin non ha mai detto che le differenze nazionali debbano
sparire e le lingue nazionali debbano fondersi in una lingua comune nei confini
di uno Stato, prima della vittoria del socialismo su scala mondiale. Lenin, al
contrario diceva qualche cosa, di addirittura opposto e precisamente che “le
differenze nazionali e statali tra i popoli e i paesi... si manterranno ancora
molto e molto a lungo anche dopo l’attuazione della dittatura del proletariato
su scala mondiale”. Come è possibile richiamarsi a Lenin dimenticando questa
sua indicazione fondamentale?
È vero che un marxista, oggi rinnegato e riformista, il signor Kautsky, afferma
qualche cosa del tutto opposto a quello che ci insegna Lenin. Egli afferma, in
contrasto con Lenin, che una vittoria della rivoluzione proletaria nello Stato
unificato austro-tedesco a metà del secolo scorso avrebbe condotto alla
formazione di una lingua tedesca comune e alla germanizzazione dei ceki poiché
“solo la forza di uno Stato che si era liberato dagli intralci dello scambio,
solo la forza della cultura contemporanea che i tedeschi portavano con sé,
avrebbe trasformato in tedeschi - senza una germanizzazione violenta - i piccolo
borghesi, i contadini e i proletari ceki arretrati, ai quali la loro nazionalità
decaduta non poteva offrir nulla”.
Si capisce che una simile “concezione” si accordi pienamente col
socialsciovinismo di Kautsky. Contro queste opinioni di Kautsky ho lottato
anch’io nel 1925 con un discorso pronunciato all’Università dei popoli
d’oriente. Ma è mai possibile che per noi, per dei marxisti che vogliono
restare fino alla fine internazionalisti, queste chiacchiere antimarxiste di un
fradicio socialsciovinista tedesco possano avere un significato positivo
qualsiasi?
Chi aveva ragione, Kautsky o Lenin? Se aveva ragione Kautsky, come si spiega
allora che certe nazionalità, relativamente arretrate come i Bielorussi e gli
Ucraini, più vicine ai Grandi-russi che i Ceki ai Tedeschi, non si siano
russificate in conseguenza della vittoria della rivoluzione proletaria
nell’URSS ma, al contrario, siano risorte e si siano sviluppate come nazioni
indipendenti? Come si spiega che nazioni quali la turkmena, la kirghisa, l’uzbeka,
la tagika (per non parlare della georgiana, dell’armena, dell’azerbaigiana,
ecc.), nonostante le loro arretrate condizioni, non solo non si siano
russificate in conseguenza della vittoria del socialismo nell’URSS, ma al
contrario siano risorte e si siano sviluppate come nazioni indipendenti? Non è
forse chiaro che i nostri egregi compagni “fuori strada”, andando a caccia
di un apparente internazionalismo, son caduti in braccio al socialsciovinismo di
Kautsky? Non è forse chiaro che, battendosi per una lingua comune nei confini
di uno Stato, nei confini dell’URSS, essi mirano in realtà a ripristinare il
privilegio della lingua che dominava prima, e precisamente della lingua
grande-russa? Dov’è in questo caso l’internazionalismo?
In secondo luogo, Lenin non ha mai detto che l’eliminazione dell’oppressione
nazionale e la fusione degli interessi delle nazionalità in uno Stato unico
significhi la soppressione delle differenze nazionali. Noi abbiamo distrutto
l'oppressione nazionale, abbiamo distrutto i privilegi nazionali ed abbiamo
instaurato l’uguaglianza delle nazioni. Abbiamo soppresso i confini statali
nel vecchio senso della parola, i pali di confine e le barriere doganali tra le
nazionalità dell’URSS. Abbiamo instaurato l’uguaglianza degli interessi
economici e politici dei popoli dell’URSS. Ma questo vuol forse dire che con
ciò abbiamo eliminato le differenze nazionali e le lingue, la cultura, il
particolare modo di vedere e di vivere delle nazioni, ecc.? È chiaro che non
vuol dir questo. Ma se le differenze nazionali, la lingua, la cultura, il
particolar modo di vivere delle nazioni rimangono, non è chiaro, forse, che la
rivendicazione di eliminare le repubbliche e le regioni nazionali nell’attuale
periodo storico è una rivendicazione reazionaria, diretta contro gli interessi
della dittatura del proletariato? Non comprendono, questi compagni “fuori
strada”, che eliminare ora le repubbliche e le regioni significherebbe privare
le grandi masse dei popoli dell’URSS della possibilità di ricevere
un’istruzione nella lingua materna, privarle della possibilità di avere una
scuola, un tribunale, un’amministrazione, organizzazioni e istituzioni sociali
e di altro genere nella lingua materna, privarle della possibilità di
partecipare all’edificazione socialista?
Non è chiaro che andando a caccia di un’apparente internazionalismo, questi
compagni “fuori strada”, sono caduti in braccio allo sciovinismo
grande-russo reazionario e hanno dimenticato, completamente dimenticato, la
parola d’ordine della rivoluzione culturale nel periodo della dittatura del
proletariato, ugualmente valida per tutti i popoli dell’URSS, sia per i
grandi-russi che per i non grandi-russi?
In terzo luogo, Lenin non ha mai detto che la parola d’ordine dello sviluppo
della cultura nazionale, nelle condizioni della dittatura del proletariato, sia
una parola d’ordine reazionaria. Al contrario, Lenin è stato sempre
favorevole ad aiutare i popoli dell’URSS a sviluppare la loro cultura
nazionale. Sotto la guida di Lenin e non di chiunque altro è stata elaborata ed
approvata al X Congresso del partito la risoluzione sulla questione nazionale in
cui si dice chiaramente che:
“Il compito del partito consiste nell’aiutare le masse lavoratrici dei
popoli non grandi-russi a raggiungere la Russia centrale più avanzata;
nell’aiutarle: a) a sviluppare e rafforzare nel loro territorio lo stato
sovietico in forme corrispondenti alle condizioni nazionali di esistenza di
questi popoli; b) a sviluppare e a rafforzare nel loro territorio tribunali,
amministrazione, organi amministrativi, organi del potere che svolgano le loro
funzioni nella lingua materna e siano composti di persone del luogo le quali
conoscano la vita e la psicologia della popolazione locale; c) a sviluppare nel
loro territorio la stampa, la scuola, il teatro, i club, ed in generale le
istituzioni culturali e di istruzione nella lingua materna; d) a creare e
sviluppare una larga rete di corsi e di scuole, di cultura generale e
tecnico-professionali nella lingua materna”.
Non è chiaro che Lenin era in tutto e per tutto favorevole alla parola
d’ordine di sviluppare la cultura nazionale nelle condizioni della dittatura
del proletariato?
Non è forse chiaro che negare la parola d’ordine della cultura nazionale
nelle condizioni della dittatura del proletariato, significa negare la necessità
dell’ascesa culturale dei popoli non grandi-russi dell’URSS, negare la
necessità dell’istruzione obbligatoria generale per questi popoli,
abbandonare questi popoli allo asservimento spirituale in cui li tengono i
nazionalisti reazionari?
Lenin, effettivamente, definiva la parola d’ordine della cultura nazionale
sotto il dominio della borghesia come una parola d’ordine reazionaria. Ma,
poteva forse essere altrimenti?
Che cos’è la cultura nazionale sotto il dominio della borghesia? Una cultura
borghese, per il contenuto, e nazionale per la forma che ha lo scopo di
intossicare le masse col veleno del nazionalismo e di rafforzare il dominio
della borghesia. Che cos’è la cultura nazionale nelle condizioni della
dittatura del proletariato? Una cultura socialista, per il contenuto, e
nazionale per la forma che ha lo scopo di educare le masse nello spirito
dell’internazionalismo e di consolidare la dittatura del proletariato. Come è
possibile confondere questi due fatti fondamentalmente diversi senza rompere col
marxismo? Non è forse chiaro che, lottando contro la parola d’ordine della
cultura nazionale nell’ordinamento borghese, Lenin colpiva il contenuto
borghese della cultura nazionale e non la sua forma nazionale? Sarebbe sciocco
supporre che Lenin considerasse la cultura socialista come una cultura
a-nazionale, che non avesse una determinata forma nazionale. I “bundisti”,
effettivamente attribuivano una volta a Lenin questa teoria assurda. Ma dalle
opere di Lenin risulta che egli protestò recisamente contro questa calunnia,
respingendo con fermezza una tale assurdità. È mai possibile che i nostri
egregi compagni “fuori strada” seguano fino a questo punto le orme dei “bundisti”?
Ma che cos'è rimasto, dopo tutto quello che si è detto, degli argomenti dei
nostri compagni “fuori strada”?
Nulla, se non i loro giuochi di destrezza con la bandiera
dell’internazionalismo e le calunnie contro Lenin.
Coloro che deviano nel senso dello sciovinismo grande-russo sbagliano
profondamente se credono che il periodo dell’edificazione del socialismo
nell’URSS sia il periodo di distruzione e di liquidazione delle culture
nazionali. Invece è proprio il contrario. In realtà, il periodo della
dittatura del proletariato e dell’edificazione del socialismo nell’URSS è
il periodo del rigoglio delle culture nazionali, socialiste per il contenuto e
nazionali per la forma. Essi, evidentemente, non comprendono che lo sviluppo
delle culture nazionali deve procedere con nuova forza introducendo e radicando
l’istruzione generale obbligatoria elementare nella lingua materna. Non
comprendono che solo grazie allo sviluppo delle culture nazionali le nazionalità
arretrate potranno contribuire effettivamente all’opera di edificazione
socialista. Non comprendono che appunto in questo sta il fondamento della
politica leninista di aiuto e di sostegno allo sviluppo delle culture nazionali
dei popoli dell’URSS.
Può sembrare strano che noi, partigiani della fusione, in avvenire, delle
culture nazionali in una sola cultura comune (sia per la forma che per il
contenuto), con una sola lingua comune, siamo nel tempo stesso fautori del
fiorire delle culture nazionali nel momento attuale, nel periodo della dittatura
del proletariato. Ma non c’è nulla di strano. Bisogna permettere alle culture
nazionali nel momento attuale di svilupparsi e di evolversi, manifestando tutte
le loro possibilità, per creare le condizioni per la loro fusione avvenire in
una cultura comune con una lingua comune. Sviluppare delle culture nazionali per
la forma e socialiste per il contenuto nelle condizioni della dittatura del
proletariato in ogni singolo paese, allo scopo di fonderle in una comune cultura
socialista per forma e per contenuto, con una lingua comune quando il
proletariato vincerà in tutto il mondo e il socialismo diventerà realtà, -
appunto in questo consiste la dialettica dell’impostazione leninista della
questione della cultura nazionale.
Si può dire che una simile impostazione del problema sia “contradditoria”.
Ma non abbiamo forse una “contraddizione” simile anche nella questione dello
Stato? Noi siamo per la scomparsa dello Stato. E nel tempo stesso siamo per un
rafforzamento della dittatura del proletariato, che rappresenti il più potente
e il più forte di tutti i poteri statali finora esistiti, il più alto sviluppo
del potere statale allo scopo di preparare le condizioni per la sparizione del
potere statale - ecco la formula marxista. È una “contraddizione”? Sì, è
una “contraddizione”. Ma questa contraddizione è vitale e rispecchia
pienamente la dialettica marxista.
Prendiamo, per es., l'impostazione leninista della questione del diritto delle
nazioni all’autodecisione, fino alla separazione. Lenin talora esprimeva la
tesi dell’autodecisione delle nazioni con la semplice formula: “separare per
unire”. Pensate: separare per unire. Sembra addirittura un paradosso. Eppure
questa formula “contradditoria” esprime quella verità vitale della
dialettica marxista che dà ai bolscevichi la possibilità di espugnare le
fortezze più inaccessibili nel campo della questione nazionale.
Lo stesso bisogna dire per la formula riguardante la cultura nazionale:
sviluppare le culture (e le lingue) nazionali nel periodo della dittatura del
proletariato in un solo paese, allo scopo di preparare le condizioni per la loro
sparizione e la loro fusione in una comune cultura socialista (ed in una lingua
comune) nel periodo della vittoria del socialismo in tutto il mondo.
Chi non ha compreso queste originalità e questa “contraddizione” del nostro
periodo di transizione, chi non ha compreso questa dialettica dei processi
storici è perduto per il marxismo.
La disgrazia dei nostri compagni “fuori strada”, consiste in questo, che
essi non comprendono e non vogliono comprendere la dialettica marxista.
Così stanno le cose per quanto riguarda la deviazione verso lo sciovinismo
grande-russo.
Non è difficile comprendere che questa deviazione riflette la tendenza delle
classi sopravvissute della nazione grande-russa, già dominante, di ricuperare i
privilegi perduti. Di qui il pericolo dello sciovinista grande-russo come
pericolo principale nel partito, nel campo della questione nazionale.
Qual è l’essenza della deviazione verso il nazionalismo locale?
L’essenza della deviazione verso il nazionalismo locale, consiste nella
tendenza a isolarsi e rinchiudersi nel proprio guscio nazionale, nella tendenza
a smorzare le contraddizioni di classe nella propria nazione, a difendersi dallo
sciovinismo grande-russo abbandonando l’alveo comune dell’edificazione
socialista, nella tendenza a non vedere quello che unisce ed avvicina le masse
lavoratrici delle nazionalità dell’URSS, ma a vedere solo quello che può
allontanarle l’una dall’altra.
La deviazione verso il nazionalismo locale riflette il malcontento delle classi
sopravvissute delle nazioni già oppresse contro il regime della dittatura del
proletariato, la loro tendenza a isolarsi nel proprio stato nazionale e ad
instaurarvi il proprio dominio di classe.
Il pericolo di questa tendenza consiste nel fatto che essa coltiva il
nazionalismo borghese, indebolisce l’unità dei lavoratori dei popoli
dell’URSS e gioca a favore di coloro che vogliono intervenire nella nostra
vita interna.
Questa è l’essenza della deviazione verso il nazionalismo locale. Il compito
del partito consiste nel condurre una lotta decisa contro questa deviazione e
nell’assicurare le condizioni necessarie per l’educazione internazionale
delle masse lavoratrici dei popoli dell’URSS.
G. Stalin (1930)
76
– L’ideologia dell'imperialismo (1910) (Rudolf
Hilferding)
La ideologia del capitale
finanziario è completamente opposta a quella del liberalismo; il capitale
finanziario non desidera la libertà, bensì il dominio; non ha nessun amore per
l’indipendenza del singolo capitalista, ma domanda piuttosto la sua
irreggimentazione; odia l'anarchia della concorrenza e desidera
l’organizzazione, ma solo per poter ripristinare la concorrenza in un grado più
alto. Per conseguire tutto ciò e, in pari tempo, per mantenere e aumentare il
suo potere, il capitale finanziario ha bisogno di uno Stato, che garantisca il
mercato interno con la protezione e faciliti la conquista di mercati esteri. Ha
bisogno di uno Stato politicamente saldo, che non sia costretto a tener conto
degli opposti interessi degli altri Stati nel formulare la sua politica
commerciale. Il capitale finanziario ha bisogno di uno Stato forte, che faccia
valere all’estero i suoi interessi e usi il potere politico per estorcere
trattati favorevoli agli Stati più piccoli; ha bisogno di uno Stato più forte
che possa esercitare la sua influenza in tutto il mondo, per essere in grado di
trasformare il mondo intero in un campo di investimento del capitale finanziario
nazionale. Esso ha infine bisogno di uno Stato che sia forte abbastanza per
poter effettuare una politica di espansione e per acquistare nuove colonie.
Mentre il liberalismo avversava la politica di potenza dello Stato e desiderava
affermarsi contro l’antico potere dell’aristocrazia e della burocrazia, per
il qual fine limitava i mezzi coattivi dello Stato entro i limiti più stretti
possibili, il capitale finanziario pretende una politica di potenza illimitata e
persisterebbe in tale pretesa, anche se le spese per l'esercito e per la marina
non assicurassero direttamente ai più potenti gruppi capitalistici un mercato
importante con enormi profitti monopolistici.
L’esigenza di una politica di espansione capovolge l’intera
“Weltanschauung” della borghesia. La borghesia cessa di essere pacifista e
umanitaria. Gli antichi sostenitori del libero scambio credevano nella libertà
commerciale, in quanto in essa vedevano non soltanto la migliore politica
economica, ma anche l’inizio di un’era di pace. Il capitale finanziario ha
da lungo tempo abbandonato tali concezioni. Non crede all'armonia degli
interessi capitalistici, ma sa che la lotta della concorrenza si avvicina sempre
più a una battaglia politica per il potere. L’ideale della pace svanisce; al
posto dell’ideale dell'umanità, avanza quello della forza e del potere dello
Stato. Lo Stato moderno, in ogni caso, derivò dalle lotte delle nazioni per
raggiungere l’unità. L’aspirazione nazionale che trovò il suo limite
naturale nella formazione della nazione come fondamento dello Stato perché essa
riconosceva ad ogni nazione il diritto di avere il suo Stato e, quindi, vedeva i
confini dello Stato nei confini naturali della nazione - si è ora trasformata
nell’aspirazione di una nazione al dominio delle altre. Il nuovo ideale è ora
la conquista del dominio del mondo per la propria nazione, il che implica una
lotta così illimitata quanto la lotta, dalla quale essa deriva, del capitale
per il profitto. Il capitale diviene il conquistatore del mondo, e ogni nuova
terra conquistata rappresenta un nuovo confine che deve essere oltrepassato.
Questa lotta diventa una necessità economica, l’astenersene abbasserebbe,
infatti, il profitto del capitale finanziario, ridurrebbe la sua capacità di
concorrenza e, infine, potrebbe ridurre una regione economica meno estesa, in
una semplice tributaria di una più ampia. Questa lotta che appare del tutto
fondata dal punto di vista economico, viene giustificata dal punto di vista
ideologico grazie ad una notevole deformazione dell’idea nazionale, con cui
non si riconosce più ad ogni nazione il diritto all’autodecisione e
all’indipendenza e che non è più un’espressione dell’idea democratica
dell’eguaglianza di tutte le nazionalità. Al contrario, il privilegio
economico del monopolio viene a riflettersi nell’idea che la propria nazione
debba trovarsi in posizione di preminenza. La propria nazione appare come
l’eletta tra tutte. Poiché l’assoggettamento delle nazioni estere avviene
per mezzo della forza, vale a dire in un modo del tutto naturale, la nazione
dominante pretende di dovere la sua posizione di predominio alle sue speciali
qualità naturali, in altre parole alle sue caratteristiche razziali. Così
l’ideologia razzista diventa il fondamento pseudo-scientifico della volontà
di potenza del capitale finanziario il quale, avvalendosi di tale ideologia,
dimostra la causa e la necessità del suo operare. Al posto di un ideale
democratico ed egualitario, subentra l’ideale oligarchico del dominio.
Mentre nel campo della politica estera questo ideale sembra includere tutta la
nazione, nella politica interna esso si estrinseca in una tirannia sulla classe
lavoratrice. Nello stesso tempo, il crescente potere dei lavoratori fa sì che
il capitale intensifichi il suo sforzo diretto a estendere il potere statale per
costruirsi una garanzia contro le richieste del proletariato.
In questo modo sulla tomba dei vecchi ideali liberali sorge l’ideologia
dell’imperialismo. Essa si fa beffe dell’ingenuità del liberalismo. Quale
illusione credere a un’armonia di interessi in un mondo di lotte
capitalistiche in cui soltanto la superiorità delle armi decide! Quale
illusione aspettare il regno della pace perpetua e predicare la legge
internazionale, mentre è soltanto la forza a decidere il destino dei popoli!
Quale idiozia desiderare di estendere i rapporti legali esistenti nell’interno
di uno Stato al di là dei suoi confini!
Quanti irresponsabili disordini sono creati da quell’assurdità umanitaria che
crea un problema dei lavoratori, scopre delle riforme sociali da attuarsi
all’interno dello Stato, e desidera l'abolizione nelle colonie della schiavitù
contrattuale e che è l'unica possibilità di sfruttamento razionale! La
giustizia eterna è un bel sogno, ma nessuno costruì mai ferrovie a furia di
moralizzare. Come possiamo conquistare il mondo se ci si affida alla virtù
educatrice della concorrenza?
Al posto degli svaniti ideali della borghesia, l’imperialismo sostituisce la
distruzione di tutte queste illusioni, ma solamente per far sorgere una nuova e
più grande illusione. L'imperialismo è moderato quando considera i conflitti
reali tra i gruppi di interessi capitalistici, siano questi divergenti o comuni.
Ma esso si lascia trasportare e si eccita quando rivela il proprio ideale.
L'imperialista nulla desidera per sé; tuttavia non è neppure l’utopista e il
sognatore che dissolve la confusione disperata delle razze in tutti gli stadi di
civiltà ed è sempre pronto a sviluppare l’esangue concetto di umanità.
Freddamente e lucidamente, l’imperialista guarda la folla dei popoli e scorge
che al disopra di tutti c’è la propria nazione. Essa è reale; essa vive
nello Stato forte che diventa sempre più grande e più potente, e la sua
glorificazione giustifica tutti gli sforzi dell’individuo. Il sacrificio degli
interessi individuali in favore del più alto interesse generale, che costruisce
la condizione di ogni ideologia sociale vitale, è in tal modo attuato; lo
Stato, che nulla ha a che fare con il popolo, e la nazione sono in tal modo
legati insieme e dall’idea nazionale si fa la forza propulsiva della
politica. Gli antagonismi di classe sono aboliti al servizio della totalità.
L’azione comune della nazione unita verso la meta della grandezza nazionale si
sostituisce alla lotta di classe, la quale per la classe abbiente è tanto
infruttuosa quanto dannosa.
Questo ideale che apparentemente unisce con un nuovo legame la smembrata società
borghese deve trovare una accettazione ancor più estatica dato che la
disgregazione della società borghese progredisce rapidamente.
Rudolf Hilferding (1872-1941)
77
– La funzione principale dello Stato (Paul
M. Sweezy)
C’è da parte dei teorici
liberali moderni una certa tendenza a considerare lo Stato come una istituzione
costituita negli interessi della società nel suo complesso, allo scopo di
svolgere un’opera mediatrice e conciliatrice tra gli antagonismi ai quali dà
inevitabilmente origine l’esistenza sociale. È questa una teoria che,
evitando le insidie della metafisica politica, serve a integrare in un modo
abbastanza soddisfacente una considerevole quantità di fatti osservati. Essa
contiene tuttavia una fondamentale deficienza, il cui riconoscimento conduce
alla formulazione di una teoria essenzialmente marxiana nel suo orientamento.
Pertanto, una critica di quella che può essere chiamata la concezione dello
Stato come mediatore tra le classi costituisce forse la migliore introduzione
alla teoria marxista.
La teoria dello Stato mediatore tra le classi sostiene, di solito implicitamente
che la struttura classistica costituente il substrato della società o, il che
è la stessa cosa, il sistema delle relazioni di proprietà, sia un dato
immutabile quanto l’ordine naturale stesso. Essa procede, quindi, a ricercare
gli accorgimenti ai quali potranno addivenire le varie classi per tirare avanti
insieme l’una accanto all’altra e trova che la costituzione di una
istituzione per conciliare i contrastanti interessi è la logica e necessaria
risposta a tale problema. A questa istituzione vengono assicurati i poteri per
mantenere l’ordine e per dirimere le controversie. Ciò che viene chiamato
“Stato” è considerato come l'equivalente, nel mondo reale, di questa
costruzione teorica.
Non è difficile scoprire quale sia il punto debole di questa teoria. Esso
consiste nel ritenere immutabile e, per così dire, autoperpetuantesi la
struttura classista della società.
La superficialità di questo asserto è dimostrata da uno studio anche rapido
della storia. Sta di fatto che molte forme di rapporti di proprietà, con le
loro concomitanti strutture classiste, sorsero e scomparvero nei tempi passati e
non c'è nessuna ragione per sostenere che non continueranno a fare così per il
futuro. La struttura classista della società non fa parte dell’ordine
naturale delle cose; essa non è che il prodotto del passato sviluppo sociale e
cambierà nel corso del futuro sviluppo stesso. Una volta riconosciuto questo,
diviene evidente come la teoria liberale abbia torto nella maniera stessa in cui
essa inizialmente pone il problema. Non ci si può domandare come – data una
determinata struttura classista – si comporteranno le varie classi con i loro
divergenti e spesso contrastanti interessi per tirare avanti insieme; ma ci si
deve domandare come si sia formata una determinata struttura classista e con
quali mezzi venga assicurata la continuazione della sua esistenza. Non appena si
tenti di dare una risposta a questa domanda appare evidente che, nella società,
lo Stato ha una funzione principale e molto più importante di quella che i
liberali attualmente gli attribuiscono. Esaminiamola da vicino.
Un determinato tipo di rapporti di proprietà serve a definire e delimitare la
struttura classista della società. Da un tipo di rapporti di proprietà una
classe o alcune classi (i proprietari) ricavano vantaggi importanti; le altre
classi (i non proprietari) soffrono gravi svantaggi. Una istituzione speciale
efficiente e pronta a usare la forza a qualsiasi grado è richiesta come fattore
essenziale per il mantenimento di tale tipo di rapporti di proprietà.
L’indagine dimostra che lo Stato possiede questa caratteristica al più alto
grado e che non c’è nessun’altra istituzione che possa a tal riguardo
competere con esso. Ciò di solito si esprime col dire che lo Stato, ed esso
soltanto, esercita un potere sovrano, d’imperio sopra tutti i soggetti alla
sua giurisdizione. Non è pertanto difficile a questo punto identificare lo
Stato come garante di un dato tipo di rapporti di proprietà.
Se ora ci si domanda da dove lo Stato provenga, la risposta è che esso è il
prodotto di una lunga e ardua lotta nella quale la classe che occupa nel momento
le posizioni-chiave del processo produttivo, acquista vantaggio sopra le sue
rivali e forma uno Stato che rafforzerà quel tipo di rapporti di proprietà che
è nell’interesse di tale classe mantenere. In altre parole, ogni Stato è la
creatura della classe o delle classi della società che beneficiano del
particolare tipo di rapporti di proprietà che lo Stato stesso deve rafforzare.
Un po’ di riflessione convince che non potrebbe avvenire diversamente. Una
volta abbandonato il concetto, storicamente insostenibile, che la struttura
classista sia un fatto appartenente all’ordine naturale, è chiaro che uno
Stato – che non fosse quello che abbiamo detto – difetterebbe dei requisiti
di stabilità. Se le classi non avvantaggiate fossero in possesso del potere
statale, esse tenterebbero di usarlo per costituire un ordine sociale più
favorevole ai loro propri interessi, mentre una partecipazione al potere statale
da parte delle varie classi non farebbe che trasferire la sede del conflitto in
seno allo Stato stesso.
Non si vuol negare che tali conflitti in seno allo Stato – corrispondenti ai
conflitti fondamentali tra le classi – abbiano avuto luogo in certi periodi
storici di transizione. Peraltro, in quei lunghi periodi durante i quali un
determinato ordine sociale gode di una esistenza relativamente continua e
stabile, il potere statale deve essere monopolizzato dalla classe o dalle classi
che sono i principali beneficiari.
Come nella teoria sopraesposta si ha la concezione basilare di uno Stato
mediatore tra le classi, qui si delinea l’idea base di quella che è stata
chiamata la teoria della dominazione di classe. La prima dà come data
l’esistenza di una certa struttura classista e vede nello Stato
un’istituzione per conciliare i contrastanti interessi delle varie classi; la
seconda, d’altro lato, riconosce che le classi sono il prodotto di sviluppi
storici e vede nello Stato uno strumento nelle mani delle classi dominanti per
rafforzare e garantire la stabilità della struttura classista stessa.
È importante comprendere che, per quanto riguarda la società capitalistica,
dominazione di classe e “protezione della proprietà privata” sono
espressioni virtualmente equivalenti. Quindi, quando si afferma con Engels che
il più importante scopo dello Stato è la protezione della proprietà privata,
si dice altresì che lo Stato è uno strumento per la dominazione di classe. Il
che è compreso senza alcun dubbio sufficientemente dai critici della teoria
marxiana, che tendono a considerare il concetto della dominazione di classe come
qualche cosa di più torbido e di più sinistro che la “semplice” protezione
della proprietà privata. In altre parole, essi tendono a ritenere riprovevole
la dominazione di classe e meritoria la protezione della proprietà privata. Di
conseguenza, non capita mai a essi di identificare i due concetti. Di frequente
ciò è dovuto, senza alcun dubbio, al fatto che essi hanno in mente non la
proprietà capitalistica, ma piuttosto quella proprietà privata che esiste in
una società a produzione mercantile semplice e in cui ciascun produttore è
proprietario e lavora con propri mezzi di produzione. Da tali condizioni non vi
sono classi di sorta e quindi non vi è dominazione di alcuna classe. In una
società capitalistica, tuttavia, la proprietà ha un significato affatto
differente; ed è facile dimostrare come la protezione di essa si identifichi
con la preservazione della dominazione di classe. La proprietà privata
capitalistica non consiste in cose - le cose esistono indipendentemente dalla
loro appartenenza - ma in una relazione sociale tra persone. La proprietà
conferisce ai suoi titolari la libertà dal lavoro e la possibilità di disporre
del lavoro degli altri e questo costituisce il fondamento di ogni dominazione
sociale, qualsivoglia forma essa possa assumere. Ne consegue che la protezione
della proprietà equivale fondamentalmente ad assicurare ai proprietari le
dominazione sociale sui non proprietari. E questo, a sua volta, è ciò che si
deve intendere per dominazione di classe in quanto essa è l’oggetto della
funzione precipua dello Stato.
L’affermazione che la difesa della proprietà privata è il primo compito
dello Stato, è il fattore decisivo e determinante dell’atteggiamento del puro
socialismo marxista verso lo Stato. “La teoria comunista - così scrissero
Marx ed Engels nel “Manifesto del partito comunista” - può riassumersi in
questa sola sentenza: abolizione della proprietà privata”. Poiché lo Stato
è il primo protettore della proprietà privata, ne consegue che la
realizzazione di questo fine non può essere effettuata senza un urto tra le
forze del socialismo e il potere statale.
Paul
M. Sweezy (1942)
78
- L’imperialismo (Maurice
Dobb)
Fu soprattutto come critica del mercantilismo che
l’economia politica classica, e in modo speciale la sua teoria del commercio
estero, accese le menti dei contemporanei e conquistò il proprio posto nella
storia. La condanna del mercantilismo come sistema e la confutazione dei fallaci
ragionamenti dei suoi apologisti fu il motivo dominante di tutti gli scritti sia
di Adam Smith che di James Mill e di Ricardo. Data la somiglianza tra il
mercantilismo e il moderno imperialismo, è tanto più stupefacente che gli
economisti moderni abbiano avuto così poco da dire su quest’ultimo, e lo
abbiano considerato un argomento che esulava dalla loro competenza. La
somiglianza, tra il colonialismo del sec. XVIII e quello di oggi, almeno sotto
un aspetto superficiale, è stata spesso rilevata. Essa consiste non solo nel
fatto che ambedue riguardano un sistema coloniale, ma nell’impiego di certe
pratiche monopolistiche e nella analogia delle antitesi che le loro ideologie
presentano con le dottrine dell’economia classica.
I primi economisti nutrivano ben poche illusioni circa il mercantilismo; e la
loro analisi scoprì molto chiaramente i rapporti essenziali che stavano alla
base della elaborata sovrastruttura di regolamenti commerciali e le ideologie
ideate a sua spiegazione e difesa. Si resero conto che il suo carattere
essenziale era una forma speciale di politica monopolistica e che il vantaggio
che veniva con esso perseguito era un vantaggio monopolistico, e soprattutto il
vantaggio di una classe ristretta. James Mill, che aveva descritto le colonie
come “un vasto sistema assistenziale” a favore delle classi più elevate,
scrisse che “la madrepatria, costringendo le colonie a venderle le merci più
a buon mercato di quanto non le venderebbero ad altri paesi, impone certamente
un tributo su di esse; non diretto, certo, ma non meno reale, anche se
mascherato”; mentre Say, descrivendo il sistema “come costruito sulla
costrizione, restrizione e monopolio”, dichiarava che la “metropoli può
costringere le colonie ad acquistare da essa qualsiasi cosa di cui abbiano
bisogno; questo monopolio, o questo privilegio esclusivo, mette in grado i
produttori metropolitani di far pagare per le merci alle colonie più di quanto
esse valgano”. Adam Smith - che aveva dato al problema la sua impostazione
classica - denunciava il sistema in questi termini:
“Il monopolio del commercio coloniale, come tutti gli altri meschini e
perniciosi espedienti del sistema mercantile, deprime l’industria di tutti gli
altri paesi, ma soprattutto quella delle colonie, senza incrementare per nulla
quella del paese a cui favore è stabilito (…). Il monopolio, invero, aumenta
il saggio del profitto mercantile e, quindi, in certa misura il guadagno dei
mercanti (…). Per favorire l’interesse ristretto di un ristretto ceto di
persone in un paese, esso danneggia gli interessi di tutti gli altri ceti di
persone in quel paese e di tutte le persone negli altri paesi (…). Una grande
fonte originaria di reddito, i salari del lavoro, deve esser stata resa in tutti
i tempi meno abbondante di quanto sarebbe stata altrimenti, a causa del
monopolio”.
(...) Quel che caratterizzava il mercantilismo era un rapporto di commercio
regolato tra una colonia e la metropoli, organizzato in modo tale da volgere la
ragione di scambio a favore della seconda e a svantaggio della prima. In questo
sistema l’investimento nella colonia, quando si verificava, sembra abbia avuto
una funzione subordinata. L'imperialismo moderno ripete questo carattere dello
sfruttamento attraverso il commercio; e, mentre nei primi stadi
dell’imperialismo, questo carattere può essere stato meno rilevante che non
fosse nel sistema coloniale dei secc. XVII e XVIII, negli stadi successivi esso
assume una notevole e crescente importanza nella forma di politiche
neomercantilistiche di “autarchia”, di unità imperiali. Ma, tra il
mercantilismo e l’imperialismo, esiste naturalmente tutta una differenza che
c’è tra uno stadio primitivo dello sviluppo del capitalismo e lo stadio più
avanzato della tecnica industriale su larga scala, dell’associazione della
finanza con l’industria e dell’organizzazione politica monopolistica. Di
conseguenza, in questo secondo stadio l’esportazione di capitale esercita una
funzione dominante, e con essa l’esportazione di beni strumentali e la
ipertrofia dell’industria che produce questi ultimi. Anzi, tra i contrasti che
distinguono il vecchio dal nuovo sistema coloniale, il fatto dell’investimento
di capitali nell’area coloniale sembra sia il principale. Questo investimento
assume forme assai varie; e descriverlo come consistente soltanto, o anche
prevalentemente, nell’investimento di capitale industriale, nello sfruttamento
diretto di un proletariato coloniale, significa dare un quadro semplicistico e
inesatto del processo reale. L’investimento nella colonia, assume spesso la
forma di prestito in moneta su larga scala
o dello sfruttamento in forme primitive di produzione, simile a quanto fece
il capitale mercantile nell’Europa occidentale nel periodo del sistema di
lavoro a domicilio. Inoltre, la caratteristica fondamentale dell’investimento
coloniale sin dalle sue origini è consistita, nell’investimento privilegiato:
cioè, nell’investimento in imprese che presentano qualche vantaggio
differenziale, preferenza o monopolio effettivo, sotto forma di diritto di
concessione, o qualche attribuzione di uno status privilegiato. I diritti di
monopolio e le pratiche restrittive, sembra che abbiano costituito sempre la
maggiore attrattiva dell’investimento coloniale e che abbiano fornito un
elemento essenziale all’imperialismo, come sistema di estrazione del profitto
in ampie zone.
Poiché l’investimento nelle zone coloniali rappresenta un trasferimento di
capitale ad aree in cui è facile assicurarsi privilegi quasi monopolistici, e
dove il lavoro è più abbondante e a buon mercato, e la “composizione
organica del capitale” è più bassa, il processo costituisce
un’importantissima influenza operante contro la tendenza alla caduta del
saggio del profitto nella madrepatria. Inoltre, esso esercita questa influenza
in duplice modo. Non soltanto implica che il capitale esportato nella colonia
venga investito a un tasso più alto che se fosse investito in patria, ma crea
anche una tendenza del saggio del profitto in patria a rimanere più elevato di
quanto sarebbe altrimenti. Quest’ultimo effetto si verifica perché viene
ridotta l’abbondanza del capitale in cerca di investimento nella madrepatria a
causa del redditizio sbocco coloniale, viene allentata la pressione sul mercato
del lavoro e il capitalista può acquistare forza-lavoro nella madrepatria a un
prezzo più basso. L’esportazione di capitale, in altre parole, rappresenta un
mezzo per ricreare l’”esercito industriale di riserva” nella madrepatria,
aprendo nuovi campi di sfruttamento all’estero. Il capitale guadagna così
doppiamente: attraverso il più alto tasso di profitto che ottiene all’estero
e attraverso il più alto tasso di “plus-valore” che può conservare nella
madrepatria; e questo duplice guadagno è la ragione per cui fondamentalmente
gli interessi del capitale e del lavoro in questo problema sono in contrasto.
Per la stessa ragione l’economia capitalistica ha un incentivo alla politica
imperialistica che l’economia socialistica non avrebbe.
Che cosa significhi ciò si può intendere supponendo il processo portato
all’estremo: se si suppone cioè che nelle colonie esistano illimitatamente
strati proletari da sfruttare (e risorse naturali a non finire) e se, inoltre,
si suppone che siano rimossi tutti gli ostacoli all’esportazione di capitale.
La fine logica del processo (se si tiene a seguire una ipotesi puramente
astratta) sarebbe di abbassare i tassi di salario nei più vecchi paesi
capitalistici sino al livello dominante nelle aree coloniali e - fino a che
rimangano aree coloniali da sfruttare - di mantenere la massa dalla popolazione
in tutto il mondo allo stesso livello di vita. Per una serie di ragioni
concrete, il processo non raggiunge - e nemmeno si avvicina - a questo astratto
limite (che apparentemente sembrerebbe implicare la “decolonizzazione” della
colonia, come anche la parziale deindustrializzazione della madrepatria). Ma la
tendenza rimane come tendenza parziale, anche se contrastata da altri fattori.
(…)
Qui appunto, in questo più stretto controllo della madrepatria sulla politica
interna dalla colonia sembra consistere quella logica politica
dell’imperialismo che - come la sua stessa storia rivela - consiste nel
procedere dalla “penetrazione economica” alle “sfere d’influenza”,
dalle “sfere d’influenza” ai “protettorati” o controllo indiretto, e
dai “protettorati” - attraverso l'occupazione militare, all’annessione. E
appena interviene il controllo politico - come ausiliario dell’investimento -
esiste la possibilità di pratiche monopolistiche e preferenziali; e, se questo
controllo politico viene usato, presumibilmente sarà usato per favorire quei
particolari interessi che rappresenta. Il processo di investimento e di sviluppo
economico della colonia non si svolgerà certo in una idillica atmosfera di
laissez-faire. (…)
Il detto che “il commercio segue la bandiera” esprime la verità essenziale
che un aspetto importante della funzione delle colonie nella economia
internazionale è che esse costituiscono in larga parte “mercati privati”
per gli interessi del gruppo nazionale che le controlla, anche là dove vige la
politica della “porta aperta”. Il numero e l’ampiezza di tali sfere
privilegiate che un capitalismo nazionale può sfruttare, determinano in
notevole misura, il saggio di profitto che può ottenere e il posto che può
tenere nell’economia mondiale. In questo senso, la “ricerca dei mercati”,
cui si riferiscono i teorici del sottoconsumo, ha un significato indipendente:
cioè, la ricerca di più estese possibilità di ricavare un profitto
monopolistico dallo sfruttamento per mezzo del commercio, come distinto dalla
estrazione del “normale” plus-valore.
Ma, oggi, anche la conservazione nominale della politica della “porta
aperta” si fa sempre più rara. Gli accordi circa le zone di influenza corrono
paralleli agli accordi territoriali tra i cartelli internazionali che dividono
il mercato in “riserve di caccia”. Appelli politici vengono usati
direttamente per influire sulle domande, e vediamo gruppi di interessi sfruttare
pregiudizi politici per escludere prodotti rivali (come accadde, per esempio,
alcuni anni fa, nella famosa campagna contro il petrolio russo). La politica e
l’economia sono così intimamente intrecciate che il semplice odore di una
concessione petrolifera sia dimostrato capace di gettare confusione in almeno
una conferenza internazionale, le recenti politiche di autarchia, di
nazionalismo economico, erigenti barriere doganali intorno alle loro unità
nazionali o imperiali e sviluppanti pletoricamente gli accordi di
contingentamento, perseguono semplicemente in una forma più perfetta l’ideale
del mercato limitato e della riserva monopolistica; mentre gli accordi di
scambio bilanciato - venuti ultimamente di moda - e il riesumato vangelo dei
saldi attivi di esportazione della bilancia commerciale, sono espliciti
riconoscimenti di quel neo-mercantilismo, che è sempre stato latente nel
moderno imperialismo. In questo processo, i perturbamenti monetari, su cui
prevalentemente si era fissata l’attenzione degli economisti, dovrebbero
apparire come effetto piuttosto che come causa: le svalutazioni monetarie
soltanto come strumenti di una rivalità nelle esportazioni; e le opposizioni di
blocchi monetari rivali - quali il blocco aureo, il blocco della sterlina, il
blocco del dollaro - come un aspetto di una manovra per creare aree economiche
protette e isolate. Quando un Hitler o un Mussolini proclamano la necessità di
sbocchi coloniali, non desiderano realmente abbondanza, ma limitazione; non
accesso all’abbondanza per le loro popolazioni, ma riserve monopolizzate per
la grande industria.
Rimane l’importante problema di sapere per qual ragione questo nuovo
colonialismo dovesse apparire in questo particolare stadio storico, come ha
fatto. Lenin affermò che l’imperialismo è la caratteristica del capitalismo
nella sua fase monopolistica, specialmente nello stadio in cui si attua
l’associazione della finanza con l’industria, con la subordinazione delle
decisioni industriali alla strategia finanziaria su larga scala: quello stadio
che Hilferding definì “capitalismo finanziario”. Quindi, l'imperialismo
implica non solo un’esportazione di capitali in nuove aree, dove
ringiovanendosi potrebbe ripercorrere la propria storia, ma un’estensione del
capitalismo a nuove aree sotto specifiche condizioni, con la conseguente
apparizione di nuovi elementi nella situazione. (…)
L’evidenza della storia mostra che l’imperialismo è associato con il fatto
che il capitalismo in un paese abbia raggiunto un certo stadio del suo sviluppo;
e che l’imperialismo fiorisce rapidamente una volta raggiunto questo stadio
del capitalismo, ma non prima.
I due caratteri dello sviluppo capitalistico cui sembra più ragionevole
connettere questa tendenza espansionistica sono i seguenti: da una parte,
l'esaurimento, o quasi esaurimento, delle possibilità di quello che si
definisce il reclutamento “estensivo” dell’”esercito di riserva
industriale” entro i vecchi confini nazionali; dall’altra, l’elevarsi,
incoraggiato dal primo, del livello tecnico, ovvero della composizione organica
del capitale, sino al punto che esige un considerevole sviluppo dei settori
industriali addetti alle costruzioni pesanti. Questo duplice sviluppo sarà
probabilmente associato con la tendenza a un piuttosto brusco declino nella
redditività del capitale, mentre lo sviluppo tecnico dei mezzi di produzione
precostituirà la base per quella concentrazione del capitale da cui possono
trarre incremento i grandi gruppi monopolistici. Il capitalismo diventa
“ultramaturo”, secondo l’espressione di Lenin, nel senso che il
“capitale non trova più occasioni per un investimento redditizio”. Se
questi sviluppi sono contrassegnati da una rapida caduta nel rendimento del
capitale, questo fatto costituirà uno stimolo sia per l’adozione di pratiche
monopolistiche, nelle industrie della madrepatria, sia per la ricerca di nuovi
campi di investimenti all’estero, mentre la formazione di grandi gruppi
monopolistici soprattutto se connessi con il mondo finanziario, produrrà quel
tipo di organizzazione che solo è in grado di intraprendere l’azione
strategica di conquiste economiche su larga scala oltremare. Inoltre, c’è un
motivo speciale nella logica connessione fra monopolio e colonialismo. Mentre il
monopolio in una industria particolare o in un gruppo di industrie può riuscire
a elevare il saggio di profitto, esso è incapace, non appena sia divenuto
generale, di elevare il saggio del profitto generale, salvo che non possa
ridurre il prezzo della forza-lavoro o spremere qualche strato di redditi
intermedio nella madrepatria. Nella ricerca del successo è quindi continuamente
spinto a estendere all’estero la sfera di sfruttamento. (...)
Il primo di questi importanti risultati del nuovo imperialismo è l’effetto
che ha sui rapporti di classe nella madrepatria, il sovrapprofitto e la nuova
prosperità che la fortunata nazione è in grado di ottenere, creano per la
classe lavoratrice della metropoli, o almeno per sezioni privilegiate di essa,
la possibilità di partecipare in qualche misura ai guadagni dello sfruttamento,
anche solo nella forma di una minore pressione sui salari rispetto a quella alla
quale il capitale sarebbe dovuto probabilmente ricorrere se privo di tali
sbocchi.
Là dove l’organizzazione sindacale è forte, essa può strappare concessioni
più facilmente di quanto non avrebbe potuto fare altrimenti e assicurarsi una
certa posizione privilegiata. Ciò in larga misura serve a spiegare la
conservazione di quella che è stata spesso chiamata un’”aristocrazia del
lavoro” in Inghilterra e negli Stati Uniti e in misura minore, in Francia e in
Germania: di una classe lavoratrice che si trova in una situazione relativamente
privilegiata rispetto al proletariato del resto del mondo. Essi sono gli
“schiavi di palazzo” della madrepatria a differenza degli “schiavi di
piantagione” alla periferia dell’impero, sentono una parziale identità di
interessi coi loro padroni e una riluttanza a turbare lo “status quo”: un
fatto apparentemente riflesso per un intero periodo (il periodo della seconda
internazionale e della socialdemocrazia) nel movimento operaio di questi paesi.
Nella sua prefazione alla seconda edizione (1892) della sua opera su “Le
condizioni della classe lavoratrice in Inghilterra”, Engels faceva la ben nota
affermazione sul movimento operaio britannico: “Durante il periodo del
monopolio industriale inglese, la classe lavoratrice inglese ha in una certa
misura condiviso i benefici del monopolio. Questi benefici erano divisi molto
inegualmente; la minoranza privilegiata ne intascava la parte maggiore, ma anche
la gran massa aveva, di tanto in tanto, una partecipazione almeno temporanea. E
questo è il motivo per cui, dopo la fine dell’owenismo, non c’è stato
socialismo in Inghilterra. Con il crollo di quel monopolio, la classe
lavoratrice inglese perderà quella posizione privilegiata e si troverà
generalmente allo stesso livello dei suoi compagni lavoratori degli altri paesi.
E questo è il motivo perché ci sarà di nuovo socialismo in Inghilterra”. Di
fronte agli avvenimenti del 1914, Lenin parlò con parole pungenti della
tendenza “dell’imperialismo in Inghilterra a dividere i lavoratori, a
rafforzare l’opportunismo fra di essi, a generare una temporanea cancrena nel
movimento dei lavoratori”; e si riferiva ai capi della socialdemocrazia
contemporanea, ai tribuni dei più rammolliti “schiavi di palazzo”
metropolitani, come ai “sergenti-maggiori del capitale nelle file del
lavoro”. In pari tempo, nei paesi capitalistici, tendeva a svilupparsi sia una
cosiddetta “classe media” vasta e sproporzionata, la cui vitalità dipendeva
direttamente o indirettamente dalla sua connessione con l'imperialismo,
estendentesi dagli impiegati negli uffici cittadini all’amministrazione
coloniale, sia un inflazionato ceto di redditieri prosperante sul reddito degli
investimenti esteri.
In secondo luogo, la funzione storica dell’imperialismo nelle aree coloniali
fu di creare una struttura di classe simile a quella trovata nei vecchi paesi
capitalistici. Come presupposto dell’investimento industriale, esso richiedeva
un proletariato rurale e successivamente urbano; e, via via che
l'industrializzazione procedeva, si andava anche creando una borghesia
coloniale, che progredì dalla condizione di compradores, mediatori ed usurai,
speculatori in terreni, organizzatori di industrie indigene, coltivatori
abbienti, sino a quella di imprenditori industriali. Appariva inevitabile che
questa classe, risentendo i privilegi monopolistici del capitale straniero e
l’influenza di interessi non residenti, dovesse entrare in rivalità con gli
interessi imperialistici, così come nel sec. XVIII in Inghilterra il capitale
industriale di recente formazione aveva intrapreso una campagna
antimonopolistica, culminata in una guerra civile. Qui appunto, nel desiderio di
spossessare il capitale straniero dei suoi privilegi e di perseguire una
politica di sviluppo della industria indigena sotto la protezione dello stato
sta la radice del movimento nazionalistico coloniale: di un nazionalismo
destinato a riprodurre, in un diverso ambiente storico, i caratteri dei
movimenti borghesi democratici in Europa del 1789, del 1830 e del 1848. Allo
stesso modo che il mercantilismo condusse alla rivolta delle colonie americane
contro l’Inghilterra, così l’imperialismo ha portato alla rivolta coloniale
oggi in Asia, domani forse in Africa. L’imperialismo, come si è detto,
rappresenta un rapporto non semplice, ma complesso, fra madrepatria e colonia.
Non costituisce una riproduzione nella colonia del tipo “puro” di
capitalismo industriale, comprendente il semplice rapporto fra proletariato
coloniale e capitale industriale, sia indigeno che straniero. (Se fosse così,
non vi sarebbe bisogno del nazionalismo coloniale, in quanto la ragione
economica, che sta alla base del conflitto, farebbe nascere un “puro”
movimento proletario e socialista). Ma comprende altresì un rapporto di
sfruttamento monopolistico attraverso il commercio con l’economia coloniale
considerata come un unico complesso. Pertanto, larghi settori della borghesia
coloniale hanno radici economiche che le portano nell’ambito del movimento
nazionalista; e, di conseguenza, il nazionalismo coloniale rappresenta un
movimento fortemente interclassista. Il secolo XX era quindi destinato ad
assistere ad un nuovo fenomeno storico: sottoforma di rivolte
nazional-democratiche nelle province dell’impero che si collegano alla rivolta
proletaria nella madrepatria, di cui Marx aveva parlato, per scuotere le
fondamenta del dominio capitalistico. In questa nuova epoca può anche accadere
che il centro di gravità abbia a spostarsi e le prime, piuttosto che la
seconda, determinino il corso degli eventi.
Una terza conseguenza dell'imperialismo sotto forma di eventi nell'economia
mondiale, fu un’accentuata disparità di sviluppo fra diversi paesi e diverse
aree. Nel sec. XIX sembrava quasi che il processo dell’industrializzazione
esercitasse un'influenza livellatrice sulle diverse parti del mondo.
L’espansione del mercato mondiale, sia per le merci che per il capitale, si
riteneva tendesse generalmente a diminuire le differenze nazionali e a portare
progressivamente i diversi paesi a una uniformità di livelli tecnici e anche
dei tenori ai vita. È probabilmente vero che questa affermazione fu sempre
soggetta a importanti limitazioni. Ma, col sorgere del nuovo sistema coloniale,
apparvero certi tipi nuovi di disuguaglianza che erano significativi per la loro
influenza, sia sulla struttura interna di classe, sia sulla stabilità interna
di vari gruppi nazionali. A considerarlo superficialmente, può sembrare che il
monopolio rappresenti un’unificazione, un coordinamento e un più alto grado
di ordinata pianificazione. Ciò può essere in parte vero per i rapporti
all’interno della sfera di un determinato controllo monopolistico. Ma il
monopolio significa essenzialmente privilegio, e privilegio economico significa
restrizione ed esclusione, significa necessaria preferenza su qualcun altro,
esclusione di qualcun altro; e in ciò sono già contenuti i germi
dell’ineguaglianza e della rivalità. Le potenze più fortunate nella politica
coloniale sono in grado di conquistare una nuova prosperità (almeno per un
certo periodo) e una rafforzata stabilità interna. Quando la rivalità
raggiunge lo stadio di conflitto aperto, e il conflitto si tramuta in guerra,
l’estensione del territorio di un gruppo sarà realizzabile soltanto a spese
dell’altro; come nelle lotte tra banditi il “territorio” di una banda
viene inizialmente allargato con l’occupazione di zone vergini, ma più tardi
può essere allargato soltanto rubando terreno a una banda rivale. Che questo
stadio fosse già raggiunto nel 1914, sembra ampiamente attestato dal trattato
di Versailles, coi suoi trasferimenti in blocco di colonie dai vincitori ai
vinti, Lenin citava nella sua teoria queste nuove ineguaglianze e rivalità per
dimostrare: l’impossibilità di quello che era stato definito
“superimperialismo” (un imperialismo di potenze imperiali per sfruttare
congiuntamente e pacificamente l'intero globo); la possibilità oggettiva, che,
quando una profonda crisi, quale la guerra mondiale minasse l’intera
struttura, la rivolta proletaria contro il capitalismo e il trionfo dei
socialismo si attuassero, prima che nei più antichi paesi capitalistici (i
quali, essendo stati i primi e i più fortunati nella corsa alle colonie,
avevano ottenuto una proroga della prosperità), nei paesi che essendo meno
sviluppati industrialmente costituivano “l’anello più debole della
catena”. In quest’ultima conclusione egli trovava sia una giustificazione
per la propria politica in Russia, sia una risposta a quello che era stato
continuamente definito “il grande paradosso del marxismo”: che la
rivoluzione cioè, che Marx aveva profetizzata settanta anni prima, fosse
scoppiata prima in Russia, anziché nei paesi occidentali.
La concezione dell’imperialismo, con le sue rivalità latenti e la sua logica
interna di espansione, offre un interessante parallelo all’analisi
dell'economia schiavistica fatta dal Cairnes nella sua opera “Slave power”.
Il Cairnes vi mise in rilievo come negli stati meridionali dell’America del
nord, l'unica forma di nuovo investimento e l’unica maniera di estendere il
profitto consistesse nell’acquisto di altre piantagioni e di un maggior numero
di schiavi. Per tanto, la difficile economia degli stati sudisti era
continuamente sospinta per la necessità d’espandersi, ad acquistare più
schiavi e ad estendere il sistema delle piantagioni dell'ovest.
Nell’eventualità di una limitazione di questo processo stava l’inevitabilità
di un conflitto finale col nord. Una simile brama di espansione scorre
chiaramente nel sangue dell’economia capitalistica; e anche questa è una
brama che non può essere soddisfatta indefinitamente. La stessa reazione che
genera, sotto forma di nazionalismo coloniale, pone ostacoli sempre più forti a
qualsiasi intensificazione della sua politica monopolistica e serve anche a
rallentare i legami dell’impero. Per il capitalismo nel suo complesso, il
colonialismo può costituire soltanto una dilazione transitoria.
Se si colloca la crisi economica del (primo) dopoguerra su uno sfondo di questo
tipo, se ne ottiene una interpretazione molto diversa da quella usuale e molto
più significativa. Uno sfondo di questo genere sembra anzi necessario se
vogliamo trovare un senso nello sconcertante incubo dei recenti avvenimenti, se
ci preoccupiamo in sostanza di ricercare le “causae causantes”, e non ci
contentiamo del quadro superficiale fornito da un’analisi limitata alle
“cause immediate”. Vista in questa più vasta prospettiva, la crisi del
nostro mondo postbellico va molto oltre gli “spostamenti di produzione dovuti
alla guerra”, le “restrizioni governative al commercio e alle imprese”, i
“perturbamenti monetari” e altri analoghi fattori che figurano così
cospicuamente nelle trattazioni tradizionali del problema, e che per molti
economisti sembrano ancora costituire il limite della loro visuale; e comincia
ad emergere una chiara immagine di una “crisi generale”, le cui radici sono
più profonde che i movimenti ciclici. Marshall disse che “in economia, né
quegli effetti di cause note né quelle cause di effetti noti che sono più
palesi, sono in generale i più importanti: molte volte vale più la pena di
studiare “quel che non si vede” piuttosto che “quel che si vede”
particolarmente quando ci si occupa “non di qualche questione di carattere
meramente locale e temporanea”, ma della “elaborazione di una lungimirante
politica per il bene pubblico”.
(…) Se qualcosa di quanto è stato detto sopra è vero, una interpretazione di
questi avvenimenti, che non sia superficiale, deve chiaramente prender le mosse
da un fatto centrale. Questo fatto centrale è che il campo di investimento
redditizio per il capitale è molto più ristretto di quanto non fosse
sull’altro versante di quello storico spartiacque del 1914-18. È
apparentemente più ristretto, non tanto perché si siano raggiunti i limiti
dello sfruttamento coloniale, quanto a causa dei limiti che la stessa tensione,
creata dall’imperialismo, impone. Durante e dopo la prima guerra mondiale il
nazionalismo coloniale divenne una forza imponente...
Connesso con questa restrizione delle frontiere del sovrapprofitto coloniale è
un altro fatto: lo stesso sviluppo delle restrizioni e barriere monopolistiche
ha avuto per effetto di restringere il campo di ulteriori investimenti. Il
profitto che la restrizione raccoglie in prima istanza è ottenuto con la
esclusione di qualche capitale che altrimenti sarebbe entrato nello stesso
campo; così che l’effetto cumulativo di tali restrizioni è di rendere
sovraffollati altri campi e, quindi, di ridurre altrove il rendimento al di
sotto di quanto si sarebbe ritenuto possibile. Quindi, come “soluzione”
della difficoltà fondamentale in una direzione, esso opera peggiorando la
difficoltà in un’altra: è la politica d’impoverimento del vicino”. (…)
Inoltre, questa vera e propria riduzione del campo di investimento all’interno
delle aree monopolistiche acuisce la passione per le esportazioni di capitale
verso aree esterne; infatti, tali esportazioni rappresentano a un tempo
l’unico sbocco per il capitale eccedente e la condizione necessaria per
conservare il regime monopolistico. (…)
Quella che Marx chiamò “sovrapproduzione di capitale” si manifestò
inevitabilmente in forma acuta. L’improvvisa cessazione degli investimenti
(dopo il grande crollo del 1929), sia all'estero che all’interno, diede inizio
alla paralisi progressiva del 1930-31. E una volta iniziata la depressione, il
prevalere delle restrizioni monopolistiche sembra ne abbia accentuato e
prolungato gli effetti. In particolare, sembra ch’esso abbia fatto aumentare
la perdita puramente materiale di questa crisi e ricadere l’onere della
depressione - in una misura senza precedenti - sui lavoratori, sotto forma di
disoccupazione e sotto-occupazione. Questo sabotaggio restrittivo si effettuò
nella forma di controllo dei prezzi da parte dei cartelli e dei trust, diretto a
mantenere inalterato il saggio del profitto sul capitale. Conservare inalterati
i prezzi significava restringere la produzione; e a ciò si deve se la
depressione assunse in un grado così eccezionale la forma di una crisi di
eccesso di capacità e di disoccupazione, con un enorme spreco di mano d’opera
e di macchine.
Se l’estensione del campo di investimento attraverso lo sfruttamento coloniale
viene bloccata improvvisamente, il problema dell’”esercito industriale di
riserva” nella madrepatria si fa di colpo acuto. (…)
I due movimenti degli ultimi anni che più chiaramente hanno le loro radici
nelle disfunzioni postbelliche del capitalismo, sono il “fascismo" e la
disintegrazione della cosiddetta “classe media”. C’è una evidente
connessione fra il fascismo, quale ideologia di nazionalismo economico e
politico, e l’imperialismo come sistema caratteristico di un’epoca. Ma il
carattere preciso di questa connessione, pur sembrando abbastanza chiaro nei
suoi tratti essenziali e diventando sempre più chiaro col procedere degli
eventi, non appare sempre a tutt’oggi valutato equamente. Gli avvenimenti
degli ultimi anni offrono in abbondanza materiale per giustificare il concetto
che la funzione storica del fascismo sia duplice.
In primo luogo, quella di rompere e disperdere le organizzazioni indipendenti
della classe lavoratrice, e di farlo non nell’interesse della “classe
media” o “dell’uomo della strada” ma, in definitiva, nell’interesse
del grande capitale. In secondo luogo, quella di organizzare la nazione sia
spiritualmente - attraverso una intensa propaganda - sia praticamente - con la
preparazione militare e una centralizzazione autoritaria - per un’ambiziosa
campagna di espansione territoriale. (...) Ma la connessione tra fascismo e
colonialismo non consiste solo nel fatto che il secondo figura come un prodotto
incidentale del primo. La connessione appare fondamentale e riguardante non solo
i risultati, ma anche l’origine e le radici sociali del movimento. Il fascismo
fu definito un figlio della crisi e in un certo senso è tale; ma il giudizio è
troppo semplicistico. Esso è il figlio di un tipo speciale di crisi; cioè una
crisi del capitalismo monopolistico, traente la sua gravità dal fatto che il
sistema si trova la strada sbarrata, sia per lo sviluppo estensivo, che per uno
sviluppo più intensivo del campo dello sfruttamento. Per spezzare questi
limiti, nuove e straordinarie misure - misure di dittatura politica - vengono
inevitabilmente all’ordine del giorno. Se si dovessero riassumere in breve i
presupposti storici del fascismo, si potrebbe parlare di tre fattori dominanti:
la sfiducia del capitale di trovare una soluzione normale per le difficoltà
create dalla limitazione del campo di investimento; una considerevole e
disagiata “classe media”, ovvero elementi declassati che, in assenza di un
altro punto di orientamento, sono maturi per essere conquistati al credo
fascista; e una classe lavoratrice abbastanza privilegiata e abbastanza forte
per resistere a una normale pressione sul suo tenore di vita, ma
sufficientemente disunita e priva di coscienza di classe (almeno nella sua
direzione politica) per essere politicamente debole nell’affermare la sua
forza e nel resistere all’attacco. La prima di queste condizioni è più
probabilmente la caratteristica del paese imperialistico, privato dei frutti del
colonialismo su cui precedentemente contava. (…) Evidentemente, non è una
semplice coincidenza che il fascismo sia sorto in due paesi che erano stati così
apertamente delusi nelle loro ambizioni coloniali dai risultati della grande
guerra; come è possibile che analoghe tendenze riescano a manifestarsi in
Inghilterra, culla della democrazia parlamentare e del movimento sindacale, al
primo serio apparire di una “disoccupazione” della classe media, e di
sintomi di un declino della posizione dell’Inghilterra come centro finanziario
ed esportatore. (...)
Lo stato fascista è acceso da una brama di espansione territoriale, non solo
nella direzione dei paesi arretrati, come per l’innanzi, ma anche verso
territori vicini, il cui controllo assicurerebbe vantaggi monopolistici alla
grande industria della madrepatria. (...) La scena è già chiaramente
preparata, il sipario anzi è già alzato per una guerra brigantesca per la
spartizione del globo.
Maurice Dobb (1937)
79
- Violenza e legalità (1902) (Rosa
Luxemburg)
Benché negli ultimi tempi si
sia tanto parlato della definitiva invalidazione dei mezzi rivoluzionari vecchio
stile, sinora non è mai stato chiaramente spiegato che cosa propriamente
s’intenda per mezzi del genere e con che cosa ci si proponga di sostituirli.
Di solito è uso contrapporre ai “mezzi rivoluzionari” – cioè, in
sostanza, alla rivoluzione violenta di strada, “l’opera quotidiana di
organizzazione e chiarificazione” delle masse lavoratrici. Un tale modo di
procedere è tuttavia sbagliato, per il semplice motivo che organizzazione e
propaganda non sono ancora in sé ancora lotta, ma semplici mezzi di
preparazione ad essa e in quanto tali non più necessari per una rivoluzione che
per una qualunque altra forma di lotta. Organizzazione ed educazione di per se
stesse rendono ancora così poco superflua la lotta “politica”, quanto la
formazione di sindacati e la raccolta di contributi le lotte salariali e gli
scioperi. Ciò che si contrappone l’uno all’altro, vantando antiteticamente
“mezzi rivoluzionari” e vantaggi dell’organizzazione e della propaganda,
è in effetti da un lato rivoluzione violenta, dall’altro riforma legale,
parlamentarismo.
“È possibile passare dal capitalismo al comunismo attraverso una serie di
forme sociali, di istituzioni giuridiche ed economiche, e perciò è nostro
dovere sviluppare questa progressione logica davanti al parlamento. In queste
parole di Jaurès è formulata a tutte lettere la concezione su accennata, così
come nell’altra sua dichiarazione: “l’unico metodo, che rimane al
proletariato, è quello dell’organizzazione legale e dell’azione legale”.
È di estrema importanza per la chiarificazione, tenere a priori per fermo
quanto sopra al fine di sfrondare il campo di discussione da ogni banalità
sull’utilità dell’organizzazione e della propaganda tra le masse e mettere
a fuoco la polemica sull’unico punto effettivamente in contestazione.
Ciò che ci appare anzitutto degno di rilievo nel fermo proponimento di
sostituire ogni uso della violenza nella lotta proletaria con l’azione
parlamentare, è la rappresentazione di un arbitrario “rivoluzionarismo”.
Secondo questa concezione le rivoluzioni, evidentemente a seconda che siano
riconosciute utili o superflue e dannose, vengono compiute od omesse, preparate
o archiviate, e dipenderà solo da quale convinzione volta a volta abbia la
meglio nella socialdemocrazia perché in avvenire si effettuino o meno delle
rivoluzioni in paesi capitalisti. Come però la teoria legalitaria del
socialismo sottovaluta la potenza del partito operaio in altri settori, così su
questo punto la sopravvaluta.
La storia di tutte le rivoluzioni del passato ci mostra che movimenti di
violenza popolare, assai lungi dall’essere un prodotto arbitrario e cosciente
dei cosiddetti “capi” o dei “partiti”, come si immaginano il poliziotto
e lo storico borghese ufficiale, sono piuttosto dei fenomeni sociali del tutto
elementari, accavallantisi con la violenza della natura e che trovano la loro
origine nella natura di classe della società moderna. A questo stato di cose
non ha apportato ancora alcun mutamento neppure l’avvento della
socialdemocrazia, ed anche il suo ruolo non consiste nel prescrivere leggi allo
sviluppo storico della lotta di classe ma, al contrario, nel piegarsi ad esse e
in questa maniera utilizzarle. Se la socialdemocrazia si volesse opporre a delle
rivoluzioni proletarie, che rappresentassero una necessità storica, l’unico
risultato per essa sarebbe di scadere da una funzione di direzione a una di
retroguardia o di trasformarsi in un ostacolo impotente della lotta di classe,
che finalmente a un dato momento non potrebbe non svilupparsi, bene o male,
senza di essa.
È sufficiente tener presenti questi semplici fatti per rendersi conto che la
questione “rivoluzione o passaggio puramente legalitario al socialismo?”,
non riguarda la tattica socialdemocratica, ma è anzitutto un problema di
“sviluppo storico”. In altre parole: eliminando la rivoluzione dalla lotta
di classe proletaria, i nostri opportunisti vengono al tempo stesso a decretare
né più né meno che la violenza ha cessato di essere un fattore della storia
moderna.
Questo il nocciolo teorico della questione, basta solo formularlo che la follia
di un tale punto di vista balza agli occhi: la violenza, non solo con
l’avvento della legalità borghese del parlamentarismo, non ha cessato di
giocare un ruolo storico, ma è oggi esattamente come in tutte le precedenti
epoche la base dell’ordine politico costituito. L’intero stato capitalista
riposa sulla violenza e ne è di per sé una prova sufficiente e patente la sua
organizzazione militare, e non avvertire ciò costituisce un vero miracolo di
abilità del dottrinarismo opportunista. Ma anche gli stessi domini riservati
della “legalità”, a più vicino esame, ne forniscono prove sufficienti.
I crediti per la Cina non sono mezzi forniti dalla “legalità”, dal
parlamentarismo, per compiere atti di violenza? Sentenze giudiziarie come quelle
di Löbtau, non sono un esercizio “legale” della violenza? Anzi, chiediamoci
piuttosto: in che consiste propriamente l’intera funzione della legalità
borghese?
Se un “libero cittadino”, contro la sua volontà, è posto coercitivamente
in uno spazio ristretto e inabitabile, e ivi trattenuto per un certo tempo da un
altro individuo, ognuno capisce trattarsi di un atto di violenza. Ma non appena
ciò avviene sulla base di un libro stampato, chiamato “codice penale”, e il
luogo assume il nome di “regio carcere o penitenziario prussiano”,
l’operazione si trasforma in un atto di pacifica legalità. Se un uomo è
costretto da un altro, contro la propria volontà, all’uccisione sistematica
dei propri simili, si tratta di un atto di violenza. Non appena però la stessa
cosa prende nome “servizio militare”, il buon borghese si figura di
respirare nella piena quiete della legalità. Se una persona viene defraudata da
un’altra contro la propria volontà di una parte dei beni o della mercede,
nessuno dubita di essere alla presenza di un atto di violenza; ma se questo modo
di procedere ha nome “tassazione indiretta”, allora si tratta semplicemente
di esercizio delle leggi in vigore.
In una parola: ciò che ci si presenta come legalità borghese non è altro che
la violenza della classe dominante aprioristicamente elevata a norma precettiva.
Una volta avvenuta questa fissazione dei singoli atti di violenza a norma
obbligatoria, la cosa si può rispecchiare capovolta nella mentalità giuridica
borghese come in quella degli opportunisti socialisti: l’ordine legale come
una creazione autonoma della giustizia e la violenza coercitiva dello stato
semplicemente come una conseguenza, una “sanzione” delle leggi. In effetti
è al contrario, proprio la legalità borghese (e il parlamentarismo come la
legalità in divenire) a costituire solo una determinata forma sociale
fenomenica della violenza politica della borghesia cresciuta sulla base
economica.
A ciò va commisurato il fantasioso di tutta quanta la teoria del legalitarismo
socialista. Mentre le classi dominanti in tutto il loro ambito d’azione, in
tutto il loro fare e disfare, fanno perno sulla violenza, soltanto il
proletariato in lotta contro queste classi, dovrebbe aprioristicamente, e una
volta per tutte, rinunciarvi. E quale mai terribile spada gli dovrebbe fare da
arma per la repressione della violenza organizzata? La stessa legalità, in cui
la violenza della borghesia si impronta a violenza costituita, a norma sociale!
Certo, questo terreno della legalità borghese parlamentaristica non si limita
ad essere un campo di dominio della classe capitalista, ma è anche il terreno
della lotta su cui i contrasti tra proletariato e borghesia pervengono a
composizione. Solo che, essendo per la borghesia l’ordinamento giuridico
soltanto l'espressione della propria violenza costituita per il proletariato la
lotta parlamentare può rappresentare soltanto l’aspirazione ad elevare al
potere la propria violenza. Se dietro alla nostra attività legale,
parlamentare, non stesse la forza della classe lavoratrice, sempre pronta ad
entrare in azione in caso di necessità, l’attività parlamentare della
socialdemocrazia si trasformerebbe in una perdita di tempo altrettanto geniale
come, per esempio, attingere acqua con un colabrodo. I “realpolitici”, che
incessantemente rimandano ai “risultati positivi” dell’attività
parlamentare socialdemocratica, per giocarli con un argomento contro la necessità
e utilità della violenza nella lotta operaia, non tengono invero conto che
questi successi stessi, pur nella loro meschinità, sono pur sempre da
considerare come un effetto dell’indivisibile, latente azione della forza.
Ma non basta. Il fatto che alla base della legalità borghese stia ancora solo
la violenza, trova espressione nelle vicende della storia particolare del
parlamentarismo.
Praticamente ciò si estrinseca nel fatto palpabile che qualora le classi
dominanti potessero mai supporre seriamente che dietro ai nostri parlamentari
non stessero, al caso, masse popolari pronte all’azione, che le teste
rivoluzionarie e le lingue rivoluzionarie non fossero in grado o non ritenessero
per opportuno reggere al caso pugni rivoluzionari, in questa eventualità il
parlamentarismo stesso e l’intera legalità ci verrebbero prima o poi
sottratti sotto i piedi in quanto terreno di lotta politica. Lo dimostra in
senso affermativo il destino del diritto elettorale in Sassonia, in senso
negativo quello del diritto elettorale al Reichstag. Nessuno può dubitare che
in Germania il così frequentemente periclitante suffragio universale non venga
“escamoté” non per qualche riguardo verso il liberalismo tedesco, ma
principalmente per timore della classe lavoratrice, per convinzione che la
socialdemocrazia su questo punto non saprebbe stare allo scherzo. E parimenti
anche il maggiore fanatico della legalità non oserebbe contestare che qualora,
un giorno il suffragio universale al Reichstag dovesse esso pure essere “escamoté”,
non dalle semplici “proteste legali”, quanto piuttosto dall’uso della
forza, la classe lavoratrice tedesca potrebbe sperare una riconquista a breve o
a lunga scadenza del terreno legale della lotta.
In questo modo già dalle ipotesi pratiche la teoria del legalitarismo
socialista viene ridotta all’assurdo, la forza, ben lungi dall'essere
detronizzata dalla “legalità”, ne appare piuttosto l’autentica
patrocinatrice, più esattamente il fondamento altrettanto dal lato della
borghesia come da quello del proletariato.
E viceversa, la legalità si dimostra come il risultato, soggetto a continue
oscillazioni, dei rapporti di forza volta a volta intercorrenti tra le classi in
conflitto. La Baviera come la Sassonia, il Belgio come il Deutsches Reich, sono
altrettanti esempi recentissimi che le regole parlamentari della lotta politica
sono accordate o rifiutate, mantenute o revocate, a seconda che gli interessi
della classe dominante vi possano essere assicurati o meno nel loro essenziale
e, inoltre, a seconda che la forza latente delle masse popolari eserciti con
sufficiente efficacia il proprio effetto d’ariete o di arma difensiva.
Ma se dunque la forza in certi casi estremi non può essere evitata in funzione
di mezzo difensivo a protezione dell’acquisizione parlamentare, essa risulta
non meno mezzo offensivo, in determinati casi insostituibile, là dove compito
primo è la conquista del terreno legale della lotta di classe.
I tentativi di revisione dei “mezzi rivoluzionari”, in connessione ai
recenti avvenimenti belgi sono piuttosto la prova più notevole di coerenza
politica mai offerta da anni, in generale, dalla spinta revisionista. Perfino se
si potesse parlare di un fiasco dei “mezzi rivoluzionari”, nel senso di uso
della forza, nella campagna belga, la loro sommaria condanna sulla base
dell’unica sconfitta belga presuppone evidentemente che l’uso della violenza
nella lotta operaia debba comportare incondizionatamente una garanzia di
successo in qualunque circostanza e in ogni caso. È chiaro che se fosse lecito
argomentare in questi termini da lungo tempo, per esempio, avremmo dovuto
archiviare la lotta sindacale, le lotte salariali, che certo ci hanno già
fruttato innumerevoli sconfitte.
La circostanza più rimarchevole è tuttavia che nel conflitto belga che
dovrebbe averne dimostrato l’inefficacia, non è stato fatto il minimo uso di
metodi violenti, qualora non si voglia, all’unisono con la polizia, tacciare
di “atto di violenza” il tranquillo sciopero da parte dei lavoratori! E
proprio a causa di ciò la sconfitta belga dimostra l’esatto contrario di ciò
che le si vuole attribuire: essa dimostra che attualmente, in Belgio, a
giudicare dall’insieme, ben scarse si presentano le prospettive di conseguire
il suffragio universale paritetico senza il concorso della forza, dato il
tradimento dei liberali come la risolutezza clericale a ricorrere a mezzi
estremi. Anzi, essa dimostra ancora dell’altro, e cioè che, se perfino forme
parlamentari così elementari, così borghesi, per nulla esorbitanti dal quadro
dell’ordine esistente, come il diritto elettorale paritetico, non sono
procacciabili pacificamente; se le classi dominanti si appellano da parte loro
alla forza bruta già per opporsi a una riforma puramente borghese e del tutto
naturale per uno stato capitalista, ogni speculazione su una pacifica abolizione
parlamentare della violenza statale capitalista, dell’intero dominio di
classe, non è dunque che un ridicolo fantastico parto dell’infantilismo
politico.
E ancora un’altra cosa la sconfitta belga sta a dimostrare! Dimostra ancora
una volta che i legalitari socialisti, prendendo la democrazia borghese per la
forma storica predestinata alla graduale realizzazione del socialismo, non
operano con una forma concreta di democrazia, con un concreto parlamentarismo,
quali conducono una triste e grama esistenza quaggiù sulla terra, ma con una
democrazia immaginaria, astratta, concepita al disopra delle classi, in eterno
progresso e in continuo sviluppo di autorità.
Sottovalutazione del tutto fantastica della crescente realizzazione e
altrettanto fantastica sopravvalutazione delle conquiste della democrazia, si
addicono e si completano l’una con l’altra nel modo più felice. Jaurès
tripudia nel bel mezzo delle meschine riforme di Millerand e dei microscopici
successi del repubblicanismo e interpreta ogni proposta di riforma
dell’istruzione ginnasiale, ogni progetto di statistica della disoccupazione
come altrettante pietre miliari dell’ordinamento socialista. In questo egli
ricorda molto bene il suo conterraneo Tartarin de Tarascon, che nel suo esotico
“giardino delle meraviglie”, tra i vasi di fiori con banane “baobab” e
alberi di cocco grossi un dito, s’immagina di passeggiare sotto la fresca
ombra di una foresta vergine tropicale.
I nostri opportunisti incassano dalla realtà schiaffi sul tipo del recente
tradimento del liberalismo belga e poi dichiarano: “caeterum censeo”, il
socialismo possa essere realizzato solo mediante la democrazia statale borghese.
Essi non si rendono affatto conto di non far altro che ripetere con parole
diverse, vecchie teorie, per le quali la legalità e la democrazia borghesi
sarebbero elette a realizzare la libertà, l’uguaglianza e la felicità
universale; non teorie della grande rivoluzione francese (le parole d’ordine
di questa erano soprattutto espressione di una ingenua fede precedente la
riprova storica), ma teorie dei verbosi letterati e avvocati del 1848, degli
Odilon Barrot, dei Lamartine, dei Garnier-Pagès, che promettevano di realizzare
tutte le promesse della grande rivoluzione per via di semplici ciance
parlamentari. Ed era necessario che queste teorie soffrissero un quotidiano
fiasco nello spazio di un secolo, che la socialdemocrazia come fallimento fatto
carne di queste teorie le seppellisse così radicalmente che perfino il ricordo
di esse, dei loro autori, di tutta la loro atmosfera storica fosse sparito per
intero, perché potessero ora risorgere sotto la specie di una idea del tutto
vergine, ai fini della realizzazione delle mete socialdemocratiche. Ciò che sta
alla base delle dottrine opportunistiche non è evidentemente, come si pretende,
la teoria dell’evoluzione, ma le ripetizioni periodiche della storia, ogni
edizione della quale diventa sempre più noiosa e insulsa.
La socialdemocrazia tedesca ha incontestabilmente realizzato da decenni una
revisione estremamente importante della tattica socialista e si è così
aggiudicata meriti straordinari presso il proletariato internazionale. La
revisione consisteva nell’accantonamento dell’antica fede nella rivoluzione
violenta, come unico metodo della lotta di classe e come lo strumento in ogni
tempo funzionale per l’introduzione dell’ordinamento socialista. Oggi, come
la risoluzione parigina di Kautsky ha ribadito, è divenuta opinione dominante
che la presa del potere statale da parte della classe lavoratrice possa essere
soltanto il risultato di un periodo più o meno lungo di metodica lotta di
classe quotidiana, in quanto gli sforzi per la progressiva democratizzazione
dello Stato e del parlamentarismo rappresentano un mezzo estremamente efficace
per l’elevazione spirituale e in parte materiale della classe lavoratrice.
Ma ciò è anche tutto quello che praticamente la socialdemocrazia tedesca ha
dimostrato. Né in generale la violenza della storia né rivoluzioni violente
come strumento di lotta del proletariato sono state con questo bandite una volta
per tutte, e il parlamentarismo innalzato a unico metodo della lotta di classe.
Tutt’al contrario, la forza è e rimane la “ultima ratio” anche della
classe lavoratrice, la legge suprema della lotta di classe, ora allo stato
latente, ora in atto. E se noi rivoluzioniam le teste con l’attività
parlamentare come con ogni altra, è in fin dei conti, perché in caso di
necessità la rivoluzione discenda dalle teste nei pugni.
Non è certamente per predilezione verso le violenze o verso romanticherie
rivoluzionarie che i partiti socialisti devono essere preparati, nel caso in cui
i nostri sforzi si indirizzino contro interessi vitali delle classi dominanti,
anche a cozzi violenti a breve o a lunga scadenza con la società borghese; ma
per amara necessità storica. Il parlamentarismo come solo e sacrosanto mezzo
politico di lotta della classe lavoratrice, è altrettanto fantastico e in
ultima linea reazionario del solo sacrosanto sciopero generale o della sola
sacrosanta barricata. Certo, la rivoluzione violenta nelle odierne condizioni è
un mezzo di impiego estremamente arduo e a doppio taglio. E dobbiamo anche
attenderci che il proletariato faccia uso di questo mezzo solo allorquando esso
rappresenti l’unica via pratica per la sua avanzata, e naturalmente solo in
circostanze in cui la situazione politica complessiva e il rapporto di forze
garantiscano più o meno la probabilità del successo. Ma è “a priori”
indispensabile l’aperto riconoscimento della necessità dell’uso della
forza, sia in singoli episodi della lotta di classe, come per la conquista
finale del potere statale; è la forza che può prestare, anche alla nostra
attività pacifista, legale, la sua particolare energia ed efficacia.
Se aprioristicamente e una volta per tutte la socialdemocrazia volesse
effettivamente rinunziare, come le suggeriscono gli opportunisti, all’uso
della forza, e le masse lavoratrici giurassero sulla legalità borghese, prima o
poi tutta la loro lotta parlamentare e, in genere, politica, crollerebbe
miseramente, per dar via libera allo strapotere della violenza reazionaria.
Rosa Luxemburg (1875-1919)
80 - Formazione dell’”armata di riserva” (1909) (Rosa Luxemburg)
Nel movimento ascendente
dell’onere di lavoro e nella compressione del tenore di vita dei lavoratori al
livello minimo fisiologico e in parte considerevolmente sotto lo stesso livello,
il moderno sfruttamento capitalistico sta alla pari a quanto praticato
nell’economia schiavista e in regime di servitù della gleba durante il
periodo della loro peggiore degenerazione, quando cioè queste due forme
economiche erano prossime alla disgregazione. Ma di esclusiva prerogativa della
produzione mercantile capitalistica rimane il fenomeno - in precedenza del tutto
sconosciuto – dell’esistenza permanente di uno stato di disoccupazione e
conseguentemente di non-consumo tra le file dei lavoratori; vale a dire il
fenomeno della cosiddetta armata di riserva del lavoro. La produzione
capitalistica dipende dal mercato e non può non seguirne la domanda. Ma questa
muta continuamente e dà alternativamente origine ad esercizi annuali,
“saisons” e mesi cosiddetti buoni e cattivi. Il capitale deve continuamente
adeguarsi a codesti mutamenti congiunturali e conseguentemente impiegare un
numero ora maggiore ora minore di lavoratori. Perciò per avere sotto mano in
ogni momento la quantità di forze di lavoro necessaria per far fronte anche
alle più forti richieste del mercato, accanto a un certo numero di lavoratori
occupati occorre tenere costantemente a disposizione un considerevole numero di
disoccupati di riserva. In quanto tali, i lavoratori non-occupati non fruiscono
di alcun salario, la forza lavoro non è comprata, è semplicemente in deposito;
il non-consumo di una parte della classe lavoratrice costituisce dunque una
parte essenziale e integrante della legge del salario della produzione
capitalistica. Come questi disoccupati si conservino in vita, non riguarda il
capitale, ma ogni tentativo di eliminare l’armata di riserva è da questo
respinto come un attentato ai propri interessi vitali. Un esempio clamoroso ce
lo fornisce la crisi cotoniera inglese dell’anno 1863. Allorché,
improvvisamente, per mancanza di cotone grezzo americano, le filande e le
fabbriche inglesi di tessuti dovettero interrompere la produzione e quasi 1
milione di popolazione operaia rimase senza pane, per sfuggire alla minaccia
della morte per fame una parte di questi disoccupati decisero di emigrare in
Australia. Essi chiesero al parlamento inglese la concessione di 2 milioni di
sterline, al fine di rendere possibile l’emigrazione di 50.000 operai
disoccupati. Contro questa audace richiesta operaia, i cotonieri elevarono grida
di indignazione. L’industria non può fare a meno delle macchine e gli operai
sono essi pure delle macchine, non si deve dunque rimanerne sprovvisti. “Il
paese” avrebbe sofferto una perdita di 4 milioni di sterline, qualora i
disoccupati affamati si fossero improvvisamente allontanati. In conformità il
parlamento ricusò i fondi di emigrazione e i disoccupati rimasero incatenati al
loro digiuno al fine di costituire la riserva indispensabile al capitale. Un
altro drastico esempio è quello fornito dai capitalisti francesi nell’anno
1871. Quando, dopo la caduta della Comune, con e senza formalità giuridiche era
persistentemente perseguito il massacro degli operai parigini e venivano così
assassinati decine di migliaia di proletari - e, naturalmente, i migliori e
capaci - coloro che costituivano l’élite operaia, in mezzo al soddisfatto
sentimento di vendetta si destò nel padronato una preoccupazione che il
capitale non dovesse presto risentire dolorosamente la scarsità di
“braccia” sul mercato; proprio allora, infatti, a guerra conclusa,
l’industria andava incontro a un fervido risveglio degli affari. Parecchi
imprenditori parigini non temettero quindi di adoperarsi presso tribunali a
temperare le persecuzioni dei comunardi, in modo da risparmiare la mano
d’opera dalla carneficina delle sciabole per il braccio secolare del capitale.
Ma doppia è la funzione che l’armata di riserva ha da svolgere a pro del
capitale: in primo luogo, di fornire forza lavoro per ogni eventualità di
repentino incremento degli affari, e in secondo luogo, di esercitare attraverso
la concorrenza costituita dai disoccupati una costante pressione sui lavoratori
occupati, e di abbassare a un minimo i salari di questi ultimi.
Marx distingue nell'armata di riserva quattro diversi strati, la cui funzione
per il capitale e le cui condizioni di esistenza si configurano diversamente. Lo
strato superiore risulta dalla disoccupazione periodica di lavoratori
industriali, un fenomeno che si registra costantemente in tutti i mestieri,
inclusi i più favorevoli. La sua composizione muta di continuo, perché ad ogni
operaio capita di rimanere, a volte, senza lavoro e a volte di essere occupato;
il loro numero è anche fortemente fluttuante a seconda dell’andamento degli
affari. Molto elevato in tempo di crisi, minore in congiuntura favorevole; ma
non si esaurisce mai e, in generale, si accresce col procedere dello sviluppo
industriale. Il secondo strato, è quello del proletariato degli operai non
qualificati che affluiscono in città dalla campagna, si presentano sul mercato
con minori pretese e, in quanto semplici manovali, non sono legati a uno
specifico ramo di lavoro, ma fungono da serbatoio a disposizione di tutti i
settori. La terza categoria è quella dei proletari infimi senza regolare
occupazione, e costantemente alla ricerca di questo o quel lavoro occasionale.
Tra di essi sono da ricercare le più lunghe giornate di lavoro, i salari più
bassi, e perciò questo strato non è altrettanto utile dei precedenti più
elevati, ma addirittura altrettanto indispensabile al capitale. Esso trova
costantemente le sue reclute tra la mano d’opera in soprannumero
dell’industria e dell’agricoltura, particolarmente però tra il piccolo
artigianato in rovina e i mestieri subalterni morenti. Esso costituisce la vasta
base dell’industria a domicilio e in generale agisce, per così dire, dietro
le quinte, dietro il palcoscenico ufficiale dell’industria. Ma non solo non ha
nessuna tendenza a sparire ma, al contrario, si incrementa, tanto in
conseguenza, degli effetti crescenti dell’industria sulla città e la
campagna, come per la più forte natalità.
Finalmente il quarto strato dell’armata di riserva proletaria è costituito
dai veri e propri “pauperes”, i poveri, in parte abili al lavoro e in
periodi di buon andamento degli affari parzialmente occupati nell’industria o
nel commercio, da cui sono i primi ad essere cacciati fuori in periodi di crisi;
in parte inabili: vecchi operai che l’industria non può più utilizzare,
vedove proletarie, orfani, figli di indigenti, mutilati e invalidi della grande
industria, dell’industria mineraria, ecc...; da ultimo, elementi disadatti al
lavoro: vagabondi e simili. Questo strato dà direttamente nel “Lumpenproletariat”:
delinquenti, prostitute, anormali e simili. Il pauperismo, dice Marx,
rappresenta l’ospizio di invalidità della classe operaia e il peso morto
della sua armata di riserva. La sua esistenza non è meno una conseguenza
necessaria e inevitabile dell’armata di riserva, di quanto questa non lo sia
dello sviluppo dell’industria. La povertà e il “Lumpenproletariat” sono
tra le condizioni d’esistenza del capitalismo e fanno tutt’uno con il suo
sviluppo: quanto maggiore la ricchezza sociale, il capitale attivo e la massa
dei lavoratori da esso impiegata, tanto maggiore anche il numero di disoccupati
disponibile, l’armata di riserva. Quanto maggiore l’armata di riserva in
relazione alla massa di lavoratori occupata, tanto maggiore lo strato inferiore
della povertà del pauperismo, della delinquenza. Col capitale e la ricchezza
cresce inevitabilmente anche la quantità dei disoccupati e dei senza salario e
conseguentemente anche il “lazzaretto” della classe lavoratrice - la povertà
ufficiale. Questa, dice Marx, la legge assoluta e generale dello sviluppo
capitalistico.
Il fenomeno costituito dalla formazione di uno strato permanente e crescente di
elementi senza lavoro era sconosciuto, lo abbiamo detto a tutte le precedenti
forme sociali. (...)
La storia del passato conosce solo un esempio in cui un grande strato di
popolazione sia rimasto senza occupazione e senza pane. È il caso degli antichi
contadini romani che, cacciati dalle loro terre e trasformati in proletariato,
rimasero privi di occupazione. Questa proletarizzazione dei contadini fu certo
una conseguenza logica e necessaria della costituzione dei grandi latifondi come
pure della diffusione dell’economia schiavistica. Ma, per l’esistenza
dell’economia schiavistica e del grande possesso fondiario il fenomeno non era
assolutamente indispensabile. Al contrario, il proletariato romano disoccupato
fu solo una calamità, un nuovo onere per la società, e la società di allora
cercò di porre rimedio al proletariato e alla sua miseria con tutti i mezzi a
lei accessibili: periodica distribuzione di terre, distribuzione di mezzi di
sussistenza, regolamentazione di una enorme importazione di grano, e bassi
prezzi artificiali delle granaglie. In conclusione, questo grande proletariato
dell’antica Roma veniva bene o male mantenuto direttamente dallo Stato.
La produzione mercantile capitalistica è la prima forma di economia nella
storia dell’umanità in cui la disoccupazione e l’indigenza di un grande e
crescente settore della popolazione e la diretta povertà senza speranze di un
altro settore parimenti crescente, sia non soltanto una conseguenza, ma anche
una necessità, una condizione di vita di questa economia. Incertezza
nell’esistenza di tutta la massa lavoratrice e cronico stato di ristrettezze,
in parte miseria vera e propria di determinati larghi strati della popolazione,
sono per la prima volta un fenomeno normale della società.
E gli intellettuali della borghesia, che non riescono a immaginarsi altra forma
sociale di quella attuale, sono così compresi di questa necessità naturale
d’uno strato di disoccupati e affamati, da interpretarla come una legge di
natura voluta da Dio. Al principio del sec. XIX, l’inglese Malthus, ne fece il
fondamento della sua celebre teoria della sovrapopolazione, secondo la quale la
povertà trae origine dalla cattiva abitudine dell’umanità di moltiplicare le
progenie più rapidamente dei mezzi di sussistenza.
Ma, abbiamo visto, questi risultati non sono altro che i semplici effetti della
produzione e dello scambio mercantili. Questa legge mercantile che formalmente
riposa sulla piena uguaglianza e libertà, genera - di assoluta meccanicità,
senza alcun intervento giuridico o violento e con ferrea necessità - una
disuguaglianza sociale così crassa quale assolutamente mai fu conosciuta in
tutti i rapporti sociali precedenti basati sul dominio diretto dell’uomo
sull’uomo. Per la prima volta la fame è direttamente il pungolo, che
giornalmente mette alla frusta la vita della massa lavoratrice. E anche questo
viene spiegato come “legge di natura”.
Il prete anglicano Townsend già nell’anno 1786 scriveva: “Sembra una legge
di natura che i poveri siano a un grado tale dei leggeroni da essercene
continuamente per l’adempimento delle funzioni più servili, sudici e comuni
della comunità. I fondi di umana felicità vengono così assai accresciuti, i
più delicati sono liberati dagli strapazzi e possono dedicarsi indisturbati a
più alti compiti. La legge sui poveri ha la tendenza a distruggere l’armonia
e la bellezza, la simmetria e l’ordine di questo sistema che Dio e la natura
hanno creato”.
I “delicati” che vivono a spese degli altri, hanno visto in ciò il dito di
Dio e una legge della natura, come sempre del resto, in ogni forma di società
che assi curasse loro le gioie della vita, i maggiori spiriti non esclusi da
questa illusione storica. Così scriveva - di alcuni millenni precorrendo il
sacerdote inglese - il grande pensatore greco Aristotele: “ È la natura
stessa che ha creato la schiavitù. Gli animali si dividono in maschi e femmine.
Il maschio è un animale perfetto e comanda, la femmina è meno perfetta e
obbedisce. Parimenti nella razza umana si danno individui che stanno tanto più
in basso degli altri, quanto il corpo rispetto all’anima o l’animale
rispetto all’uomo; ci sono esseri che sono esclusivamente capaci di lavori
fisici, e sono inetti a portare a termine qualcosa di più perfetto. Questi
individui sono per natura destinati alla schiavitù, perché per loro non v’è
alcunché di meglio che obbedire ad altri... In conclusione c’è poi un così
grande divario tra lo schiavo e l’animale? I loro lavori si eguagliano, essi
ci sono utili solo per il loro corpo. Concludiamo dunque da questi principi che
la natura ha fatto certi uomini per la libertà e altri per la schiavitù, che
è dunque utile e giusto che lo schiavo si rassegni”.
La “natura” che è dunque fatta responsabile di ogni forma di sfruttamento,
col tempo in ogni caso deve avere di molto corrotto i propri gusti. Poiché se
ancora può valere la pena sottomettere all’ignominia della schiavitù una
grande massa di popolo per sollevare sulla schiena di questa un libero popolo di
filosofi e geni come Aristotele, la degradazione attuale di milioni di proletari
e di grassi dignitari ecclesiastici è uno scopo che si presenta ben poco
allettante.
Rosa Luxemburg (1875-1919)
81 - Le tendenze dell’economia capitalistica (1909) (Rosa Luxemburg)
Abbiamo visto come la produzione mercantile sia
sorta dopo la graduale dissoluzione di ogni forma di società con una qualche
determinata organizzazione pianificata della produzione - società comunistica
primitiva, economia schiavistica, economia medioevale. Abbiamo inoltre visto
come dall’economia mercantile semplice, ossia dalla produzione cittadina
artigianale alla fine del Medioevo si sia sviluppata del tutto meccanicamente,
vale a dire senza intervento della volontà e della coscienza degli uomini,
l’attuale economia capitalistica. In principio ci siamo posti
l’interrogativo: “Com’è possibile l’economia capitalistica?” Questa
è in vero anche la questione scientifica fondamentale dell’economia politica.
Ora, la scienza ce ne dà una risposta adeguata. Essa ci mostra come si articoli
come un tutto e possa funzionare l’economia capitalistica che, in
considerazione della sua completa deficienza di pianificazione e della mancanza
di ogni cosciente organizzazione, al primo sguardo si presenterebbe come una
impossibilità, un inestricabile indovinello. E precisamente in questo modo:
Mediante lo scambio delle merci e l’economia monetaria, con cui congiunge
economicamente tutti i singoli produttori e i più remoti paesi della terra e
realizza così la divisione del lavoro su tutta la terra;
mediante la libera concorrenza che assicura il progresso tecnico e
contemporaneamente trasforma costantemente in proletari i piccoli produttori,
così da mettere a disposizione del capitale la forza-lavoro da acquistare;
mediante la legge capitalistica del salario che, da un lato, meccanicamente
provvede a che i salariati non si sollevino mai dallo stato di proletari e non
si sottraggano al lavoro agli ordini del capitale, dall’altro permette al
capitale un sempre maggiore ammassamento di lavoro non pagato, sempre maggior
accumolo ed ampiamento dei mezzi di produzione;
mediante l’armata di riserva industriale che concede alla produzione
capitalistica ogni possibilità di dilatazione e di regolazione secondo i
bisogni della società;
mediante il livellamento del tasso di profitto che condiziona il costante
movimento del capitale da un ramo di produzione a un altro e così regola
l’equilibrio della divisione del lavoro, infine:
mediante le oscillazioni di prezzo e le crisi, che in parte quotidianamente, in
parte periodicamente, portano un aggiustamento tra la produzione cieca e caotica
e le necessità sociali.
In questo modo, grazie all’azione meccanica delle suddette leggi economiche,
sorte del tutto spontaneamente, senza alcun cosciente intervento della società,
l’economia capitalistica sussiste. Vale a dire, in questo modo diviene
possibile che, nonostante faccia difetto un qualunque rapporto economico
organizzato tra singoli produttori, nonostante la totale mancanza di
pianificazione nell’attività, economica degli uomini, la produzione sociale e
il circolo che essa attua col consumo procedano, la grande massa della società
venga mantenuta al lavoro e assicurato il progresso economico: lo sviluppo della
produttività del lavoro umano come fondamento dell’intero progresso civile.
Ma si tratta delle condizioni fondamentali dell’esistenza di una qualunque
società umana, e fintanto che una forma di economia storicamente sorta soddisfi
a queste condizioni, per quanto dipende da essa, è in grado di sopravvivere,
sempre che rappresenti una necessità storica.
I rapporti sociali non sono però delle forme pietrificate, immutabili. Abbiamo
visto come nel corso dei tempi essi abbiano subito molteplici variazioni, come
siano soggetti a un eterno mutamento, attraverso cui appunto si fa strada il
progresso civile umano, l’evoluzione.
Ai lunghi millenni dell’economia comunistica primitiva, che conducono la
società umana dai primordi di un’esistenza ancora semianimale a un alto grado
di sviluppo civile, alla formazione della lingua e della religione,
all’allevamento del bestiame e all’agricoltura, alla vita in sedi stabili e
alla costruzione di villaggi, segue la formazione della schiavitù antica che da
parte sua porta con sé nuovi e grandi progressi della vita sociale per finire,
a sua volta, con la decadenza del mondo antico. Dalla società comunistica dei
Germani nell’Europa centrale cresce sulle rovine del mondo antico una nuova
struttura: l'economia servile, basata sul feudalesimo medioevale.
Lo sviluppo riprende il suo processo ininterrotto: in grembo alla società
feudale medioevale nascono nelle città dei germi di una forma economica e
sociale tutt’affatto nuova, si costituiscono le corporazioni artigianali, la
produzione mercantile e una regolare attività commerciale, che finiscono per
decomporre la società servile feudale; questa va a pezzi per far posto alla
produzione capitalistica che, grazie al commercio mondiale, alla scoperta
dell’America e della via marittima per le Indie, è venuta crescendo dalla
produzione mercantile artigianale.
Da parte sua, il sistema di produzione capitalistico, considerato a priori da
tutta l’enorme prospettiva del progresso storico, non è né immutabile né
eterno, ma una semplice fase di passaggio a ugual titolo delle trascorse forme
sociali, un gradino nella colossale scala dello sviluppo civile umano. E in
effetti, osservato più da vicino, lo sviluppo stesso del capitalismo porta con
sé le ragioni del proprio tramonto e superamento. Finora abbiamo orientato la
nostra ricerca in direzione dei rapporti che rendono possibile l’economia
capitalistica: è ora tempo di passare a conoscere quelli che la rendono
impossibile.
A questo scopo basta solo trarre le conseguenze ulteriori delle leggi interne
del dominio capitalistico. Sono esse stesse a rivolgersi a un certo grado dello
sviluppo contro tutte le condizioni fondamentali di esistenza della società
umana. Ciò che particolarmente contraddistingue il sistema di produzione
capitalistico di fronte a tutti quelli precedenti, è la sua interna spinta a
estendersi meccanicamente su tutta la superficie della terra e a eliminare ogni
altro ordinamento sociale antecedente. Ai tempi del comunismo primitivo, tutto
il mondo, per quanto accessibile alla ricerca storica, era uniformemente coperto
di economie comunistiche. Solo che tra le singole comunità e tribù
comunistiche non esistevano affatto relazioni, o ne esistevano di debolissime
nel caso di prossimità geografica. Ognuna di tali comunità o tribù viveva per
sé una vita chiusa e se anche incontriamo fatti sorprendenti, come per esempio
la quasi identità di denominazione della comunità comunistica germanica e
quella paleoperuviana del Sud America, “Mark” l’una, “marca” questa,
sinora la circostanza resta ancora per noi un enigma irrisolto, quando non si
tratti di un semplice caso. Anche al tempo della diffusione della schiavitù
antica troviamo maggiori o minori somiglianze nell’organizzazione e nella
struttura delle singole economie e dei singoli Stati schiavistici
dell’antichità, non tuttavia una loro comunione di vita economica. Nello
stesso modo la storia dell’artigianato corporativo e della sua liberazione si
è ripetuta con maggiore o minore somiglianza nella maggior parte delle città
italiane, tedesche, olandesi, inglesi, ecc. medievali; ma si è per lo più
trattato della storia isolata di ciascuna città. La produzione capitalistica si
estende su tutti i paesi, non semplicemente configurandoli economicamente tutti
in egual modo, ma collegandoli a un’unica grande economia mondiale
capitalistica.
All’interno di ciascun paese industriale europeo la produzione capitalistica
soppianta incessantemente il piccolo esercizio, l’artigiano e il piccolo
contadino. Contemporaneamente, essa trascina nell’ambito dell’economia
mondiale tutti i paesi europei arretrati nonché l’America, l’Asia,
l’Africa, l’Australia in due modi: col commercio mondiale e con le conquiste
coloniali. Questi fenomeni cominciarono all’unisono già con la scoperta
dell’America, alla fine del sec. XV, si estesero ulteriormente nel corso dei
secoli seguenti, ma raggiunsero un maggior vigore particolarmente nel corso del
sec. XIX, allargandosi sempre di più. Entrambi - commercio mondiale e conquiste
coloniali - agiscono in collaborazione nella seguente maniera. Dapprima portano
i paesi industriali capitalistici europei in contatto con ogni specie di forme
sociali di altre parti del mondo, a livelli di civiltà e di economia più
antichi: economie schiavistiche contadine, economie servili feudali, ma
prevalentemente forme comunistiche primitive. Mediante il commercio, in cui
vengono attirate queste economie, rapidamente si decompongono e vanno in rovina.
Mediante la fondazione di società commerciali coloniali in suolo straniero, o
mediante conquista diretta, sia la terra - la più importante base della
produzione - come il bestiame, dove esso esiste, cadono nelle mani di Stati
europei o delle società commerciali. In questo modo i rapporti sociali
originari e il sistema economico degli indigeni vengono dovunque distrutti.
Interi popoli in parte sterminati, per il resto proletarizzati e in questa o
quella forma come schiavi o come salariati posti al servizio del capitale
industriale e commerciale. La storia delle decennali guerre coloniali che si
protraggono per tutto il sec. XIX: insurrezioni contro Francia, Inghilterra,
Olanda e Stati Uniti in Asia, contro Spagna e Francia in America - è la storia
della lunga e tenace resistenza delle vecchie società indigene contro la loro
distruzione e proletarizzazione da parte del moderno capitale - una lotta dalla
quale, in conclusione, il capitale emerge ovunque vincitore.
In prima linea ciò equivale a un’enorme estensione del campo di dominio del
capitale, a uno sviluppo del mercato e dell’economia mondiale, in cui i paesi
popolati del globo terrestre sono reciprocamente produttori e acquirenti dei
prodotti, lavorano in collaborazione, sono ripartizioni di una e identica
economia, che abbraccia tutta la terra.
Ma ecco l’altra faccia della medaglia: l’immiserimento progressivo sulla
superficie terrestre di sempre più vasti settori dell’umanità e progressiva
incertezza della loro esistenza. Con la sostituzione di antichi rapporti
comunistici, contadini o di quelli servili, dalle limitate forze produttive e
dal benessere minimo, ma con condizioni di esistenza salde e assicurate a tutti,
a pro dei rapporti coloniali capitalistici, con relativa proletarizzazione e
schiavitù salariale, per tutti i paesi interessati d’America, Asia, Africa,
Australia, sopravviene l’ora della nuda miseria, di dissueto e insopportabile
onere di lavoro e per soprammercato di totale incertezza dell’esistenza. Dopo
che il fertile e ricco Brasile è stato trasformato per le necessità del
capitalismo europeo e nordamericano in un’immensa desolazione e in
un’uniforme piantagione di caffè e intere masse di indigeni in schiavi
salariati e proletarizzati ad uso delle piantagioni, come se non bastasse,
questi schiavi salariati in seguito ad un fenomeno di natura puramente
capitalistica - la cosiddetta “crisi del caffè” - vengono improvvisamente
abbandonati per un bel tratto di tempo alla disoccupazione e a cruda fame. La
ricca ed enorme India, dopo decenni di resistenza disperata, venne assoggettata
al dominio del capitale dalla politica coloniale inglese, e da allora carestia e
tifo famelico, che mietono ogni volta milioni di vittime, sono ospiti periodici
della regione del fiume Gange. Nell’interno dell’Africa, negli ultimi 20
anni la politica coloniale inglese e tedesca ha in parte trasformate in schiavi
salariati, in parte fatte morire di fame, intere popolazioni, disperse ai
quattro venti le loro ossa. Le disperate insurrezioni e le epidemie di fame
nella gigantesca Cina sono le conseguenze della disgregazione della vecchia
economia contadina e artigianale di quel paese a causa della penetrazione del
capitalismo europeo. La penetrazione del capitalismo europeo negli Stati Uniti
fu accompagnata in un primo tempo dalla distruzione degli indiani americani
indigeni e dalla rapina delle loro terre da parte degli inglesi immigrati; in
seguito dall’installazione, all’inizio del XIX secolo, di una produzione
capitalistica di materie prime per l’industria inglese, poi dalla
schiavizzazione di quattro milioni di negri africani, che furono venduti in
America da mercanti di schiavi europei per essere posti al servizio del capitale
come forza lavoro per le piantagioni di cotone, di zucchero e di tabacco.
Così una parte del mondo dopo l’altra e in ogni continente una contrada dopo
l’altra, una razza dopo l’altra, cadono fatalmente sotto il dominio del
capitale, e sono sempre nuovi innumerevoli milioni di persone che decadono nella
proletarizzazione, nella schiavitù, nell’insicurezza dell’esistenza, in
breve nell’immiserimento. L'istituzione dell’economia capitalistica porta
d’altro canto con sé sempre maggiore miseria, un intollerabile onere di
lavoro e una crescente incertezza dell’esistenza su tutta la terra, a cui
corrisponde l’accumulo del capitale in poche mani. L’economia mondiale
capitalistica significa sempre più l’aggiogamento di tutta l’umanità a un
lavoro faticoso in condizioni di privazioni e sofferenze innumerevoli, di
degenerazione fisica e spirituale, al fine esclusivo dell’accumulo di
capitali. Abbiamo visto: il sistema di produzione capitalistico ha la
particolarità che per esso il consumo umano, che nelle precedenti forme
economiche era scopo, diventa solo mezzo, ai servizi del fine vero e proprio:
l’accumulo di profitto capitalistico. L’autosviluppo del capitale appare
principio e fine, scopo assoluto e senso di tutta la produzione. La follia di
questi rapporti si rivela tuttavia soltanto nella misura in cui la produzione
capitalistica si dilata a produzione mondiale. Qui, alla scala dell’economia
mondiale, l’assurdo dell’economia capitalistica raggiunge la sua esatta
espressione nel quadro di una umanità intera gemente tra spaventose sofferenze,
sotto il giogo di una cieca potenza sociale da lei stessa inconsciamente creata,
il capitale. Lo scopo fondamentale di ogni forma sociale di produzione: il
sostentamento della società attraverso il lavoro, la soddisfazione dei suoi
bisogni appare qui soltanto completamente posta sulla testa, in quanto diventano
legge su tutta la superficie della terra la produzione non per amore degli
uomini, ma del profitto e regola il sotto consumo, la costante incertezza del
consumo e, periodicamente, il diretto non consumo dell’enorme maggioranza
degli uomini.
Nello stesso tempo lo sviluppo dell’economia mondiale comporta ancora altri
importanti fenomeni e perfino per la produzione capitalistica stessa. Come
abbiamo detto, il dominio capitalistico europeo fa il suo ingresso nei paesi in
due tappe: anzitutto la penetrazione commerciale e il conseguente inserimento
degli indigeni nello scambio mercantile, in parte anche la trasformazione delle
forme di produzione indigene preesistenti in produzione mercantile; in seguito,
l’espropriazione, in questa o in quella forma delle terre dei nativi e
conseguentemente dei loro mezzi di produzione. Questi mezzi di produzione nelle
mani degli europei si trasformano in capitale, mentre gli indigeni si
trasformano in proletari. A queste due prime tappe, tuttavia, ne segue di regola
prima o poi una terza: la fondazione nel paese coloniale di una vera e propria
produzione capitalistica, sia per iniziativa di europei immigrati che di
indigeni arricchiti. Gli Stati Uniti del Nord America, che dapprincipio furono
popolati da inglesi ed altri europei emigrati, dopo la distruzione, nel corso di
una lunga guerra, dei pellirossa indigeni, costituirono dapprima un retroterra
agricolo dell’Europa capitalistica destinato a fornire all’industria inglese
le materie grezze, come cotone e grano, e acquirente, in cambio, di ogni specie
di prodotti industriali di provenienza europea. Nella seconda metà del XIX
secolo, tuttavia, sorge negli Stati Uniti una industria locale che non solo
subentra all’importazione dall’Europa, ma ben presto entra in dura
concorrenza col capitalismo europeo nella stessa Europa e nelle altre parti del
mondo. In India, con l'industria tessile, e di altro tipo locale, è sorto
parimenti un pericoloso concorrente al capitalismo inglese. L'Australia ha
battuto la stessa strada la stessa strada evolutiva, da paese coloniale a paese
industriale e capitalistico. In Giappone già alla prima tappa, dietro impulso
del commercio mondiale, si è sviluppata un’industria locale, ciò che ha
protetto il Giappone dalla ripartizione colonialistica europea. In Cina, il
processo di smembramento e saccheggio del paese da parte del capitalismo europeo
si complica con gli sforzi interni di fondare, con l’aiuto del Giappone, una
propria produzione capitalistica contro quella europea, onde ne risultano anche
per la popolazione complicazioni e sofferenze raddoppiate. In questo modo, non
solo sono il dominio e l’autorità del capitale ad estendersi su tutta la
terra mediante la creazione di un mercato mondiale, ma è il sistema di
produzione capitalistico a diffondersi a poco a poco sull’intera superficie
terrestre. Ma in questo modo i bisogni di espansione della produzione e il suo
mercato, vale a dire la possibilità di vendita, entrano in un rapporto
reciprocamente sempre più critico. Come abbiamo visto, è intima esigenza e
legge di vita della produzione capitalistica, che essa abbia la possibilità di
non rimanere ferma, bensì di estendere sempre più e addirittura, sempre più
rapidamente, cioè di produrre sempre più celermente maggiori quantità di
merci in sempre più vaste aziende con sempre più perfezionati mezzi tecnici.
In sé stessa, questa possibilità di espansione della produzione capitalistica
non conosce confini, perché il progresso tecnico e conseguentemente anche le
forze produttive della terra non hanno limiti. Solo che questa esigenza di
espansione va a cozzare contro limiti ben determinati, cioè contro l'interesse,
per il profitto da parte del capitale. La produzione e la sua espansione hanno
senso unicamente se, almeno, ne derivi il profitto medio “corrente”. Ma che
ciò avvenga, dipende dal mercato, cioè dal rapporto tra la domanda solvente da
parte dei consumatori e la quantità delle merci prodotte e i loro prezzi.
L’interesse per il profitto da parte del capitale, che da un lato esige una
sempre più rapida e sempre maggiore produzione, si crea dunque da se stesso ad
ogni piè sospinto dei limiti di mercato che ostacolano la violenta spinta
espansiva della produzione. Ne risulta, come abbiamo visto, l’inevitabilità
delle crisi industriali e commerciali che periodicamente equilibrano il rapporto
tra la spinta produttiva capitalistica - in sé sfrenata e illimitata - e i
limiti capitalistici di consumo e rendono possibile la sopravvivenza e
l’ulteriore sviluppo del capitale.
Solo che quanti più paesi sviluppano una propria industria capitalistica tanto
maggiori sono l’esigenza e le possibilità di espansione dei limiti del
mercato. Se si confrontano i progressi compiuti dall’industria inglese negli
anni “sessanta” e “settanta”, quando era ancora il paese capitalistico
dominante sul mercato mondiale, con il suo sviluppo negli ultimi due decenni, da
quando Germania e Stati Uniti del Nord America hanno notevolmente limitato il
peso inglese sul mercato mondiale, risulta che in relazione al passato la sua
crescita si è fatta assai più lenta. Ma ciò che fu isolatamente il destino
dell’industria inglese minaccia inevitabilmente anche l’industria tedesca,
nordamericana e finalmente tutta l’industria mondiale. Irresistibilmente, ad
ogni passo innanzi del suo proprio sviluppo, la produzione capitalistica si
approssima al momento in cui non si potrà espandere e sviluppare che sempre più
lentamente e con difficoltà. Certo, lo sviluppo capitalistico ha di per se
stesso ancora il tempo per compiere un grande tratto di strada, durante il quale
il sistema di produzione capitalistico dominante sul mercato mondiale
rappresenterà ancora soltanto la frazione minore della produzione complessiva
della terra. Perfino nei più vecchi paesi industriali dell’Europa, accanto a
grandi aziende industriali continuano ad esistere numerosi piccoli esercizi
artigianali e soprattutto la maggior parte della produzione dell’economia
rurale, cioè quella contadina, non esercita su base capitalistica. Inoltre, ci
sono in Europa interi paesi, in cui la grande industria è appena sviluppata,
mentre la produzione artigianale locale porta un carattere prevalentemente
contadino e artigianale. E finalmente, nelle restanti parti del mondo,
eccettuato il Nord America, i centri di produzione capitalistica costituiscono
solo piccoli punti dispersi mentre interi enormi tratti di paese in parte non
sono neppure passati alla semplice produzione mercantile. Certo, la vita
economica di tutti questi strati sociali e paesi europei a produzione non
capitalistica come quella dei paesi extraeuropei è anch’essa dominata dal
capitalismo. Per quanto personalmente possa condurre ancora la più primitiva
economia parcellare, il contadino europeo dipende nel modo più completo
dall’economia del grande capitale, dal mercato mondiale col quale lo hanno
portato in contatto il commercio e la politica fiscale dei grandi Stati
capitalistici.
Nello stesso modo, i paesi primitivi extraeuropei vengono portati dal
capitalismo europeo e nordamericano, dal commercio mondiale e dalla politica
coloniale. Di per se stesso il sistema di produzione capitalistico potrebbe
ancora trovare una forte espansione, qualora dovesse eliminare dovunque tutte le
forme arretrate di produzione. In linea generale anche l’evoluzione si svolge,
come abbiamo già esposto, in questa direzione. Solo che è proprio attraverso
questo procedere che il capitalismo si avviluppa nella contraddizione
fondamentale; quanto più in luogo di produzioni più arretrate subentra quella
capitalistica, tanto più stretti si fanno, per le esigenze di espansione degli
esercizi capitalistici già esistenti, i limiti del mercato creati
dall’interesse per il profitto. La cosa si fa del tutto chiara se ci
rappresentiamo per un momento che lo sviluppo del capitalismo sia progredito così
lontano che sulla superficie terrestre tutto quanto prodotto da uomini, lo sia
solo capitalisticamente, vale a dire solo da imprenditori privati capitalistici
in grandi aziende con moderni lavoratori salariati. È a questo punto che viene
chiaramente in luce l'impossibilità (indefinita) del capitalismo.
Rosa Luxemburg
82 - Il partito socialista italiano (1911) (Rosa Luxemburg)
L’ultimo Congresso del Partito
socialista italiano è stato per ogni socialista un fatto di grandissima
importanza nella vita del movimento operaio internazionale. Mai, come allora in
Italia, si è palesato con spaventosa chiarezza che il partito socialista ha la
sua ragione di vita solo nel fatto di essere l’avanguardia cosciente nella
lotta di classe del proletariato e che, venendogli a mancare questa funzione,
esso deve necessariamente presto o tardi perire. L'impressione più viva è
stata senza dubbio, quella che il partito italiano si avvii sopra una strada che
conduce all’abisso. Non questa o quella politica, non l’una o l’altra
tendenza, ma l’avvenire, l’esistenza stessa del partito, ha dato al
Congresso di Milano la sua eminente e, direi anche, tragica importanza per il
socialismo internazionale. Se dibattito vi fu, fu per le cause della decadenza,
fu circa i mezzi per combatterla; ma il fatto della decadenza non fu messo in
dubbio, si palesò anzi tutti nella sua cruda nudità.
Così il movimento italiano da circa dieci anni a questa parte ha assunto
l’importanza di un esempio ammonitore per l’Internazionale tutta. Nel suo
attuale disorientamento e nella sua debolezza, esso grida ai socialisti di tutto
il mondo: ecco a che cosa si riduce il partito socialista qualora le tendenze
opportunistiche prendono il sopravvento e quando sposta il proprio centro di
gravità dalla propaganda rivoluzionaria nelle masse all’azione parlamentare.
Dopo pochi anni di questa politica pratica essa si palesa quale la meno pratica
di questo mondo perché essa è veramente intenta a segare il ramo sul quale sta
seduta. Essa perde il contatto con le masse del proletariato, perde il terreno
sotto ai suoi piedi, diventa il trastullo della politica borghese trascinandosi
dietro, quale ombra della propria debolezza, il sindacalismo, questa caricatura
anarchica del socialismo rivoluzionario. Ma l’esperimento fatto con logica così
spietata dall’opportunismo socialista non può avere in Italia che una
conseguenza sola, quella di rigenerare il movimento operaio. Le leggi obiettive
dell’evoluzione capitalista e della lotta di classe, non hanno cessato di
agire e di imporsi solo perché i capi del partito socialista le abbiano perdute
di vista per un momento. Queste leggi storiche obbiettive del capitalismo
debbono anche in Italia esplicarsi con un movimento rivoluzionario di classe
fugando le nebbie dell’opportunismo. E perciò traiamo la certezza della
vittoria finale dell’ala rivoluzionaria, per quanto ne possa parere precaria e
difficile la posizione. Oggi non è che una minoranza, un terzo all’incirca
dell’intero partito socialista, ma essa ne costituisce il virgulto giovane dal
quale dovrà nascere la rigenerazione del movimento operaio italiano. L’ala
rivoluzionaria, costituisce anche in Italia l’avanguardia
dell’Internazionale operaia, che nella sua grandissima maggioranza tiene
sempre alta la bandiera della lotta di classe. Perciò il nuovo periodico degli
intransigenti italiani sarà raccolto con soddisfazione e gioia dai socialisti
di tutti i paesi. Dieci anni fa ancora, l’aristocratica rivista del partito
italiano, la “Critica sociale”, portava come sottotitolo quello di
“rivista di socialismo scientifico”. In seguito il sottotitolo fu omesso.
Anche il socialismo “scientifico” andò in soffitta. Possa esso rivivere nel
nuovo giornale. Possa il proletariato italiano, vittima di tanto sfruttamento
trarre dalla “soffitta” coi concetti teorici del marxismo le sue armi più
efficaci di lotta intransigente senza quartiere contro la borghesia ed il suo
dominio di classe!
Rosa Luxemburg
83 - Alla redazione del “Labour Leader” di Londra (Rosa Luxemburg)
Cari compagni,
è con gioia e al tempo stesso con profondo dolore che ogni socialdemocratico
tedesco rimasto fedele ai propri principi dell’internazionalismo proletario,
non può non cogliere l’occasione per inviare ai compagni stranieri un
fraterno saluto socialista. Sotto i colpi omicidi della guerra mondiale
imperialistica il nostro orgoglio e la nostra speranza – l’Internazionale
della classe operaia - è ignominiosamente crollata; e più ignominiosamente di
tutte, certamente, è crollata la nostra sezione tedesca, quella predestinata a
marciare alla testa del proletariato mondiale. È necessario esprimere questa
amara verità, non per darsi a disperazione e rassegnazione infruttuose ma, al
contrario, per trarre i debiti insegnamenti dal riconoscimento spregiudicato
degli errori commessi e dallo stato di cose esistente. Nulla riuscirebbe più
fatale per l’avvenire del socialismo che se i partiti operai dei vari paesi
decidessero di accogliere la teoria e prassi borghesi per le quali dovrebbe
essere naturale e inevitabile che i proletari delle diverse nazioni in guerra si
scannino reciprocamente agli ordini delle loro classi dirigenti, e
successivamente si scambino ancora reciproci fraterni abbracci, come se nulla
fosse. Un’Internazionale, che in questo modo riconoscesse scientemente la
spaventosa rovina attuale quale prassi normale anche per l’avvenire, e pure
pretendesse ancora esistere, sarebbe soltanto una rivoltante caricatura del
socialismo, un parto dell’ipocrisia, esattamente nei termini della diplomazia
degli Stati borghesi, delle loro alleanze e dei loro trattati internazionali.
No! Lo spaventoso macello reciproco di milioni di proletari, al quale oggi con
orrore assistiamo, queste orge dell’imperialismo omicida che hanno luogo sotto
le ipocrite insegne di “patria”, di “diritto delle genti”, di “civiltà”,
di “libertà”, devastano paesi e città, disonorano la civiltà, calpestano
la libertà e il diritto delle genti, rappresentano un autentico tradimento del
socialismo.
Ma il socialismo internazionale ha radici troppo salde e troppo profonde nella
situazione contemporanea per poter persistere in questa situazione di sfacelo.
L’imperialismo e le sue mostruose dottrine di questo appunto nutrono timore,
che l’Internazionalproletaria risorga dalle ceneri quale unica salvezza
dell’umanità dall’inferno di un dominio di classe in sfacelo e storicamente
superato. Già ora, a pochi mesi dall’inizio della guerra, sta svanendo anche
in Germania la sbornia sciovinistica tra le masse lavoratrici, piantate in asso
nelle grandi ore storiche dai loro capi; ritorna la coscienza e giorno per
giorno aumenta il numero dei proletari ai quali quanto ora va accadendo, accende
in volto un rossore di vergogna e di collera. Da questa guerra le masse popolari
ritorneranno sotto la nostra vecchia bandiera con ancora più vivo impulso, non
per tradirla nuovamente alla prossima orgia capitalistica, contro le sue mene
delittuose, contro le sue infami menzogne e la sua miserabile retorica a base di
“patria” e di “libertà”, e per piantarla vittoriosamente sulle rovine
dell’imperialismo sanguinario.
Con i più cordiali e fraterni saluti socialisti
Rosa
Luxemburg
Berlin-Südende, dicembre 1914
84
- Ai proletari di tutti i Paesi (1918) (Rosa Luxemburg)
Proletari! Lavoratori e
lavoratrici! Compagni!
La rivoluzione ha fatto il proprio ingresso in Germania. Le masse dei soldati,
da quattro anni spinte al macello per amore dei profitti capitalistici, le masse
dei lavoratori, per quattro anni dissanguate, spremute, affamate, si sono
sollevate. Il terribile strumento dell’oppressione: il militarismo prussiano,
questo flagello dell’umanità, giace a terra spezzato; i suoi rappresentanti
più in evidenza e quindi i più palesi responsabili di questa guerra, il Kaiser
e il Kronprinz, sono fuggiti dal paese. Ovunque si sono costituiti consigli
operai e dei soldati.
Proletari di tutti i paesi, noi non vi diciamo che in Germania tutto il potere
sia effettivamente nelle mani dei lavoratori, che la vittoria completa della
rivoluzione proletaria sia già un fatto compiuto. Siedono ancora al governo
quei socialisti che nell’agosto 1914 hanno sacrificato il nostro bene più
prezioso, l’Internazionale, che, per quattro anni hanno tradito ad un tempo
stesso la classe operaia tedesca e l’Internazionale.
Ma, proletari di tutti i paesi, ora è il proletariato tedesco che vi parla. Noi
crediamo di avere il diritto di presentarci in suo nome di fronte al vostro
giudizio. Dal primo giorno di questa guerra ci siamo sforzati di soddisfare i
nostri doveri internazionali, combattendo con tutte le nostre forze quel governo
criminale e stigmatizzandolo come vero responsabile della guerra.
In quest’ora noi siamo giustificati di fronte alla storia, davanti
all’Internazionale e al proletariato tedesco. Le masse ci danno la loro
adesione entusiastica, sempre nuovi gruppi di lavoratori condividono la
coscienza che è suonata l’ora della resa dei conti col dominio di classe
capitalistico.
Questa grande opera non può tuttavia essere portata a termine dal solo
proletariato tedesco che può combattere e vincere soltanto appellandosi alla
solidarietà dei proletari di tutto il mondo.
Compagni dei paesi belligeranti, noi conosciamo la vostra situazione. Ben
sappiamo che i vostri governi, ora che han raggiunto la vittoria, ne accecano
con lo splendore, larghi strati popolari. Noi sappiamo che così riesce loro di
far dimenticare coi successi le cause e gli obbiettivi della strage.
Ma, sappiamo anche un’altra cosa. Sappiamo che anche nei vostri paesi il
proletariato ha sopportato i sacrifici più spaventosi in sangue e in beni, che
esso è stanco dell’orrido macello, che il proletariato ora torna a casa, e a
casa trova ora uno stato di necessità e di miseria, mentre nelle mani di pochi
capitalisti si sono ammucchiati i miliardi. Esso si è accorto e sempre più si
accorgerà che la guerra è stata condotta anche dai vostri governi per amore
del denaro. E si accorgerà ancora che il vostro governo, quando parlava di
“diritto e civiltà”, e di “protezione delle piccole nazioni”, intendeva
i profitti capitalistici, non meno del nostro, quando cianciava di “difesa
della patria”: che la pace di “giustizia” e della “lega dei popoli”
era pari alla stessa bassa pirateria della pace di Brest-Litowsk. Qui come là
la stessa svergognata rapacità, la stessa volontà di oppressione, la stessa
risoluzione di sfruttare all’estremo la brutale superiorità della spada.
L'imperialismo di tutti i paesi non conosce alcun “accomodamento”, conosce
solo una ragione: il profitto del capitale; solo un linguaggio: quello della
spada; solo un mezzo: la forza. E se ora va discorrendo in tutti i paesi, da voi
come da noi, di “lega dei popoli”, di “disarmo”, di “diritti delle
piccole nazioni”, di “autodeterminazione dei popoli”, si tratta del solito
frasario senza fondamento dei signori per addormentare la vigilanza proletaria.
Proletari di tutti i paesi! Questa guerra deve essere stata l’ultima. Lo
dobbiamo ai 12 milioni di vittime rimaste assassinate. Lo dobbiamo ai nostri
figli, lo dobbiamo all’umanità.
L’Europa è stata rovinata dall’infame massacro dei Popoli. Dodici milioni
di cadaveri ricoprono i luoghi spaventosi del crimine imperialista. Il fiore
della gioventù e la migliore energia dei popoli giace falciata. Innumerevoli
forze produttive sono andate distrutte. L’umanità è prossima a morire
dissanguata per un salasso senza esempio nella storia del mondo. Vincitori e
vinti sono sull’orlo dell’abisso. Minacciano l’umanità la fame più
spaventosa, il ristagno di tutto il meccanismo produttivo, epidemie e
degenerazione.
I grandi criminali di questa spaventosa anarchia, di questo caos scatenato, le
classi dirigenti non sono capaci di padroneggiare la loro opera. La bestia
Capitale che ha evocato l’inferno della guerra mondiale, non è più in grado
di esorcizzare, di ristabilire un ordine autentico, di assicurare alla
tormentata umanità pane e lavoro, pace e cultura, giustizia e libertà.
Ciò che le classi dominanti ci vanno preparando sotto il nome di pace e
giustizia, è soltanto una nuova opera della forza bruta, da cui solleva le sue
mille teste l’idra dell’oppressione, dell’odio e di nuove guerre
sanguinose.
Solo il socialismo è in grado di portare a temine la grande opera di una pace
durevole, di lenire le mille sanguinanti ferite dell’umanità, di trasformare
in fiorenti giardini le campagne europee calpestate dal passo
dell’apocalittico cavaliere della guerra, di evocare decuplicate nuove forze
produttive al posto di quelle distrutte, di risvegliare tutte le energie fisiche
e morali dell’umanità, e di sostituire l’odio e la discordia con solidarietà
fraterna, armonia e rispetto per tutto ciò che ha sembiante umano.
Se rappresentanti dei proletari di tutti i paesi sotto la bandiera del
socialismo si porgessero la mano per concordare la pace, questa sarebbe conclusa
in poche ore. Allora non ci sarebbero controversie per la riva sinistra del
Reno, la Mesopotamia, l’Egitto o le colonie. Allora ci sarebbe solo un popolo:
l’umanità lavoratrice di tutte le razze e di tutte le lingue. Ci sarebbe solo
una legge: l’uguaglianza di tutti gli uomini. Ci sarebbe solo un fine:
prosperità e progresso per tutti.
L’umanità sta davanti a una alternativa: dissoluzione e tramonto
nell’anarchia capitalistica o rinascita attraverso la rivoluzione sociale. Se
credete nel socialismo, è l’ora di mostrarlo coi fatti. Se siete socialisti,
si tratta ora di agire.
Proletari di tutti i paesi, se vi chiamiamo ora a una lotta comune, non è per
amore dei capitalisti tedeschi che sotto l’insegna “nazione tedesca”
cercano di sfuggire alle conseguenze dei loro crimini: è per noi come per voi.
Riflettete: i vostri capitalisti vittoriosi sono pronti a reprimere nel sangue
la nostra rivoluzione, che temono non meno della propria. Voi stessi con la
“vittoria” non siete diventati più liberi, siete diventati ancora più
schiavi. Se le vostre classi dirigenti riuscissero a soffocare la rivoluzione
proletaria in Germania e in Russia, si volgerebbero poi contro di voi con peso
raddoppiato. I vostri capitalisti sperano che la vittoria su di noi e sulla
Russia rivoluzionaria dia loro la forza necessaria per trascinarvi a frustate e
per innalzare il millenario regno dello sfruttamento sulla tomba del socialismo
internazionale.
Perciò in quest’ora il proletariato tedesco guarda a voi. La Germania è
gravida di rivoluzione sociale, ma il socialismo può essere realizzato soltanto
dal proletariato mondiale.
E per questo vi incitiamo: Su alla lotta! Su all’azione! Il tempo dei vuoti
manifesti, delle rivoluzioni platoniche e delle parole roboanti è trascorso:
per l’Internazionale è suonata l'ora dell’azione. Vi esortiamo. Eleggete
dovunque dei consigli dei lavoratori e dei soldati, che assumano il potere
politico e che assieme a noi ristabiliscano la pace.
Non Lloyd George né Poincaré, non Sonnino né Wilson né Erzberger o
Scheidemann possono concludere la pace. La pace deve essere stipulata sotto la
bandiera sventolante della rivoluzione mondiale e socialista.
Proletari di tutti i paesi! Noi vi esortiamo a completare l’opera di
liberazione socialista, a ridare aspetto umano al mondo deturpato e a inverare
quelle parole con cui in vecchi giorni ci siamo spesso salutati e con cui ci
separavamo:
L’Internazionale sarà l’umanità!
Viva la rivoluzione mondiale del proletariato!
Proletari di tutto il mondo unitevi!
In nome dello Spartakusbund
Rosa
Luxemburg, Karl Liebknecht,Franz Mehring, Clara Zetkin
85
- La controrivoluzione (Antonio Gramsci)
I nemici delle rivoluzioni
proletarie del 1919 hanno costituito una coalizione reazionaria che riproduce
nell’Europa odierna le linee generali dell’equilibrio esistente nel 1848,
risultante dalla coalizione costituitasi contro le rivoluzioni semiproletarie di
quell’anno.
La Prussia rimane sempre il perno della reazione: Scheidemann ed Ebert si sono
rivelati servitori delle potenze occidentali non meno zelanti di quanto non
siano stati i re di Prussia verso lo zar. La guardia prussiana ha strangolato
Berlino prima, a Monaco ultimamente, il movimento comunista per
l’instaurazione dello Stato dei Consigli.
(Nota: gruppi e reparti armati, guidati da ufficiali reazionari, avevano
soffocato nel gennaio 1919 il movimento spartachista a Berlino e assassinato
Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg. La repubblica bavarese dei Consigli era caduta
ai primi di maggio 1919).
Nel 1848 la coalizione reazionaria era organizzata intorno alla Russia degli
zar: il re di Prussia era il fedele vassallo dell'imperatore moscovita, il
fedele strumento delle sue imprese di bassa polizia internazionale. Le
rivoluzioni di Parigi, di Praga, di Vienna, di Budapest, di Varsavia, di Milano
furono allora stangolate, direttamente o indirettamente, dalle forze
russo-prussiane che controllavano gli slavi del sud. I prussiano-croati domarono
Praga, i croati domarono Milano, i cosacchi domarono Budapest. Dei popoli slavi
erano rivoluzionari soltanto i polacchi e i boemi; gli altri erano specializzati
nell’assassinare le rivoluzioni.
La Russia zarista, caduta, e sostituita dalla Repubblica dei Soviet, la
coalizione odierna si è venuta organizzando intorno alla Francia. Eccettuata la
Prussia, la fisionomia generale dell’equilibrio reazionario è oggi
simmetricamente in contrapposizione con quello del ’48. La Francia, focolare
delle rivoluzioni, è diventata baluardo della conservazione capitalista; la
Boemia e la Polonia sono le sue vassalle, con la Prussia, la Finlandia, la
Rumenia. La Polonia impedisce il contatto tra i Soviet russi e i comunisti
prussiani; la Boemia e la Rumenia minacciano i Soviet ungheresi. La fortuna
immediata delle rivoluzioni proletarie in Baviera, in Ungheria e in Russia è
riposta nella rapidità con cui le forze comuniste si rafforzano e paralizzano
(prima di conquistarlo) lo stato in Prussia, in Rumenia, in Boemia e in Polonia.
Questa configurazione assunta dalle potenze della conservazione capitalista
dimostra quanto sia stupida la critica ai comunisti russi che hanno conquistato
il potere quando la civiltà russa non era ancora “matura” per il
socialismo. La critica è stupida perché basata sulla concezione utopistica
della rivoluzione simultanea in tutto il globo. Infatti, se la rivoluzione
comunista fosse scoppiata normalmente prima in Inghilterra, nel paese cioè che
ha raggiunto l’apice della parabola del processo di sviluppo della produzione
capitalista, essa sarebbe stata subito schiacciata dalla Prussia e dalla Russia.
La rivoluzione comunista doveva scoppiare in Russia per potersi rassodare ed
estendere con minori difficoltà che altrove. I proletariati di Inghilterra, di
Francia, di Italia, con tutta la loro forza organizzata, con tutto l’orrore
che cinque anni di guerra hanno suscitato contro la guerra, con tutta la loro
coscienza rivoluzionaria, non sono riusciti a impedire totalmente la guerra
contro la Russia comunista. Si può immaginare che il proletariato russo, in
regime zarista o borghese-parlamentare, avrebbe potuto impedire una guerra
contro la Germania comunista, o l’Inghilterra comunista? La Russia è davvero
la martire dell’Internazionale: essa sconta tutte le nostre debolezze, tutte
le nostre esitanze, tutti i nostri baloccamenti bizantini. Il proletariato russo
ha aperto l’era delle rivoluzioni proletarie e sostiene su di sé lo
scatenarsi furioso dei demoni impazziti del capitalismo. Per quanti errori, per
quante colpe il proletariato russo abbia potuto commettere - secondo ciò che
dicono i sicofanti delle casseforti - gli operai e contadini dell’Europa
occidentale non possono dimenticare che esso soffre la fame, combatte una guerra
atroce d’esaurimento per definitivamente creare le condizioni necessarie
all’avvento dell’ionale comunista.
Antonio Gramsci (1891- 1937) 15 maggio 1919
86 - L’Internazionale comunista (Antonio Gramsci)
L’Internazionale comunista è
nata e si sviluppa dalle rivoluzioni proletarie e con le rivoluzioni proletarie.
Già tre grandi stati proletari: le Repubbliche Soviettiste di Russia, di
Ucraina e di Ungheria ne formano la base reale storica.
In una lettera a Sorge del 12 settembre 1874, Federico Engels scrisse a
proposito della I Internazionale in via di sfacelo: “L’Internazionale ha
dominato dieci anni di storia europea e può con fierezza guardare l’opera
sua. Ma essa è sopravvissuta nella sua forma antiquata. Credo che la prossima
Internazionale sarà, dopo che gli scritti di Marx avranno operato per qualche
anno, direttamente comunista e instaurerà i nostri principi.
La II Internazionale non realizzò la fede dell’Engels; dopo la guerra,
invece, e dopo le esperienze positive della Russia, si sono disegnati nettamente
i contorni dell’Internazionale rivoluzionaria, dell’Internazionale di
realizzazione comunista.
La nuova Internazionale ha per base l’accettazione di queste tesi
fondamentali, che sono elaborate secondo il programma della Lega Spartaco di
Germania e del partito comunista (bolscevico) di Russia:
L'epoca attuale è l’epoca della decomposizione e del fallimento dell’intero
sistema mondiale capitalista, ciò che significherà il fallimento della civiltà
europea se il capitalismo non verrà soppresso con tutti i suoi antagonismi
irrimediabili.
Il compito del proletariato nell’ora attuale consiste nella conquista dei
poteri dello Stato. Questa conquista significa: soppressione dell’apparato
governativo della borghesia e organizzazione di un apparato governativo
proletario.
Questo nuovo governo proletario è la dittatura del proletariato industriale e
dei contadini poveri, che deve essere lo strumento della soppressione
sistematica delle classi sfruttatrici e della loro espropriazione. Il tipo di
stato proletario non è la falsa democrazia borghese, forma ipocrita della
dominazione oligarchica finanziaria, ma la democrazia proletaria che realizzerà
la libertà delle masse lavoratrici; non il parlamentarismo, ma l’autogoverno
delle masse attraverso i propri organi elettivi; non la burocrazia di carriera,
ma organi amministrativi creati dalle masse stesse, con la partecipazione reale
delle masse all’amministrazione del paese e all’opera socialista di
costruzione. La forma concreta, dello stato proletario è il potere dei Consigli
o di organizzazioni consimili.
La dittatura del proletariato è la leva dell’espropriazione immediata del
capitale e della soppressione del diritto di proprietà privata dei mezzi di
produzione, che devono essere trasformati in proprietà della nazione intera. La
socializzazione della grande industria e dei suoi centri organizzatori, le
banche; la confisca delle terre dei proprietari fondiari e la socializzazione
della produzione agricola capitalista (comprendendo per socializzazione la
soppressione della proprietà privata, il passaggio della proprietà allo Stato
proletario e lo stabilimento dell’amministrazione socialista a mezzo della
classe operaia); il monopolio del grande commercio; la socializzazione dei
grandi palazzi nelle città e dei castelli nelle campagne; l’introduzione
dell’amministrazione operaia e l’accentramento delle funzioni economiche
nelle mani degli organi della dittatura proletaria, ecco il compito del governo
proletario.
Al fine di assicurare la difesa della rivoluzione socialista contro i nemici
interni ed esterni, e il soccorso ad altre frazioni nazionali del proletariato
in lotta, è necessario di disarmare completamente la borghesia e i suoi agenti,
e di armare tutto il proletariato, senza eccezione.
La situazione mondiale nell’ora presente esige il massimo contatto fra le
differenti frazioni del proletariato rivoluzionario. Come pure il blocco
completo dei paesi nei quali la rivoluzione socialista è già vittoriosa.
Il metodo principale di lotta è l’azione delle masse del proletariato fino al
conflitto aperto contro i poteri dello Stato capitalista.
Tutto il movimento proletario e socialista mondiale si orienta decisamente verso
l’Internazionale comunista. Gli operai e i contadini sentono tutti, anche se
confusamente e vagamente che le Repubbliche soviettiste di Russia, Ucraina e
Ungheria, sono le cellule di una nuova società che realizza tutte le
aspirazioni e le speranze degli oppressi del mondo. L’idea della difesa delle
rivoluzioni proletarie dagli assalti del capitalismo mondiale deve servire a
stimolare i fermenti rivoluzionari delle masse; su questo piano è necessario
concertare un’azione energica e simultanea dei partiti socialisti
d’Inghilterra, di Francia e d’Italia che imponga l’arresto di ogni
offensiva contro la repubblica dei Soviet. La vittoria del capitalismo
occidentale sul proletariato russo significherebbe l’Europa gettata per un
ventennio in braccio alla più spietata e feroce reazione. Nessun sacrificio può
essere più grande se si riuscirà a impedire che ciò avvenga. Se si riuscirà
a rafforzare l’Internazionale comunista, che sola darà al mondo la pace nel
lavoro e nella giustizia.
Antonio Gramsci (24 maggio 1919)
87 - Primo: rinnovare il partito (Antonio Gramsci)
Il partito socialista italiano è il partito degli
operai e dei contadini poveri. Sorto nel campo della democrazia liberale (nel
campo della concorrenza politica, che è una proiezione del processo di sviluppo
del capitalismo) come una delle forze sociali che tendono a crearsi una base di
governo e a conquistare il potere di Stato per rivolgerlo a beneficio dei loro,
la sua missione consiste nell’organizzare gli operai e i contadini poveri in
classe dominante, nello studiare e promuovere le condizioni favorevoli per
l’avvento di una democrazia proletaria.
Il partito socialista italiano è riuscito ad attuare la più facile ed
elementare parte del suo compito storico: è riuscito ad agitare le masse fin
negli strati più profondi, è riuscito ad accentrare l’attenzione, del popolo
lavoratore sul suo programma di rivoluzione e di Stato operaio, è riuscito a
costruire un apparecchio di governo di tre milioni di cittadini che, se
consolidato e materializzato in istituti permanenti rivoluzionari, sarebbe stato
sufficiente per impadronirsi del potere di Stato. Il partito socialista non è
riuscito nella parte essenziale del suo compito storico: non è riuscito a dare
una forma permanente e solida all’apparecchio che era riuscito a suscitare
agitando le masse. Non è riuscito a progredire e perciò è caduto in una crisi
di marasma e di letargia. Costruito per conquistare il potere, costruito come
schieramento di forze militanti deciso a dare battaglia, l’apparecchio di
governo del partito socialista va in pezzi, si disgrega; il partito perde ogni
giorno più il contatto con le grandi masse in movimento; gli avvenimenti si
svolgono e il partito ne è assente; il paese è percorso da brividi di febbre,
le forze dissolventi della democrazia borghese e del regime capitalista,
continuano a operare implacabili e spietate e il partito non interviene. Non
illumina le grandi masse degli operai e contadini, non giustifica il suo fare,
non lancia parole d’ordine che calmino le impazienze, che impediscano le
demoralizzazioni, che mantengano serrati i ranghi e forte la compagine delle
armate operaie e contadine. Il partito, che era diventato la più grande energia
storica della nazione italiana, è caduto in una crisi di infantilismo politico,
è oggi la più grande delle debolezze sociali della nazione italiana. Non fa
meraviglia davvero che in tali propizie condizioni, i germi di dissoluzione
della compagine rivoluzionaria: il nullismo opportunista e riformista e la
fraseologia pseudorivoluzionaria anarchica (due aspetti della tendenza piccolo
borghese) pullulino e si sviluppino con rapidità impressionante.
Le condizioni internazionali e nazionali della rivoluzione proletaria si
profilano sempre più nette e precise e si consolidano. Ed ecco, proprio nel
momento che potrebbe essere decisivo, lo strumento massimo dalla rivoluzione
proletaria italiana, il partito socialista, si decompone, aggredito e
avviluppato insidiosamente dai politicanti parlamentari e dai funzionari
confederali, da individui che rivendicano un potere rappresentativo che non ha
base seria e concreta, che si fonda sull’equivoco, che si fonda sull’assenza
di ogni continuità d’azione e sulla poltroneria mentale che è propria degli
operai come di tutti gli altri italiani. E dalla parte comunista, dalla parte
rivoluzionaria, dalla parte degli enti direttivi nominati dalla maggioranza
rivoluzionaria, nessuna azione d’insieme per arginare questa decomposizione,
per disinfettare il partito, per organizzarlo in compagine omogenea, per
organizzarlo come sezione della III Internazionale, inserita fortemente nel
sistema mondiale di forze rivoluzionarie che intendono seriamente attuare le
tesi comuniste.
La resistenza del blocco imperialista, che era riuscito a soggiogare il mondo a
poche casseforti, è spezzata, è disgregata dalle vittorie militari dello Stato
operaio russo. Il sistema della rivoluzione proletaria internazionale, che
s’impernia sull’esistenza e sullo sviluppo come potenza mondiale dello stato
operaio russo, possiede oggi un esercito di due milioni di baionette, esercito
pieno di entusiasmo guerriero perché vittorioso e perché consapevole di essere
il protagonista della storia contemporanea. Le vittorie e le avanzate
dell’esercito della III Internazionale scuotono le basi del sistema
capitalista, accelerato il processo di decomposizione degli stati borghesi,
acuiscono i conflitti nel seno delle democrazie occidentali. Gli inglesi si
preoccupano per l’India, la Turchia, la Persia, l’Afghanistan, la Cina, dove
si moltiplicano i focolari di rivolta, e con una lieve pressione fanno sparire
Clemenceau dalla scena politica. La caduta del pupazzo antibolscevico rivela
immediatamente le incrinature dal blocco reazionario francese, e inizia il
disgregamento dello Stato politico; la tendenza comunista e intransigente si
rafforza nel movimento operaio. La questione russa pone di fronte
l’opportunismo di Lloyd George e l’intransigenza controrivoluzionaria di
Winston Churchill, ma il terreno della democrazia britannica, il magnifico campo
di manovra per la demagogia radicale lloydgeorgiana, è completamente mutato: la
struttura della classe operaia inglese continua a svilupparsi, lentamente, ma
sicuramente, verso forme superiori: gli operai vogliono intervenire più spesso
e più direttamente nelle deliberazioni dei programmi di azione: i congressi
delle Trade Unions si moltiplicano e i rivoluzionari sempre più spesso e più
efficacemente vi fanno sentire la loro voce; l’ufficio permanente dei
congressi sindacali si trasferisca dalle mani del gruppo parlamentare laburista
nelle mani di un comitato centrale operaio. In Germania il governo di
Scheidemann si decompone, sente venirsi meno ogni consenso popolare, il terrore
bianco imperversa brutalmente: gli operai comunisti e indipendenti hanno
riacquistato una certa libertà di movimento e si diffonde la persuasione, che
solo la dittatura proletaria può salvare la nazione tedesca dallo sfacelo
economico e dalla reazione militarista. Il sistema internazionale
controrivoluzionario si dissolve per l’acuirsi delle contraddizioni intime
della democrazia borghese e dell’economia capitalista e per le gigantesche
spinte del proletariato russo. Lo Stato borghese italiano va in pezzi per gli
scioperi colossali nei servizi pubblici, per il fallimento fraudolento, e
ridicolo della politica estera e interna. Le condizioni sufficienti e necessarie
per la rivoluzione proletaria si attuano e nel campo internazionale e nel campo
nazionale. Ed ecco: il partito socialista viene meno a se stesso e alla sua
missione; partito di agitatori, di negatori, di intransigenti nelle questioni di
tattica generale, di apostoli delle teorie elementari, non riesce a organizzare
e a inquadrare le grandi masse in movimento, non riesce a riempire i minuti e le
giornate, non riesce a trovare un campo di azione che in ogni momento lo tenga a
contatto con le grandi masse. Non riesce a organizzare la propria intima
compagine, non ha una disciplina teorica e pratica che gli consenta di rimanere
sempre aderente alla realtà proletaria nazionale e internazionale per
dominarla, per controllare gli avvenimenti e non esserne travolto e stritolato.
Partito degli operai e dei contadini rivoluzionari, lascia che l’esercito
permanente della rivoluzione, i sindacati operai, rimanga sotto il controllo di
opportunisti che ne incantano, a loro piacere, il congegno di manovra, che
sistematicamente sabotano ogni azione rivoluzionaria, che sono un partito nel
partito, e il partito più forte, perché padroni dei gangli motori del corpo
operaio. Due scioperi, che potevano essere micidiali per lo stato, si sono
svolti e lasceranno lunghi strascichi di recriminazioni e di aggressioni
polemiche da parte degli anarchici, senza che il partito avesse una parola da
dire, un metodo da affermare che non sia quello vieto e logoro della più vieta
e logora II Internazionale: il “distinguo” tra sciopero economico e sciopero
politico. E così mentre lo Stato subiva una crisi acutissima, mentre la
borghesia armata e piena di odio avrebbe potuto iniziare un’offensiva contro
la classe operaia, mentre si profilava il colpo di mano militarista, i centri
rivoluzionari operai furono lasciati in balia di se stessi, senza parola
d’ordine generale; la classe operaia, si trovò rinchiusa e imprigionata in un
sistema di compartimenti stagni, smarrita, disillusa, esposta a tutte le
tentazioni anarcoidi.
Siamo noi scoraggiati e demoralizzati? No, ma è necessario dire la verità nuda
e cruda, è necessario rivelare una situazione che può, che deve essere mutata.
Il partito socialista deve rinnovarsi, se non vuole essere travolto e stritolato
dagli avvenimenti incalzanti; deve rinnovarsi perché la sua disfatta
significherebbe la disfatta della rivoluzione. Il partito socialista deve essere
sul serio una sezione della III Internazionale, e deve incominciare con attuarne
le tesi nel suo seno, nel seno della compagine degli operai organizzati. Le
masse organizzate devono diventare padrone dei loro organismi di lotta, devono
“organizzarsi in classe dirigente” prima di tutto nei loro propri istituti,
debbono fondersi col partito socialista. Gli operai comunisti, i rivoluzionari
consapevoli delle tremende responsabilità del periodo attuale, devono essi
rinnovare il partito, dargli una figura precisa e una direzione precisa; devono
impedire che gli opportunisti piccolo borghesi lo riducano al livello dei tanti
partiti del paese di Pulcinella.
Antonio Gramsci – 24-31 gennaio 1920
88 - Lo Stato italiano (Antonio Gramsci)
In un articolo pubblicato
recentemente sul “Resto del Carlino”, Enrico Ferri, che è professore di
diritto penale all’università ed è stato per tante legislature deputato al
Parlamento, “manifesta l’opinione che non si capisce perché, la direzione
generale delle carceri sia sotto il ministero dell’Interno e non debba andare
invece sotto il ministero di Grazia e Giustizia”. A quanto pare, il prof.
Ferri “manifesta l’opinione” che il perché sia solamente strano e casuale
e creda, pertanto, sia possibile cassarlo con un decreto ministeriale. Poiché
il prof. Enrico Ferri per tanti anni è stato il “leader” del movimento
operaio italiano, non fa meraviglia che gli operai e i contadini italiani
debbano fare tanti sforzi per giungere a concepire lo stato come sviluppo
storico, a concepirlo come organizzazione massima della classe proprietaria,
concepirlo come strumento nelle mani della classe-operaia, rivolto a soffocare
la borghesia tanto nel campo politico quanto nel campo economico, per coordinare
e sistemare le condizioni di avvento del comunismo e garantire incontrastata
libertà di sviluppo alla società comunista. Se poi si pensa che l’on.
Filippo Turati, altro “leader” (anti-Ferri per ragioni di dottrina e di
comprensione marxista!), dopo cinque anni di guerra e dopo il massacro di 15
milioni di uomini, ottiene un grande successo parlamentare intrattenendo
l’assemblea dei rappresentanti del popolo italiano con un elegante discorso
sul diritto di voto delle prostitute (il profondo spirito marxista dell’on.
Filippo Turati ha trovato modo, non pertanto, di manifestarsi nella
identificazione e definizione della categoria sociale: “salariate
dell’amore”), la meraviglia sminuisce ancora e si comprendono perfettamente
le tendenze anarcoidi del proletariato italiano; si comprende che per la classe
operaia italiana, Carlo Marx non sia stato altro che “un santo al
capezzale”, un nome senza soggetto che non sia una medaglia, una cartolina
illustrata, un liquore.
Cos'è lo Stato italiano? E perché è quello che è? Quali forze economiche e
quali forze politiche sono alla sua base? Ha subito un processo di sviluppo? Il
sistema di forze che ha determinato il suo nascere è rimasto sempre lo stesso?
Per l’azione di quali fermenti interni si è svolto il processo? Quale
posizione occupa l’Italia nel mondo capitalistico e come hanno influito le
forze esterne al processo interno? Quali forze nuove ha rivelato e fatto
sviluppare la guerra imperialista? Che direzione probabile prenderanno le
attuali linee di forza della società italiana?
Il nullismo opportunista e riformista, che ha dominato il partito socialista
italiano per decine e decine di anni, e oggi irride con lo scetticismo beffardo
della senilità agli sforzi della nuova generazione ed al tumulto di passioni
suscitate dalla rivoluzione bolscevica, dovrebbe fare un piccolo esame di
coscienza sulle sue responsabilità e la sua incapacità a studiare, a
comprendere e a svolgere azione educativa. Noi giovani dobbiamo rinnegare questi
uomini del passato, dobbiamo disprezzare questi uomini del passato. Quale legame
esiste tra noi e loro? Cosa hanno creato, cosa ci hanno consegnato da
tramandare? Quale ricordo di amore e di gratitudine, per averci aperto e
illuminato la via della ricerca e dello studio per aver creato le condizioni di
un nostro progresso, di un nostro balzo in avanti? Tutto abbiamo dovuto fare da
noi, con le nostre forze, con la nostra pazienza: la generazione socialista
italiana attuale è figlia di se stessa; non ha il diritto di irridire ai suoi
errori e ai suoi sforzi chi non ha lavorato, chi non ha prodotto, chi non le può
lasciare nessun’altra eredità che non sia una mediocre raccolta di mediocri
articolucci da giornale quotidiano.
Lo Stato italiano che, parlamentare, starebbe alla repubblica dei Soviet, come
la città all’orda barbarica, non ha mai tentato neppure di mascherare la
dittatura spietata della classe proprietaria. Si può dire che lo Statuto
albertino sia servito a un solo fine preciso: a legare fortemente le sorti della
Corona alle sorti della proprietà privata. I soli freni infatti che funzionano
nella macchina statale per limitare gli arbitri del governo dei ministri del re
sono quelli che interessano la proprietà privata del capitale. La Costituzione
non ha creato nessun istituto che presidii almeno formalmente le grandi libertà
dei cittadini: la libertà individuale, la libertà di parola e di stampa, la
libertà di associazione e di riunione. Negli Stati capitalistici, che si
chiamano liberali democratici, l’istituto massimo di presidio delle libertà
popolari è il potere giudiziario: nello Stato italiano la giustizia non è un
potere, è un ordine, è uno strumento del potere esecutivo, è uno strumento
della Corona e della classe proprietaria.
Si capisce quindi perfettamente che la direzione generale delle carceri, come le
direzioni particolari, come gli agenti della pubblica sicurezza, come tutto
l’apparato repressivo dello Stato dipendano dal ministero degli interni e si
capisce anche, perfettamente come in Italia il presidente del Consiglio si
riservi sempre gli Interni, voglia cioè che tutto l’apparato di forza armata
del paese sia completamente nelle sue mani: il presidente del Consiglio è
l’uomo di fiducia della classe dei proprietari; alla sua scelta collaborano le
grandi banche, i grandi industriali, i grandi proprietari terrieri, lo stato
maggiore; egli si prepara la maggioranza parlamentare con la frode, con la
corruzione; il suo potere è illimitato, non solo di fatto, come è
indubbiamente in tutti i paesi capitalistici, ma anche di diritto; il presidente
del consiglio è l’unico potere dello Stato italiano.
La classe dominante italiana non ha neppure avuto la ipocrisia di mascherare la
sua dittatura; il popolo lavoratore è stato da essa considerato come un popolo
di razza inferiore, che si può governare senza complimenti come una colonia
africana.
Il paese è sottoposto a un permanente regime di stato d’assedio. In ogni ora
del giorno e della notte, un ordine del ministro dell’interno di prefetti può
fare entrare in movimento l’amministrazione poliziesca. Gli agenti vengono
sguinzagliati nelle case e nei locali di riunione; senza mandato dei giudici,
che sono passivi, in pura via amministrativa, la libertà individuale e di
domicilio è violata. I cittadini sono ammanettati, confusi coi delinquenti
comuni in carceri luride e nauseabonde, la loro integrità fisiologica è
indifesa contro la brutalità e i contatti, i loro affari sono interrotti o
rovinati, per il semplice ordine di un commissario di polizia, un locale di
riunione viene invaso e perquisito, una riunione viene sciolta. Per il semplice
ordine di un prefetto, un censore cancella uno scritto, il cui contenuto non
rientra affatto nelle proibizioni contemplate dai decreti generali. Per il
semplice ordine di un prefetto i dirigenti un sindacato vengono arrestati, cioè
si tenta di sciogliere un’associazione.
La Russia era portata ad esempio di Stato dispotico sotto lo zar; effettivamente
non c’era differenza alcuna tra lo Stato zarista e lo Stato italiano, tra la
Duma e il parlamento. C’era una differenza di cultura politica e di sensibilità
umana tra il popolo russo e il popolo italiano: i russi liberali e socialisti
denunciavano al mondo gli abusi del potere; gli italiani, meno sensibili, si
lamentavano solo per gli episodi più mostruosi, meno colti politicamente non
riuscivano a identificare, negli episodi singoli una continuità dipendente
dalla costituzione dello stato. Non esistendo in Italia la giustizia come potere
indipendente, non essendo in Italia la giustizia come potere indipendente, non
essendo in Italia l’apparato repressivo agli ordini della giustizia, il potere
parlamentare non esiste, la legislazione è una truffa, nella realtà e nel
diritto esiste un solo potere, quello esecutivo, esiste la Corona, esiste la
classe proprietaria che vuole essere difesa a tutti i costi.
Lo Stato dello zar era lo Stato dei proprietari terrieri: ciò spiega la
rozzezza dei ministri dello zar: i contadini dicono pane al pane e sopprimono a
colpi di randello i loro nemici. La rivoluzione del marzo 1917 è stato il
tentativo di introdurre nello Stato un equilibrio tra industriali e contadini.
Lo Stato liberale nasce dall’equilibrio di queste due forze della proprietà
privata. La divisione dei poteri, cioè il sorgere accanto al parlamento di un
potere giudiziario che garantisca l’uguaglianza politica dei partiti borghesi
di governo, che impedisca ai singoli partiti al potere di servirsi
dell’apparecchio statale per perpetuare le condizioni della loro permanenza al
potere, è la caratteristica dello Stato liberale. Il popolo lavoratore russo,
entrato in movimento nel marzo 1917, ha impedito che la rivoluzione si
cristallizzasse alla fase liberale borghese: gli operai dell’industria hanno
continuato l’opera iniziata dai proprietari dell’industria, e hanno
soffocato tutti i proprietari, e hanno emancipato tutte le Classi oppresse.
Lo Stato unitario italiano si è costituito per impulso dei nuclei borghesi
industriali della Alta Italia; si è consolidato con lo svilupparsi
dell’industria a danno dell’agricoltura, con un soggiogamento brutale
dell’agricoltura agli interessi dell’industria; lo stato italiano non fu
liberale, perché non nacque da un sistema di equilibrio; ma i ministri del re
d’Italia, educati alla fraseologia liberale inglese, al randello del contadino
russo preferiscono il sacchetto di sabbia dell’”apache” londinese per
sopprimere i nemici dell’industriale.
Già prima della guerra i rapporti interni della classe proprietaria italiana si
erano modificati: Salandra, che dichiarò la guerra, era il primo presidente del
Consiglio meridionale dello Stato italiano: Nitti è il secondo. Il potere
esecutivo si stacca dal vecchio sistema di forze capitalistiche: la sostanza
economica dello Stato italiano è diventata fluida, è entrata in movimento. La
campagna si impadronisce dello Stato: essa ha un grande partito, il Partito
popolare. Lo Stato liberale, la repubblica borghese dovrebbe essere lo sbocco
normale delle forze capitalistiche in movimento, se non esistesse in Italia una
classe operaia rivoluzionaria, anche essa in movimento, decisa ad attuare la sua
missione storica, a sopprimere la classe proprietaria, a instaurare la
democrazia operaia.
Tra la repubblica dei Soviet e la repubblica borghese, tra la democrazia operaia
e la democrazia liberale, i riformisti e gli opportunisti scelgono la repubblica
borghese e la democrazia liberale. La gioventù intellettuale socialista
italiana, che non ha legami alcuni con questi uomini del passato, con questi
intellettuali piccolo-borghesi, che è libera da pregiudizi e tradizioni, che ha
acquistato maturità nella passione della guerra e carattere rivoluzionario
nello studio della rivoluzione bolscevica, è chiamata a creare quella
produzione che è specifica della sua attività storica; idee, miti, audacia di
pensiero e di azione rivoluzionaria per la fondazione della Repubblica
soviettista italiana.
Antonio Gramsci - (7 febbraio 1920)
89
- Partito e frazione (Palmiro
Togliatti)
Nella prima discussione che si
svolse tra la Centrale del partito russo e il compagno Trotzki, la questione
delle “frazioni” venne trattata esplicitamente. Uno dei capitoli del
“nuovo corso” è dedicato ad essa. Nella seconda discussione, chiusa di
recente con le decisioni note, la questione delle frazioni non è stata trattata
in modo esplicito, ma è sottintesa, si può dire a tutto il dibattito. Lo
scritto sugli “Insegnamenti dell’ottobre” può infatti, con un piccolo
sforzo di logica, essere tratto alla dimostrazione non solo della ineluttabilità,
ma della necessità che in seno al partito della classe operaia si svolga una
lotta di frazioni. La tesi sostenuta dal “Nuovo corso” è quella della
inevitabilità pratica delle frazioni, dimostrata con esempi storici presi dalla
vita del partito russo e integrata con l’affermazione che l’esistenza di
frazioni è un “minor male” in confronto con la burocratizzazione e con la
perdita del contatto tra partito e classe operaia. Gli “Insegnamenti
dell’Ottobre” generalizzano la tesi e le danno una base teorica, ponendo la
formazione di tendenze e il contrasto di frazioni, in rapporto con lo sviluppo
politico del partito e con le situazioni oggettive cui esso deve adattare la
propria tattica. Ogni svolta tattica, ed a più forte ragione ogni svolta
strategica, cioè ogni mutamento di situazioni oggettive il quale imponga un
cambiamento di direttive strategiche o tattiche, provoca delle “frizioni”
tra le necessità nuove e le vecchie consuetudini, provoca quindi una formazione
di tendenza e di gruppi e una lotta di frazione.
Solo in conseguenza di questa formazione e di questa lotta, il nuovo riesce,
fortunatamente, a spezzare l’involucro entro il quale lo si vorrebbe
costringere, e a trionfare.
Il problema è tra i più delicati della nostra dottrina. Esso riguarda in modo
diretto l’origine, lo sviluppo e la funzione del partito comunista ed i suoi
rapporti con le forze che spontaneamente si creano e muovono in seno alla classe
lavoratrice. E vi è una parte della dottrina svolta o adombrata da Trotzski che
deve essere accettata perché pienamente rispondente alla realtà. È la parte
che riguarda appunto i rapporti che corrono tra il partito, la classe operaia e
le situazioni oggettive in cui l’uno e l’altra si muovono.
Il partito è una parte della classe operaia. Esso è quindi soggetto a una
serie di influenze esercitate da forze e correnti che in seno alla classe
operaia, si determinano. Il partito inoltre ha una tattica la quale deve
adeguarsi di continuo alle situazioni reali e al loro svolgimento. Negare
l’esistenza e la necessità dell’influenza sopra il partito di questo doppio
ordine di fattori è negare l’esistenza del partito stesso come organismo
vivente. All’infuori di questa influenza i nostri problemi perdono il loro
valore, le nostre soluzioni e le nostre parole d’ordine perdono il loro
significato per diventare formule aride e vuote. Nell’esame dei nostri
problemi, anzi, la dialettica marxista consiste nel ritrovare di continuo le
connessioni tra di essi. Le situazioni oggettive e i raggruppamenti di forze che
si producono in seno alla massa lavoratrice. L’errore fondamentale delle
“tesi di Roma”, ad esempio, è di non riconoscere le influenze e le
connessioni di cui parliamo, o di ritenere possibile che essi siano regolate e
“neutralizzate” mediante la codificazione di certi confini che la strategia
e la tattica del partito non dovrebbero mai superare. La concezione del partito
che ne risulta, ha potuto essere tacciata di antimarxismo, e non a torto. La
dialettica ha infatti qui ceduto il posto a una visione del tutto formalistica e
giuridica della realtà. Da Hegel a Marx si è tornati indietro, a Kant e al
kantismo.
Il confine che le “tesi di Roma” si affannano a stabilire è destinato di
volta in volta ad apparire vano di fronte alla mutevole realtà della storia. Di
volta in volta, il problema dei “limiti” della nostra tattica assume nuove
forme e richiede soluzioni originali, e colui il quale aveva creduto di
risolvere ogni cosa con lo scrivere un codice di norme assolute, valide per ogni
tempo e per ogni luogo, ed efficaci a preservare di qualsiasi deviazione, è
condannato, se non vuol modificare la sua posizione, a cadere nel pessimismo.
Ma affermata la esistenza di forze “esterne” le quali influiscono sopra il
partito, affermata anzi la necessità che questa influenza si faccia sentire, e
che il partito abbia la forza di subirla e di dominarla nello stesso tempo, cioè
che esso, tenendo continuamente il contatto con le masse lavoratrici e adattando
la propria tattica alle situazioni oggettive, eserciti la sua funzione di guida
rivoluzionaria, ed escluso che la soluzione del problema sia da trovare nella
direzione indicata dalle “tesi di Roma”, occorre esaminare se essa non si
trovi invece nell’ammettere la lotta delle frazioni, affidandole il compito di
richiamare al momento opportuno il partito all’adempimento del suo dovere
rivoluzionario.
Vi è in proposito un precedente storico di enorme importanza: - quello datoci
dal modo come i partiti e la internazionale comunista si sono formati uscendo
dal seno della Seconda Internazionale. Il precedente non ha però nessun valore,
perché è relativo allo stesso modo come la Internazionale socialista era
costituita e funzionava. In seno alla Seconda Internazionale ed ai partiti che
vi aderivano, la lotta di frazione era l'unica forma possibile di controllo
dell’indirizzo politico e di elaborazione di nuove direttive, l’unica forma,
cioè nella quale nuove forze sorte dal seno della classe operaia potevano
cercare di inserirci nell’organismo esistente per trasformarlo, e l’unica
forma nella quale esso poteva venir richiamato ai compiti impostogli da una
nuova situazione politica. Nei partiti della Seconda Internazionale la lotta di
frazione era quindi una regola. La questione dell’indirizzo del partito era
sempre aperta come lotta di una minoranza di opposizione per la conquista della
maggioranza e del potere. Ogni congresso si riduceva al dibattito di un punto
solo, e questo punto era l’approvazione dell’operato e il voto di fiducia
per la Centrale eletta dal precedente congresso. Finito il congresso con questo
voto, la minoranza ritenevasi automaticamente costituita in frazione, anche se
la discussione non continuava in modo aperto. Essa veniva esclusa di regola
dalla partecipazione agli organi centrali e non si riteneva responsabile degli
atti del partito. Ogni errore della maggioranza dirigente diventava, in questa
situazione, un successo della minoranza oppositrice, e mediante
l’accumulazione di questi “successi” si veniva creando o si cercava di
creare la nuova situazione, che doveva avere uno sbocco nella nuova lotta di
congresso con il suo nuovo voto.
Questo metodo di vita del partito e della Internazionale veniva e viene tuttora
giudicato da alcuni come un metodo “dialettico”. In realtà esso non ha
niente di dialettico, se non è il susseguirsi di posizioni estreme
contraddittorie. Ciò che costituisce l’essenza della dialettica non è però
il fatto che le posizioni contraddittorie si seguono e si sostituiscono l’una
all’altra, ma il fatto che esse “si risolvono” l’una nell’altra, cioè
sono legate assieme in una “unità” che è loro premessa e loro risultato.
Dove è lotta di frazione quello che manca è appunto, invece, l’unità e il
processo di sviluppo unitario. Al posto della dialettica che è la base della
dottrina rivoluzionaria marxista noi troviamo qui, ancora una volta, la logica
formale, la logica kantiana, secondo la quale sono edificati la dottrina e gli
istituti della democrazia. Le radici del sistema di vita dei partiti della
Internazionale basato sul frazionismo sono infatti da ricercare nel sistema
parlamentare inglese, basato sul regime del Gabinetto, del “voto di fiducia”
e della rotazione dei partiti al governo. Siamo in piena democrazia formale:
cosa assai comprensibile, del resto,
trattandosi della Seconda Internazionale socialista, di cui tutti sanno quale fu
la fondamentale deviazione dal marxismo rivoluzionario.
Ciò che aveva un valore per questa internazionale, non lo ha dunque più per
noi e lo stesso compagno Trotzki, negli esempi di costituzione di frazioni
tratti dalla storia del partito comunista russo prima e dopo l’ottobre, non ne
cita uno nel quale la soluzione del problema pendente si sia avuta
“attraverso” la lotta frazionistica. Questa appare quindi piuttosto come
residuo di un costume non del tutto superato, anziché come necessità, per lo
sviluppo continuo e per l’esatto orientamento del partito. Il contatto con le
masse e l’adattamento della tattica alle situazioni reali, in tutti i casi
indicati da Trotzki, vengono trovati non per la via “parlamentare” del
frazionismo, ma attraverso altre vie, cioè attraverso il funzionamento regolare
degli organi dirigenti e degli organi di base del partito comunista il quale è
riuscito a ordinare se stesso in modo da non essere più “il parlamento”, ma
la organizzazione politica della classe operaia.
Siamo così giunti al centro del problema. La lotta di frazione è incompatibile
con un partito che sia “partito rivoluzionario della classe operaia” e tende
a impedire che esso lo diventi perché sposta i problemi della sua vita e del
suo sviluppo dal terreno sul quale essi sono risolubili, ad un terreno sul quale
non potranno mai ricevere una soluzione che non sia esteriore e formale.
Il problema della utilizzazione per il partito ed entro il partito, delle forze
che spontaneamente sorgono tra le masse è risolubile solo mediante il contatto
organico e profondo con le masse del proletariato d’officina. Il problema
dell’esattezza dell’indirizzo politico è risolubile soltanto sul terreno
della continuità di un processo storico rivoluzionario, della inserzione in
esso e della diretta collaborazione ad esso di tutti i fattori di una
determinata situazione di partito.
Al di fuori di queste soluzioni il frazionismo può dare l’apparenza della
fedele custodia del principio rivoluzionario e del contatto ininterrotto con le
sorgenti dell’energia e della spontaneità proletaria, ma questa
“apparenza” viene pagata con la distruzione della realtà e della possibilità
di ogni lavoro rivoluzionario e con la sostituzione ad esso di uno scenario da
vacua e stolta commedia parlamentare.
Palmiro Togliatti - (1 marzo 1924)
90 - Contro il pessimismo (Antonio Gramsci)
Nessun modo migliore può
esistere di commemorare il quinto anniversario della Internazionale comunista,
della grande associazione mondiale di cui ci sentiamo, noi rivoluzionari
italiani, più che mai parte attiva e integrante, che quello di fare un esame di
coscienza e un esame del pochissimo che abbiamo fatto e dell’immenso lavoro
che ancora dobbiamo svolgere, contribuendo specialmente a dissipare questa
oscura e grave nuvolaglia di pessimismo che opprime i militanti più qualificati
e responsabili, e rappresenta un grande pericolo, il più grande forse del
momento attuale, per le sue conseguenze di passività politica, di torpore
intellettuale, di scetticismo verso l’avvenire.
Questo pessimismo è strettamente legato alla situazione generale del nostro
paese; la situazione lo spiega; ma non lo giustifica, naturalmente, che
differenza esisterebbe tra noi e il partito socialista, se anche noi sapessimo
lavorare e fossimo attivamente ottimisti solo nei periodi di vacche grasse,
quando la situazione è propizia, quando le masse lavoratrici si muovono
spontaneamente, per impulso irresistibile e i partiti proletari possono
accomodarsi nella brillante posizione della mosca cocchiera? Che differenza
esisterebbe tra noi e il partito socialista se anche noi, partendo sia pure da
altre considerazioni, da altri punti di vista avendo sia pure un maggior senso
di responsabilità e dimostrando di averlo con la preoccupazione fattiva di
apprestare forze organizzative e materiali idonee per parare ogni evenienza, ci
abbandonassimo al fatalismo, ci cullassimo nella dolce illusione che gli
avvenimenti non possono che svolgersi secondo una determinata linea di sviluppo,
quella da noi prevista, nella quale troveranno infallibilmente il sistema di
dighe e canali da noi predisposto, incanalandosi e prendendo forma e potenza
storica in esso? È questo il nodo del problema, che si presenta astrusamente
aggrovigliato, perché la passività sembra esteriormente alacre lavoro, perché
pare che ci sia una linea di sviluppo, un filone in cui operai sudano e si
affaticano a scavare meritoriamente.
L’Internazionale comunista è stata fondata il 5 marzo 1919, ma la sua
formazione ideologica e organica si è verificata solo al Secondo Congresso, nel
luglio-agosto 1920, con l’approvazione dello Statuto e delle 21 condizioni.
Dal Secondo Congresso comincia in Italia la campagna per il risanamento del
partito già iniziata nel marzo precedente dalla sezione di Torino con la
mozione di presentare all’imminente Conferenza nazionale del partito che
appunto a Torino doveva tener si, ma non aveva trovato ripercussioni notevoli
(alla conferenza di Firenze della frazione astensionista, tenuta nel luglio
1920, prima del Secondo Congresso, fu respinta la proposta fatta da un
rappresentante dell’”Ordine Nuovo” di allargare la base della frazione,
facendola diventare comunista, senza la pregiudiziale astensionista che
praticamente aveva perduto gran parte della sua ragione d’essere). Il
Congresso di Livorno, la scissione avvenuta al Congresso di Livorno furono
riallacciati al Secondo Congresso, alle sue 21 condizioni, furono presentati
come una conclusione necessaria delle deliberazioni formali del Secondo
Congresso. Fu questo un errore e oggi possiamo valutare tutta l’estensione per
le conseguenze che esso ha avuto. In verità, le deliberazioni del Secondo
Congresso erano l’interpretazione viva della situazione italiana, come di
tutta la situazione mondiale, ma noi, per una serie di ragioni, non muovemmo per
la nostra azione, da ciò che succedeva in Italia, dai fatti italiani che davano
ragione al secondo Congresso, che erano una parte e delle più importanti della
sostanza politica che animava le decisioni e le misure organizzative prese dal
Secondo congresso, noi, però, ci limitammo a battere sulle questioni formali,
di pura logica, di pura coerenza, e fummo sconfitti perché la maggioranza del
proletariato organizzato politicamente ci diede torto, non venne con noi,
quantunque noi avessimo dalla nostra parte l’autorità e il prestigio
dell’Internazionale che erano grandissimi e sui quali ci eravamo fidati. Non
avevamo saputo condurre una campagna sistematica, tale da essere in grado di
raggiungere e di costringere alla riflessione tutti i nuclei e gli elementi
costitutivi del partito socialista, non avevamo saputo tradurre in linguaggio
comprensibile a ogni operaio e contadino italiano il significato di ognuno degli
avvenimenti italiani degli anni 1919-20: non abbiamo saputo, dopo Livorno, porre
il problema del perché il Congresso avesse avuto quella conclusione, non
abbiamo saputo porre il problema praticamente, in modo da trovarne la soluzione,
in modo da continuare la nostra specifica missione che era quella di conquistare
la maggioranza del proletariato. Fummo - bisogna dirlo - travolti dagli
avvenimenti, fummo senza volerlo, un aspetto della dissoluzione generale della
società italiana, diventata un crogiuolo incandescente dove tutte le
tradizioni, tutte le formazioni storiche, tutte le idee prevalenti si fondevano
qualche volta senza residuo: avevamo una consolazione alla quale ci siamo
tenacemente attaccati, che nessuno si salvava, che noi potevamo affermare di
aver previsto matematicamente il cataclisma, quando gli altri si cullavano nella
più beata e idiota delle illusioni. Siamo entrati, dopo la scissione di Livorno,
in uno stato di necessità. Solo questa giustificazione possiamo dare ai nostri
atteggiamenti, alla nostra attività dopo Livorno: la necessità, che si poneva
crudamente, nella forma più esasperata, del dilemma di vita o morte. Dovemmo
organizzarci in partito nel fuoco della guerra civile, cementando le nostre
sezioni col sangue dei più devoti militanti; dovemmo trasformare, nell’atto
stesso della loro costituzione, del loro arruolamento, i nostri gruppi in
distaccamento per la guerriglia, nella più atroce e difficile guerriglia che
mai classe operaia abbia dovuto combattere. Si riuscì tuttavia: il partito fu
costituito e fortemente costituito: esso è una falange d’acciaio, troppo
piccola certamente per entrare in una lotta contro le forze avversarie, ma
sufficiente per diventare l’armatura di una più vasta formazione, di un
esercito che, per servirsi del linguaggio storico italiano, possa far succedere
la battaglia del Piave alla rotta di Caporetto.
Ecco il problema attuale che si pone, inesorabilmente: costituire un grande
esercito per le prossime battaglie, costituirlo inquadrandolo nelle forze che da
Livorno a oggi hanno dimostrato di saper resistere senza esitazioni e senza
indietreggiamenti, all’attacco violentemente sferrato dal fascismo. Lo
sviluppo dell’Internazionale comunista, dopo il secondo Congresso ci offre il
terreno adatto a ciò, interpreta, ancora una volta - con le deliberazioni del
Terzo e del Quarto congresso, deliberazioni integrate da quelle degli Esecutivi
allargati del febbraio e giugno 1922 e del giugno 1923, - la situazione, e i
bisogni della situazione italiana. La verità è che noi, come partito, abbiamo
già fatto alcuni passi in avanti in questa direzione: non ci rimane che
prendere atto di essi e arditamente continuare. Che significato hanno infatti
gli avvenimenti svoltisi in seno al partito socialista, con la scissione dai
riformisti in un primo tempo, con l’esclusione del gruppo di redattori di
“Pagine rosse” in un secondo tempo e col tentativo di escludere tutta la
frazione terzinternazionalista in un terzo e ultimo tempo? Hanno questo preciso
significato: che mentre il nostro partito era costretto, come sezione italiana,
a limitare la sua attività alla lotta fisica di difesa contro il fascismo e
alla conservazione della sua struttura primordiale, essa, come partito
internazionale, operava, continuava ad operare per aprire nuove vie verso il
futuro, per allargare la sua cerchia di influenza politica, per far uscire dalla
neutralità una parte della massa che prima stava a guardare indifferente o
titubante. L'azione dell’Internazionale fu, per qualche tempo, la sola che
abbia permesso al nostro partito di avere un contatto efficace con le larghe
masse, che abbia conservato un fermento di discussione e un principio di
movimento in strati cospicui della classe operaia che a noi era impossibile
nella situazione data, altrimenti raggiungere. È stato indubbiamente un grande
successo l’aver strappato dalla ganga del partito socialista dei blocchi, aver
ottenuto, quando la situazione pareva peggiore, che dall’amorfa gelatina
socialista si costituissero i nuclei i quali affermavano di aver fede,
nonostante tutto, nella rivoluzione mondiale i quali, coi fatti se non con le
parole che pare brucino più dei fatti, riconoscevano di aver errato nel
1920-21-22. È stata questa una sconfitta del fascismo e della reazione: è
stata, se vogliamo esser sinceri, l’unica sconfitta fisica e ideologica del
fascismo e della reazione in questi tre anni di storia italiana.
Occorre reagire energicamente contro il pessimismo di alcuni gruppi del nostro
partito, anche dei più responsabili e qualificati. Esso rappresenta, in questo
momento, il più grave pericolo, nella situazione nuova che si sta formando nel
nostro paese e che troverà la sua sanzione e la sua chiarificazione nella prima
legislazione fascista. Si approssimano grandi lotte, forse le più sanguinose e
pesanti di quelle degli anni scorsi: è necessaria perciò la massima energia
nei nostri dirigenti, la massima organizzazione e centralizzazione della massa
di partito, un grande spirito di iniziativa e una grandissima prontezza nella
decisione. Il pessimismo prende prevalentemente questo tono: ritorniamo a una
situazione pre-Livorno, dovremo rifare lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima
... e che credevamo definito. Bisogna dimostrare a ogni compagno come sia errata
politicamente e teoricamente questa posizione. Certo, bisognerà ancora lottare
fortemente: certo il compito del nucleo fondamentale del nostro partito
costituitosi a Livorno non è ancora finito e non lo sarà per un pezzo ancora
(esso sarà ancora vivo e attuale anche dopo la rivoluzione vittoriosa). Ma non
ci troveremo più in una situazione pre-Livorno, perché la situazione mondiale
e italiana non è, nel 1924, quella del 1920, perché noi stessi non siamo più
quelli del 1920 e non lo vorremmo mai più ridiventare. Perché la classe
operaia italiana è molto mutata e non sarà più la cosa più semplice di
questo mondo farle rioccupare le fabbriche con, per cannoni, dei tubi da stufa,
dopo averle intronato le orecchie e smosso il sangue con la turpe demagogia
delle fiere massimaliste. Perché esiste il nostro partito, che è pur qualcosa,
che ha dimostrato di essere qualcosa, e nel quale noi abbiamo una fiducia
illimitata, come nella parte migliore, più sana, più onesta del proletariato
italiano.
Antonio Gramsci - (15 marzo 1924)
91
- Sulla contraddizione (Mao
Tse Dun)
La legge della contraddizione
insita nelle cose, nei fenomeni, ossia la legge dell'unità degli opposti, è la
legge fondamentale della dialettica materialistica. Lenin afferma: “Nel senso
proprio della parola la dialettica è lo studio delle contraddizioni
nell’essenza stessa degli oggetti...” Questa legge è detta ripetutamente da
Lenin l’essenza della dialettica. Perciò studiando questa legge, non possiamo
non toccare una vasta cerchia di problemi, non possiamo non toccare molte
questioni filosofiche. Se comprenderemo queste questioni, ci saranno chiare le
basi stesse della dialettica materialistica. E si tratta delle questioni
seguenti: le due concezioni del mondo, il carattere universale della
contraddizione, l’identità e la lotta degli opposti, il posto
dell’antagonismo nella contraddizione. (...)
La causa fondamentale dello sviluppo delle cose non si trova fuori di esse,
nella natura contradditoria intimamente pertinente alle cose stesse. Ad ogni
cosa e fenomeno sono intimamente inerenti le contraddizioni. Queste appunto
generano il movimento e lo sviluppo delle cose. Le contraddizioni inerenti alle
cose e ai fenomeni sono la causa fondamentale del loro sviluppo, mentre il nesso
e l’azione reciproca delle cose e dei fenomeni tra loro, rappresentano una
causa secondaria. Così, la dialettica materialistica ha respinto decisamente la
dottrina meta-fisica della causa esterna o dell’impulso, avanzata dai
sostenitori del materialismo meccanicistico volgare. È assolutamente chiaro che
le cause meramente esterne sono capaci soltanto di generare il movimento
meccanico delle cose, cioè di modificare il volume e la quantità, ma non
possono spiegare perché le cose e i fenomeni sono qualitativamente diversi in
infiniti modi e perché le cose si trasformano l’una in un’altra. (...) Così
lo sviluppo della società, è determinato principalmente non da cause esterne,
ma interne.
Molti Stati che si trovano in condizioni climatiche e geografiche quasi uguali,
si differenziano radicalmente l’uno dall’altro per il grado del loro
sviluppo, si sviluppano in modo estremamente ineguale. Perfino grandi
trasformazioni sociali avvengono in un solo Stato sebbene non si abbiano, in
questo paese, cambiamenti geografici e climatici. (...)
Per comodità di esposizione mi soffermo dapprima sul carattere universale della
contraddizione e poi sul suo carattere particolare. In realtà dopo la scoperta
della concezione materialistica e dialettica del mondo da parte dei grandi
fondatori del marxismo, Marx ed Engels, e dei continuatori della loro opera,
Lenin e Stalin, la dialettica materialistica è stata applicata con grande
successo in numerosi campi d’indagine della storia dell’umanità e della
natura, in molti campi della trasformazione della società e della natura; il
carattere universale della contraddizione è oramai riconosciuto da molti e
perciò non occorrono troppe parole per illustrare tale questione; il problema
del carattere particolare della contraddizione, invece, non è stato ancora
compreso da numerosi compagni, e in ispecial modo dai dogmatici. Essi non
comprendono che nelle contraddizioni l’universale esiste nel particolare. Essi
non comprendono quale enorme importanza per la direzione della nostra pratica
rivoluzionaria abbia lo studio del carattere particolare delle contraddizioni
insita nella cose e nei fenomeni concreti del nostro tempo. Perciò il problema
del carattere particolare delle contraddizioni richiede uno studio serio, e
all’esame di esso deve essere dedicato sufficiente spazio. (...)
La questione del carattere universale o assoluto della contraddizione presenta
due aspetti: in primo luogo, le contraddizioni esistono nei processi di sviluppo
di tutte le cose e fenomeni; in secondo luogo, nel processo di sviluppo di ogni
cosa e fenomeno il movimento delle contraddizioni esiste dal principio alla
fine.
Engels afferma: “Lo stesso movimento è una contraddizione...” Lenin
definisce la legge dell’unità degli opposti come “il riconoscimento (la
scoperta) delle tendenze contraddittorie opposte, che si escludono
reciprocamente, in tutti i fenomeni e processi della natura (dello spirito e
della società inclusi)”.
Sono giuste queste affermazioni? Sì, sono giuste. L’interdipendenza e la
lotta degli opposti, proprie di ogni fenomeno, determinano la vita di tutte le
cose e di tutti i fenomeni, e ne promuovono lo sviluppo. Non esistono cose che
non contengano contraddizioni. Se non esistessero le contraddizioni, non vi
sarebbe sviluppo dell’universo.
La contraddizione è la base delle forme semplici del movimento (per esempio,
del movimento meccanico) e a maggior ragione la base delle forme complesse del
movimento. (…)
Nella guerra l’attacco e la difesa, l’avanzata e la ritirata, la vittoria e
la sconfitta sono fenomeni contradditori. Senza l’uno non esiste neppure
l’altro. La lotta e il nesso reciproco di questi due lati costituiscono il
tutto unico della guerra, progrediscono con lo sviluppo di essa, ne decidono
l’esito.
Ogni divergenza nelle concezioni umane deve essere considerata come un riflesso
delle contraddizioni oggettive. Le contraddizioni oggettive, riflettendosi nel
pensiero soggettivo, formano il movimento contraddittorio dei concetti,
promuovono lo sviluppo del pensiero, risolvono continuamente i problemi che si
pongono di fronte al pensiero umano.
Contrapposizione e lotta tra varie opinioni sorgono continuamente nel partito;
esse sono il riflesso nel partito delle contraddizioni di classe esistenti nella
società e della contraddizione tra il nuovo e il vecchio. Se nel partito non ci
fossero né contraddizioni né lotta ideologica, nel corso della quale le
contraddizioni vengono superate, la vita del partito stesso cesserebbe. (...)
Fin dal loro apparire borghesia e proletariato, lavoro e capitale sono stati in
contraddizione; ma questa contraddizione non era ancora acuta. Persino nelle
condizioni sociali dell’Unione Sovietica tra gli operai e i contadini esiste
una differenza. La differenza tra di loro è una contraddizione, la quale però
non può acuirsi e diventare antagonismo, non può assumere la forma di lotta di
classe, non è equivalente alla contraddizione tra lavoro e capitale; gli operai
e i contadini nel corso dell’edificazione del socialismo hanno stabilito fra
loro una solida alleanza, e la contraddizione sopra indicata viene
progressivamente superata nel processo del passaggio dal socialismo al
comunismo. Qui possiamo parlare soltanto di differenza nel carattere delle
contraddizioni, ma non della loro presenza o assenza. (…)
Che cosa significa nascita di un nuovo processo? Significa che la vecchia unità
e gli opposti che la costituivano lasciano il posto a una nuova unità e ai
nuovi opposti che la costituiscono; così nasce il nuovo processo che
sostituisce il vecchio. Il vecchio processo si conclude, il nuovo sorge. Il
nuovo processo, che contiene nuove contraddizioni, inizia la storia dello
sviluppo delle proprie contraddizioni.
Lenin rileva che Marx ha dato nel “Capitale” un modello di analisi del
movimento degli opposti, che passa attraverso tutto il processo di sviluppo
della cosa, del fenomeno dal principio alla fine. Questo metodo deve essere
applicato nello studio del processo di sviluppo di ogni fenomeno. Lo stesso
Lenin ha applicato in modo appropriato questo metodo, che permea tutte le sue
opere.
I comunisti cinesi debbono assimilare questo metodo; solo così potranno
analizzare giustamente la storia e la situazione attuale della rivoluzione
cinese e determinarne le prospettive. (…)
Ci soffermeremo adesso sul carattere particolare e relativo della
contraddizione. Questa questione deve essere considerata sotto vari aspetti.
Anzitutto, in tutte le diverse forme di movimento della materia le
contraddizioni hanno un carattere particolare. La conoscenza della materia da
parte dello uomo è la conoscenza delle forme di movimento della materia, perché
nel mondo non esiste nulla tranne la materia in movimento, e il movimento della
materia assume sempre forme determinate. Considerando ogni singola forma in
movimento, occorre tenere presente gli elementi che essa ha in comune con le
altre forme di movimento.
Ma è ancora più importante - ed è questo il fondamento della nostra
conoscenza delle cose - tener conto del carattere particolare proprio di ogni
forma di movimento, cioè tener conto della sua differenza qualitativa dalle
altre forme di movimento. Solo in questo modo è possibile distinguere un
fenomeno dall’altro. Ogni forma di movimento contiene le sue contraddizioni
particolari che costituiscono l’essenza particolare del fenomeno; e quest’ultima
differenzia un fenomeno dagli altri. In questo consiste la causa interna o base
della varietà infinita delle cose e dei fenomeni esistenti nel mondo. Nella
natura vi sono numerose forme di movimento: il movimento meccanico, il suono, la
luce, il calore, l’elettricità, l’associazione, la dissociazione, ecc.
Tutte queste forme di movimento della materia si trovano in un rapporto di
interdipendenza, ma nella loro essenza si differenziano l’una dall’altra.
L’essenza particolare di ogni forma di movimento è determinata dalle
contraddizioni particolari che essa sola contiene. Tale situazione non si
riscontra soltanto nella natura: essa esiste egualmente nei fenomeni sociali e
ideologici. Ogni forma sociale, ogni forma della conoscenza contiene le sue
contraddizioni particolari e possiede una sua essenza particolare.
La classificazione delle discipline scientifiche si fonda appunto sulle
contraddizioni particolari insite negli oggetti dell’indagine scientifica. Lo
studio di determinate contraddizioni, insite soltanto in una determinata sfera
di fenomeni, costituisce appunto l’oggetto di questa o quella scienza. (…)
Naturalmente, se non si riconosce il carattere universale della contraddizione
è impossibile scoprire la causa universale o base universale del movimento,
dello sviluppo dei fenomeni; ma se non si analizza il carattere particolare
delle contraddizioni è impossibile determinare l’essenza particolare che
distingue un fenomeno dagli altri, scoprire le cause o basi particolari del
movimento, dello sviluppo dei fenomeni, delimitare i campi dell’indagine
scientifica.
Se si considera la continuità del movimento nel processo della conoscenza
umana, si osserva che esso si estende sempre progressivamente dalla conoscenza
del generale. Gli uomini conoscono dapprima l’essenza particolare di molti
fenomeni diversi e solo in seguito possono passare alla generalizzazione, alla
conoscenza dell’essenza generale dei fenomeni. Soltanto dopo aver conosciuto
questa essenza generale, guidati da questa conoscenza e indagando in seguito le
diverse cose concrete, che non sono ancora state studiate superficialmente, e
cogliendone l’essenza particolare è possibile completare, arricchire e
sviluppare la conoscenza di una data essenza generale, evitando che tale
conoscenza si trasformi in qualcosa di arido e fossilizzato. Queste sono quindi
le due fasi del processo della conoscenza: la prima, dal particolare al
generale, la seconda, dal generale al particolare. Lo sviluppo della conoscenza
umana è sempre un movimento a spirale, e ogni ciclo eleva la conoscenza a un
livello superiore, la approfondisce continuamente (purché si rispetti
rigorosamente il metodo scientifico). L’errore dei nostri dogmatici a questo
proposito consiste nel fatto che essi, da una parte, non comprendono che, solo
indagando il carattere particolare delle contraddizioni e dopo aver conosciuto
l’essenza particolare delle singole cose, è possibile conoscere appieno il
carattere universale delle contraddizioni, l’essenza generale delle cose; e,
d’altra parte, non capiscono che, conoscendo l’essenza generale delle cose,
è necessario proseguire l’indagine delle cose concrete, che non sono ancora
state studiate a fondo o si sono presentate di recente. I nostri dogmatici sono
degli scansafatiche, respingono ogni lavoro minuzioso di ricerca sulla cose
concrete, considerano le verità generali come cose cadute dal cielo, le
trasformano in qualcosa di incomprensibile, in formule meramente astratte,
negano completamente l’ordine normale, attraverso cui l’uomo giunge alla
conoscenza della verità. Essi non comprendono nemmeno il nesso reciproco della
conoscenza, dal particolare al generale e dal generale al particolare. Non
comprendono affatto la teoria marxista della conoscenza. (...)
Tutte le forme di movimento in ogni processo reale e non immaginario di sviluppo
sono qualitativamente diverse; nel nostro lavoro di ricerca dobbiamo rivolgere
particolare attenzione a questo punto e da esso cominciare. Le contraddizioni
qualitativamente diverse possono essere superate solo con metodi
qualitativamente diversi. Ad esempio, la contraddizione fra le masse popolari ed
il regime feudale, si risolve con il metodo della rivoluzione democratica
borghese. La contraddizione fra il proletariato e la borghesia, con il metodo
della rivoluzione socialista. La contraddizione tra le colonie e
l’imperialismo, con il metodo della guerra nazionale rivoluzionaria. La
contraddizione tra la classe operaia e i contadini nella società socialista, si
risolve con il metodo della collettivizzazione e meccanizzazione
dell’agricoltura. Le contraddizioni all’interno del partito comunista, con
il metodo della critica e dell’autocritica. Le contraddizioni tra la società
e la natura con il metodo dello sviluppo delle forze produttive, il processo
cambia, il vecchio processo e le vecchie contraddizioni, vengono liquidati,
sorgono un nuovo processo e nuove contraddizioni; in corrispondenza mutano anche
i metodi per il superamento delle contraddizioni. (...) La soluzione di
contraddizioni diverse con metodi diversi è un principio che i
marxisti-leninisti debbono rigorosamente rispettare. (...) Lenin afferma: “Per
conoscere effettivamente l’oggetto occorre abbracciare, studiare tutti i suoi
lati, tutti i nessi e le ‘mediazioni’: noi non raggiungeremo mai ciò
pienamente, ma l’esigenza della multilateralità ci premunirà dagli errori e
dallo schematismo”.
Noi dobbiamo ricordare queste parole.
Nel processo generale di sviluppo dei fenomeni, noi dobbiamo studiare non
soltanto le peculiarità del movimento degli opposti nel loro nesso reciproco e
tenendo conto della posizione di ciascuna delle parti; ma anche le
caratteristiche particolari delle diverse fasi di questo processo di sviluppo,
che anch’esse non possono venir trascurate. (...) Inoltre, fra le numerose
contraddizioni grandi e piccole, condizionate dalla contraddizione fondamentale
o che si trovano sotto la influenza di essa, alcune divengono più acute, altre
divengono momentaneamente o parzialmente risolte o attenuate, altre poi sorgono
ex novo. Appunto per questo il processo consiste di diverse fasi. Chi non
rivolge la sua attenzione alle fasi del processo di sviluppo di un fenomeno, non
è in grado di risolvere in modo giusto le contraddizioni insite in esso. (...)
Da ciò deriva che nello studio della natura specifica di ogni contraddizione
bisogna evitare ogni arbitrarietà soggettiva e attenersi all’analisi
concreta. Senza l’analisi concreta è impossibile conoscere la natura
specifica di qualsiasi contraddizione. Dobbiamo sempre ricordare la parole di
Lenin: analisi concreta della situazione concreta.
Quando Marx ed Engels applicarono allo studio del processo storico sociale la
legge della contraddizione insita nei fenomeni, essi scoprirono le
contraddizioni tra le forze produttive e i rapporti di produzione, tra la classe
degli sfruttatori e la classe degli sfruttati, e la contraddizione che ne
scaturiva tra la base economica e la sovrastruttura politica, ideologica, ecc.
Essi videro che tali contraddizioni producono inevitabilmente nelle diverse
società classiste rivoluzioni sociali di diverso carattere.
Quando Marx applicò questa legge allo studio della struttura economica della
società capitalistica, vide che la contraddizione fondamentale di tale società
è la contraddizione tra il carattere sociale della produzione e la forma
privata dell’appropriazione. Tale contraddizione si manifesta nella
contraddizione tra il carattere organizzato della produzione nelle singole
imprese e il carattere disorganizzato della produzione nella società presa nel
suo insieme. Nei rapporti di classe tale contraddizione si manifesta nella
contraddizione tra la borghesia e il proletariato.
A causa dell’enorme varietà dei fenomeni e dell’illimitato loro sviluppo ciò
che in un determinato caso è universale può in un altro caso trasformarsi in
particolare. E viceversa, ciò che in un caso determinato è particolare, può
in un altro caso trasformarsi in universale.
La contraddizione, propria del regime capitalistico, tra il carattere sociale
della produzione e la proprietà privata dei mezzi di produzione è generale per
tutti i paesi in cui esiste e si sviluppa il capitalismo. Per il capitalismo
tale contraddizione ha un carattere universale.
Ma questa contraddizione propria del capitalismo rappresenta un fenomeno
inerente a una determinata fase storica nello sviluppo della società classista
in generale; riguardo alla contraddizione tra le forze produttive e i rapporti
di produzione nella società classista in generale, essa costituisce il
carattere particolare della contraddizione. Ma, scoprendo il carattere
particolare di tutte le contraddizioni della società capitalistica, Marx svelò
in modo ancor più approfondito, completo e multilaterale il carattere
universale delle contraddizioni tra le forze produttive e i rapporti di
produzione nella società classista in genere.
Poiché il particolare è legato all’universale, poiché ad ogni fenomeno è
interamente pertinente non solo l’elemento particolare della contraddizione ma
anche l’elemento universale, l’universale esiste nel particolare. Perciò
nello studio di un determinato fenomeno occorre scoprire ambedue questi aspetti
e il loro nesso reciproco, individuare il particolare e l’universale che sono
insiti in un dato fenomeno e il loro nesso reciproco, scoprire il legame
reciproco tra il fenomeno e i numerosi altri fenomeni fuori di esso. Stalin,
nella sua famosa opera “Principi del leninismo”, analizzando le radici
storiche del leninismo, esamina la situazione internazionale in cui il leninismo
è nato, le contraddizioni del capitalismo, giunte all’estremo nella fase
imperialistica; mostra come queste contraddizioni abbiano fatto sì che la
rivoluzione proletaria è divenuta una questione di azione immediata, e come
abbiano creato le condizioni favorevoli per il diretto abbattimento del
capitalismo. (…)
Il rapporto fra carattere universale e carattere particolare della
contraddizione è il rapporto tra generale e individuale. Il carattere
universale consiste nell’esistenza delle contraddizioni in tutti i processi
dal principio alla fine, contradditori sono i movimenti, le cose, i processi, i
pensieri. Questa legge generale è valida per tutti i tempi e luoghi senza
eccezione. Perciò la contraddizione è universale, assoluta. Tuttavia questo
universale esiste attraverso l’individuale, e senza l’individuale non può
esservi l’universale. Può forse esistere l’universale se si esclude tutto
l’individuale? L’individuale nasce dal fatto che ogni contraddizione ha
particolarità proprie. Tutto l’individuale è condizionato, temporaneo e
perciò relativo.
Questo principio dell’universale e dell’individuale, dell’assoluto e del
relativo è la quintessenza della questione delle contraddizioni insite nei
fenomeni; non comprendere tale principio equivale a rinunciare alla dialettica.
Mao Tse-Dun (1937)
92
- Il movimento (cinese) del 4 Maggio 1919 (Mao
Tse-Dun)
Venti anni fa, il movimento del
4 maggio mostrò che la rivoluzione democratica borghese contro l’imperialismo
e il feudalesimo era entrata in una nuova fase. Ma il movimento del 4 maggio,
semplice movimento di rinnovamento culturale, fu soltanto uno degli aspetti
della rivoluzione democratica borghese contro l’imperialismo e il feudalesimo
in Cina. Il sorgere e lo svilupparsi, in quel periodo, di nuove forze sociali,
portò al costituirsi di uno schieramento che divenne più tardi una forza
importantissima della rivoluzione democratica borghese: lo schieramento composto
dalla classe operaia, dalle masse studentesche e dalla giovane borghesia
nazionale. Nel corso del movimento del 4 maggio combatterono nelle prime file
centinaia di migliaia di eroici studenti; e per questo aspetto il movimento del
4 maggio rappresentò un passo avanti in confronto alla rivoluzione del 1911.
La rivoluzione democratica borghese in Cina - se ne ripercorriamo il cammino a
cominciare dalla sua origine - è passata attraverso diverse fasi: la guerra
dell’oppio, la guerra dei “taiping”, la guerra cino-giapponese del 1894,
il movimento per le riforme del 1898, la rivolta dei “boxers”, la
rivoluzione del 1911, il movimento del 4 maggio, la spedizione del nord e la
guerra rivoluzionaria agraria. L’odierna guerra antigiapponese è una fase
ulteriore di questo sviluppo, la fase più grandiosa, più vigorosa e più
costruttiva. La rivoluzione democratica borghese si potrà considerare compiuta,
solo quando ci saranno sostanzialmente le forze imperialiste straniere e le
forze feudali interne, e si sarà creato in Cina uno Stato democratico
indipendente. A partire dalla guerra dell’oppio, ognuna delle fasi di sviluppo
della rivoluzione cinese ha avuto caratteristiche sue proprie. Ma ciò che
contraddistingue in maniera sostanziale queste fasi tra di loro è il fatto che
esse siano avvenute prima o dopo la nascita del partito comunista. Tuttavia, nel
loro insieme, tutte queste fasi hanno il carattere di una rivoluzione
democratica borghese. Questa rivoluzione democratica mira alla creazione di un
sistema sociale che non ha precedenti nella storia della Cina, cioè di un
regime democratico; questo tipo di società è stato preceduto dalla società
feudale (che, negli ultimi cento anni, si trasformò in una società
semicoloniale e semifeudale), e sarà seguito da una società socialista. Se
chiediamo a un comunista perché egli lotta, prima per un sistema sociale
democratico borghese e solo dopo per un sistema sociale socialista, vi risponderà:
perché risponde al corso ineluttabile della storia.
Il compimento della rivoluzione democratica cinese dipende da forze sociali
determinate. Tali forze sono la classe operaia, i contadini, gli intellettuali e
la parte progressista della borghesia: o, in altre parole, operai, contadini,
soldati, intellettuali e commercianti e industriali rivoluzionari, con gli
operai e i contadini come forze rivoluzionarie fondamentali e la classe operaia
come guida della rivoluzione. Senza queste forze rivoluzionarie fondamentali,
senza la direzione della classe operaia, è impossibile portare a termine la
rivoluzione democratica antimperialista e antifeudale. Oggi i nemici principali
della rivoluzione sono gli imperialisti giapponesi e i loro collaboratori
cinesi, e base della politica rivoluzionaria è la formazione di un fronte unico
nazionale antigiapponese, fronte unico composto da tutti gli operai, i
contadini, i soldati, gli intellettuali e i commercianti e industriali
antigiapponesi. La vittoria finale della guerra antigiapponese sarà raggiunta
solo quando il fronte unico degli operai, dei contadini, dei soldati, degli
intellettuali e dei commercianti e industriali sarà stato sufficientemente
rafforzato e sviluppato.
Nel movimento per la rivoluzione democratica cinese, gli intellettuali furono
all’avanguardia del risveglio nazionale. Sia la rivoluzione del 1911 che il
movimento del 4 maggio, misero chiaramente in luce questa loro funzione, e nel
movimento del 4 maggio la loro partecipazione fu più numerosa e più attiva che
nella rivoluzione del 1911. Ma se gli intellettuali non si uniranno con le masse
degli operai e dei contadini, essi non potranno giungere ad alcun risultato. La
linea di demarcazione tra gli intellettuali rivoluzionari, da una parte, e gli
intellettuali non rivoluzionari e controrivoluzionari dall’altra, è segnata
dalla volontà o meno di unirsi strettamente, in teoria e in pratica, alle masse
degli operai e dei contadini. Soltanto ciò e non altro, non certo di
chiacchierare dei “Tre principi popolari” o di marxismo, segna la linea di
demarcazione tra gli uni e gli altri. Vero rivoluzionario è chi è pronto a
unirsi strettamente in teoria e in pratica, con le masse degli operai e dei
contadini.
Sono ora passati venti anni dal movimento del 4 maggio, e quasi due anni dallo
scoppio della guerra antigiapponese. Gravi responsabilità per il raggiungimento
degli obiettivi della rivoluzione democratica e della guerra antigiapponese
ricadono sui giovani e sugli uomini di cultura del nostro paese; io spero che
ciascuno di loro saprà comprendere la natura e il carattere delle forze motrici
della rivoluzione cinese e, legando strettamente la propria azione a quella
delle masse operaie e contadine, saprà andare tra queste masse come
propagandista e organizzatore. Il giorno in cui, in tutto il paese, il popolo si
solleverà come un sol uomo, sarà il giorno della vittoria nella guerra
antigiapponese.
Al lavoro dunque, giovani di tutta la Cina!
Mao Tse-Dun
93 - Contro il “liberalismo (Mao Tse-Dun)
(Le pagine che seguono furono
scritte il 7 settembre 1937)
Noi siamo per un dibattito ideologico, che è l’arma per raggiungere la
solidarietà nel partito e nelle organizzazioni rivoluzionarie, e per prepararle
alla lotta. Ogni comunista e ogni rivoluzionario deve impugnare quest’arma.
Il “liberalismo” nega invece la lotta ideologica ed è per una pace senza
principi; nasce da ciò uno stile di lavoro decadente e ipocrita e, in
conseguenza, alcune unità e alcuni individui nel partito e nelle organizzazioni
rivoluzionarie hanno cominciato a degenerare politicamente.
Il liberalismo si manifesta in vari modi.
Sebbene si sappia chiaramente che un certo individuo è in torto, tuttavia per
la vecchia amicizia, o perché è un compaesano, o un amico di scuola, o un caro
e amato compagno, o un antico collega, o un ex subordinato, non si sente il
bisogno di discutere con lui sulla base dei principi, ma si lascia correre per
conservare la pace e l’amicizia. Oppure si tratta la questione di sfuggita,
senza approfondirne seriamente gli aspetti sempre per conservare l’armonia.
Come risultato, si danneggia l’organizzazione e l’individuo stesso. Questo
è il primo tipo di liberalismo.
Indulgere in un irresponsabile criticismo in privato, senza dare suggerimenti
positivi alla organizzazione. Non dire le cose in faccia alla gente, ma
mormorare alle sue spalle; stare zitti alle riunioni, ma chiacchierare dopo. Non
preoccuparsi del principio della vita collettiva, ma esser pieni solo di
illimitata autoindulgenza. Questo è il secondo tipo.
Non prendere in considerazione le cose che non hanno un interesse personale;
parlare il meno possibile di cose di cui si sa bene che sono sbagliate; essere
pieni di cautele per salvare se stessi, e ansiosi solo di evitar grane. Questo
è il terzo tipo.
Disubbidire agli ordini e porre le proprie opinioni al disopra di ogni cosa.
Chiedere alle organizzazioni facilitazioni speciali e respingerne la disciplina.
Questo è il quarto tipo.
Impugnare dispute e questioni contro i punti di vista sbagliati, ma non per
amore della compattezza, per far progredire e migliorare il lavoro, ma per
portare attacchi personali, per sfogarsi, per rifarsi di torti subiti e
vendicarsi. Questo è il quinto tipo.
Ascoltare opinioni errate senza discuterle, non controbattere quando si
ascoltano opinioni controrivoluzionarie, ma tollerarle placidamente come se
niente fosse. Questo è il sesto tipo.
Non impegnarsi nell’azione di propaganda e di agitazione, non interessarsi
della vita delle masse e non preoccuparsi conoscerla, ma lasciare le masse sole,
senza interesse per il loro benessere e la loro infelicità; dimenticare di
essere comunista e comportarsi come se un comunista fosse un individuo come un
altro. Questo è il settimo tipo.
Non indignarsi di fronte ad azioni che vanno a detrimento delle masse, né
dissuadere o fermare chi è responsabile di tali azioni, né cercare di
insegnargli la via giusta, ma lasciarlo perseverare nell’errore. Questo è
l’ottavo tipo.
Lavorare senza entusiasmo e senza un piano o una direzione definita, lavorare
con negligenza e lasciar andare le cose alla deriva. “Finché sarò bonzo,
suonerò le campane”. Questo è il nono tipo.
Pensare di aver ben meritato della rivoluzione per i servizi prestati e darsi
arie da veterano; essere incapace di fare le cose più grandi e disdegnare i
piccoli compiti; essere trascurato nel lavoro e distratto nello studio. Questo
è il decimo tipo.
Essere conscio dei propri errori ma non cercar di correggerli, e avere un
atteggiamento liberale verso se stesso. Questo è l’undicesimo tipo.
Potremmo enumerarne molti altri, ma questi undici sono i tipi principali.
Tutte queste sono manifestazioni di liberalismo.
Nelle organizzazioni rivoluzionarie il liberalismo è estremamente dannoso. È
un corrosivo che distrugge l’unità, che mina la solidarietà, che induce
all’inattività e crea disaccordo. Esso priva le file rivoluzionarie di
compattezza nell’organizzazione e di serietà nella disciplina, si oppone a
che le nostre direttive politiche siano fermamente portate avanti e separa le
organizzazioni di partito dalle masse che esse dirigono. È una tendenza
estremamente pericolosa.
Il liberalismo germoglia sull’egoismo piccolo-borghese, che pone in primo
piano i propri interessi personali e in secondo piano gli interessi della
rivoluzione, producendo così il liberalismo ideologico, politico e
organizzativo.
I liberali considerano i principi del marxismo come dogmi astratti; essi li
approvano, ma non sono pronti a metterli in pratica pienamente; essi non sono
capaci di mettere il marxismo al posto del loro liberalismo. Queste persone
hanno appreso il marxismo, ma insieme hanno appreso il liberalismo; parlano di
marxismo ma praticano il liberalismo; applicano il marxismo agli altri e il
liberalismo per se stessi. Hanno in riserva l’una e l’altra merce, e trovano
modo di usare l’una e l’altra. Così lavora la mente di certe persone.
Il liberalismo è una manifestazione di opportunismo ed è fondamentalmente in
conflitto con il marxismo. Ha una caratteristica di passività, ed ha
oggettivamente l’effetto di aiutare il nemico; per questo il nemico è
soddisfatto ch’esso si conservi in mezzo a noi. Essendo questa la sua natura,
non deve aver più posto nelle file rivoluzionarie.
Noi dobbiamo servirci dello spirito attivo del marxismo per respingere il
liberalismo e la sua passività. Un comunista deve essere franco, fedele e
attivo, considerare gli interessi della rivoluzione come la sua vera vita e
subordinare i suoi interessi personali a quelli della rivoluzione; un comunista
deve aderire, sempre e ovunque ai principi giusti e condurre una lotta
instancabile contro tutte le idee e le azioni sbagliate, in modo da consolidare
la vita collettiva del partito e rafforzare i legami tra il partito e le masse;
un comunista deve interessarsi più della vita del partito e delle masse che
della propria vita, più degli altri che di stesso. Solo così può essere
considerato comunista.
Tutti i comunisti leali, onesti, attivi e tenaci devono unirsi per contrastare
le tendenze liberali evidenti in alcuni di noi, e indirizzare questi individui
nella direzione giusta. Questo è uno dei compiti del nostro fronte ideologico.
Mao Tse-Dun
94
- Il volto del nazifascismo (1941) (Palmiro Togliatti)
Una volta, parecchi anni or
sono, Mussolini proclamò che il fascismo non è merce di esportazione. Egli
sentiva che il giorno in cui si fosse proposto di esportare i metodi fascisti al
di là dei confini d’Italia, quel giorno sarebbe stato l’inizio della sua
fine, perciò quando si rivolgeva al pubblico degli altri paesi egli era tutto
lattemiele. Non parlava che di progresso e di civiltà. Che cosa significassero
per il disgraziato popolo italiano quella civiltà e quel progresso, venissero a
vederlo, gli inglesi e gli americani, se ci riuscivano. Il bastone e l’olio di
ricino degli squadristi, il pugnale di Dumini, l’incendio delle Camere del
lavoro e di migliaia di case di braccianti e di operai, il saccheggio a man
salva, l’assassinio in dieci contro uno e più tardi, la dilapidazione del
tesoro dello Stato e lo scorticamento sistematico della popolazione lavoratrice,
tutto questo doveva essere riservato all’uso interno. A noi accadde, perfino,
alle volte, mentre battevamo le dure vie dell’esilio, e ci sforzavamo, come
era nostro dovere, di suscitare l’orrore contro questo spaventoso ritorno alla
barbarie, che è il regime fascista, di incontrare della incredulità. È
possibile, anzi, che persino in Italia, oggi, soprattutto fra le nuove
generazioni avvelenate da venti anni di propaganda fascista, ci sia chi ha
dimenticato gli orrori dei primi tempi e non comprenda la vera natura del regime
mussoliniano.
Hitler si è incaricato di aprire gli occhi a tutti. Egli ha lanciato il suo
esercito alla conquista dell’Europa e del mondo e alla luce delle gesta di
questo esercito, tutti ora possono vedere che cosa il fascismo è nella realtà,
a che cosa esso riduce gli uomini, a quale sorte esso condanna i popoli che
sottopone al suo giogo. Le maschere cadono, e un grido di raccapriccio si leva,
da tutti i paesi civili. Ricordiamo le cose che si dissero dell’esercito
tedesco all’inizio della grande guerra imperialista mondiale, soprattutto
durante l’invasione del Belgio. Mussolini fu uno degli uomini che più si
adoperarono allora per rendere popolari quei racconti che del resto, pare, si
riferissero a fatti di eccezione e che non sempre poterono essere accertati.
Oggi non si tratta più, né di fatti isolati né di racconti la cui autenticità
possa essere messa in dubbio. Dalla Francia all’Ucraina, da Leopoli a
Belgrado, dai villaggi della Bielorussia alle capanne dei pescatori della
Norvegia, un quadro uniforme di terrore, di rapina, di bestialità appare agli
occhi sbigottiti dell’Europa. La parola che Guglielmo II aveva dato ai suoi
soldati: “Siate degli Unni”, Hitler l’ha tradotta in atto. Egli ha avuto
bisogno, per riuscirci, di pervertire profondamente l’animo del popolo
tedesco, e soprattutto della sua gioventù. Tutti i mezzi sono stati impiegati a
questo scopo: la propaganda dell’odio e gli emblemi superstiziosi della morte,
la brutalità e la corruzione, la stupida disciplina della caserma e
l’incitamento delle passioni più volgari. I restii - coloro che protestavano
in nome della civiltà contro questa impresa di imbestiamento di tutta una
generazione, di tutto un popolo - sono stati soppressi fra le torture. I libri
che predicavano ideali umani, che parlavano di libertà, di uguaglianza, di
fratellanza, sono stati bruciati sulle piazze, in mezzo a macabre danze di
squadristi ubriachi. Sgozzare col pugnale esseri senza difesa, torturare
l’avversario dopo averlo legato a un palo perché non si possa muovere,
violentare le donne inermi, rubare, incendiare le case altrui, ridurre popoli
armati alla schiavitù, questi sono gli ideali che Hitler ha inculcato alla
gioventù tedesca. Così il nazionalismo ha ottenuto il suo scopo che era di
crearsi un esercito di attacco non più di uomini ma di bestie feroci.
I soldati hitleriani non sono più dei soldati secondo il significato comune di
questo termine. Non è un soldato colui che dirige la mitraglia contro le donne
e i bambini, come fecero i tedeschi in Polonia, nel Belgio, in Francia, lungo le
strade affollate di fuggiaschi. Non sono soldati i bruti che, dopo aver
conquistato un villaggio riuniscono la popolazione atterrita, si fanno
consegnare le ragazze di 14 e 15 anni, le violentano a turno sotto gli occhi dei
genitori e dopo averle violentate le schiacciano sotto i cingoli dei tank. Non
sono soldati coloro che, a Leopoli, fucilano a centinaia gli operai colpevoli di
essere stati iscritti al sindacato, le donne ree di aver fatto parte delle
organizzazioni di soccorso alle vittime politiche. Non sono soldati coloro che
seppelliscono vivi in Ucraina, gli attivisti delle organizzazioni politiche dei
lavoratori. Non sono soldati coloro che mettono a sacco le case dei paesi
conquistati, che rubano gli orologi e gli stivali ai morti, che caricano i loro
tank di indumenti femminili da mandare alle loro amanti nelle retrovie.
No, questi non sono soldati. Queste sono delle belve! Questi sono dei fascisti.
E nulla è più sacro del grido di odio che da tutti i paesi d’Europa si leva,
oggi contro coloro che hanno ridotto un popolo a essere strumento di barbarie.
Morte ai fascisti tedeschi! - gridano le madri di Parigi che hanno visto i loro
figlioli fucilati presso la tomba del Milite Ignoto, dove manifestavano il loro
amore per la loro patria immortale. Morte ai fascisti tedeschi! - grida il
contadino serbo, croato, boemo, giurando vendetta per il suo villaggio
saccheggiato, per la sua casa data alle fiamme. Morte ai tedeschi fascisti! -
gridano i popoli della Grecia, del Belgio, della Norvegia, che vogliono vivere
sulle terre loro, come greci, come belgi, come norvegesi, e non come schiavi
della Germania. Morte ai fascisti tedeschi! - grida il polacco che si è vista
strappare la figlia, la sposa, per mandarle alle case di prostituzione destinate
agli ufficiali di Hitler. In nome di tutte le libertà calpestate, in nome delle
sofferenze inaudite di milioni di
uomini di null’altro colpevoli che di aver difeso la loro libertà e la loro
vita; in nome di tutto quello che di caro e di sacro sempre hanno avuto gli
uomini - morte ai fascisti tedeschi!
Noi non abbiamo mai predicato l’odio fra i popoli. Nella comprensione
reciproca e nella collaborazione tra tutti i popoli vediamo il futuro
dell’umanità, ma perché questo
futuro sia possibile, è necessario spezzare la strada che oggi è sbarrata dal
nazionalsocialismo hitleriano e dal fascismo. Chi di spada ferisce, di spada
perisce. Chi ha predicato l’odio, la distruzione e la morte, sarà travolto
dall’odio e dalla vendetta dei popoli. Tragico sarà il destino del popolo
tedesco se, in uno sforzo supremo di liberazione e di redenzione, esso non
insorgerà a tempo contro i despoti, che lo hanno ridotto alla barbarie. Questo
dobbiamo comprendere bene noi italiani. Chi
vuole legare il destino dell’Italia a quello della Germania hitleriana,
condanna il proprio paese a subire la stessa catastrofe verso cui Hitler spinge
il popolo tedesco. Questo non deve essere. Questo non sarà. Lo impediranno i
soldati italiani, gli operai, gli intellettuali. Lo impediranno le donne
d’Italia, nel cui animo arde il fuoco dei migliori sentimenti umani. Lo
impedirà tutto il popolo nostro, levandosi come un sol uomo per la difesa della
sua civiltà, del suo avvenire, della sua vita.
Palmiro Togliatti
95 - La classe operaia e la partecipazione al governo (giugno 1944) (Palmiro Togliatti)
Nell’Italia d’un tempo,
cosiddetta democratica e liberale, precedente alla usurpazione fascista del
potere, intorno al problema della eventuale partecipazione al governo di
rappresentanti del partito socialista, si discusse e lottò per decenni. La
posizione dell’ala marxista del movimento operaio fu sempre, in proposito,
chiarissima. Ogni partecipazione al potere venne considerata inammissibile; ogni
proposta di accettare gli inviti a collaborare al governo, provenienti da gruppi
e uomini politici borghesi, giustamente denunciata come tentativo di asservire
il movimento operaio a finalità e interessi contrastanti con i suoi propri. Su
questa posizione si mantenne la grande maggioranza delle masse lavoratrici in
modo incrollabile, tanto che tutti gli esponenti del movimento socialista i
quali vollero deviare per altro cammino furono respinti dalle masse stesse e
dalle loro organizzazioni come traditori.
Oggi, dopo il crollo del fascismo, l’ingresso nel governo non solo di
rappresentanti socialisti, ma comunisti, è stato deciso in pochi giorni, e i
partiti che lo hanno deciso non solo non hanno visto diminuita la loro autorità
fra le masse lavoratrici, ma hanno raccolto il consenso generale e vedono
crescere la loro autorità e il loro prestigio di giorno in giorno. Regna fra
gli operai e fra tutti gli elementi di avanguardia la convinzione profonda che
la partecipazione al governo dei partiti proletari era una necessità imperiosa,
e questo vuol dire che la massa, stessa del popolo intuisce, anche se non
sarebbe capace di esprimerla chiaramente, la profonda differenza che passa tra
la situazione odierna del nostro paese e quella del primo periodo di sviluppo e
affermazione del movimento socialista, quando la partecipazione al potere fu
considerata inammissibile da tutta la parte sana e vitale di questo movimento.
La situazione del nostro paese è determinata oggi da due elementi. Il primo è
la guerra di liberazione nazionale contro i tedeschi; l'altro è la necessità
di far seguire al crollo del regime fascista - che si produsse in quel modo che
tutti sanno - la distruzione effettiva e completa di tutti i residui di questo
regime. La classe operaia, - è bene ripeterlo, quantunque mi sembri che nessuno
lo metta in dubbio, oggi, tra noi - non è contro tutte le guerre. Essa lotta
risolutamente contro le guerre ingiuste “il cui scopo è di assoggettare altri
paesi, altri popoli”; ma sostiene le guerre giuste, le guerre di liberazione,
il cui scopo è “la difesa del popolo contro le aggressioni esterne e i
tentativi di assoggettarlo”. La guerra del popolo italiano contro gli invasori
hitleriani e contro i traditori fascisti è, fra tutte, la più giusta. Essa è
tale perché l’Italia fu presa alla gola e aggredita a tradimento quando,
spossata da otto anni di brigantaggio internazionale fascista, aveva chiaramente
espresso la sua volontà di cercare nella uscita dalla guerra un inizio di
rinnovamento. Essa è tale perché l’invasione hitleriana, oltre ad, avere …
… qui si interrompe la battitura a macchina.